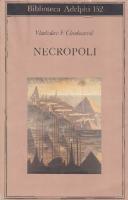La Necropoli di Capestrano, I: Scavi d'Ercole 2003–2009 9781407316345, 9781407345314
La necropoli di Capestrano (AQ), celebre per la famosa statua di guerriero, rappresenta il sito archeologico più noto de
157 80 312MB
Italian Pages [513] Year 2018
Front Cover
Title Page
Copyright
INDICE
ENGLISH SUMMARY
INTRODUZIONE AI VOLUMI SULLA NECROPOLI DI CAPESTRANO
CAPITOLO I
I.1. Le ricerche a Capestrano dal 1934 al 2012: la storia degli scavi e riflessioni sulle aree funerarie nella Piana di Capestrano
I.2. Le necropoli di Capestrano: integrazione dei dati noti e analisi aerofotointerpretative
CAPITOLO II
La tipologia dei materiali dagli scavi nella necropoli
CAPITOLO III
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
III.1. FOSSASCOPANA: LA CAMPAGNA 2003 (TOMBE 100-192)
III.2. FOSSASCOPANA: LA CAMPAGNA 2007 (TOMBE 194-258)
III.3. FOSSASCOPANA: LA CAMPAGNA 2008 (TOMBE 259-284)
III.4. FOSSASCOPANA: LA CAMPAGNA 2009 (TOMBE 285-341)
TAVOLE
BIBLIOGRAFIA
APPENDICE NUMISMATICA: La moneta della Tomba 206 di Capestrano
Recommend Papers

- Author / Uploaded
- Vincenzo d'Ercole
- Valeria Acconcia
- Deneb Cesana
- Similar Topics
- History
- Archaeology
File loading please wait...
Citation preview
Vincenzo d’Ercole si è laureato in Paletnologia presso l’Università “La Sapienza” di Roma e dal 1979 fino al 2011 è stato funzionario archeologo presso la Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo (Mibact). Dal 2012 lavora presso la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo a Roma. Valeria Acconcia è laureata in Etruscologia e ha conseguito il dottorato in Etruscologia e Archeologia italica presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Dal 2009 insegna Etruscologia presso l’Università di Chieti. Attualmente Valeria Acconcia è funzionario archeologo in servizio presso L’Istituto Centrale per l’Archeologia (Mibact).
l na tio ne di nli ad l o ith ria W ate m
The necropolis of Capestrano (AQ, Abruzzo), well-known for its warrior statue, is the most famous archaeological site of the pre-Roman middle-Adriatic area of Italy. From 1934 onwards, archaeological investigations have uncovered a complex funerary area dating to the period between the 8th century BC and the 2nd century AD, with a total of about 500 burials. In this first volume, the authors offer a complete catalogue of the excavation in the Fossascopana, a central sector of the necropolis, investigated between 2003 and 2009. They present a documented review of the history of research on the site, archaeological artefact typologies, funerary aspects, burial rituals and social organization, alongside taphonomic, anthropological and palaeopathological data.
BAR S2895 2018 D’ERCOLE ET AL. LA NECROPOLI DI CAPESTRANO, I
La necropoli di Capestrano (AQ), celebre per la famosa statua di guerriero, rappresenta il sito archeologico più noto dell’età preromana dell’Italia medio-adriatica. Fin dal 1934 gli scavi archeologici hanno scoperto una complessa area funeraria databile al periodo tra VIII sec. a.C. e gli inizi del II sec. d.C. per un totale di circa 500 tombe. Nel primo volume gli autori offrono un catalogo completo degli scavi condotti nell’area di Fossascopana, il settore centrale della necropoli, tra il 2003 e il 2009. La completa documentazione delle indagini archeologiche qui condotte include: storia delle ricerche, aspetti del rituale funerario, tipologia degli oggetti di corredo, indicatori dell’organizzazione sociale, analisi tafonomica, dati antropologici e paleopatologici.
La Necropoli di Capestrano, I Scavi d’Ercole 2003–2009
Vincenzo d’Ercole Valeria Acconcia Deneb Cesana
Deneb Cesana è laureata in Archeologia all’Università di Genova dove si è specializzata in Preistoria e protostoria. Ha ottenuto il dottorato in Antropologia e Paleopatologia presso l’Università di Chieti e il suo interesse di ricerca si focalizza sullo studio dei resti umani da contesti funerari dell’Abruzzo preromano. Attualmente Deneb Cesana è funzionario archeologo in servizio presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città dell’Aquila e i comuni del cratere (Mibact).
‘All scholars interested in pre-Roman Italy will benefit from reading this publication.’ Prof. Gilda Bartoloni, La Sapienza—Università di Roma ‘The publication of these new data, produced with a modern stratigraphic approach, is useful for the reconstruction of the whole context, even enhancing the value of previous discoveries.’ Dr Cecilia Rossi, Università degli Studi di Padova
BAR International Series 2895 B A R
2018
La Necropoli di Capestrano, I Scavi d’Ercole 2003–2009
Vincenzo d’Ercole Valeria Acconcia Deneb Cesana con il contributo di Silvia D’Alessandro, Francesca Delle Grazie, Serafino Lorenzo Ferreri, Francesca Mancini, Stefania Montanaro, Federica Properzio, Elena Rossi, Laura Sagripanti, Serena Torello Di Nino
BAR International Series 2895 2018
by Published in BAR Publishing, Oxford BAR International Series La Necropoli di Capestrano, I © The authors and contributors severally Capestrano, loc. Fossascopana, Tomba 212, brocca in ceramica in impasto buccheroide. The Authors’ moral rights under the UK Copyright, Designs and Patents Act are hereby expressly asserted. All rights reser ved. No par t of this work may be copied, reproduced, stored, sold, distributed, scanned, saved in any for m of digital for mat or transmitted in any for m digitally, without the written per mission of the Publisher.
ISBN 9781407316345 paperback ISBN 9781407345314 e-format DOI https://doi.org/10.30861/9781407316345 A catalogue record for this book is available from the British Library
BAR titles are available from: BAR Publishing Banbury Rd, Oxford, [email protected] + ( ) + ( ) www.barpublishing.com
,
Vorrei dedicare il lavoro sulla necropoli di Capestrano al proficuo “incontro” tra un archeologo alla fine del suo percorso lavorativo e due, archeologhe, che lo stanno iniziando ora nelle file del Mibact. A riprova che specializzazioni diverse (protostoria, etruscologia e antichità italiche, antropologia), età ed esperienze differenti possono essere ingredienti fondamentali nella riuscita di un buon lavoro di squadra.
Vincenzo d'Ercole - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Valeria Acconcia - Istituto Centrale per l'Archeologia Deneb T. Cesana - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città dell’Aquila e i comuni del cratere.
INDICE ENGLISH SUMMARY ........................................................................................................................... vii INTRODUZIONE AI VOLUMI SULLA NECROPOLI DI CAPESTRANO ...................................................... 1 CAPITOLO I I.1. Le ricerche a Capestrano dal 1934 al 2012: la storia degli scavi e riflessioni sulle aree funerarie nella Piana di Capestrano – V. d’Ercole ............................................................................... 3 I.2. Le necropoli di Capestrano: integrazione dei dati noti e analisi aerofotointerpretative – S.L. Ferreri......................................................................................................................................... 17 CAPITOLO II La tipologia dei materiali dagli scavi nella necropoli – V. Acconcia................................................. 45 CAPITOLO III Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture – V. Acconcia e D. Cesana .................... 203 III.1. Fossascopana: la campagna 2003 (Tombe 100-192) – S. D’Alessandro e D.Cesana ............ 204 III.2. Fossascopana: la campagna 2007 (Tombe 194-258) – F. Properzio e D.Cesana .................. 266 III.3. Fossascopana: la campagna 2008 (Tombe 259-284) – F. Delle Grazie e D.Cesana ............. 304 III.4. Fossascopana: la campagna 2009 (Tombe 285-341) – S. T. Di Nino, F. Mancini, E. Rossi e D.Cesana ......................................................................................................................... 318 TAVOLE ............................................................................................................................................ 353 BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................................. 479 APPENDICE NUMISMATICA La moneta della Tomba 206 di Capestrano – S. Montanaro ........................................................... 497 IMMAGINI ANTROPOLOGICHE. Materiale aggiuntivo è disponibile per il download da http://www.barpublishing.com/additional-downloads.html.
v
ENGLISH SUMMARY settlement of Capestrano restarted in 2003. The fieldwork was supported to a significant extent by the local authorities, in particular the Abruzzo Region and the Municipality of Capestrano, while the post-excavation documentation was undertaken as part of several degree dissertations and doctoral theses at the University “Gabriele D’Annunzio” of Chieti-Pescara. Paradoxically, after Cianfarani’s time, the Superintendence of Abruzzo had never considered the Capestrano site worthy of interest and investment. In full concord, as always, with the editors of BAR Publishing, we have decided to divide the publication of the excavations of the necropolis of Capestrano into two volumes. The first one covers, after a short history of research, the investigations conducted between 2003 and 2009 in the central area of the cemetery, called Fossascopana. The second will cover both the latest excavations (2010-2012), conducted around the central area of the necropolis, and the investigations carried out from the 1930s to the 1990s, the so-called “old excavations”. The two volumes include in-depth physical anthropological and demographic analysis of the human remains, conducted by Deneb Cesana, along with specific typologies and chronological seriation for the archaeological artefacts, analysed by Valeria Acconcia and her colleagues, as well as my own contribution relating to the issue of statues, stele and menhirs in the middle-Adriatic necropolis. Valeria, Deneb and I share joint responsibility for the whole project, especially the historical conclusions. We do not claim to put an end to the debate, but we do wish to make what we see as an important contribution to the history of the Italic people, at long last giving a context to the Capestrano “Warrior”: a real “Return of the King”!
Introduction to the publication of the Capestrano necropolis (V. d’Ercole) At the end of the 1970s, for any archaeologist like me who was approaching the complex issue of funerary ritual in pre-Roman Abruzzo, there existed three main necropoleis as reference points: Campovalano in the north, Capestrano in the centre and Alfedena in the south. Scraping away the surface, however, the state of knowledge and publication did not match the “celebrity” and importance of these sites. For example, the necropolis of Campovalano was published in preliminary and non-systematic form by Valerio Cianfarani, while Capestrano had only the publication by Giuseppe Moretti from the 1930s. The recent excavations (197579) conducted at the necropolis of Alfedena by Franca Parise Badoni and Maria Ruggeri Giove have also been published at the urging of Giovanni Scichilone. In the 1970s, in order to remedy the lack of a complete and systematic documentation of the sites, Renato Peroni promoted the organization of two study groups respectively dedicated to the analysis of Campovalano and Alfedena. Unfortunately, this initiative was not successful. Beginning in the 1980s, after the death of Cianfarani, the current author took over directing and coordinating the archaeological excavations at Campovalano, leading to the creation of an archaeological museum in Campli (inaugurated in 1988). In the years between 2003 and 2016, my work led to the complete publication of the necropolis in three volumes in the British Archaeological Reports International Series. Between 1994 and 2011, an exceptional burst of archaeological research activity in the province of L’Aquila, corresponding to the ancient territory of the Vestini Cismontani, led to the excavation and complete publication of the necropolis of Fossa in three volumes published in Pescara, and the Archaic phases (8th-5th centuries BC) of Bazzano in three volumes published in Mainz. Subsequently, in this inspiring context of “fervour” regarding the archaeology of the Vestini - both Cismontani and Transmontani research on, and study of, the necropolis and the vii
Capestrano, I
Superintendence of Abruzzo 1992 Alessandro Usai, official of the Superintendence of Abruzzo (Usai 1993). The year 2003 marks a major shift in the history of archaeological research in Capestrano. Since then, investigations have been expanded to include the settlement of Colle Sant’Antonino and at the same time, until 2011, research at the necropolis was coordinated by Vincenzo d’Ercole, official for this area in the Superintendence for Archaeological Heritage of Abruzzo (Spanu 2004, 380-392; Menozzi and Fossataro 2011, 476; Menozzi and Di Antonio 2014, 288-297; Menozzi, Fossataro, Torello Di Nino and d’Ercole 2014, 265-290). After the earthquake that hit the Abruzzo region on April 6, 2009, many archaeologists, in particular Adriano La Regina, contributed to the reconstruction by organizing an international archaeology school focused on the excavation of the necropolis of Capestrano, directed by Alessandro Guidi and Massimo Pennacchioni of the University of Roma Tre and Oliva Menozzi of the University of Chieti-Pescara. The following year, the research continued in collaboration with the University of ChietiPescara (Acconcia, d’Ercole and Papi 2012, 494-500) and further investigations have been carried out as part of preventive/rescue archaeology (D’Alessandro et al. 2014, 297302). In autumn 2011, as part of cultural heritage preservation and management, research was focused on the Presciano area (d’Ercole and Di Sabatino 2014, 302-305). The University of Chieti-Pescara in 2012 obtained an excavation concession for the Fontanelle area, located between Fossascopana and Capo d’Acqua (Acconcia and Di Sabatino 2016, 156-159). Finally, the most recent work at the necropolis of Capestrano was carried out in July 2017 by a team from the University of Chieti-Pescara directed by Oliva Menozzi in the area of Capo d’Acqua. To summarise the present state of research in the Capestrano necropolis, “modern” projects (2003-2017) explored about 5,000 square metres where at least 520 burials were identified, while the “old” excavations (19341992) revealed 85 tombs in 2,000 square
CHAPTER 1 I.1. History of archaeological research at the Capestrano necropolis (V. d’Ercole) The great necropolis of Capestrano, dating to the Iron Age, is located on an extensive alluvial plain, at 340 to 370 metres above sea level, which has been exploited by man since prehistoric times. In fact, the first archaeological traces of human frequentation of this area date back to the period between the Pleistocene and the Holocene, in particular strata of the Mesolithic and Early Neolithic occupation at Capo d’Acqua (Radmilli 1977, Tozzi 1966, Bonuccelli and Faedo 1968, Grifoni Cremonesi 1969). Evidence from the metal ages begins in the Copper Age (d’Ercole 2015) and continues into the Early and Middle Bronze Age with a famous “hoard” of flanged axes having been discovered in the 19th century (Montelius 18951910, Peroni 1971). Therefore, throughout the arc of prehistory, the Capestrano plain was inhabited with either permanent or transitory settlements depending on the particular nature of the exploitation of natural resources: first, hunting and gathering and, later, agricultural activity (NeolithicBronze Age). This situation radically changes in the first millennium BC (Iron Age), when the whole plain becomes the site of a cemetery that remained in use for a thousand years (d’Ercole and Martellone 2008, 143). The discovery of the necropolis was accidental: in 1934, the chance discovery of the wellknown Capestrano statue brought about the beginning of archaeological research into the Iron Age of this territory (Moretti 1938; Salvia Del Rosario 1985, 165-174; Salvia Del Rosario 1992, 49-55). Several excavations were carried out at the necropolis after the Second World War: 1965 (Terrosi Zanco 1967) 1963-64 (Cianfarani 1976) 1973 Paola Piana Agostinetti from La Sapienza University of Rome in collaboration with Franca Parise Badoni 1979 Riccardo Tulipani, conservator of the Superintendence 1982 Sandra Gatti on behalf of the viii
English summary
the burials. In fact, the tombs tended to be placed on the margins, in the residual spaces with respect to previous ones, and taking into account the aggregation by lineages of descent. Regarding this, an excellent example is represented by the numerous “grotticella” tombs (21 in total), which are always placed a little apart from the earlier tombs, maybe a means of intentionally indicating the end of a familiar or clan lineage. Between the 1st century BC and the 1st century AD, when Romanisation of the territory occurred, everything changed: in the necropolis we now see a “cappuccina” grave, a series of cremation burials (36 in total), and two “chamber” tombs, containing funerary beds with decoration in bone, placed along the sacred street. The road axes represent the macroscopic symbol of a world that has expanded in extent: from the small territorial states (toutai) of the Iron Age to the global and cosmopolitan universe of the Roman Empire, where the Aufinum community lived.
metres: we thus see an average density of one burial every 12 square metres. Applying this density to the possible extension of the entire necropolis of around 390 hectares, it is possible to calculate a feasible total of 325,000 burials distributed across the 40 generations that occur between the 9th century BC and the 2nd century AD (the chronological range of use of the funerary site). This would suggest 8,125 burials per generation divided amongst infants, adults and the elderly of both sexes - perhaps not so far from reality. The central nucleus of the necropolis is included within the upper Y-shaped branches of the river Tirino: in this wide and triangular fluvial terrace are found the various investigated burial areas of Fossascopana, Capo d’Acqua, Fontanelle, Via Dell’Olmo along with those identified through “anomalies” on the surface at Monaresca and Macero Bucci. Given the current state of knowledge, it is possible to identify the oldest burials of the necropolis (9th-8th centuries BC) as being those at Vatormina and Presciano (Tomb 11). Only in the mature and late Orientalizing period (7th century BC) do the tombs, other than at Vatormina, expand to the central area of the necropolis (the so-called interfluvial triangle) with a few burials dispersed throughout the area: Tomb 134 and Tomb 178 (excavated in 2003 in Fossascopana) and two male burials, associated with each other, discovered in 2017 at Capo d’Acqua. In the Archaic age (6th century BC), the necropolis reaches its maximum expansion and splendour. All the burial areas were in use: Fossascopana, Fontanelle, Capo d’Acqua, Via Dell’Olmo, Vatormina, Church of Santa Maria di Presciano, Fonti di Presciano. The archaeological data demonstrate a funerary ritual with a standardised funerary assemblage: bronze vessels, metal tools for banqueting, high quality weapons, remarkably refined and decorated ceramic pottery, and Attic ceramics. Moreover, stone statues depicting the social élite were commissioned and erected. The apogee continues into the Classical age (5th century BC) but then changes in later times (4th2nd centuries BC), not with regard to the features and quality of funerary rituals, but, rather, in the choice of topographic location for
I.2. Topographic study of the Capestrano necropolis and aerial photographic analysis (S.L. Ferreri) The necropolis of Capestrano is located in the Tirino river valley, which constitutes a geomorphological unit located between the Navelli upland and the Gran Sasso mountain in a strategic position connecting the coastal zone and the interior mountain area of Abruzzo. The excavations conducted at the necropolis since 1934 have produced a substantial and complex body of cartographic data. A recent in-depth topographic analysis through a GIS approach attempted to realise a map in vector format (DXF and SHP), collecting every piece of archaeological data from excavation documentation and archival sources (Ferreri 2014). The methodology for positioning was adapted to the availability of site plans, especially originals, and the possibility of relating the information to regional or cadastral cartography or to aerial photography and georeferenced satellite images. In some cases, confirmation from oral sources has been decisive. A particular importance was given to the analysis of aerial photographs that contributed ix
Capestrano, I
characteristics or, rarely, decorative characteristics; see Peroni 1967; 1998). As will be seen below, the search for comparable materials has been mostly limited to a geographic area that largely corresponds to central Italy, with a particular focus on the Middle Adriatic area, and to the best known and most carefully published contexts. Amongst these, several publications form useful and necessary cornerstones – the Fossa (AQ) necropolis, the Iron Age to Late Archaic necropolis of Bazzano (AQ), Campovalano (TE) and Alfredena (CH) – while offering an updated chronological framework (Cosentino, d’Ercole and Mieli 2001; d’Ercole and Copersino 2003; d’Ercole and Benelli 2004; Weidig 2014; Chiaramonte Treré and d’Ercole 2003; Chiaramonte Treré, d’Ercole and Scotti 2010; d’Ercole, Martellone and Cesana 2016; Parise Badoni and Ruggeri Giove 1980; Parise Badoni et al. 1982; Parise Badoni 2002). To these we add work on other necropoleis of the Abruzzo region, only partially published, for example those on the Pescara area (Staffa 2001; 2003), Teramo (e.g. Atri, Baldelli and Ruggeri Giove 1992) or the southern coast Papi 1979; Staffa 2000). A useful summary of the Hellenistic period evidence in the Abruzzo area was put forward by Benelli and Rizzitelli (2010). A particularly useful context, at least partly as a result of its exhaustive publication, is that of the necropolis of Colfiorito di Foligno (PG), which presents substantial affinities with the culture of the inland Aquila area (Ponzi Bonomi 1997). The pre-Roman necropoleis of the Marche also offer numerous points of comparison, even if most of the published contexts from this area belong to a lightly more ancient period (see, for example, Silvestrini e Sabbatini 2008).
in a significant way to the discovery of the widespread presence of burials in the L’Aquila territory (Tartara 2008a; Ferreri 2016; Tartara 2016). Then a GIS database was created and populated with archaeological and territorial information. This allowed the production of a series of maps, published in this volume, focused on funerary evidence in the Capestrano area (Figg.1.351.44). Starting from multiple sources (archaeological, archival, cadastral, oral, aerial photographic, georeferenced satellite images), every sector of the necropolis is delineated in detail on the basis of the cartographic documentation available: Fossascopana, FossascopanaMonaresca (Tav. 1, n. 15; Tav. 1, n. 16), Macero Bucci (Tav. 1, n. 18), Monaresca-Via dell’Olmo (Tav. 1, nn. 12a-b), PizzoneFossascopana and Fontanelle (Tav. 1, nn. 11ab), Capo d’Acqua-Noce S. Ianni, Maragone (Tav. 1, n. 2b), Vaturnina (Tav. 1, n. 3a), Vignera di Capponi, Vicenne-Santa Maria di Presciano (Tav. 1, 22 e 24), Presciano, Presciano-Rajo (Tav. 1, nn. 26-27), Cesa, Valle Cursore (Tav. 1, nn. 28a-d). In this research, the topographic methodology included not only the use of technical instruments for positioning archaeological finds and elaborating a comprehensive cartography, but also promoted their contextualization in the territory in order to delineate the features of the funerary landscape in relation to settlement distribution, road patterns and resource exploitation. CHAPTER 2 Typological analysis of archaeological materials from the Capestrano necropolis (V. Acconcia) This chapter presents an overview of the materials from the Capestrano necropolis, originating from excavations ranging from those of 1934 through to the very recent campaigns. The approach is strictly typological, classifying materials into classes/forms/types with the addition, where necessary, of varieties and variants (these latter should be understood as isolated examples that are distinguished form the reference types by specific morphological
CHAPTER 3 Capo d’Acqua-Fossascopana: catalogue of the burials (V. Acconcia and D. Cesana) The catalogue includes the burial contexts investigated at Fossascopana in 2003, 2007, 2008, and 2009. Every tomb is described in-depth on the basis of available excavation documentation and the preserved archaeological and anthropological x
English summary
materials. Features and layout of the burial and the taphonomic data as documented in the field are provided for each tomb. Then, the anthropological data from the study of the human remains in the post-excavation phase and the archaeological data relating to the grave goods are described. In the case of absence of biological data, sex and age are hypothesised on the basis of cultural features. The measurements are expressed in cm. With regard to the funerary assemblages, their description follows an order based on functional class: 1) Pottery and bronze vessels, for the consumption, preservation and handling of food and beverages, for the preservation of oils and unguents and for lighting (classes AN-P); 2) Equipment for preparing and cooking foods, weaving and spinning tools (class Q); 3) Equipment for personal care (class R); 4) Ornaments (class S); 5) Weapons (class T). The archaeological finds are categorised according to the general typology (Chapter II), or are simply assigned to a class or shape, depending on their state of preservation. The technological characteristics of ceramic finds are described on the basis of observation of broken edges. Their completeness depends on the state of preservation of each piece: if a vessel is whole, the description of the fabric may only be partial. The archaeological and anthropological data described here represent an important source of information and form a solid basis for in-depth research across a significant range of themes. They are made available here so as to enable future students and scholars to further develop research and study regarding the necropolis of Capestrano.
xi
INTRODUZIONE AI VOLUMI SULLA NECROPOLI DI CAPESTRANO Per qualunque archeologo che, come me, si fosse accostato, alla fine degli anni settanta, alla problematica dei rituali funerari preromani dell’Abruzzo tre erano i punti di riferimento principali: le necropoli di Campovalano al nord, di Capestrano al centro e di Alfedena al sud. Grattando sotto la superficie si scopriva però che lo stato delle conoscenze e delle pubblicazioni non corrispondeva alla “fama” e notorietà dei siti in questione. Per Campovalano vi erano i recenti lavori, preliminari e non sistematici, di Valerio Cianfarani, per Capestrano si era rimasti a Giuseppe Moretti degli anni trenta, solo per Alfedena erano stati pubblicati, per volontà di Giovanni Scichilone, i recenti scavi (1975-79) condotti nella necropoli da Franca Parise Badoni e Maria Ruggeri Giove. Per tentare di sopperire a questo “vuoto” di conoscenze sistematiche Renato Peroni aveva creato due gruppi di studio per le necropoli di Campovalano e di Alfedena che, purtroppo, non riuscirono nell’intento. A partire dagli anni ottanta, dopo la morte di Cianfarani, la ripresa degli scavi a Campovalano, da parte di chi scrive, portò alla creazione di uno specifico museo archeologico a Campli (inaugurato nel 1988) e, negli anni compresi fra il 2003 e il 2016, all’edizione integrale della necropoli in tre volumi editi, ad Oxford, dai British Archaeological Reports International Series. Tra il 1994 e il 2011 l’eccezionale impulso alle ricerche archeologiche nel territorio aquilano dei Vestini Cismontani portò allo scavo e all’edizione completa, in tre volumi editi a Pescara, della necropoli di Fossa e, almeno per le fasi arcaiche (VIII-V sec. a.C.), di quella di Bazzano a L’Aquila, sempre in tre volumi, editi a Mainz. In questo quadro di “fervore” nei confronti dell’archeologia dei Vestini, sia Cismontani che Transmontani, rientra anche la ripresa delle ricerche e degli studi sulla necropoli e sull’abitato di Capestrano condotta a partire dal 2003. Se le ricerche sul campo debbono tanto agli enti locali, Regione Abruzzo e Comune di Capestrano, la conseguente attività di documentazione e di studio si basa molto su tesi di laurea e diplomi di dottorato espletati soprattutto all’Università “Gabriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara. Paradossalmente, dopo Cianfarani, la Soprintendenza d’Abruzzo non ha mai ritenuto il sito di Capestrano degno di interesse e di investimenti. In totale sintonia, come sempre, con gli editori dei BAR Publishing abbiamo deciso di suddividere in due volumi l’edizione degli scavi della necropoli: nel primo vengono illustrate, dopo una breve storia delle ricerche, le indagini condotte tra il 2003 e il 2009 nell’area centrale del cimitero, quella denominata come Fossascopana. Nel secondo volume verranno raccolti sia gli scavi più recenti (2010-2012), condotti anche fuori dall’area centrale del sepolcreto, che, per quanto ci è stato possibile, quelli effettuati dagli anni trenta agli anni novanta del secolo scorso: i cosiddetti “vecchi scavi”. Nei due volumi sono presenti gli approfondimenti di antropologia fisica e di demografia, a cura di Deneb Cesana, quelli di tipologia e seriazione cronologica dei manufatti archeologici, a cura di Valeria Acconcia e dei suoi collaboratori, oltre ad un mio contributo sulla problematica di statue, stele e menhir nelle necropoli medio-adriatiche. È responsabilità corale, mia, di Valeria e di Deneb, la “confezione” del tutto e soprattutto le conclusioni storiche che non pretendono di concludere nulla ma di portare un importante tassello alla storia dei popoli italici dando, finalmente, un contesto alla statua del guerriero di Capestrano: un vero “ritorno del Re”! Roma, 19 agosto 2017 Vincenzo d’Ercole
1
CAPITOLO I I.1. Le ricerche a Capestrano dal 1934 al 2012: la storia degli scavi e riflessioni sulle aree funerarie nella Piana di Capestrano Vincenzo d’Ercole determinanti che permetteranno al genere umano di non dipendere più, totalmente, dalla natura e dall’ambiente ma di divenire artefice del proprio destino. Almeno durante le fasi più antiche del Neolitico (6.000-4.500 a.C.) l’uomo continua ad abitare nella piana di Capestrano nei pressi dell’antico accampamento di Capo d’Acqua. È probabile che proprio la piana fosse il luogo deputato ad ospitare i campi in cui venivano coltivati i cereali mentre le sorgenti e le numerose pozze d’acqua, esistenti in loco accogliessero, sulle loro rive, il bestiame che veniva addomesticato ed allevato. I resti archeologici di questo periodo non sono più solo strumenti in pietra come ai tempi dell’accampamento mesolitico, ma vasi di terracotta decorati con unghiate ed incisioni geometriche: altro significativo portato delle nuove acquisizioni tecnologiche del Neolitico. Il villaggio neolitico di Capo d’Acqua venne indagato negli anni sessanta sempre dal team di paletnologi dell’Università di Pisa (Bonuccelli e Faedo 1968, 87) ma frammenti ceramici con decorazioni del neolitico antico si rinvengono ancora oggi nei terreni arati posti nelle vicinanze di Capo d’Acqua. La posizione del complesso di cavità cultuali (le grotte delle Marmitte, della Sacrestia e dell’Altare che si aprono, a 750 metri di quota sul livello del mare, sulle pendici di Monte Serra, in località Capranica), collocate all’inizio delle alture che delimitano la conca di Ofena (Grifoni Cremonesi 1969, 131-150), ci fa intravedere un primo segnale del limite che doveva circoscrivere il territorio della comunità che abitava a Capo d’Acqua. Allo stato attuale delle conoscenze non si hanno testimonianze archeologiche di presenze umane nel territorio di Capestrano per le fasi recenti del Neolitico (circa 4500-3500 a.C.) mentre, per quanto riguarda l’età del Rame (3500-2300 a.C.), conosciamo un frammento di ascia-martello in
La sede della grande necropoli dell’età del Ferro di Capestrano, oggetto del presente lavoro, è una estesa pianura alluvionale, posta ad una quota compresa fra i 340 e i 370 metri sul livello del mare, che è stata utilizzata fin dalla preistoria (Figg.1.1, 1.2). Con la fine delle glaciazioni wurmiane e con il passaggio tra quella che i geologi definiscono era Pleistocenica e l’ingresso nell’era in cui ancora viviamo, l’Olocene, si entra nel Mesolitico (XVIII millennio a.C.). Le comunità, costituite sostanzialmente da piccole bande di individui seminomadi, si adattano alle nuove condizioni climatico-ambientali integrando la caccia ai grandi mammiferi, in via di estinzione, con selvaggina di piccola taglia, uccelli e pesci e sviluppando la raccolta dei frutti spontanei della terra che diviene l’elemento base della loro alimentazione. Nel 1965, in occasione della realizzazione della diga destinata a sbarrare il corso superiore del Tirino poco a valle delle sue sorgenti, in località Capo d’Acqua, gli archeologi preistorici dell’Università di Pisa, guidati da Antonio Radmilli, effettuarono un saggio di scavo, oggi sommerso dalle acque del lago artificiale, di 3x3 metri che intercettò, a circa un metro e mezzo di profondità, i livelli mesolitici (Radmilli 1977, 235). Si dovrebbe trattare, malgrado la limitatezza dell’area indagata, dei resti di un accampamento stagionale collocato sulle rive del lago che, allora, esisteva nella Conca di Ofena (Tozzi 1966, 13). A giudicare dagli animali cacciati (cervo, bue) è ipotizzabile la presenza di ampie foreste intorno agli alvei lacustri mentre la caccia allo stambecco doveva avvenire in quota, sulle montagne circostanti, con le prede portate a valle e consumate nell’accampamento sulla piana, vicino all’acqua. Nel VII millennio a.C. è attestata, in tutta l’Italia centromeridionale, l’introduzione dell’agricoltura e dell’allevamento, fattori 3
Capestrano, I
pietra rinvenuto, sporadicamente, da chi scrive, nel terreno agricolo che copriva le tombe dell’età del Ferro scavate, nell’anno 2010, in località Presciano1. Forse allo stesso periodo ma con maggiori incertezze cronologiche vista la tipologia meno specifica e diagnostica rispetto alle asce da battaglia, potrebbe essere attribuita una punta di freccia in selce grigia con peduncolo ed alette pronunciate rinvenuta, non in giacitura primaria, nel corso degli scavi effettuati, nel 2003, nella necropoli di Capestrano in località Fossascopana-Cinericcio (d’Ercole 2015a, 99-111). Il quadro delle testimonianze archeologiche si amplia con l’età del Bronzo (2300-1000 a.C.): dalla fine dell’ottocento è “noto” infatti un ripostiglio composto da 11 o 12 asce in bronzo a margini rialzati (una delle quali del tipo San Lorenzo in Noceto) riferibile alle fasi di passaggio fra l’antica e la media età del Bronzo (Montelius 1895-1910, II, 1, col. 581; Peroni 1971, 248). Un’altra ascia di bronzo, sempre del tipo a margini rialzati, è stata rinvenuta dalla signora Iva Polscina senza precise indicazioni di provenienza (Fig. 1.5) mentre un frammento ceramico decorato in stile “appenninico”, con losanghe contrapposte campite a punteggio, riferibile quindi alla fase finale della media età del Bronzo (1500-1350 a.C.), è stato rinvenuto, in superficie, sui terreni arati, durante le ricognizioni che precedettero, nell’anno 2003, gli scavi nella necropoli di FossascopanaCinericcio. Quello che appare evidente dal quadro, sia pure sommario, sopra esposto è che durante tutto l’arco della preistoria la pianura di Capestrano è stata usata come sede dell’insediamento, sia stabile che provvisorio come nel Mesolitico, e come ambiente da cui trarre le necessarie risorse alimentari: la caccia e la raccolta prima l’agricoltura cerealicola dopo (Neolitico-Bronzo). Questa situazione cambia radicalmente nel I millennio a.C. (età del Ferro) quando l’intera
pianura viene sottratta agli usi agricoli per divenire la sede di un millenario cimitero. È stato proposto da tempo che sul finire dell’età del Bronzo le comunità abruzzesi, soprattutto quelle dell’area montana appenninica, abbandonassero la poco redditizia cerealicoltura che potevano praticare nelle loro, non numerose, pianure (generalmente poste a quote piuttosto elevate) per concentrare le attività economiche2 e produttive nell’allevamento del bestiame con la pratica della transumanza verticale (d’ErcoleMartellone 2008, 143). In questo il territorio aquilano è particolarmente favorito vista la presenza di ampi pascoli in quota, sia sugli altopiani del Velino Sirente a sud-est che in quelli del Gran Sasso a nord-ovest, da utilizzare nei mesi estivi che, a breve distanza, della pianura centrale necessaria per il pascolo invernale. In realtà la pianura centrale è composta da almeno tre terrazzi: quello propriamente aquilano (posto a quota maggiore), quello di Navelli, intermedio, al centro e, appunto, quello di Capestrano-Ofena collocato alla quota più bassa sul livello del mare (Fig. 1.3). Il rinvenimento casuale nel 1934 della cosiddetta statua di Capestrano costituisce il punto di inizio delle ricerche archeologiche relative all’età del Ferro nel territorio in esame (Moretti 1938; Salvia Del Rosario 1985 vedi anche, 19 e il II Volume di questo lavoro) (Figg. 1.6, 1.7). Quasi tutti conoscono la “storiella”: un contadino del luogo, Michele Castagna, impiantando un vigneto, nel mese di settembre, nel suo terreno, trovò la statua rotta in due pezzi; in conseguenza di ciò, nel dicembre seguente, l’archeologo Giovanni Annibaldi (futuro Soprintendente alle Antichità dell’Abruzzo, del Molise e delle Marche) condusse, per conto della Regia Soprintendenza alle Antichità di Roma, allora competente per territorio, una campagna di scavi (nel terreno di
1
2
Un altro frammento di ascia-martello in pietra, di età eneolitica, mi venne mostrato, in occasione di una conferenza da me tenuta a Capestrano, dalla signora Iva Polscina, senza una specifica indicazione di provenienza. Appare evidente, pur nell’assoluta sporadicità ed “inconsitestenza” dei ritrovamenti riferibili all’età del Rame, che la presenza di due asce martello e di una punta di freccia fanno pensare più a dei corredi tombali che non a dei contesti di abitato.
La capacità di “condizionare” una scelta economicoproduttiva così radicale come l’abbandono dell’agricoltura (con le conseguenti certezze di autosostentamento) implica l’esistenza di un “potere” ben saldo e riconosciuto; alla stessa leadership (di tipo protostatale?) spettava anche il difficile compito di gestire il capitale comune, composto dalle grandi greggi, probabilmente, ancora, di proprietà collettiva, delle tribù o dei clan e non dei singoli individui.
4
Le ricerche a Capestrano dal 1934 al 2012
Castagna) che portò al ritrovamento dell’elmo mancante, della statua femminile 3 e di 33 sepolture tra quelle a fossa (28) e ad incinerazione (Moretti 1936-1937, 94). L’area di scavo, di forma grosso modo rettangolare (20x30 metri), si estendeva per circa mq 600; le incinerazioni (5) erano allineate a circa 10 metri di distanza a nord dell’asse stradale antico. Le tombe a fossa risultavano in file allineate fra loro, con un andamento che sarà poi ripreso da quello della via glareata ascrivibile al periodo romano (vedi, 20) ed erano orientate verso est tranne la tomba 3, l’unica che presentava, sul lato sinistro della fossa, un loculo laterale. Come esplicitato più avanti tre o quattro tombe erano disposte a raggiera intorno alla sepoltura n. 3. Nel dicembre del 1934 furono rinvenuti (sempre per lavori di impianto di un vigneto), in Contrada Raio, nella proprietà di Francesco Trecca, anche dei resti murari e un capitello con testa leonina: un mausoleo d’età romana? Una seconda campagna di scavo (purtroppo mai pubblicata), di estensione più limitata della precedente (250 mq?), di forma quadrangolare, posizionata sul margine ovest dello scavo del 1934, venne effettuata nell’anno 1937 (giugnoagosto) nelle proprietà di Giovanni Alleva, Lorenzo Stella e Ernesto Sensini, ancora da Annibaldi, fruttando (oltre al rinvenimento di 14 sepolture a fossa e, forse, una ad incinerazione) il reperimento “dei basamenti di altre due statue” andati poi dispersi4. Tutto ciò si evince da una relazione dello stesso Annibaldi, redatta nella sua qualità di Soprintendente alle Antichità dell’Abruzzo e del Molise, scritta il 4/9/1940 e conservata negli archivi della Soprintendenza oggi Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Chieti. Le due “nuove” statue, “della stessa pietra e dello stesso stile di quelle già rinvenute”, furono portate alla luce il 23 giugno del 1937: la prima, di dimensioni
maggiori, conservava i piedi e l’attacco dei pilastrini laterali “con tracce di lettere per quello di destra; la seconda più piccola sembra appartenere al torsetto muliebre già scoperto”. Purtroppo di queste due porzioni di statue si è persa ogni traccia né esistono immagini di alcun tipo: ignoriamo se esse siano state lasciate in deposito, dopo lo scavo, a Capestrano oppure, più verosimilmente, trasportate a Roma insieme ai corredi tombali e lì ignorate e dimenticate nei magazzini della Soprintendenza di Roma e il Museo di Villa Giulia dove sono pervenuti, sia pure privi di indicazioni di provenienza, gli altri reperti archeologici (Fig. 1.8). L’apparente assenza di tumuli nella necropoli di Capestrano pone anche il problema del posizionamento delle statue in pietra: infatti sia in Europa che nel resto d’Italia si è sempre dato per scontato che le statue sormontassero il sepolcro venendo poste cioè a coronamento dell’elevato del tumulo stesso. In Abruzzo sono stati trovati in situ (e cioè come li avevano collocati gli antichi) i menhir (stele in pietra non rifinite) nelle necropoli di Fossa e Bazzano fra i Vestini, a Celano e Scurcola Marsicana fra gli Equi, a Pizzoli fra i Sabini: in tutti questi casi (tranne la tomba 3 di Celano, la più antica della serie) i menhir sono allineati in fila e collocati fuori dal tumulo, appoggiati alla sua crepidine (il cerchio di pietre che delimita la tomba) generalmente sul lato occidentale, quello del tramonto del sole5 (d’Ercole e Cella 2007a, 32-45). A Capestrano sono state portate alla luce almeno tre o cinque statue (permangono i dubbi sull’autenticità della statua venduta nel 1992 a New York e sulla effettiva pertinenza della base minore rinvenuta nel 1937 al torsetto femminile portato alla luce nel 1934), di differenti dimensioni, la maggior parte delle quali rinvenute nella stessa, ristretta, area; è possibile, a mio avviso, ipotizzare che le statue fossero poste in opera, allineate in ordine decrescente, ai margini occidentali del tumulo, andato distrutto, che racchiudeva la sepoltura del Re
3
La porzione residua della statua femminile, realizzata dalla stessa mano (Aninis?) che ha effigiato il guerriero di Capestrano, sia che rappresenti la moglie o, più probabilmente, la giovane figlia del Re Nevio, rappresenta l’unica testimonianza sinora nota in Abruzzo, di una figura muliebre considerata degna di essere scolpita nella pietra e, quindi, per l’eternità: la regina o la principessa dei Vestini. 4 E qui mi pare che la maledizione archeologica di Capestrano raggiunga il suo culmine: “perdersi” due statue su quattro non è da tutti!
5
In quasi tutte le sepolture d’età orientalizzante-arcaica del territorio Vestino Cismontano si riscontra come la testa dei defunti venisse posizionata ad est, verso il sorgere del sole e l’inizio della vita; mentre i piedi sono ad ovest, la direzione del tramonto del sole e, quindi, della fine della vita, la morte.
5
Capestrano, I
orciolo, ed un altro, probabilmente, ad una donna: fibula e il secondo vaso. Il nucleo sepolcrale di Vatomina non si esaurisce nel corso della prima età del Ferro ma come testimoniano gli altri reperti sequestrati (oggi conservati nei depositi del Museo della Preistoria di Celano-Paludi) prosegue in epoca tardo-orientalizzante/arcaica, 700-450 a.C., (pugnali e punte di lancia in ferro, gancio di cinturone in bronzo del “tipo a grata”, kantharos in bucchero etrusco) fino a giungere al periodo italico/ellenistico, 350-150 a.C. con un delicato balsamario-alabastron in vetro policromo blu e giallo (Martellone 2010a, 308327) (Fig. 1.12). Dopo la seconda guerra mondiale furono condotti, con motivazioni diverse, alcuni scavi nella necropoli: nel 1965 vennero portate alla luce tre sepolture d’età arcaica (ma ne furono individuate almeno sette) in località Capo d’Acqua in seguito agli scavi, a carattere preistorico, condotti dall’Università di Pisa (Terrosi Zanco 1967, 320). In occasione della costruzione della strada provinciale 153, Valle del Tirino, furono indagate, dalla Soprintendenza alle Antichità dell’Abruzzo e del Molise, negli anni 19631964, undici sepolture, a tutt’oggi inedite, quattro delle quali riferibili alla fase arcaica, cinque al periodo italico-ellenistico e due all’età romano-imperiale (Cianfarani 1976, 62). Si dovrebbe trattare di due piccole aree, una di forma quadrangolare (50 mq circa) l’altra, più grande (150 mq circa), con perimetro trapezoidale, posizionate ad est degli scavi Annibaldi; una, quella trapezoidale, sempre a monte della via interpoderale (come gli interventi degli anni trenta), mentre l’altra, quella quadrangolare, per la prima volta, a valle. Nel 1973 Paola Piana Agostinetti, dell’Università la Sapienza di Roma, in collaborazione con Franca Parise Badoni, funzionario della Soprintendenza dell’Abruzzo, proseguì le ricerche nella stessa area (probabilmente ad ovest dello scavo del 1934 e a valle della strada bianca nota come via di Fossascopana) portando alla luce tre tombe a grotticella scavate nel banco con i corridoi di accesso rivolti verso l’asse stradale antico e due sepolture a fossa, purtroppo, anche in questo
Nevio Pompuledio, la tomba 3 (vedi il II Volume di questo lavoro) (Figg. 1.9-1.11). Sempre nel 1937 un contadino consegnò un piccolo vaso cilindrico contenente 184 monete in argento, dei vittoriani romani, del 218/217 a.C. rinvenuti in località Fossascopana o Fossacapanna (Cesano 1938, 20). Senza conoscere le precise circostanze del rinvenimento risulta impossibile stabilire con certezza se si trattasse di un ripostiglio, un tesoretto magari nascosto da un mercenario, oppure, visto il luogo di ritrovamento, un’offerta, un dono a carattere funerario: certo tentare di nascondere qualcosa in un luogo sempre frequentato e continuamente oggetto di scavi per realizzare tombe come una necropoli in piena attività appare quanto mai illogico! Nel frattempo gli abitanti del luogo, certamente spinti dal desiderio di guadagno “facile”, derivanti da premi di rinvenimento da parte dello stato italiano o da vendite illecite sul mercato antiquario, andavano scavando nei loro terreni saccheggiando sepolture e disperdendone i contesti di provenienza come testimoniano i sequestri operati dai Regi Carabinieri ai signori Vincenzo Visione e Nunzio D’Antoni. Mentre in questi casi l’area coinvolta negli scavi abusivi era sempre circostante quella di Michele Castagna (località Fossascopana o Cinericcio), nel caso di Demetrio Matteucci il “vero scempio di tombe, compiendo manomissioni irreparabili di materiale di notevole interesse” fu effettuato in un’altra zona, in località Vatomina, Vatormina o Vaturnina (vedi, 28). Proprio tra il materiale qui recuperato nel 1940 vi sono i reperti più antichi che testimoniano l’inizio della storia della necropoli fra IX e VIII secolo a.C. (900-700 a.C.). Si tratta, nello specifico, di una spada corta in ferro (Cosentino, d’Ercole e Mieli 2003, 37) sul tipo di quelle trovate, successivamente, nella necropoli di Fossa (Cosentino, d’Ercole e Mieli 2001), di una fibula in bronzo ad arco serpeggiante con occhielli e staffa a disco di lamina, di due orcioli in ceramica uno dei quali con tre bugne sul punto di massima espansione (Cella 2012, 57-105). A giudicare dal materiale residuo si dovrebbe trattare di almeno due corredi funebri uno riferibile ad un maschio, quello con spada ed 6
Le ricerche a Capestrano dal 1934 al 2012
caso, rimaste inedite6. Interessante la presenza, all’interno di una tomba a grotticella, di una deposizione infantile collocata fra due coppi contrapposti rituale che, come diverrà evidente a partire dagli scavi delle necropoli di Fossa e Bazzano del 1992, costituisce una peculiarità culturale del territorio vestino cismontano (d’Ercole 2014, 29-61) (Figg. 1.13, 1.14). Nel 1979, in occasione di lavori di canalizzazione condotti dal Consorzio di Bonifica dell’Alto Tirino, furono portate alla luce, da Riccardo Tulipani restauratore della Soprintendenza, quattro tombe realizzate con blocchi di pietre di riutilizzo, di epoca “tardo-imperiale”, in località Campo Morto ai margini orientali della piana di Fossascopana. Nella stessa occasione si rinvennero una sepoltura analoga (con lastre di pietra) ed una tomba a cappuccina in località Presciano7. Un sopralluogo condotto nel 1982 da Sandra Gatti, per conto della Soprintendenza dell’Abruzzo, portò all’identificazione di due tombe a grotticella, già saccheggiate e semidistrutte, in località Santa Pelagia molto distanti, a nord ovest dell’area della necropoli8.
Nell’estate del 1992 furono effettuati dei lavori per la realizzazione di un acquedotto9, in quella occasione il funzionario della Soprintendenza dell’Abruzzo, Alessandro Usai, esplorò tre sepolture10, tra cui una deposizione femminile d’epoca arcaica, nell’area compresa fra la stazione di sollevamento di Capo d’Acqua e la centrale in località il Lago, individuando, sulle pareti della trincea, numerose strutture d’età neolitica (non indagate) e recuperando otto frammenti del rivestimento in osso di un letto funebre (Usai 1993, 299). Il 2003 costituisce l’anno di svolta nella storia delle ricerche archeologiche a Capestrano: è da allora infatti che hanno inizio le indagini, che ancora proseguono annualmente, nell’abitato di Colle Sant’Antonino (o Sant’Antimo) 11 condotte dall’Università Gabriele D’Annunzio di Chieti-Pescara e dirette da Emanuela Fabbricotti prima e da Oliva Menozzi poi, e, gli spazi vuoti che intervallavano e scandivano i settori utilizzati a scopo funerario purtuttavia è una cifra, apparentemente enorme per l’Abruzzo, ma che non si dovrebbe discostare troppo dalla realtà di un cimitero di un central place poi città come Aufinum in uso per circa mille anni (IX sec. a.C.-I sec d.C.). 9 Nel dicembre dello stesso anno la sede di New York della casa d’asta Sotheby’s ha venduto, per un prezzo di 231.000 dollari, un torso in pietra del tutto simile, almeno a giudicare dalle foto, di minori dimensioni, alla statua del guerriero di Capestrano con indicazioni di provenienza “central Italy”: coincidenza? 10 Dai dati, invero assai pochi, disponibili per gli scavi condotti a Capestrano negli anni compresi fra il 1934 e il 1992 si può dedurre che siano state individuate 85 sepolture in un’area indagata sicuramente superiore ai mille metri quadrati ma, verosimilmente, inferiore ai duemila. 11 Il sito venne identificato come sede di insediamento negli anni 1962-63 durante una serie di ricognizioni, fortemente volute dal Soprintendente Valerio Cianfarani e condotte, fra gli altri, da Ranuccio Bianchi Bandinelli dell’Università di Roma, da Silvio Ferri dell’Università di Pisa, da Antonio Giuliano dell’Università di Genova. In quella occasione venne anche notato l’asse stradale che univa l’abitato alla necropoli. Il mio primo approccio con il sito dell’antica Aufinum avvenne nel 1989 quando, con il Soprintendente dell’epoca, Giuseppe Andreassi e con il collega, geologo, Silvano Agostini facemmo un sopralluogo per verificare l’impatto sui resti archeologici delle cave aperte su Colle Lungo: identificammo testimonianze di un abitato antico nelle propaggini meridionali del colle (nella zona nota come Sant’Antonino) che provvedemmo, quindi, a delimitare, preservare e tutelare ma nessun resto archeologico ci permise di intervenire sul resto dell’altura.
6
Un’altra delle “maledizioni” che colpisce la necropoli di Capestrano è costituita dal fatto che molte delle ricerche che si sono effettuate sul sito siano rimaste inedite e, quindi, sconosciute ed inutilizzabili; si fa prima a citare le poche campagne di scavo pubblicate: quella, iniziale, del 1934 e quella, a Capo d’Acqua, del 1965. Neanche di queste però si dispone di planimetrie, di disegni e catalogo degli elementi di corredo trovati nelle 36 sepolture totali. 7 Nel 1938 erano stati rinvenuti, nella medesima località, in un terreno di proprietà di Maria Celli, alla profondità di 80 cm, dei resti umani e “un piatto porta-profumi ed altri vasetti rotti” mentre nelle Notizie degli Scavi del 1894, alla pagina 407, è ricordato il rinvenimento di un’epigrafe. 8 L’individuazione del nucleo sepolcrale, tardo, di Santa Pelagia che costituisce (allo stato attuale delle conoscenze) il margine occidentale della necropoli permette di circoscrivere un perimetro grossomodo “triangolare” all’interno del quale sono comprese tutte le tombe finora note a Capestrano. Gli altri punti fermi utilizzabili come limiti, vertici e “confini” dell’impianto sepolcrale sono Capo d’Acqua a nord e Presciano a sudest: da ciò si evince un comprensorio di 3.350 metri in senso est-ovest (da Santa Pelagia a Presciano) per 2.330 in direzione nord-sud (da Presciano a Capo d’Acqua) che si estende per circa 390 ettari. Naturalmente nessuno pensa che tutta l’area interessata dalla presenza del sepolcreto fosse interamente e densamente occupata dalle tombe: come si è visto con gli scavi 2003 numerosi sono 7
Capestrano, I
fino all’anno 2011, le ricerche nelle aree di necropoli coordinate da chi scrive in qualità di funzionario di zona della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo (Fig. 1.4). Le decennali ricerche sull’insediamento posto sulle propaggini meridionali di Collelungo hanno rivelato la presenza di buche per l’alloggiamento di pali lignei per sostenere le capanne “protostoriche” non meglio definibili cronologicamente, collocate su uno dei terrazzi artificiali che rendevano “gradonato” il pendio sud-est dell’abitato difeso da un triplice circuito murario (Spanu 2004, 381-392; Menozzi e Fossataro 2011, 476; Menozzi e Di Antonio 2014, pp. 288-297; Menozzi et al. 2014, 265290). Gli scavi nella necropoli vennero condotti grazie ad un progetto europeo denominato “Equal-Terra dei guerrieri”, coordinato da chi scrive e da Roberta Cairoli con la società Archeores 12 che portò al rinvenimento di 77 (dal numero 100 al 192) contesti sepolcrali13 in un’area, complessiva, indagata di circa 2.000 mq, al restauro e alla documentazione, effettuata nei laboratori del Museo di Preistoria di Celano, dei materiali emersi. In considerazione dell’assenza di planimetrie generali della necropoli di Capestrano e dell’incessante lavoro di scavo (sia legale che non) condotto nei 70 anni precedenti (19342003) nella stessa area di Fossascopana decisi di realizzare numerose trincee esplorative e di aprire diversi saggi di scavo per verificare lo
stato dei luoghi, definire l’attendibilità stratigrafica, la consistenza dei depositi, il livello di “disturbo” e manomissioni, i “pieni” e i “vuoti”. I Saggi A (200 mq), E (100 mq) ed F (100 mq), situati ad ovest del centro della necropoli (identificato con lo scavo del 1934 e il rinvenimento delle statue), non diedero nessun risultato archeologico costituendo, allo stato attuale delle conoscenze, un limite, quello occidentale, dell’area sepolcrale (vedi, 23-24). Un altro limite (o, almeno, spazio vuoto, privo di seppellimenti) è quello nord-ovest dove è stata aperta una vasta area di scavo, denominata B (500 mq) in cui si sono state identificate delle fosse disposte a raggiera, probabilmente dovute a delle lavorazioni agricole. Altre tre piccole trincee, prive di denominazione (due a monte ed una a valle della strada interpoderale), sono state aperte sul lato orientale dello scavo del 1934 rivelando come il relativo sottosuolo fosse stato ampiamente manomesso dai contadini e dai cacciatori di tesori. Infine sono stati esplorati due settori, il Saggio C a valle della strada e il Saggio D a monte, che sono stati indagati esaustivamente (vedi, 23 e il par. III.1 di questo volume) (Figg. 1.15, 1.17). Il primo misura, approssimativamente, 15x30 metri per un’area di quasi 500 mq; al suo interno sono state portate alla luce 25 sepolture, di cui 14 a inumazione in fossa, 8 a grotticella e 3 sotto coppo, di cronologia compresa fra l’età arcaica e quella tardo ellenistica (VI-II sec. a.C.). L’elemento più interessante è certamente rappresentato dalla disposizione sul terreno delle sepolture: infatti quello che sembra mancare, nella necropoli di Capestrano, sono le tombe a tumulo probabilmente, come per molte altre necropoli abruzzesi, a causa del limitato interro (i tumuli e le deposizioni più antiche erano poggiati sulla superficie del paleosuolo dell’età del Ferro) compromesso dalle arature con mezzi meccanici operate a partire dagli anni ‘5014. Le uniche, possibili, tracce della presenza di tumuli sono un gruppo di 7 tombe,
12
Il progetto fu finanziato dall’Unione Europea, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalla Regione Abruzzo, dall’Università de L’Aquila e dal Comune di Capestrano. Tra i 26 archeologi che presero parte agli scavi e alla documentazione dei reperti vanno citati Silvia D’Alessandro, Marta Baumgartner, Elisa Cella, Gianfranco Mieli, Serena Cosentino, Mauro Garofalo, Chiara Esposito, Marianna D’Ovidio. 13 Non conoscendo l’esatto numero di sepolture portate alla luce prima del 2003 nella necropoli di Capestrano decisi, per non creare troppa confusione per i posteri, di cominciare da 100 la numerazione delle tombe (ampliando di poco, per eccesso e maggiore sicurezza, la cifra esatta, 85). Malgrado il mio tentativo, carico di buone intenzioni, credo che Capestrano sia la necropoli con il maggior numero (10?) di tombe numero 1: ogni scavatore ha ricominciato la numerazione dei contesti sepolcrali, ogni volta, dall’inizio come se l’elemento significativo e di distinzione non fosse il sito di appartenenza ma l’archeologo che via via si trovava ad operare nell’area.
14
Non a caso la maggior parte dei contesti funerari abruzzesi relativi alla prima età del Ferro-orientalizzante antico (X-VIII sec. a.C.) sono stati portati alla luce fra la fine dell’ottocento e la prima metà del novecento quando l’aratura meccanica non aveva portato a termine la sua opera di “distruzione di massa”: illuminante, in tal senso, il caso del territorio teramano (di Gennaro e d’Ercole 2017, pp. 71-96).
8
Le ricerche a Capestrano dal 1934 al 2012
tumulo del Re fosse collocato in una posizione “significativa” nella pianura di Capestrano ce lo conferma la contiguità con il passaggio della via sepolcrale 15 che metteva in comunicazione il centro abitato con l’area cimiteriale. Un terzo, eventuale, tumulo potrebbe essere quello identificato, nel 2012, in località Fontanelle, di una decina di metri di diametro, in uso da prima dell’età arcaica fino a quella italico-ellenistica. Del tutto diversa appare la distribuzione delle sepolture nel Saggio D un’area rettangolare indagata per circa 400 mq (circa 15x25 metri) in cui sono state portate alla luce 51 sepolture, a stretto contatto l’una con l’altra, dei tipi a inumazione in fossa (41), a grotticella (3), all’interno di coppi (1) e a incinerazione (7), di cronologia compresa fra il VII a.C. e il I sec. d.C. Sul margine sud dell’area di scavo è stato individuato un tratto dell’antica strada pavimentata a ciottoli, già venuta alla luce nelgli scavi Annibaldi del 1934; la viabilità antica corre, pressappoco, sotto la strada bianca, interpoderale, nota come via di Fossascopana. Proprio la vicinanza con la via sacra potrebbe aver dato origine all’alta densità e al sovrapporsi delle sepolture: costituiva, infatti, elemento di “prestigio” e di visibilità sociale essere sepolti lungo il percorso nel quale si svolgevano i cortei funebri dalla città dei vivi a quella dei morti. Risulta molto evidente, nel Saggio D, come le sepolture siano molto strette e fitte nelle immediate vicinanze della strada e di come si vanno rarefacendo man mano che ci si allontana da essa. Non solo, sul lato nord del saggio, le tombe diminuiscono di numero ma lì vengono realizzate le tombe a grotticella che, in genere, testimoniano l’ultima fase di utilizzo di
ellenistiche, a grotticella che si dispongono a intorno ad uno spazio circolare, di circa 12 metri di diametro, per la maggior parte vuoto, tranne una fossa arcaica (tomba 112) non posizionata al centro (d’Ercole e Cella 2007b, 111), alcune tombe a fossa disposte a semicerchio intorno a quella del guerriero (tomba 3; d’Ercole 2000, 43), ed un raggruppamento di sepolture individuato negli scavi condotti nel 2012 in località Fontanelle (Acconcia e Di Sabatino 2016, 156-159). Si potrebbe leggere il record archeologico riscontrato nel 2003 nel Saggio C come dovuto all’impianto di una tomba a tumulo (di 12 metri di diametro) con deposizione centrale, non in fossa, andata perduta così come la crepidine, in pietre, del monumento funerario; all’interno del tumulo, impiantato fra VIII e VII secolo a.C., si depone, in età arcaica, la tomba a fossa 112 con un ricco corredo di armato che funge da terminus post quem per la sepoltura originaria più antica ormai distrutta (Figg. 1.18-1.20). Nel corso del VI e, forse, del V secolo a.C. vengono realizzate tre tombe a fossa che si dispongono, con andamento anulare, sul margine nord-est del tumulo. La memoria del personaggio sepolto al centro del tumulo perdura fino al II secolo a. C quando vengono realizzate almeno sette tombe a grotticella, monosome, che si dispongono in modo radiale intorno all’antico sepolcro circolare enfatizzandone, ancora di più, la rilevanza. Tra queste si segnala quella di una madre defunta (tra i 30 e i 34 anni di età) per una gravidanza, di 7-8 mesi, non portata a termine, con deposto, a lato della gamba sinistra, un maiale tagliato a pezzi: la tomba 172 (Figg. 1.21, 1.22). La disposizione “radiale” di quattro tombe a fossa arcaiche (tombe 12-15) e “l’eccentrico” orientamento della tomba 3 (rivolta a nord mentre, di regola, le sepolture vestine cismontane sono orientate ad est, verso il mare) (d’Ercole e Martellone 2007a, 17-38), ci permettono di ipotizzare la presenza di un altro tumulo andato distrutto, che poteva racchiudere la sepoltura del Re Nevio Pompuledio (La Regina 2010, 230-273). Anche il presumibile diametro del tumulo (circa 15 metri) ben si accorderebbe con il range dei sepolcri monumentali abruzzesi dell’epoca: 18 metri per la tomba 300 della necropoli di Fossa, 25 metri per la tomba 2 di Campovalano. Che il
15
Addirittura nella sua sistemazione più recente, quella di età imperiale, la strada intercetta il tumulo reale tagliandolo in parte nel suo settore meridionale. Dall’anno 2003 è in atto una collaborazione con i Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale e il gruppo elicotteri di Pratica di Mare per il monitoraggio delle attività di tutela archeologica in provincia de l’Aquila (Tartara 2007, 448-564; Tartara 2008a, 163-194) Tale attività ha portato all’identificazione, dall’alto, di numerose e sconosciute necropoli vestine (Varranone a Poggio Picenze, Peltuinum, Navelli, San Demetrio nei Vestini, ecc.); per quanto attiene Capestrano le si deve l’identificazione del nucleo sepolcrale di Presciano (poi parzialmente indagato nel 2009) e l’ampliamento della necropoli verso Capo d’Acqua come identificato nel volo effettuato in data 23 giugno 2011. 9
Capestrano, I
protrattosi negli anni 2007 e 200818, interessò un’area prossimale al Saggio D indagato nel 2003, sul lato orientale di questo; si tratta di un settore, di forma rettangolare, di 25x50 metri per un’area di circa 1.250 mq collocato a monte della strada bianca interpoderale (vedi, parr. III. 2-3 di questo volume). Nell’area indagata vennero portate alla luce 90 sepolture del tipo a fossa ed una a grotticella per un arco cronologico compreso fra il VII e il II secolo a.C. (dalla tomba 194 alla 284). La distribuzione sul terreno delle sepolture indagate non sembra fornire molti elementi di lettura a parte l’evidente concentrazione delle sepolture più recenti (IV-II sec. a.C.) nella zona occidentale dell’area di scavo compresa, naturalmente, la tomba a grotticella, infantile, 214. Le sepolture a fossa tardoorientalizzanti/arcaiche, a parte un’evidente “ricchezza” nei corredi funebri, non offrono spunti interpretativi tranne, forse, per un gruppo di esse, posizionate sul margine orientale dello scavo (quello con minore interro e più soggetto a scavi clandestini) che potrebbero essere state inserite in un tumulo (di una decina di metri) di cui manca, come al solito, la deposizione
un settore di necropoli: le piccole “camere” ipogeiche, incavate nel terreno, chiudono, presso i Vestini Cismontani, un ciclo di vita di un gruppo familiare o di una linea di discendenza (ghenos). L’assenza di tombe nel Saggio B (circa 500 mq) ci mostra che il limite massimo in cui erano realizzate sepolture nella necropoli di Capestrano, sul lato a monte della via sepolcrale, era di 40 metri: infatti il contiguo scavo del 1934 ci mostra seppellimenti effettuati fino a 20/25 metri di distanza dalla strada. È probabile, quindi, che solo una fascia di 30 metri a nord della via sepolcrale venisse utilizzata come luogo di sepoltura: a partire almeno dai 40 metri di distanza il terreno della pianura (almeno in quel settore della necropoli) non era “sacro” e destinato ad ospitare i defunti. Un elemento che emerse con gli scavi del 2003 fu la prerogativa che vede la presenza, durante il periodo italico-ellenistico (IV-II sec. a.C.), di tombe a fossa con un “ripostiglio” (una sorta di “buchetta”, Figg. 1.23-1.26) ricavato in una parete laterale in cui viene deposto il servizio potorio: un’olla ed uno skyphos a vernice nera (si veda il caso, emblematico, della tomba 144, una deposizione femminile di 25-34 anni di età alla morte, portata alla luce nel Saggio C). Dopo una pausa di 5 anni nelle ricerche sul campo la rinnovata Amministrazione Comunale di Capestrano decise di investire nella ricerca archeologica incaricando la Cooperativa Vestea 16 de L’Aquila di effettuare scavi nella necropoli sotto la direzione di scrive e il controllo della Soprintendenza ai Beni Archeologici dell’Abruzzo 17 . Lo scavo,
Soprintendenza alle Antichità degli Abruzzi e del Molise con a capo Giovanni Annibaldi sostituito, nel dopoguerra, da Valerio Cianfarani (due archeologi particolarmente attivi a Capestrano). Nel 1975, con la nascita del Ministero dei Beni Culturali, venne istituita la Soprintendenza per Beni Archeologici dell’Abruzzo di cui fu a capo, fino al 1988, Giovanni Scichilone al quale seguirono numerosi altri (M. A. Fugazzola Delpino, G. Andreassi, M. R. Sanzi Di Mino, A. M. Bietti Sestieri, S. Balbi De Caro, R. Poggiani Keller, A. Pessina) fino al 2016, quando gli uffici territoriali vennero accorpati per competenze e “spezzettati” sul territorio divenendo, nel nostro caso, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio de L’Aquila e cratere, in un caso e di Chieti e dell’Abruzzo fuori del cratere del terremoto del 2009, nell’altro, diretta, quest’ultima, da Francesco di Gennaro probabilmente l’ultimo Soprintendente archeologo dell’Abruzzo. 18 A partire dall’anno 2008 il materiale archeologico emerso dagli di scavi effettuati a Capestrano fu depositato nella sede comunale dove furono attrezzati, a carico del Comune, dei depositi differenziati per classi e tipologie di materiali (resti antropologici, corredi funerari, mosaici, resti lapidei) e dei laboratori di pronto intervento. Nell’anno successivo, in seguito agli eventi sismici dell’aprile 2009, la Soprintendenza ampliò il territorio di competenza del deposito-laboratorio ricoverando, a Capestrano, materiali della Grotta a Male di Assergi già esposti a Stiffe, di Navelli, di Caporciano, di Fossa.
16
Gli archeologi che effettuarono le ricerche furono Alberta Martellone, Silvia D’Alessandro, Elisa Cella, Viviana Merlino, Francesca Lerza; l’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione fornì la sua preziosa collaborazione per il prelievo, sul campo, dei reperti archeologici. 17 Chiedo scusa soprattutto agli eventuali lettori non italiani del continuo mutamento di denominazione degli enti preposti alla salvaguardia del patrimonio archeologico. Per quanto riguarda Capestrano e l’Abruzzo si potrebbe così riassumere: prima dell’entrata in vigore della legge 1/6/1939 la competenza, nel territorio aquilano (come si è visto), era della Soprintendenza alle Antichità di Roma mentre l’area costiera adriatica dipendeva da Ancona, Soprintendenza degli Scavi e dei Musei di Antichità delle Marche e dell’Abruzzo (Dall’Osso 1910, 368-404). Nel 1939 viene istituita, dal Ministero della Pubblica Istruzione, la Regia 10
Le ricerche a Capestrano dal 1934 al 2012
L’unica tomba ipogeica a grotticella portata alla luce nella campagna del 2007 (tomba 214) è la sepoltura di una bambina defunta fra i 4 e i 6 anni di età che, oltre al consueto corredo del periodo, recava, vicino alla mano destra, una tanagrina in terracotta, oggetti normalmente di uso votivo: considerando la tenera età del defunto si potrebbe ipotizzare che la statuetta fittile femminile rappresentasse una sorta di “bambola” adatta ai giochi di una bambina (Fig. 1.31). Gli effetti del terremoto subito dall’Abruzzo il 6 aprile del 2009 portarono molti archeologi, in primis Adriano La Regina, a cercare di dare una mano nella ricostruzione di uno stile di vita fornendo la propria opera di specialisti e ricercatori: per Capestrano questo significò una intensa stagione di indagini 19 . Grazie all’utilizzo del Convento di San Giovanni di Capestrano, di proprietà comunale, fu messa in piedi una vera scuola di archeologia internazionale che operava, sul campo, nella necropoli di Capestrano ma anche nella città di Aveia (Fossa) e nelle ricognizioni sui siti d’altura vestini oltre che al prelievo e al contestuale restauro (con i due più prestigiosi Istituti operanti in Italia: Roma e Torino) dei reperti portati alla luce. Gli scavi nella necropoli, condotti in collaborazione con Alessandro Guidi e Massimo Pennacchioni dell’Università di Roma tre ed Oliva Menozzi dell’Università di Chieti-Pescara che per quell’anno “abbandonò” le ricerche nell’abitato di Aufinum, si concentrarono sul lato sud-ovest dello scavo 2007-2008 e sotto il percorso della strada bianca, la via di Fossascopana (anche per verificare l’esistenza di altre, eventuali, porzioni
centrale, originaria. Appare chiaro però come il lato settentrionale dello scavo sia, praticamente, privo di seppellimenti (le tombe non superano i 20 metri di distanza dal lato lungo sud) confermando quella fascia, prossimale alla via sepolcrale, di fitto utilizzo della necropoli già visibile negli scavi del 1934 e del 2003 Saggio D. Che l’arte della guerra fosse particolarmente “coltivata” nel territorio di Capestrano ce lo indicano, oltre alle armi perfettamente rappresentate sulla statua del re e a quelle deposte nelle tombe, due vasi in cui sono visibili scene di battaglia. I due vasi mostrano la tattica del “muro di scudi” utilizzata dalle fanterie in ordine chiuso, pesantemente ed omogeneamente equipaggiate, disposte in linea per un lungo range cronologico che va dalla protostoria al medioevo: almeno 1000 a.C.– 1000 d.C. Il primo dei due vasi, un’olla su piede in ceramica nerastra, rinvenuto fuor di contesto, reca delle incisioni, campite con pasta rossa, in cui le figure umane sono estremamente schematizzate, anche gli scudi appaiono indifferenziati a differenza della brocca in ceramica in impasto buccheroide (trovata nella tomba 212) in cui gli scudi, sempre rotondi, hanno emblemi differenti ed anche i guerrieri, vivacizzati da campiture di colore bianco, allineati forse su due file, sono maggiormente caratterizzati. Questo modo di combattere, fanti su più linee, si è diffuso in Abruzzo tra la prima età del Ferro e l’età orientalizzante (1000-600 a.C.) per venire sostituito, in età arcaica, da combattimenti fra singoli, armati di spada lunga in ferro, come il guerriero di Capestrano (d’Ercole 2010a, 138-177). La sepoltura 241, femminile, si segnala per la presenza di una piccola coppa su piede, in ceramica di imitazione attica, verniciata di nero; si tratta della medesima tipologia di quelle attestate in alcuni corredi (tombe 41 e 42), degli inizi del V secolo a.C., portate alla luce nella necropoli di Campovalano (Chiaramonte Treré e d’Ercole 2003; Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010). Proprio con Campovalano si confronta la necropoli di Capestrano anche per la dovizia di vasellame in bronzo deposto nei corredi funebri come mostra il corredo della tomba 241 (Grassi 2003, 491-518) (Figg. 1.27, 1.28 e Figg. 1.29, 1.30).
19
Gran parte del merito della ripresa delle ricerche archeologiche a Capestrano va all’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Antonio D’Alfonso che, fra il 2007 e il 2009, si è prodigata, in ogni modo, per favorire il prosieguo dei lavori mettendo a disposizione risorse, mezzi meccanici, operai, laboratori, depositi e “foresterie” di ogni tipo: non credo che a Capestrano si vedranno mai più all’opera, contemporaneamente, tante università (Chieti-Pescara, Napoli Orientale, Roma Tre), istituti stranieri (Ècole Française de Rome, Museo di Monaco di Baviera), il Centro di Conservazione e Restauro La Venaria Reale di Torino, l’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro del Mibact, la Soprintendenza per i Beni Archeologici per l’Abruzzo, come accadde nell’estate del 2009.
11
Capestrano, I
necropoli del territorio tombe di incinerati di età giulio-claudia (I sec. d.C.) sono pochissimo rappresentate (d’Ercole, Menozzi e Torello Di Nino 2011, 487-504). Le sepolture portate alla luce nella campagna del 2009 vanno dalla tomba 285 alla 341 per un totale di 52 contesti funerari in un’area indagata di circa 10x50 metri (500 mq)20 (Figg. 1.33, 1.34). Con la medesima équipe, un po’ ridotta, venne effettuata un’altra, breve, campagna di scavo nel giugno del 2010 nell’area opposta della via sepolcrale (un saggio di forma quadrangolare di circa 10x10 metri) che, oltre a meglio definire lo sviluppo e la larghezza dell’asse stradale, portò al rinvenimento di due tombe a grotticella (tombe 344 e 346) e due a fossa. Al di fuori del contesto di Fossascopana, Le immagini riprese con gli elicotteri dei Carabinieri avevano mostrato delle anomalie rettangolari in un terreno, collocato sulla riva opposta del fiume, non lontano dalla fonte di Presciano (Tartara 2008a, 163-194). Il passaggio del terreno in oggetto dal “vecchio” proprietario ad un noto viticoltore 21 pose il problema della trasformazione agricola dell’area da maggese (con arature profonde circa 30 cm) all’impianto di un vigneto con scassi profondi almeno un metro. Contattato il nuovo proprietario e ricevutone l’assenso, fu possibile, nel settembre 2010, effettuare una campagna di scavi grazie alla collaborazione dell’Università Gabriele D’Annunzio di ChietiPescara22 (Acconcia, d’Ercole e Papi 2012, 494500). Venne aperto un saggio, nella porzione nord-ovest dell’appezzamento, di forma rettangolare di circa 25x15 metri, per un’area di 431 mq; furono individuate almeno 80 sepolture di cui ne vennero scavate, per ragioni di tempo, 57 tra deposizioni neonatali in coppi (22), in fossa ed una (la tomba 50) a grotticella. La
di statuaria arcaica), che venne, momentaneamente, preclusa al traffico (vedi, par. III.4 di questo volume). Venne così portato alla luce l’intero tracciato della via sepolcrale dalla zona degli scavi condotti da Annibaldi negli anni trenta fino all’attuale settore di indagini per oltre 100 metri di lunghezza e 4 metri di larghezza. Il principale elemento di novità, a parte la definitiva identificazione dell’asse stradale, autentico asse portante della necropoli, è stata l’esaustiva esplorazione archeologica della fascia antistante la via sacra con la messa in luce di un cospicuo numero di tombe ad incinerazione (34, di cui tre nel “recinto” tomba 303, vedi, 327-329, (Fig. 1.32) e due nella tomba 337, vedi, 348-349), 19 tombe a inumazione in fossa, di cui 3 di epoca arcaica/tardo-arcaica e 2 a camera. Nella stessa area sono state rinvenute anche tre iscrizioni lapidee latine. Mentre le sepolture all’interno di grotticelle non hanno uno specifico rapporto con gli assi stradali le tombe a camera costruite si aprono invece a diretto contatto con le vie sepolcrali: è questo il caso delle tombe 304 e 320 affiancate, molto rovinate, portate alla luce nel 2009 nell’area di Fossascopana e, probabilmente, di quella, intercettata nel 1992, nella zona di Capo d’Acqua. Interessante la presenza di un frammento di bracciale in vetro blu da uno strato di livellamento rinvenuto nei pressi della tomba a camera 320 che amplia, dopo l’analogo rinvenimento nella sepoltura 600 di Campovalano, l’area di diffusione dei braccialetti celtici in Abruzzo facendoli “scendere” a sud del fiume Tronto (d’Ercole, Martellone e Cesana 2016, 161). Verosimilmente da due camere funerarie provengono i resti delle appliques in osso che rivestivano altrettanti letti funerari. Di tipo centro-italico gli otto frammenti del letto rinvenuto nel 1992, più recente e certamente pertinente ad un modello di più larga diffusione quello della tomba 320 (per il quale, vedi il II Volume di questo lavoro; Martellone 2010b, 328-361) con dei piccoli puttini alati alcuni dei quali suonano il doppio flauto. L’ultima fase di vita nella necropoli è testimoniata dalle sepolture ad incinerazione identificate ai diretti margini della via sepolcrale; si tratta quasi di un unicum in terra vestina in quanto nelle altre
20
Come si chiarirà nel par. III.4, alcuni numeri di sepoltura sono stati assegnati in corso di scavo a stratificazioni diverse dai contesti funerari, ma comunque ad essi collegati. 21 La storia archeologica della necropoli di Capestrano è legata, indissolubilmente, alla produzione del vino: dalle prime scoperte degli anni trenta fino a quelle del III millennio d. C. 22 La cattedra che si rese disponibile, in questa occasione, fu quella di Etruscologia e Antichità Italiche tenuta da Raffaella Papi; sul campo il lavoro fu coordinato da Valeria Acconcia. 12
Le ricerche a Capestrano dal 1934 al 2012
tomba 11, relativa ad un individuo infantile, probabilmente di sesso femminile a giudicare dall’assenza di armi e dalla presenza di fermatrecce in bronzo e di altri ornamenti come collane in ambra ed anelli, appare come la più antica del campione portato alla luce ed inquadrabile all’inizio dell’età del Ferro, data la presenza di fibule a disco in lamina di ferro come quelle rinvenute nelle necropoli di Teramo La Cona e di Scurcola Marsicana Piani Palentini. La maggior parte delle deposizioni indagate copre un arco cronologico compreso fra l’età arcaica e l’ellenismo (VI-II sec. a.C.). La presenza di due tombe a grotticella, incavate nel banco di gesso presente nel lato nord-ovest dello scavo, disposte in maniera “radiale” potrebbe fare ipotizzare una situazione analoga a quella riscontrata nel Settore C dello scavo 2003: la presenza di un tumulo (edificato fra la prima età del Ferro e l’orientalizzante) marginato ed esaltato, in epoca italicoellenistica, da tombe a grotticella, monosome, disposte tutte intorno alla crepidine a mò di raggi del sole. Naturalmente il tumulo originario, se effettivamente esistente, si estenderebbe oltre l’angolo nord-ovest dell’area di scavo mentre la seconda tomba a grotticella (oltre la 50) non è stata scavata ma solo identificata sul terreno con una lettera dell’alfabeto: portare alla luce una sepoltura del genere con solo mano d’opera “studentesca” è lungo, faticoso ed impegnativo. Tra l’autunno del 2010 e la primavera 2011 dei lavori pubblici per la posa in opera di un impianto di irrigazione delle acque rese possibile effettuare un intervento di archeologia d’emergenza 23 , in corso d’opera, lungo il tracciato afferente il territorio di Capestrano. La continua assistenza archeologica durante i lavori di scavo per la posa in opera delle tubature permise di identificare una struttura abitativa protostorica in località Vatormina, una sepoltura arcaica sotto il manto della strada moderna in prossimità della chiesa di Santa Maria di Presciano, un nucleo sepolcrale nei
pressi di via Dell’Olmo (vedi, il Volume II di questo lavoro) e delle tombe nella zona di Capo d’Acqua (D’Alessandro et al. 2014, 297-302). La tomba individuata sotto il manto stradale (parzialmente manomessa e compromessa da lavori precedenti), davanti alla chiesa di Santa Maria di Presciano, era riferibile ad un maschio adulto con spada tipo Capestrano, calzari, spiedi, fibule in ferro, olla in impasto e bacile in bronzo. Ma l’elemento di maggiore interesse di questa scoperta è dato dalla sua posizione topografica: dopo i “confusi” ritrovamenti di tombe saccheggiate a Vatormina prima della guerra e quelli nel terreno di Maria Celli, la tomba a cappuccina rinvenuta nel 1979, solo nel 2010-11, con gli scavi regolari di Presciano (Fig.1.16), è stato possibile accertare la presenza di una grande area cimiteriale, posizionata sulla riva destra del Tirino, a lunga continuità di vita (dalla prima età del Ferro agli inizi dell’impero romano), comparabile con quella, meglio nota, collocata sulla sponda opposta del fiume: la necropoli del guerriero di Capestrano. Un gruppo di sette tombe è stato rinvenuto sul lato orientale della strada, Via Dell’Olmo, che conduce da Fossascopana a Capo d’Acqua; quattro sepolture (tombe 2, 4, 5, 8) erano manomesse, la tomba 7 era pertinente ad una donna adulta di epoca arcaica mentre la fossa 6 (tagliata dalla 7) che, viste le dimensioni ridotte doveva essere pertinente ad un infante, aveva un servizio potorio di tre vasi in impasto buccheroide con elaborare decorazioni incise campite in rosso. All’epoca italico-ellenistica è invece attribuibile un grotticella (tomba 3) all’interno della quale era sepolta una bambina, secondo il modello già visto a Capestrano con la tomba 214 dello scavo 2007, con una complessa acconciatura composta da elementi in osso (tra cui un astragalo), ferro e pietra. Nel corso del 2011 la normale attività di tutela effettuata dalla Soprintendenza, in questo specifico caso in collaborazione con la stazione dei Carabinieri di Capestrano, permise di identificare uno sbancamento agricolo per la messa a cultura di un vigneto nella zona pianeggiante sottostante l’abitato antico alle sue immediate pendici nord-est, in località Case Caruso. Oltre a molto materiale da costruzione, sia lapideo che fittile, si rinvenne
23
I lavori di scavo e movimento terra furono seguiti, sul campo, dagli archeologi (Alberta Martellone, Silvia D’Alessandro, Ilaria Di Sabatino, Francesca Lerza, Maria Giorgia Di Antonio, Serena Torello Di Nino) afferenti alla cooperativa Vestea de L’Aquila e coordinati, per conto della Soprintendenza dell’Abruzzo, da chi scrive. 13
Capestrano, I
un’iscrizione24 funeraria, in latino, su pietra che farebbe pensare all’esistenza di mausolei riferibili alla prima età imperiale collocati, in bella vista, al confine tra la città dei vivi e quella dei morti. Un altro “ampliamento” dell’area della necropoli fu effettuato il 23 giugno del 2011 nel corso di uno dei voli con gli elicotteri dei Carabinieri che erano iniziati nel 2003: ebbi modo di notare le classiche anomalie rettangolari (crop-marks) sulle colline alle spalle del nucleo sepolcrale, noto, di Capo d’Acqua. Ai margini occidentali dei casolari esistenti a Capo d’Acqua Borgo si notano le tracce di almeno 20 tombe sulla cima della collina ed almeno altrettante sul pendio sottostante: spero che gli impianti fotovoltaici e le costruzioni realizzate dopo il 2011 non abbiamo interferito con la necropoli. Visto l’incremento delle conoscenze archeologiche sull’area di Capestrano avvenuto fra il 2003 e il 2011 e i rischi per la conservazione e tutela dei siti (soprattutto a causa del cambiamento della destinazione d’uso agricolo) la Soprintendenza decise di apporre dei vincoli: elaborai pertanto le relazioni tecniche per l’abitato di Aufinum (Colle Sant’Antonino), l’area centrale della necropoli (Fossascopana, Capo d’Acqua, via Dell’Olmo), la struttura protostorica di Vatormina e l’area di necropoli di Presciano. Per poter apporre un adeguato vincolo archeologico sul sito di Presciano, indagato preliminarmente nel 2010, si ritenne opportuno effettuare, nell’autunno 2011, dei saggi di scavo nella parte mediana dell’appezzamento e nel settore sud-ovest al limitare dello stesso (d’Ercole e Di Sabatino 2014, 302-305). Nell’estremità meridionale dell’area fu indagato un settore di circa 9x11 metri (quasi 100 mq) che confermò la presenza di una struttura di epoca romana (già individuata in foto aerea): probabilmente una villa, sui cui resti sono state impiantate delle sepolture, plurime, di età medievale. Un altro saggio di scavo venne aperto al centro dell’area oggetto di procedimento di vincolo; in settore di circa
8x25 metri (200 mq) si individuarono almeno 12 sepolture a fossa distribuite in due gruppi separati da una fascia di terreno “libero” di almeno 8 metri. Data la limitatezza delle risorse economiche disponibili furono portate alla luce solo tre sepolture (tombe 60-62) tutte poste nel raggruppamento nord-orientale, quello più denso di testimonianze archeologiche: le tre deposizioni esaminate appartengono a delle donne adulte cronologicamente comprese fra la fine del VII e il VI secolo a.C. La disposizione “radiale” di alcune di esse e lo spazio non utilizzato fra i due gruppi di tombe individuate potrebbero far ipotizzare la presenza di tumuli ma la limitatezza dell’area indagata e la “brevità” delle indagini non permettono, per ora, di andare oltre. Dall’inizio dell’anno 2012, chi scrive, è stato trasferito a Roma alla Direzione Generale Archeologia del Mibact e pertanto ha cessato (dopo 33 anni) di occuparsi, sul campo, delle ricerche archeologiche a Capestrano e in Abruzzo. Nell’estate del 2012 l’Università di ChietiPescara ottenne una concessione di scavo per la zona di Fontanelle, collocata tra Fossascopana e Capo d’Acqua, dove furono portate alla luce 53 sepolture cronologicamente collocabili fra VI e III secolo a.C. (Acconcia e Di Sabatino 2016, 156-159). Lo scavo interessò un’area, di forma pressochè rettangolare, di circa 10x20 metri, indagata esaustivamente, al centro della quale si identificò un gruppo composto da una dozzina di sepolture disposte a formare un raggruppamento circolare (non è stata rinvenuta traccia della probabile crepidine) di una decina di metri di diametro. L’utilizzo di tale spazio comune (tumulo?) ha inizio almeno agli albori del VI sec. a.C. (tombe 4 e 30) e termina in età ellenistica (IV-III sec. a. C) con le deposizioni 26 e 38 (Acconcia 2014, 281-284). Al di fuori di tale raggruppamento, fra le tombe a fossa, molto addensate fra di loro, orientate, canonicamente, ad est si segnala la deposizione 9 composta da una fossa occupata da un maschio adulto e da un individuo neonatale, con corredo fittile miniaturistico (corredo 9 bis), collocato in una nicchia scavata nella parete, lunga, meridionale. L’ultimo intervento, in ordine di tempo, finora condotto nella necropoli di Capestrano è stato
24
L’epigrafe, pressochè integra, su cui sono effigiati due asini affiancati, fa riferimento a dei liberti (FAESASII) che avevano dei possedimenti nella zona: divertente la circostanza che, dall’altra parte della collina, oggi esiste un fiorente allevamento di questi animali denominato “il paradiso degli asini”. 14
Le ricerche a Capestrano dal 1934 al 2012
effettuato, nel luglio 2017, da un’equipe dell’Università di Chieti-Pescara e diretto da Oliva Menozzi nella zona di Capo d’Acqua, scavi Pisa anni sessanta, che ha portato al rinvenimento di alcune (5) sepolture a fossa (in un’area di 100 mq), sia di infanti che di adulti, cronologicamente distribuite fra VII e III sec. a.C. Allo stato attuale delle ricerche nella necropoli di Capestrano le indagini “moderne” (20032017) hanno portato all’esplorazione esaustiva di circa 5.000 metri quadrati, mezzo ettaro, in cui sono state individuate almeno 520 sepolture; aggiungendo i dati dei “vecchi” scavi (19341992) avremmo altre 85 tombe su, forse, 2000 mq di scavo pari ad una deposizione ogni 12 metri quadrati. Applicando questa densità alla, presunta, estensione dell’intera necropoli (390 ettari) avremmo spazio per 325.000 sepolture che distribuite per le 40 generazioni che intercorrono fra il IX secolo a.C. e il I sec. d.C. (range attestato di utilizzo del sito sepolcrale) darebbero una stima demografica, per generazione venticinquennale, di 8.125 individui fra infanti, adulti e vecchi di ambedue i sessi: forse non è poi così lontana dalla realtà. Il nucleo centrale della necropoli è quello compreso all’interno dei bracci superiori della Y del Tirino (Fig. 1.2): le due aste fluviali che partendo, l’una, quella orientale, da Capo d’Acqua, l’altra, quella occidentale, dalle cosiddette Sorgenti, confluiscono, poco a valle di Presciano, dando luogo al fiume che riunendo le sue acque con quelle dell’Aterno, nella zona di Popoli a “Capo Pescara”, darà origine all’omonimo fiume. In questo ampio terrazzo fluviale di forma triangolare sono compresi i vari nuclei sepolcrali indagati a Fossascopana, Capo d’Acqua, Fontanelle, Via Dell’Olmo e quelli individuati, in superficie, attraverso “anomalie” a Monaresca e Macero Bucci25. Ai margini di questa zona centrale ma sempre sulla stessa unità morfologica (il terrazzo interfluviale del Tirino), si collocano i
nuclei sepolcrali di Capo d’Acqua Borgo, anch’esso indiziato dalle crop-marks dall’alto, di Case Caruso (i sepolcri romani distrutti dall’impianto di un vigneto) e di Vatormina, i due settori di necropoli maggiormente prossimali alla città di Aufinum. I tre nuclei di Capo d’Acqua Borgo, Case Caruso e Vatormina costituiscono la base, allargata, del triangolo interfluviale che costituisce il cuore della necropoli di Capestrano attraversata, al centro, come se costituisse la bisettrice, l’asse portante, dalla via sepolcrale che metteva in comunicazione l’abitato con il luogo dell’eterno riposo e della memoria. Ancora più lontano ed esterno al “triangolo d’oro” della necropoli di Capestrano il nucleo sepolcrale di Santa Pelagia, a nord-ovest della città di Aufinum, individuato nel 1982 e costituito da due tombe a grotticella. Oltre la riva del fiume vi era la necropoli sudoccidentale (prossimale all’abitato medievale e moderno di Capestrano) costituita dai nuclei di Vicenne, Chiesa di Santa Maria di Presciano, Fonti di Presciano, terreno di Maria Celli. Più incerta la presenza di un ulteriore nucleo sepolcrale posto sulla riva opposta del Tirino, ad oriente, nel suo segmento iniziale. Unico indizio in tale direzione sono le quattro tombe realizzate con blocchi di pietre di riutilizzo, di epoca “tardo-imperiale”, portate alla luce nel 1979 in località Campo Morto. Per quanto a mia conoscenza rimane incerto il posizionamento, effettuato nel 1934 in Contrada Raio, nella proprietà di Francesco Trecca, di resti murari e di un capitello con testa leonina in cui forse è possibile leggere la presenza di una tomba monumentale d’età romano-imperiale. Allo stato attuale delle conoscenze sembra che le sepolture più antiche della necropoli (IX-VIII sec. a.C.) vadano collocate a Vatormina e alle Fonti di Presciano (tomba 11); solo con l’orientalizzante maturo e tardo (VII sec. a.C.) le tombe, oltre che a Vatormina, sembrano appropriarsi anche del settore centrale della necropoli (il cosiddetto triangolo interfluviale) con poche sepolture sparse in tutta l’area: tombe 134 e 178 scavi 2003 a Fossascopana e due seppellimenti maschili, fra loro intensamente legati, degli scavi 2017 a Capo d’Acqua. E’ con l’età arcaica (VI sec. a.C.) che la necropoli raggiunge il suo punto di massima espansione e di splendore, quasi tutti i nuclei sepolcrali
25
Si veda in questo stesso volume il contributo di Serafino Lorenzo Ferreri. A Monaresca, posta al centro dell’area fra Fossascopana, Fontanelle e Via Dell’Olmo si notano tracce di almeno 250 sepolture mentre un numero minore è visibile a Macero Bucci a sud-est di Fossascopana lungo la medesima strada interpoderale e, probabilmente, antica e coeva al sepolcreto. 15
Capestrano, I
(Fossascopana, Fontanelle, Capo d’Acqua, Via Dell’Olmo, Vatormina, Chiesa di Santa Maria di Presciano, Fonti di Presciano) vengono utilizzati; lo standard dei corredi funerari è rilevante: vasellame di bronzo, utensili metallici per il banchetto, armi di grande qualità, vasellame ceramico in impasto notevolmente raffinato e decorato, ceramica attica. Si commissionano e si erigono diverse statue in pietra raffiguranti la classe dominante. L’apogeo prosegue nel corso dell’età classica (V sec. a.C.) per modificarsi nelle fasi successive (IV-II sec a.C.) non per quanto riguarda i costumi funerari e il livello dei corredi funebri ma per la disposizione topografica delle sepolture che tendono a collocarsi ai margini, negli spazi residuali, rispetto a quelle precedenti ma sempre tenendo conto dell’aggregazione per linee di discendenza. Paradigmatica la scelta di dove posizionare le tombe a grotticella, piuttosto diffuse (21) nella necropoli: sempre all’esterno rispetto alle fosse dei periodi precedenti quasi a voler sancire, anche visivamente, una tradizione di afferenze familiari o claniche che si conclude. Infatti tra I secolo a.C. e I d.C. (con l’effettiva romanizzazione del territorio) cambia tutto: una tomba a cappuccina, 36 sepolture ad incinerazione (un portato inedito per l’Abruzzo) e 2/3 tombe a camera, adiacenti alla via sacra, con letti funerari rivestiti in osso per il trasporto funebre. Gli assi viari rappresentano il macroscopico segno di un mondo che si è allargato a dismisura: dai piccoli stati territoriali (toutai) dell’età del Ferro all’universo globale e cosmopolita dell’impero romano di cui anche la comunità di Aufinum è parte.
16
Le ricerche a Capestrano dal 1934 al 2012
I.2. Le necropoli di Capestrano: integrazione dei dati noti e analisi aerofotointerpretative Serafino Lorenzo Ferreri l’Archivio di Stato di Siena (ASSI) e la documentazione conservata nel Nuovo Museo Paludi di Celano (MUSè). Le metodologie di posizionamento sono state adattate alla disponibilità di rilievi planimetrici, prediligendo comunque gli originali, e alla possibilità di agganciare l’indagine ad elementi della cartografia (catastale, regionale) o di ortofoto e immagini satellitari georiferite; in alcuni casi è stato dirimente l’apporto delle fonti orali26. Per quanto riguarda i criteri di modellazione vettoriale adottati per la mappatura, come già accennato, l’elaborazione dei dati è stata effettuata in ambiente CAD/GIS, nei formati DXF e SHP. I rinvenimenti sporadici, per definizione punti di rinvenimento, sono stati rappresentati come elementi puntuali, e collocati, secondo i dati disponibili sul posizionamento, al centroide della particella catastale interessata, in corrispondenza di un toponimo o altro elemento riportato su cartografia o, ancora, su coordinate acquisite da dispositivi GPS. Del resto, le aree di scavo, sebbene canonicamente rappresentabili come elementi poligonali, presentano anche casi in cui il tipo di rappresentazione non può che essere puntiforme (ad esempio, gli scavi del 1965 in località Capo d’Acqua; vedi, 6). Scavi e recuperi avvenuti nell’ambito dell’assistenza archeologica alle trincee per la posa in opera della rete idrica e fognaria, e privi di documentazione grafica, sono stati mappati come elementi lineari in corrispondenza dei tratti interessati (ad esempio, i recuperi del 1992 in loc. Capo d’Acqua; vedi, 7).
La Valle del Tirino costituisce una unità geomorfologica ben definita, inquadrata tra l’Altopiano di Navelli, ad ovest, e gli ultimi contrafforti del Gran Sasso ad est, su cui si aprono i passi che la mettono in comunicazione con il versante collinare e costiero dell’Abruzzo, svolgendo una funzione di cerniera tra questo e il settore montano interno. Questo contributo interessa più propriamente l’alta Valle del Tirino, scandita in quattro terrazzi, definiti dalle aste fluviali provenienti dalle sorgenti di Capo d’Acqua, Il Lago e Presciano, e interamente ricadente nel territorio comunale di Capestrano (Tav. 1). A fronte della copiosità e della rilevanza dei dati acquisiti nel corso delle numerose indagini archeologiche condotte in questo comparto territoriale a partire dal 1934, però, spesso scarsa attenzione è stata prestata al posizionamento delle aree di scavo (per la storia delle ricerche, d’Ercole, 3-16 in questo volume). Gli strumenti cartografici sinora elaborati, compresa la cartografia vincolistica, hanno infatti rivelato sensibili discrepanze nel loro inquadramento topografico. Chi scrive ha pertanto proposto un progetto cartografico, ispirato a consolidate esperienze nell’ambito della realizzazione di banche di dati archeologici (ad es. SITAN, MAPPA, etc.), il cui ambito di sperimentazione ha compreso anche la Valle del Tirino (Ferreri 2014, 545547). È stata pertanto realizzata una mappatura in formato vettoriale su piattaforme CAD e GIS di tutte le indagini archeologiche (con esito positivo o negativo) note in letteratura o nelle fonti d’archivio. A tale proposito, sono stati consultati l’Archivio di documentazione archeologica della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell’Abruzzo con esclusione della città dell’Aquila e dei comuni del cratere (SABAP-CH, ADA); l’Archivio di documentazione archeologica della Soprintendenza Speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (SSABAP-RM, ADA);
26 I criteri adottati per la georeferenziazione sono esplicitati più avanti nei singoli casi. Un approccio multicriterio e un maggiore sforzo ricostruttivo ha richiesto la realizzazione della planimetria generale della necropoli di Fossascopana (Tav. 2), in cui si sono concentrate le indagini a partire dal 1934 e per la quale la disponibilità e la qualità della documentazione grafica di archivio, e del suo inquadramento topografico, presentano problematiche, in parte già evidenziate in Benelli e Rizzitelli 2010, 43, n. 72; Cella 2012, 66.
17
Capestrano, I
Contestualmente all’elaborazione dei dati vettoriali, si è effettuata la compilazione delle informazioni ad essi pertinenti all’interno di un database relazionale 27 . Il segmento spaziale e quello alfanumerico sono stati ricomposti grazie all’univocità stabilita da codici identificativi, ottenendo in tal modo una banca di dati archeologico-territoriali consultabile su applicazioni GIS, da cui è tratto l’apparato iconografico del presente volume. Di tutte le indagini mappate, tuttavia, in questo contributo si esaminano solo quelle che hanno restituito dati di natura funeraria riferibili ai periodi preromano e romano: a questo proposito è stato necessario effettuare preliminarmente una revisione cronologica dei singoli contesti di rinvenimento28. Al repertorio georeferenziato così costituito si aggiungono i dati derivanti dallo studio sistematico del materiale aerofotografico e satellitare: l’applicazione dell’aerofotointerpretazione si sta rivelando di fondamentale importanza per la comprensione della topografia del territorio aquilano, grazie anche all’elevata visibilità archeologica sui seminativi, la quale è ulteriormente accentuata, nel territorio in esame, da una capillare rete idrica di irrigazione (S.L. Ferreri in Acconcia 2015, 31-34, in particolare, nota 118; Ferreri 2016; Tartara 2016). La rete idrica a cui si fa riferimento è quella dell’ex Consorzio di Bonifica Alto Tirino (oggi Consorzio di Bonifica Interno - Bacino Aterno-Sagittario), di cui si è acquisita la cartografia vettoriale. L’emersione delle tracce di elementi di natura archeologica sembra derivare in alcuni casi dalle attività di irrigazione, in altri da consistenti perdite dei condotti indiziate da macchie informi di erba. Ad ogni modo, è evidente la relazione tra gli elementi individuati in traccia e i condotti di irrigazione (anch’essi
visibili in sede di fotointerpretazione). In diversi casi la loro sovrapposizione tradisce forse azioni di disturbo dei depositi archeologici durante l’escavazione delle trincee della rete idrica: tuttavia, si dispone solo di limitate segnalazioni di rinvenimenti avvenuti in occasione di tali interventi, nel 1979 e nel 1992 (Cella 2012, 57, nota 1), e solo una di esse potrebbe riferirsi ad una delle aree individuate mediante fotointerpretazione (vedi, per la località Vicenne, 28-29). Le analisi aerofotointerpretative hanno consentito la mappatura, tra l’altro, di tracce riferibili a sepolture in fossa, le cui caratteristiche (forma, dimensioni, aggregazioni planimetriche, vicinanza a nuclei indagati, etc.) suggeriscono nella maggior parte dei casi una cronologia coerente con le fasi oggetto di questo contributo29. L’approccio topografico adottato in questo contributo è quello più propriamente tecnico, relativo al posizionamento delle evidenze e alla costruzione di una cartografia ragionata. A questo fa seguito, nel Volume II, uno studio territoriale orientato all’individuazione dei caratteri del paesaggio funerario e degli elementi di continuità e discontinuità nella lunga durata, con ipotesi anche sull’assetto insediativo, viario e sullo sfruttamento delle risorse (lo stesso tipo di approccio è stato adottato, per la medesima area, alla distribuzione dei dati funerari di età imperiale, soprattutto epigrafici, in Ferreri e Panci 2017). I.2.1. Le aree funerarie Fossascopana, Fossascopana-Monaresca (Tav. 1, n. 15). L’area funeraria di Fossascopana è la più rilevante di quelle individuate nella piana di Capestrano, per aver restituito i famosi pezzi di statuaria arcaica e per l’estensione delle
27
Le informazioni relative alle indagini hanno trovato sede in una scheda dedicata (I). Sono state schedate anche le fonti archivistiche (FA), bibliografiche (FB) e i documenti grafici (DG) acquisiti, insieme alle informazioni sulla loro georeferenziazione (DGg). 28 Ad esempio, nel caso della segnalazione in loc. S. Pelagia di tombe “a camera” o “a grotticella” che, già ritenuta problematica dal funzionario competente, non è corredata dalla indicazione di materiali di corredo rinvenuti (SABAP-CH, ADA, AQ 19, Località S. Pelagia - Relazione (1982)).
29
Presentano tracce di interesse archeologico i voli della Regione Abruzzo del 17/05/2002 (Orto2001-2005), 6 e 16/07/2007 e 16/08/2007 (Orto2007), 9 e 19/08/2010 (Orto2010), 13-14/08/2011 (VRA2011), le immagini satellitari di Bing del 2012 (BM2012) e quelle di Google del 25/09/2013 (GE2013), 22/09/2015 e 24/10/2015 (GE2015a-b), 25/06/2017 (GE2017). Le abbreviazioni tra parentesi sono quelle usate in questo contributo e nell’apparato iconografico del volume.
18
Le ricerche a Capestrano dal 1934 al 2012
ricerche (vedi d’Ercole, 4-5 e il Volume II di questo lavoro)30. La documentazione d’archivio superstite relativa alle indagini del 1934 è molto lacunosa: si conserva nell’Archivio di documentazione archeologica della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Chieti e nel Nuovo Museo Paludi di Celano (SABAP-CH, ADA, AQ 19.A; MUSè, AQ 19.A). Per quanto riguarda gli appunti di scavo, sono stati consultati (nel testo si farà riferimento alla numerazione utilizzata nei due elenchi seguenti): I. lettera di G. Moretti (03/11/1934); II. telegramma di G. Moretti (12/11/1934); III. lettera di F. Vettraino (14/11/1934); IV. schizzo anonimo (forse di F. Vettraino; post 14/11/1934); V. telegramma di F. Vettraino (18/11/1934); VI. lettera di G. Annibaldi (20/11/1934); VII. lettera di G. Annibaldi (s.d.); VIII. schizzo anonimo (forse di F. Vettraino; s.d.). Per la documentazione grafica, sono stati consultati: 1a. “Determinazione per intersezione della posizione delle tombe” (non in scala); 1b. “Planimetria generale dello scavo” (1:100); 1c. sezioni AA’-HH’ (1:100); 1d. piante e sezioni di tipi caratteristici di tombe (1:25); 2. planimetria generale con misure delle tombe (1:100); 3. “Necropoli di Capestrano” (1:100; edita in Moretti 1936-1937, tav. III). La documentazione grafica è stata rielaborata in questa sede in formato vettoriale e georeferenziata su base catastale. Come criterio per la georeferenziazione è stato utilizzato l’”Atto di stima e ripartizione” del 02/02/1937 (SABAP-CH, ADA, AQ 19.A) con cui venne conferito il premio di rinvenimento ai proprietari dei terreni indagati nel 1934. Gli elenchi di tombe suddivisi sulla base di questi ultimi fa intendere i limiti delle proprietà; si
riconosce anche il confine di queste con la strada vicinale, poiché non viene concesso un premio per le tombe 11, 17-18, che infatti nella pianta edita dal Moretti risultano al di sotto della strada (vedi il n. 3 della documentazione grafica; vedi anche la Fig. 1.35). L’identificazione delle particelle catastali è stata quindi verificata, in base ai nomi dei proprietari, mediante ricerca su piattaforma SISTER: la proprietà di Michele Castagna, in cui vennero scoperte le statue, è la 893 del foglio 9. Nella documentazione d’archivio ne è indicata la larghezza di 12 m (vedi il n. IV della documentazione d’archivio), che non coincide propriamente con la cartografia catastale. Per questo motivo, preliminarmente alla rototraslazione del rilievo, si è applicato un offset su entrambi i limiti laterali della particella in modo da ottenere tale misura. Ulteriore aggancio è l’indicazione, nel documento appena citato, del “punto di rinvenimento dei frammenti della statua maschile” a 2.12 m dal limite orientale della particella del sig. Castagna. Un esame approfondito del materiale d’archivio ha consentito di ricavare ulteriori dati, soprattutto relativamente alle stratigrafie individuate in corso di scavo e sulla profondità delle tombe, sulla base delle quali si propongono delle sezioni utili a ricostruire la topografia della necropoli (Fig. 1.36). In particolare, è stato possibile puntualizzare i dati relativi alla strada antica, il cui percorso riveste un interesse fondamentale per la topografia generale dell’area in esame, e la cui posizione non è adeguatamente valorizzata nelle planimetrie edite e inedite né nei documenti d’archivio, mentre è riportata sulle sezioni originali. Il percorso stradale segnato nella planimetria al n. 3, infatti, è in realtà quello del percorso della moderna strada vicinale 31 . Le sezioni qui presentate alla Fig. 1.36 costituiscono una integrazione di quelle indicate con le lettere BB’ e H’H nell’elenco conservato nell’Archivio della Soprintendenza e indicato con il n. 1c nell’elenco sopra riportato. Ad esse sono stati aggiunti i dati stratigrafici ricavabili dagli schizzi nn. IV e VIII (la profondità delle tombe è stata verificata mediante collazione tra
30
31 Questa sovrapposizione tra percorso antico e moderno è stata a lungo accolta nella storia degli studi, vedi ad esempio Cella 2012, 61, 77, 74, fig. 13.
Il toponimo di “Cinericcio”, con cui essa è anche nota localmente, è un evidente richiamo alla presenza di sepolture a incinerazione (Marinangeli 1977, 6). 19
Capestrano, I
le sezioni originali e i documenti grafici nn. 1a, 1d, 2). La sezione II’ è stata invece interamente elaborata da chi scrive, sulla base della documentazione appena citata Dalle sezioni originali si evince lo spessore della massicciata stradale antica, di ca 0.4 m (da -0.6 a -1 m dal p.d.c.), mentre l’ampiezza della carreggiata è di ca 4 m. Grazie all’integrazione delle sezioni di scavo con i rilievi degli scavi successivi (soprattutto quello del 1937, vedi, 5), è stato possibile definirne anche l’andamento planimetrico (Fig. 1.35). Da tale ricostruzione, è evidente come il tracciato si sovrapponga problematicamente ai punti di rinvenimento delle sculture arcaiche, anche se la documentazione “verticale” consente di verificare come esse fossero probabilmente inglobate o, meglio, sottostanti alla strada antica, entro un livello di scarso spessore, definito “argilla” nella documentazione. Quest’ultimo risulta coperto dalla massicciata stradale (a -1 m dal p.d.c.) e sembra coprire direttamente il banco geologico costituito da breccia (a -1.2 m dal p.d.c.; Fig. 1.36, sez. BB’) e potrebbe corrispondere alle fasi di frequentazione della necropoli precedenti la piena romanizzazione 32 . La strada avrebbe coperto nel tratto interessato una decina di sepolture databili tra l’età arcaica e l’inizio dell’età ellenistica: tra queste, si inquadrano nella fase arcaica le nn. 2-5, 13, 16, 19, 21 e, probabilmente, 20; alla fase ellenistica (forse ad un orizzonte iniziale, vedi Benelli, Rizzitelli 2010, 44) la n. 17; di cronologia non determinabile, invece, è la n. 11 (senza corredo). Queste considerazioni si allineano alla proposta di riconoscere in questo intervento una
ristrutturazione del tessuto funerario, comprensiva dell’obliterazione delle statue, attuata probabilmente tra il II e il I secolo a.C. (Cella 2012, 77-78). Data la posizione della strada nella stratigrafia verticale, è possibile ricostruire per l’età romana un innalzamento dei livelli di frequentazione, che sembrerebbe confermato anche dalla profondità della parte superiore delle olle cinerarie di età imperiale (tombe 23-27) e da quella dei piani di deposizione delle inumazioni presenti nel settore settentrionale dello scavo (Fig. 1.36, sez. II’). Sulla base del documento indicato con il n. VIII dell’elenco sopra riportato, una delle incinerazioni si trovava a -0.8 m dal p.d.c. ed è probabile che questa indicazione sia rappresentativa di tutto il gruppo e delle tombe a inumazione 28 e 29, in cui i crani dei defunti erano coperti da coppi e già ritenute “romane” in sede di scavo (vedi, documenti n. 1d e n. VIII; Capodicasa 2005, 23; Cella 2012, 73, 81)33. La recenziorità nell’utilizzo di quest’area rispetto al resto del nucleo, sembra potersi leggere anche nella volontà di distinguerla dal settore frequentato in età arcaica ed ellenistica34. Significativo è il fatto che la fila di olle cinerarie di età imperiale non sembri allinearsi con la strada - con la quale tali contesti sarebbero in fase - bensì con le sepolture dei periodi precedenti (Fig. 1.36). È possibile che l’allineamento delle incinerazioni rispettasse una delimitazione del nucleo arcaico ed ellenistico, che non ci è nota dai dati di scavo, ma della quale si possono ricavare alcuni elementi. Nella sezione H’H, infatti, sono visibili tre grandi massi, riportati anche in una delle planimetrie inedite (documento grafico n. 1b). Data la loro posizione, essi potrebbero essere interpretati come segnacoli delle tombe 12, 1415, eventualmente costituiti dal reimpiego di
32
Le informazioni stratigrafiche annotate nella documentazione originaria sono certamente semplificate, ma nel complesso risultano più dettagliate di quelle fornite in sede di edizione, in cui si fa una distinzione unicamente tra un «terreno alluvionale negli strati superiori e argilloso compatto in quelli inferiori: in questo i morti furono sepolti a diverse profondità» (Moretti 1936, 8). A favore, invece, della ricostruzione proposta è l’indicazione del rinvenimento di una porzione del plinto della statua maschile «su terreno duro»: questo termine non può che indicare il livello posto tra la massicciata della strada antica e il banco geologico breccioso. Ulteriore indizio della presenza degli elementi scultorei sotto la strada antica è la volontà dei responsabili dello scavo del 1937 di smantellarne la massicciata nella speranza di trovarne altri frammenti.
33
Nella sezione II’ i limiti dei pozzetti delle olle e delle tombe a fossa è stato prolungato fino alla quota del livello di frequentazione romano supposto dalla quota della strada antica (-0.6 m dal p.d.c.). 34 Di opinione diversa E. Cella, la quale ritiene possibile che le inumazioni del settore settentrionale possano essere riferibili ad una fase di transizione tra l’età arcaica ed ellenistica o alla stessa fase arcaica, ma relative ad un gruppo subalterno (Cella 2012, 75-76). 20
Le ricerche a Capestrano dal 1934 al 2012
menhir di un tumulo maschile della prima età del Ferro (per questi elementi, Cosentino, d’Ercole e Mieli 2001, 193-197; d’Ercole 2014, 33) o anche di elementi della crepidine di un tumulo, ma riportati graficamente in maniera schematica e sovradimensionati 35 . A tale proposito, gli spazi rinvenuti vuoti segnalati nell’area di scavo suggeriscono la possibile presenza di strutture di questo tipo (per l’ipotesi del tumulo della tomba 3, d’Ercole, Papi e Grossi 1990, 166-167; d’Ercole 2010b; Cella 2012, 75; d’Ercole 2015a, 105-106; con alcune riserve, Capodicasa 2005, 22). Questa ipotesi non può essere verificata, in quanto le indagini del 1934 non si sono estese ulteriormente sul lato orientale; tuttavia, sembra farvi riscontro la disposizione della tomba P del 1937, che potrebbe eventualmente segnalare anche il limite del nucleo di tombe su questo lato (su questa tomba, Cella 2012, 68; sui limiti del nucleo, si tenga conto che una delle trincee del 2003, aperta tra lo scavo del 1934 e il Saggio D, ha verificato la presenza di uno spazio privo di interventi antropici; Tav. 2). Vi è la possibilità dell’esistenza di altre strutture a tumulo ai margini occidentali dello scavo del 1934 e, ancora, all’interno dell’area di scavo del 1937, come lascerebbe intendere la disposizione anomala della tomba C e la presenza di spazi non occupati da sepolture (Fig. 1.36). Tornando al problema della strada, quindi, se nella sua realizzazione non si legge una volontà di rispetto per l’area funeraria più antica, che in parte viene obliterata, è possibile che prevalessero esigenze a carattere pubblico. Essa si diparte infatti dal centro di Aufinum, attraversando in quest’area più nuclei sepolcrali 36 Nell’ambito del culto funerario, si evidenzia comunque il mantenimento della memoria, così come della contiguità topografica e, verosimilmente, della continuità di discendenza (per una ipotesi circa un possibile percorso stradale più antico).
Come è già stato messo in evidenza, alle prime indagini del 1934 seguirono negli anni successivi rinvenimenti sporadici e scavi mirati che ampliarono il quadro delle conoscenze sull’area (vedi, d’Ercole, 4). Nel giugno 1936, furono sequestrati materiali riferibili a sepolture di età arcaica ed ellenistica sconvolte a seguito di scavi di privati, effettuati nei terreni di proprietà con la speranza di accedere ai premi di rinvenimento. Si tratta delle proprietà Castagna, Visioni e D’Antoni(o) (d’Ercole 2015a, 103) che, da ricerca catastale su piattaforma SISTER, risultano al f. 19, rispettivamente partt. 32 e 863, interessate da saggi nel 1963-1964 e 2003 (Tav. 2). Nell’elenco dei materiali sequestrati sembra di poter riconoscere alcuni reperti rintracciati da E. Cella nel Museo Nazionale di Villa Giulia, in particolare un askos a vernice nera, uno dei due balsamari dalla proprietà Castagna e le quattro punte di lancia e i frammenti di spade dalla proprietà Visioni (Cella 2012, 95, nn. 17, 19, 59-60, 63-66). Dalla medesima località è segnalato il rinvenimento, nel marzo 1937, di un corredo di età imperiale, cui potrebbe riferirsi una delle due iscrizioni recuperate nel medesimo appezzamento (SABAP-CH, ADA, AQ 19.F; Ferreri e Panci 2017, 451-452, nn. 78). Per quanto riguarda la seconda campagna di scavi che interessò l’area nel giugno-luglio 1937, con l’intento programmatico di recuperare ulteriori frammenti scultorei (vedi, d’Ercole, 5), dall’esame della scarsa documentazione conservata, è evidente che essa abbia interessato i settori immediatamente a ovest e ad est dell’area già esplorata nel 193437. 37
Sulle problematiche della documentazione, Cella 2012, 62-73 e 78, dove però sono errati i riferimenti alla documentazione grafica, rintracciata in SSABAP-RM, ADA, Pratiche di tutela, 11/3, Sibari: carta archeologica; Velia: Porta Rosa (foto 1968); Capestrano: schizzi; Avezzano: scoperte di antichità. Vi si conservano infatti tre schizzi misurati e con annotazioni, relativi a: la pianta generale del saggio ad ovest di quello del 1934 (02/07/1937); piante e sezioni di alcune tombe in esso rinvenute (I-M, O 1-2; 06/07/1937); posizionamento dell’unica tomba rinvenuta nel saggio ad est di quello del 1934 (P; 10/07/1937). Vi è inoltre una pianta su lucido redatta sulla base delle misure dello schizzo planimetrico del 02/07/1937. Chi scrive ha elaborato, sulla base di questa documentazione, una pianta vettoriale di entrambi i saggi.
35
Nella documentazione d’archivio si conserva notizia del rinvenimento di almeno due tombe sotto «un gran cumulo di pietra, qualche tonnellata» (vedi, il documento n. VII). La descrizione degli oggetti dell’unica tomba scavata al momento della redazione della lettera coincide con il corredo della tomba 12. 36 Sul tracciato viario, sostanzialmente ricalcato dall’attuale Strada vicinale di Fossascopana, vedi Ferreri e Panci 2017, 441-442. 21
Capestrano, I
comunque condusse all’individuazione di un abitato (poi identificato con Aufinum), collegato alla necropoli da una strada «ora sepolta sotto le coltivazioni, ma documentata dalla concorde testimonianza dei coltivatori locali» (SABAPCH, ADA, AQ 19.L, Richiesta conc. di scavo: Università di Pisa (1962); Menozzi et al. 2014, 269; d’Ercole 2015a, 110, nota 5). A seguito della rinuncia del Ferri, impegnato in altre indagini a Siponto, Cianfarani coinvolse nelle ricerche Ranuccio Bianchi Bandinelli, allora Direttore dell’Istituto di Archeologia dell’Università di Roma. Questi effettuò, nel settembre e novembre 1963, ricognizioni preliminari alla progettazione di saggi per la realizzazione della Strada Statale 153, il cui tracciato avrebbe insistito su quello della Strada vicinale di Fossascopana (SABAP-CH, ADA, AQ 19.M, Strada veloce Valle Tirino. saggi di scavo nella necropoli italica (1963)). I saggi, che evidenziarono la necessità di una variante al progetto dell’opera, furono eseguiti nel dicembre 1963 e gennaio-febbraio 1964 dalla Cassa del Mezzogiorno, sotto la sorveglianza dell’assistente della Soprintendenza Romano Lepore, di cui resta una documentazione grafica molto sommaria e che solo parzialmente sembra essere stata rielaborata in forma definitiva (SABAP-CH, Archivio disegnatori, Disegni vari e progetti superstrada ed acquedotti nella zona del Guerriero di C. 1964; sulla problematica, Salvia Del Rosario 1984, 53-54). Non è stato possibile vettorializzare gli schizzi, né elaborare disegni vettoriali a partire da questi: pertanto, nella planimetria generale alla Tav. 2 non sono riportate le tombe delle indagini 1963-1964. È stata recuperata, invece, la planimetria complessiva dei saggi (ASSI, fondo Bianchi Bandinelli Ranuccio, b. 260, Capestrano - Zona del Guerriero, scala 1:2000), che è stata acquisita mediante foto in più porzioni, georiferite su base catastale. Sembrano esservi indicati i tratti stradali rinvenuti in alcuni saggi, in particolare in quello immediatamente ad est dell’area indagata nel 200938. In questo documento i saggi non sono
Il primo saggio, a ovest, mise in luce la “strada romana”, parallela a nord alla via vicinale e in parte sottostante ad essa, a una profondità di 1 m, di cui viene per la prima volta registrata l’ampiezza di 4 m. Questa venne tuttavia distrutta per permettere l’esplorazione delle tombe da essa coperte, alcune delle quali manomesse in antico. Stando allo schizzo accluso ad una lettera del 22/06/1937 (Cella 2012, 63), la strada sembrerebbe essere glareata, probabilmente con pietrame calcareo, con massi di contenimento di maggiori dimensioni su entrambi i lati (per i riferimenti e la notizia del rinvenimento, Cella 2012, 63). Nel complesso furono individuate 12 tombe a fossa di età arcaica ed ellenistica, una tomba a grotticella bisoma, una incinerazione entro urna di età imperiale e, come risultato principale, due basi di statue con piedi. Dall’elaborazione vettoriale del rilievo risulta che le tombe coperte dall’asse stradale antico, i cui limiti dovrebbero coincidere a nord con i “limiti dello sterro” sullo schizzo del 02/07/1937 (vedi, 19) sono le tombe A-D, F-G, L-N e in parte H. Il secondo saggio del 1937, aperto ad est dell’area indagata nel 1934 (ma di cui non sono noti i limiti) ha portato al rinvenimento di una sola sepoltura (la tomba P). La documentazione grafica di entrambi i saggi del 1937 è stata georiferita su base catastale (Fig. 1.35) ed è stato pertanto possibile verificare come i posizionamenti finora proposti non siano attendibili, basandosi su schizzi misurati e non planimetrie in scala (vedi, Cella 2012, 67 e 74, figg. 6 e 13). In questa sede il rilievo vettoriale elaborato a partire da questa documentazione è stato georeferenziato utilizzando, come punto di appoggio, l’intersezione tra la strada vicinale e i limiti ovest delle particelle catastali rappresentate sugli schizzi planimetrici, e delle quali è riportato il nome del proprietario, che è stato preventivamente verificato mediante ricerca catastale su piattaforma SISTER (Catasto B651, f. 9, part. 892, 894). Dopo circa un quarto di secolo, tentò una ripresa delle indagini nella necropoli il Soprintendente Valerio Cianfarani, affidandone nel 1962 la direzione a Silvio Ferri dell’Università di Pisa (vedi, d’Ercole, 6). Il Ferri, tuttavia, effettuò solo un sopralluogo, che
38
Questo trova un riscontro in uno degli schizzi del Lepore: in una parte del saggio sono rappresentati i limiti laterali della strada antica e, al centro della sede stradale evidentemente smantellata, la porzione inferiore di una sepoltura. Il tratto risulta perfettamente in asse con la
22
Le ricerche a Capestrano dal 1934 al 2012
numerati e, oltre a quello appena citato, si è potuto riconoscere solo il saggio indicato negli schizzi del Lepore con il n. 8, per la forma, che presenta un approfondimento sul lato est, sotto la via campestre 39 . Questo saggio, che dagli schizzi sembra aver restituito almeno sei tombe a fossa (nn. 1-6) e due incinerazioni, è posto a sud del saggio 2007-2008. A tale proposito, nel corso di queste indagini, è emerso proprio il limite settentrionale del saggio 8 del 1963-1964. Nella documentazione del Lepore sono riportate altre tombe (non numerate): l’assenza dell’indicazione dei limiti e persino del numero dei saggi rende impossibile, al momento, stabilire a quale di questi si riferiscano i rinvenimenti. Nel complesso, le indagini del 1963-1964 consentirono il recupero di una decina di sepolture databili in età arcaica, ellenistica e imperiale40. Nel 1973, la collaborazione tra l’Università La Sapienza di Roma (Paola Piana Agostinetti) e la Soprintendenza alle Antichità dell’Abruzzo (Franca Parise Badoni), portò al rinvenimento di due tombe a fossa e due tombe a grotticella con corredi di fine II-I secolo a.C., i cui corridoi di accesso erano rivolti verso la strada antica, rinvenuta a sud (vedi, d’Ercole, 6)41. Lo scavo, così come i precedenti, si svolse rimuovendo anche i livelli geologici (nel banco di breccia fu rinvenuto «un lungo osso animale fossilizzato», SABAP-CH, ADA, AQ 19.N, Campagna di scavo 1973). L’indagine fu condotta mediante una serie di trincee collegate e agganciate ad est ad un saggio precedente (ritenuto pertinente alla
campagna del 1963-1964, forse è più propriamente riferibile a quella del 1934). Il settore indagato è certamente ad ovest dell’area di scavo del 1934, probabilmente in parziale sovrapposizione con il saggio del 1937: essendo il rilievo ancora in corso di elaborazione vettoriale e georeferenziazione, non se ne è riportato l’ingombro sulla pianta generale. Le indagini a carattere sistematico avviate nel 2003 su iniziativa della società ArcheoRes s.r.l. (Roberta Cairoli) sotto la direzione scientifica di Vincenzo d’Ercole, nell’ambito del progetto EQUAL “Terra dei Guerrieri” e i cui risultati sono oggetto di questo volume, furono intraprese con l’apertura di sei aree di scavo (AF) e quattro trincee minori (Tav. 2). Tuttavia, solo due settori (C-D) restituirono dati di natura funeraria, inquadrabili nei periodi orientalizzante recente, arcaico, ellenistico e, limitatamente al Saggio D, anche imperiale (vedi, d’Ercole 7-8). È stato possibile georeferenziare queste indagini con un basso margine di errore, rielaborando le planimetrie dei Saggi C e D e posizionandole mediante rototraslazione su una foto aerea obliqua del 2003, nella quale sono visibili le aree di scavo aperte ed alcune sepolture in corso di scavo, preventivamente georiferita con algoritmo projective sulla base di sette control points individuati sull’ortofoto della Regione Abruzzo del 2007 (per la foto in questione, vedi Tartara 2007, 555, fig. 134). Sulla base di questo posizionamento, è stato possibile scalare e rototraslare la planimetria complessiva delle indagini 2003 (d’Ercole e Cairoli s.d. [2005], 10, fig. 1). Come già accennato al par. I.1, le indagini in estensione, coordinate dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo sono proseguite per quattro anni a partire dal 2007: anche i risultati di queste campagne sono resi noti nel presente volume. Negli anni 2007-2008 è stata esplorata un’area ad est del Saggio D. L’area indagata nel 2009, in collaborazione con le Università di Chieti (Prof.ssa O. Menozzi) e Roma Tre (Prof. A. Guidi), si colloca invece a sud del settore del 2007-2008 e si sviluppa a ovest con una trincea coincidente grosso modo con la sede stradale moderna. Oltre a sepolture dei periodi già attestati nella necropoli, in particolare quest’ultima indagine ha messo in
spalletta di contenimento documentata nel settore sud-est del saggio 2009 (Tav. 2). 39 Negli schizzi del Lepore in questo ampliamento, a una distanza di 7.7 m dal limite sud del saggio, è rappresentata un’incinerazione: essa è coerentemente esterna all’asse stradale antico, che in questo settore risulta attestarsi più a sud rispetto all’attuale strada interpoderale (Tav. 2). 40 Terrosi Zanco 1967, 325. nota 5, 326, nota 4, 329; La Regina 1968, 411, nota 284; Cianfarani 1976, 62; Salvia Del Rosario 1984, 53-54; Spanu 2004, 385; d’Ercole e Copersino 2003, 363; Benelli e Rizzitelli 2010, 44. I materiali sono conservati nei magazzini del MUSè (nn. inv. 19462-19507; 24507-24510; 24516-24520; 25389). 41 Iaculli 1981, 205; Salvia Del Rosario 1984, 55; Capodicasa 2005, 24-25; d’Ercole e Copersino 2003, 363-364; Romito e Sangiovanni 2008; Benelli e Rizzitelli 2010, 44. I materiali sono conservati nei magazzini del MUSè (nn. inv. 12748-12847; 202401-202402). 23
Capestrano, I
luce un settore frequentato nella tarda età repubblicana e in età imperiale prospiciente l’asse stradale antico, di cui è stata individuata la spalletta di contenimento. La trincea del 2009 ha inoltre intercettato, presso l’estremità ovest, gli scavi del 1934, a cui sarebbero da riferire anche due sepolture vuote. Si tratta delle 307 e 309 di questo volume (vedi, 331-332), probabilmente identificabili rispettivamente con la 1 e la 13 del 1934. Se questa identificazione è corretta, lo scasso di forma quadrangolare intercettato nel 2009 verrebbe significativamente a coincidere con il punto di rinvenimento della statua maschile, riportato sulla pianta generale delle indagini 1934 (Moretti 1936-1937, tav. III). La planimetria generale degli scavi 2007-2009 è stata rielaborata in formato vettoriale e georiferita con uno scarto non del tutto quantificabile42. Un ultimo intervento di scavo ha interessato la necropoli nel 2010 (vedi, d’Ercole, 13), portando alla verifica dell’ampiezza della strada antica e all’individuazione di alcune sepolture, di cui due a grotticella. Poiché di questo intervento non sono disponibili rilievi, se ne può in linea di massima collocare l’areale in corrispondenza di uno scavo richiuso visibile su Orto2010 (Tav. 2).
alla rete idrica (S.L. Ferreri in Acconcia 2015, 33, fig. 14.A, n. 6). Le tracce di sepolture a fossa sembrano addensarsi in almeno due nuclei separati dall’attuale Strada vicinale del Maragone, che prosegue il tracciato della Strada vicinale di Fossascopana in direzione delle località di Passaturo-Ponte Antico (Tav. 1, n. 23). Il nucleo settentrionale è esattamente allineato con la strada (ovest-nord-ovest/estsud-est), mentre quello meridionale è orientato più propriamente a nord-ovest/sud-est (Fig. 1.37, B). Mentre il primo sembra avere una maggiore densità, probabilmente organizzato in forma rettangolare, quello meridionale e più cospicuo non sembra avere limiti precisi. Si individuano poi piccoli raggruppamenti di tombe, e anche tombe isolate, ad est e a ovest di esso. In entrambi si registra una tendenza alla disposizione ordinata delle fosse e ad una saturazione degli spazi disponibili, probabilmente a causa di una prolungata frequentazione, verosimilmente collocabile in età arcaica ed ellenistica. La seconda tendenza è meno evidente nel nucleo a nord della strada, il quale presenta al suo interno spazi privi di tracce, la cui forma e dimensione tuttavia non sembrano riferibili a tombe a tumulo. In quest’area è stato effettuato un saggio preventivo alla realizzazione della SS 153, nel 1963-1964, di cui tuttavia non si conosce l’esito (Fig. 1.37, B).
Tra Fossascopana e Monaresca (Tav. 1, n. 16; Fig. 1.37, A). Tra la località di Fossascopana e quella di Monaresca, chi scrive ha individuato tracce, probabilmente evidenziate da perdite della rete idrica, pertinenti ad almeno sette tombe a fossa disposte radialmente intorno ad un probabile tumulo e una apparentemente isolata.
Monaresca-Via dell’Olmo (Tav. 1, nn. 12a-b). Il nucleo funerario documentato in località Monaresca-Via dell’Olmo spicca per l’estensione dell’area complessivamente occupata dalle tracce di tombe a fossa e la loro densità. I grass-marks sembrano enfatizzati da perdite della rete idrica visibili come tracce di scorrimento delle acque (S.L. Ferreri in Acconcia 2015, 33, fig. 14.A, n. 5; Ferreri 2016, 123, figg. 3-4; vedi anche, senza indicazione della località, Tartara 2016, 47, fig. 7.E). La definizione spaziale e temporale della necropoli sembra tracciabile con sufficiente dettaglio, pur basandosi su dati eterogenei e frammentari (quali appunto ortofoto e immagini satellitari). Essa appare articolata in una pluralità di nuclei distinti di cui quello più orientale (non apparso nella sua interezza) sembra organizzato secondo una conformazione rettangolare. L’area centrale
Macero Bucci (Tav. 1, n. 18). In località Macero Bucci le analisi fotointerpretative hanno consentito di individuare un’area funeraria emersa, oltre che sulle immagini presentate, anche su Orto20012005 e Orto2010, probabilmente in relazione 42
Si è effettuata una rototraslazione su due punti: l’angolo est della tomba 244, visibile su Orto2007, e l’angolo sud-est della tomba 309 con l’omologo della tomba 1 del 1934. I rilievi non risultano perfettamente allineati: tuttavia, si tenga presente che quello proposto è un tentativo di omogeneizzazione di una documentazione redatta in diversi periodi, con vari strumenti e, soprattutto, da personale con una eterogenea sensibilità topografica. 24
Le ricerche a Capestrano dal 1934 al 2012
chiaramente definito da fosse disposte in senso radiale, tendenza che sembra mantenuta, in questo caso specifico, anche nei corridoi di accesso delle tombe a grotticella (per una simile organizzazione a Fossascopana, Saggio C, scavo 2003, e Presciano-Rajo, 30, 204). Proprio quest’ultimo tipo di tomba, se è corretta l’ identificazione delle tracce, suggerisce il termine cronologico più basso della frequentazione funeraria dell’area. Verosimilmente appartenenti ad un settore periferico della medesima necropoli, sono le otto sepolture individuate durante l’assistenza archeologica per la realizzazione di un condotto fognario lungo Via dell’Olmo, tra l’autunno 2010 e la primavera del 2011 (Tav. 1, n. 12b; vedi d’Ercole, 14 e il Volume II di questo lavoro; D’Alessandro et al. 2014, 297-298; V. d’Ercole in Menozzi et al. 2014, 267). Il range cronologico dei contesti va dalla fine del VIIinizi del VI secolo a.C. (tomba 6) alla prima metà del I secolo a.C. (tomba 3). La documentazione grafica, realizzata da Silvia D’Alessandro, è stata rielaborata in formato vettoriale e georiferita con elevata precisione grazie ai pozzetti della rete idrica (L10-L11), riportati sul rilievo e visibili sulle immagini satellitari (Tav. 3).
è occupata invece da numerose tombe, tendenzialmente disposte su lunghe file parallele: è incerto, tuttavia, se si tratti di un nucleo unitario a causa di ampie macchie di vegetazione erbacea, provocate da ristagni di umidità, che inficiano la visibilità dei limiti delle fosse. Nella parte meridionale di quest’area si notano però due tracce rettilinee, tra loro perpendicolari, orientate coerentemente con le sepolture, che potrebbero corrispondere a scassi per l’alloggiamento di una delimitazione tra settori contigui della necropoli (Tav. 3, indicati dalle frecce). I nuclei più orientali, verso la strada vicinale, sono apparentemente più circoscritti. Un elemento che caratterizza l’intera necropoli è la presenza di aree sub-circolari, con diametro compreso tra i 3 e i 9 m, risparmiate tra le tombe a fossa e identificabili con tumuli rasati dai lavori agricoli (se ne contano almeno 22). In alcuni casi si legge la presenza di una fossa in posizione centrale, anche se non necessariamente pertinente alla deposizione originaria del tumulo: nel settore meridionale della necropoli, in un caso essa potrebbe essere stata sostituita da una tomba a grotticella, se la forma e le dimensioni della traccia siano da riferire, come sembra, a un corridoio di accesso. La presenza di tumuli, sebbene in negativo, costituisce un criterio per collocare l’avvio della frequentazione funeraria di quest’area non oltre l’orientalizzante recente. A partire da questa fase, e nella successiva età arcaica, la necropoli dovette ricevere una pianificazione organizzata, con tombe a fossa orientate in via preferenziale a sud-sud-est/nord-nord-ovest. La diversa tendenza all’orientamento delle fosse, che si riscontra tra i vari settori della necropoli in rapporto alla presenza di tumuli, sembra ulteriormente ribadire una distinzione in nuclei rispondenti a propri criteri organizzativi. Infatti, mentre nel nucleo occidentale si riscontrano anche disposizioni che riproducono la circonferenza dei tumuli, nell’area centrale essi sembrano delimitati da fosse disposte parallelamente o ortogonalmente, con uno schema dunque più rigido che determina la formazione di aree di rispetto di forma subquadrangolare (per una simile organizzazione a Bazzano, lotto Arcobaleno, vedi Melandri 2012, 178). Il tumulo del nucleo più orientale è invece
Pizzone-Fossascopana, Fontanelle (Tav. 1, nn. 11a-b). Il tesoretto monetale composto da 184 vittoriati d’argento del 218-217 a.C., probabilmente da mettere in relazione con l’attestazione nella seconda guerra punica di una Vestina iuventus o anche interpretato come una offerta funebre, è stato rinvenuto a seguito di lavori agricoli nel 1937, nell’area compresa tra le località di Pizzone e Fossascopana (vedi, d’Ercole, 6; Cesano 1938; Buonocore e Firpo 1998, 826827, n. 7; Fossataro 2008, 364; V. d’Ercole in Menozzi et al. 2014, 269; per la documentazione di archivio, SABAP-CH, ADA, AQ 19.B, Contrada Pizzone: Rinvenimento di monete romane (1937)). Non essendo state effettuate ricerche catastali, il rinvenimento è stato collocato tra i due toponimi (Ferreri 2014, 546, fig. 2, n. 6). Tra le due località sono state individuate alcune tracce problematiche, almeno due delle quali probabilmente riferibili a tombe a fossa (dim. 25
Capestrano, I
medie ca 2.1 x 1 m) ed altre, di forma subcircolare, forse pertinenti a pozzetti di incinerazioni (diam. ca 0.8 m; Fig. 1.38, A). L’area risulta immediatamente esterna all’insediamento di Aufinum, collocata lungo un probabile asse stradale antico ripreso dall’attuale Strada vicinale del Macero (Tav. 1, n. 11a; Ferreri e Panci 2017, 443). Lungo questo tracciato, e propriamente in località Fontanelle, è stato individuato mediante aerofotointerpretazione un nucleo di tombe a fossa interessato nel 2012 da indagini dell’Università di Chieti (Tav. 1, n. 7; per il quale, si veda d’Ercole, 14 e il Volume II di questo lavoro). In tale occasione sono state messe in luce 48 sepolture databili tra la fine del VII e il II secolo a.C.; in sede di scavo si è individuata una disposizione circolare di alcune di esse, non apprezzabile con l’esame aerofotointerpretativo. Il nucleo è stato interpretato come lotto, pianificato, pertinente ad un gruppo familiare allargato (Di Sabatino e Acconcia 2016; Di Sabatino, Ferreri e Properzio 2014; Acconcia 2015, 1-9; S.L. Ferreri in Acconcia 2015, 32 e 33, fig. 14.B; d’Ercole 2016, 156). Il rilievo indiretto di queste indagini è stato realizzato da chi scrive mediante una stazione totale meccanica (Nikon NIVO 5M) e georeferenziato mediante alcuni punti di controllo individuati sulla CTRN 1:5000 (ed. 2000); è stata effettuata anche una ulteriore verifica dell’affidabilità della georeferenziazione (Fig. 1.38, B)43. L’area indagata non ha interessato il nucleo in tutta la sua estensione: alcune tracce pertinenti ad esso si osservano oltre il limite nord-ovest del saggio; sembrano inoltre notarsi tre tombe isolate a ovest del raggruppamento principale (Fig. 1.38, B). Lo scavo ha intercettato anche una trincea di coltivazione della vite: di questo impianto, di cui non è al momento possibile stabilire la cronologia, si osservano altri filari a
sud, disposti parallelamente alla distanza di ca 11-15 m (Fig. 1.38, B). Capo d’Acqua-Noce S. Ianni, Maragone (Tav. 1, n. 2b). Le prime indagini archeologiche programmate nell’area di Capo d’Acqua-Noce S. Ianni (più comunemente nota come Capo d’Acqua) sono state avviate nel 1965 dall’Istituto di Antropologia e Paleontologia Umana dell’Università di Pisa (Prof. M. Radmilli), interessando un insediamento neolitico individuato mediante ricognizione (Bonuccelli e Faedo 1968)44. Tali indagini, condotte con due saggi, hanno permesso l’individuazione di sette tombe (di cui solo tre scavate) che avevano in parte intaccato i fondi delle unità abitative del sito preistorico (SABAP-CH, ADA, AQ 19.G, loc. Capo d’Acqua - Ricerche paletnologiche 1965). L’attribuzione cronologica dei corredi al V sec. a.C., finora accolta senza riserve, può essere aggiornata sulla base dei confronti con altri contesti editi risalendo fino all’Orientalizzante recente (vedi Volume II di questo lavoro; Terrosi Zanco 1967, 328; Salvia Del Rosario 1984, 55) 45 . Alcuni materiali sembrano infatti indicare una datazione risalente, così come la tomba 1, di cui è menzionata la copertura a tumulo (Terrosi Zanco 1967, 320-323), è probabilmente pertinente all’Orientalizzante recente. La georeferenziazione delle aree di indagine è risultata problematica per l’assenza di documentazione grafica: non è stato possibile rintracciarla negli archivi SABAP-CH e nemmeno in quelli dell’Università di Pisa46. Dei saggi sono state fornite le coordinate piane nel sistema ED50 UTM 33 e geografiche nel sistema ROMA40, origine Roma Monte Mario (Terrosi Zanco 1967, 320, nota 1; Bonuccelli e Faedo 1968, 87), la cui conversione nel sistema ETRF89 UTM 33 con software ConveRgo, restituisce però due punti distanti ca 107.5 m in senso est-ovest (Ferreri 2014, 546, fig. 2, n. 10),
43
Tale verifica ha previsto il rilievo GNSS di due punti di controllo interni all’area di scavo mediante un sistema rover (Ashtech Promark 500) in modalità RTK agganciato alla rete ITALPOS. Si è ottenuta una precisione centimetrica che rendeva evidente un errore del sistema di inquadramento su base CTRN valutabile nell’ordine di 31-34 cm in planimetria e 97 cm in altimetria. Per tale rilievo, si ringrazia il Geom. Giulio Cesare Caruso.
44
Nella medesima occasione venne indagato un giacimento mesolitico presso le sorgenti di Capo d’Acqua (Tozzi 1966; Tav. 1, n. 4b). 45 I materiali sono conservati nei magazzini del MUSè (nn. inv. 25377-253887; 202255-202256). 46 Si ringrazia la Prof.ssa R. Grifoni Cremonesi per aver controllato il fondo Radmilli su richiesta dello scrivente. 26
Le ricerche a Capestrano dal 1934 al 2012
decisamente diversi dai posizionamenti descrittivi, secondo cui i saggi erano distanti ca 30 m in senso nord-sud (Terrosi Zanco 1967, 320-321). Con questi ultimi dati coincidono invece le indicazioni delle fonti orali, secondo le quali il proprietario del terreno interessato dagli scavi del 1965 piantò, in corrispondenza di essi, due alberi (la loro assenza precedentemente al periodo delle indagini è stata verificata su aerofotogrammi storici): essi hanno costituito un singolare criterio di georeferenziazione essendo rappresentati, come elementi puntuali, nella cartografia tecnica regionale (Tav. 4, A)47. Nel 1992, durante la realizzazione di una trincea per la posa in opera di un condotto idrico, nell’ambito dei lavori del Consorzio di Bonifica Alto Tirino, un intervento d’urgenza diretto dalla Soprintendenza Archeologica (Dott. A. Usai) permise la documentazione di ulteriori resti dell’abitato neolitico anche in questo settore, disturbato dall’impianto di una necropoli italica, di cui fu possibile recuperare alcuni elementi di corredi sconvolti e documentare una sepoltura intatta (SABAP-CH, ADA, AQ 19, Capestrano (AQ) - loc. Capo d’Acqua - abitato neolitico e necropoli italica; Usai 1993; vedi, d’Ercole, 7 e il Volume II di questo lavoro) 48 . V. d’Ercole fa notare la coincidenza tra questi interventi e la messa all’asta di un torsetto maschile nello stesso anno (Franchi Dell’Orto 2010a, 180; d’Ercole 2015a, 110, nota 4). Il corredo della tomba 1 è inquadrabile alla fine del VII-inizi del VI sec. a.C. (Capodicasa 2005, 23-24; d’Ercole 2010a, 155, fig. 288; d’Ercole 2015a, 104, figg. 100101). Alla metà del II-inizi I secolo a.C. si riferiscono invece gli otto frammenti in osso, sporadici, pertinenti al rivestimento di un letto funebre (d’Ercole e Copersino 2003, 363; Martellone 2010b, 358; d’Ercole 2015a, 104). Il tratto del condotto idrico interessato dalle indagini è riportato su una pianta allegata alla relazione dell’intervento del 1992 ed è stato georiferito come elemento lineare sulla traccia
del tipo grass-mark relativa alla trincea in cui è alloggiato il condotto stesso, emersa su GE2015b (Tav. 4, A). Nella stessa area, l’assistenza archeologica al cantiere per la realizzazione di una rete fognaria nel 2011 ha permesso la documentazione, nonostante i limiti imposti dalla trincea, ampia 70-80 cm e indagata per circa 210 m, di 18 sepolture (numerate da 9 a 26; D’Alessandro et al. 2014, 298-302; V. d’Ercole in Menozzi et al. 2014, 267; per questo scavo, vedi il Volume II di questo lavoro). Alcune tombe risultavano vuote (tombe 9-10, 12, 21, 24): si è pensato che potessero essere quelle indagate nel 1965, anche se la localizzazione di queste indagini lo esclude, oppure, com’è più probabile, che siano state manomesse in tempi recenti, eventualmente anche a causa dell’agricoltura meccanizzata, come sembrerebbe indicare il rinvenimento di una spada in ferro sporadica (Tav. 4, A; D’Alessandro et al. 2014, 298). I corredi si ascrivono ai periodi Orientalizzante recente e arcaico. I rilievi sono stati elaborati in formato vettoriale e rototraslati su due pali della rete elettrica (A15 e A9) riportati graficamente e visibili su GE2015a. L’area di Capo d’Acqua-Noce S. Ianni ha anche restituito tracce pertinenti a tombe a fossa, individuate in parte da V. d’Ercole, durante un volo di monitoraggio del giugno 2011 in collaborazione con i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale (d’Ercole 2015a, 105, 107 nota 7, fig. 102), in parte da chi scrive (S.L. Ferreri in Acconcia 2015, 33, fig. 14.A, n. 4). Le tracce non sono molto evidenti e non sembrano numerose: ciò potrebbe derivare da problemi di visibilità archeologica, eventualmente legati al notevole spessore dell’interro, alla scarsa profondità delle tombe o al loro essere tagliate in strati alluvionali. Il basso numero di evidenze potrebbe però riflettere anche l’effettiva consistenza di questi nuclei funerari, essendo d’altro canto visibili nei medesimi terreni tracce di altro tipo: filari di vigneto, buche di piante, condotti della rete idrica e l’area di uno scavo effettuato nel 1979 in occasione della loro posa in opera (Tav. 4, B; si veda anche, Spanu 2004, 385). La presenza nel settore a nord di tombe a fossa apparentemente isolate e con orientamenti diversi (dim. medie ca 3 x 1.1. m) fa comunque
47
DBTR 1:5000 (ed. 2007), sez. 360104, shapefile CR27G_ALBERO, id. feature n. 728 e 741. 48 I materiali sono conservati nei magazzini del MUSè (corredo tomba 1: nn. inv. 202257-202265; reperti sporadici di età arcaica: nn. inv. 202266-202274; reperti sporadici di età ellenistica: nn. inv. 202393-202400). 27
Capestrano, I
d’Ercole e Menozzi 2016, 421) 50 . Essi rimandano ad una frequentazione avviata probabilmente nella fase iniziale della prima età del Ferro fino al periodo ellenistico. Il luogo dei rinvenimenti è collocato su base catastale, mediante fonte orale (Ferreri 2014, 546, fig. 2, n. 7)51. Tale localizzazione sembra trovare riscontro in alcune tracce visibili su un terreno ad una settantina di metri a sud-est della particella interessata dai rinvenimenti (del medesimo proprietario): sebbene non chiaramente leggibili nel complesso, alcune tracce sembrano in effetti compatibili con sepolture a fossa (Tav. 1, n. 3b; Fig. 1.40, A ). L’utilizzo funerario dell’area può essere esteso in senso cronologico, ad età imperiale, e topografico, più a sud, considerando il rinvenimento di un’iscrizione latina (CIL IX, 3390), la cui localizzazione si pone significativamente nell’immediato esterno dell’area dell’abitato di Aufinum definita dalle ricognizioni (Tav. 1, n. 9; Ferreri e Panci 2017, 441).
ipotizzare una certa articolazione delle aree sepolcrali. Ancora da questo settore, si segnala almeno una fossa a pianta sub-rettangolare di grandi dimensioni (ca 4.6 x 1.6 m). In generale però emerge un quadro piuttosto diradato, sia a nord sia a nord-ovest del lago artificiale di Capo d’Acqua e non si riconoscono particolari addensamenti, se non un ordinamento in file tra loro perpendicolari nell’appezzamento indagato nel 1965 (dim. medie ca 2.1 x 0.75 m) e una probabile disposizione a circolo per il gruppo individuato da V. d’Ercole (dim. medie ca 2.6 x 0.9 m). Quest’ultimo elemento concorderebbe con le fasi più risalenti sinora attestate dagli scavi effettuati quest’area. Allo stato attuale delle ricerche, la fase ellenistica è attestata, oltre che dai frammenti di letto in osso già citati, anche da uno skyphos a vernice nera sporadico proveniente dalla ex Collezione Fulgenzi 49 . Un’iscrizione funeraria di età imperiale rinvenuta presso le sorgenti di Capo d’Acqua potrebbe più propriamente essere riferita ad un complesso rustico, attestato nell’adiacente località Campo Morto (Ferreri e Panci 2017, 443). Ad est del lago artificiale di Capo d’Acqua, in località Maragone, è stato possibile osservare altre tracce sub-rettangolari, riconducibili in via ipotetica a tombe a fossa di dim. medie 2.6 x 0.75 cm (Tav. 1., n. 10; Fig. 1.39).
Vignera di Capponi, Vicenne-Santa Maria di Presciano (Tav. 1., nn. 22 e 24). L’area in leggero pendio compresa tra le pendici nord-orientali dell’altura su cui sorge il borgo di Capestrano e la Strada comunale di Ofena per Bussi, designata con i toponimi Vignera di Capponi (a nord) e Vicenne (a sud), è interessata dalla presenza di tracce del tipo grass-mark riferibili a sepolture, impianti di viticoltura e “false tracce” relative a condutture moderne (S.L. Ferreri in Acconcia 2015, 33, fig. 14.A, n. 9). L’interesse archeologico dell’area era stato già messo in evidenza durante un sopralluogo effettuato nel 1979 dall’assistente della Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo e del Molise, Romano Lepore, nel corso della realizzazione della rete idrica da parte del Consorzio di Bonifica Alto Tirino: al di là della generica informazione della presenza di sepolture visibili
Vaturnina (Tav. 1, n. 3a). In località Vaturnina o Vatornina (nota anche come “Vatomina” o “Vatormina” nella letteratura archeologica, anche se non nella toponomastica locale) è localizzabile un nucleo funerario da cui proviene un lotto di materiali acquisiti con un sequestro del 1939-1940, riferibili a corredi sconvolti durante l’impianto di un vigneto (SABAP-CH, ADA, AQ 19.E, Loc. Vatomina. Suppellettili funebri (1939) Rinvenute da Demetrio Matteucci; vedi, d’Ercole, 6). I reperti sono stati esaminati solo in parte (Cella 2012, 59 e 73, fig. 2; d’Ercole e Cella 2007c, 131, nota 30; V. d’Ercole in Menozzi et al. 2014, 267; d’Ercole 2015a, 103;
50
I materiali sono conservati nei magazzini del MUSè (nn. inv. 1072-1085; 1087-1101), mentre un solo reperto è esposto nel Museo Archeologico Nazionale di Chieti (n. inv. 1086). 51 L’indicazione è stata fornita dal sig. Alfredo Matteucci (Catasto B651, f. 8, part. 181).
49
I materiali sono conservati nei magazzini della Galleria romana di Chieti (nn. inv. 19311, 19313, 19314, 19318, 19330, 19332, 19354, 19355, 19379, 19382-19384, 19386). Sulla problematica attribuzione di questi materiali, Ferreri e Panci 2017, 443, nota 30. 28
Le ricerche a Capestrano dal 1934 al 2012
«quasi ovunque» nei tagli delle trincee per la posa in opera dei condotti, si segnala più precisamente una tomba in un tratto «che scende quasi perpendicolare dal paese verso la valle» (SABAP-CH, ADA, AQ 19.S, loc. Capodacqua segnalazione di scoperte 52 archeologiche - Relazione 1979) . Il tratto interessato potrebbe essere quello in località Vicenne, con andamento est/nord-est, che interessa un’area in cui l’esame delle immagini satellitari evidenzia la presenza di tracce di sepolture (Fig. 1.41). In alternativa, potrebbe identificarsi con il condotto che attraversa la località Vignera di Capponi in direzione nordest verso Il Lago, località da cui provengono numerose iscrizioni funerarie di età imperiale (Ferreri e Panci 2017, 443-444; Tav. 1, n. 17). In un ampio appezzamento attualmente coltivato a vigneto (Azienda Valle Reale) situato nell’area detta Vignera di Capponi, risultano visibili esclusivamente su un fotogramma del maggio 2002 (precedente all’impianto viticolo) meno di una trentina di tracce probabilmente riferibili a sepolture, alle quali parzialmente si sovrappongono una traccia rettilinea riconducibile ad un solco di vigneto se ne osservano altre analoghe a nord-ovest - e il tracciato della rete idrica: complessivamente, questi interventi potrebbero aver compromesso la conservazione degli ipotetici contesti tombali (Fig. 1.40, B). Sebbene non sia possibile stabilirne la cronologia (in realtà, la risoluzione dell’immagine non ne consente nemmeno una sufficiente lettura planimetrica), si tenga presente che da questa località si è supposta la provenienza di due iscrizioni funerarie di età imperiale, e che vi sono diversi indizi che fanno ritenere che in quest’area transitasse in età romana un tracciato viario di una certa rilevanza, parzialmente ripreso dalla Strada Comunale di Ofena per Bussi (Ferreri e Panci 2017, 443-446). Nella località di Vicenne, invece, le tracce di contesti tombali risultano meglio leggibili. Nell’appezzamento meridionale, le tracce sono
in numero di poco inferiore al centinaio e si dispongono a nord e a sud di una traccia negativa grosso modo rettilinea con direzione est/sud-est, della lunghezza di ca 96 m e dell’ampiezza compresa tra 2.4-3.3 m, identificabile con una strada (Fig. 1.41). Il nucleo di tracce a nord-est presenta un orientamento indipendente rispetto all’asse viario, e probabilmente comprende sepolture precedenti ad esso; quello a sud sembra presentare un orientamento coerente con il percorso stradale, tuttavia la presenza di spazi privi di tracce, sebbene non chiaramente riferibili a tombe a tumulo, induce forse a leggere il rapporto intercorrente tra la strada e le tombe nei termini di una preesistenza di queste ultime; invece, strettamente correlate - dal punto di vista topografico e, probabilmente, anche cronologico - con la strada, sembrano essere alcune tracce allineate parallelamente al percorso, a nord, e altre perpendicolari a questo, a sud, queste ultime identificabili, in via ipotetica, con tombe a grotticella (Fig. 1.41). Nella medesima località, in un appezzamento di maggiore estensione a nord di quello appena esaminato, è possibile leggere il prosieguo della traccia pertinente alla strada - anche se non in maniera continua - complessivamente per ca 220 m, e la presenza di una trentina di tracce identificabili con sepolture a fossa e, in via più incerta, a grotticella, oltre a due di forma subcircolare che potrebbero costituire pozzetti relativi ad incinerazioni (Fig. 1.41). A queste tracce si aggiungono quelle delle trincee di un impianto viticolo e della rete idrica, che potrebbero aver parzialmente intaccato i contesti tombali. All’area funeraria di Vicenne va certamente riferita la tomba maschile, arcaica, indagata nel corso della realizzazione di un impianto fognario nel 2011, sottostante la Strada Comunale di Ofena per Bussi, di cui è stato georeferenziato il punto di rinvenimento (D’Alessandro et al. 2014, 297; V. d’Ercole in Menozzi et al. 2014, 268).
52
Oltre a questa, sono segnalate altre due tombe in particolare - una priva di corredo, circondata da pietrame, ritenuta di età romana e una del tipo “a cappuccina” indicate al Lepore da un ex finanziere e un dipendente comunale che perlustravano le trincee. Purtroppo, non è menzionata la località di rinvenimento.
Presciano, Presciano-Rajo (Tav. 1, nn. 26-27). Dalla località di Presciano proviene un corredo probabilmente dell’età ellenistica, rinvenuto nel 29
Capestrano, I
1938 e segnalato dall’Ispettore onorario Tommaso Corsi (SABAP-CH, ADA, AQ 19.C, Contrada Presciano: Rinvenimenti in prop. Maria Celli (1938); V. d’Ercole in Menozzi et al. 2014, 268, nota 16). Poiché al momento non è stato possibile localizzare il terreno interessato dai rinvenimenti, il punto è stato collocato in corrispondenza del toponimo catastale. Un’ampia area funeraria è stata individuata nel 2005 tra le località Presciano-Rajo (più semplicemente nota con il primo toponimo) nell’ambito di voli di monitoraggio effettuati dal CNR-IBAM (Dott.ssa P. Tartara) in collaborazione con il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri (Tartara 2007, 553554, n. 85; 2008a, 191-192; 2008b, 11-12)53. In tale occasione, su un esteso appezzamento unitariamente coltivato ad erba medica sono stati documentati almeno tre nuclei di tracce riferibili a sepolture a fossa, di cui quello meridionale risulta poco leggibile per la sovrapposizione ad esso di evidenze di età romana e medievale (per queste fasi, vedi Ferreri e Panci 2017, 446, con bibl. prec.); l’appezzamento è interessato anche dal tracciato di un condotto idrico, che potrebbe aver intaccato le sepolture (Fig. 1.42). I nuclei nordoccidentale e centrale sono, invece, perfettamente definibili, nonostante in alcuni punti l’addensarsi di tracce non ne permetta una comprensione adeguata. Entrambi i nuclei nord-occidentale e centrale sono stati rispettivamente indagati con saggi nel 2010 e nel 2011: il primo in collaborazione tra la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo (Dott. V. d’Ercole) e l’Università di Chieti; il secondo come intervento mirato alla verifica di interesse archeologico dell’area (Fig. 1.42; vedi, d’Ercole 14 si veda anche il Volume II di questo lavoro). I dati di scavo indicano l’avvio delle fasi di frequentazione nella prima età del Ferro (tomba 11), sebbene la maggior parte dei contesti sia inquadrabile in una fase avanzata dell’età arcaica; l’utilizzo a scopo
funerario, in seguito ad una cesura successiva alla metà del V secolo a.C., riprende nella seconda metà avanzata del IV e perdura almeno fino al II secolo a.C. La carenza di dati relativi alle fasi più risalenti, almeno fino all’orientalizzante recente, può essere integrata dall’evidenza di almeno tre tumuli nel nucleo centrale, indiziati da spazi circolari privi di tracce, e da altri tre probabili rispettivamente nel settore sud-est e ai limiti nord-ovest e nord dell’area di scavo del 2010 (Fig. 1.42). Il tumulo nell’area sud-est del saggio 2010 è stato riconosciuto in fase di scavo, grazie alla disposizione circolare e alla quota digradante verso nord-ovest di tombe perinatali/neonatali in coppo. Quello ai limiti nord-ovest del medesimo saggio sembrerebbe marcato dalle tombe 48 e 50, quest’ultima del tipo a grotticella. Poiché nella tomba non scavata immediatamente a nord di quest’ultima si può riconoscere un’altra tomba a grotticella, si può ipotizzare che i rispettivi corridoi di accesso fossero orientati in senso radiale ai margini del tumulo, analogamente alla disposizione riscontrata nel Saggio C 2003 della necropoli di Fossascopana e attestata probabilmente anche a Monaresca-Via dell’Olmo (vedi, 24-25). In via più incerta, un altro tumulo potrebbe essere ravvisabile nell’orientamento delle tombe 54-55 dello stesso saggio del 2010. I rilievi strumentali e l’inquadramento topografico con aggancio su cartografia catastale, sono stati effettuati da V. Acconcia: la georeferenziazione è consistita in una semplice rototraslazione della planimetria generale su una base catastale già georiferita. Diversamente da altri casi già visti (ad es., Vaturnina, Fossascopana; vedi 28), per l’area di Presciano-Rajo non possono essere considerate nei termini di una continuità con l’uso precedente le attestazioni funerarie di età imperiale, legate all’adiacente complesso rustico, come lascia intendere la lapide di Communis, vilicus di C. Orfidius Benignus (Ferreri e Panci 2017, 446). Cesa, Valle Cursore (Tav. 1, nn. 28a-d). Con il toponimo Cesa è designata un’ampia area per la quale finora non sono noti dati archeologici, ma di cui le analisi fotointerpretative evidenziano l’interesse per la
53
Alla Fig. 1.42 è stata inserita la foto aerea obliqua del 2005 (Tartara 2008b, 11, fig. 9), georiferita da chi scrive utilizzando un algoritmo di trasformazione projective su punti di controllo posti sull’attacco a terra dei pali della rete elettrica e al centroide dei pozzetti della rete idrica, riconosciuti sull’immagine di GE2013. 30
Le ricerche a Capestrano dal 1934 al 2012
rilevano numerosissime tracce relative ad un frutteto e ad estesi vigneti, il cui orientamento è affine al tracciato individuato (Fig. 1.43, A). Nel settore ad est della strada si notano altri grass-marks, meno di una decina, molto probabilmente pertinenti a tombe a fossa (dim. medie ca 2.3 x 1.2 m): alcune presentano una disposizione semicircolare, adombrando alla presenza di una tomba a tumulo (Fig. 1.43, A). Ancora nel nucleo centrale, ma a ovest della Strada vicinale di Cesa, sono visibili con minore evidenza altre tracce, ancora - forse - di tombe a fossa (Fig. 1.43, A). Sicuramente pertinenti a contesti tombali sono invece quelle rilevate a meno di 200 m a sud-est del blocco centrale: il nucleo si presenta con almeno una ventina di grass-marks, di forma sub-rettangolare (dim. medie ca 2.8 x 1.2 m), disposti parallelamente alla Strada comunale di Ofena per Bussi; si osserva almeno uno spazio vuoto, che fa presumere la presenza di una tomba a tumulo (Tav. 1, n. 28c; Fig. 1.44, A). Un ultimo raggruppamento di tracce probabilmente compatibili con tombe a fossa si osserva (anche su GE2015a) subito a valle della Strada Comunale di Ofena, in località Valle Cursore, in un appezzamento che evidenzia anche tracce di filari di un vigneto: entrambe le evidenze sembrano coerenti con l’orientamento della strada moderna, risultando rispettivamente parallele e perpendicolari ad essa (Tav. 1, n. 29a; Fig. 1.44, C).
presenza di tracce di impianti agricoli, resti di viabilità e necropoli, a cui in parte si sovrappone il tracciato della rete idrica (S.L. Ferreri in Acconcia 2015, 33, fig. 14.A, n. 7). Sui terreni immediatamente a monte della Strada Comunale di Ofena per Bussi, per una fascia di circa 900 m di lunghezza in direzione nord-ovest/sud-est, dell’ampiezza di circa 200 m, si riscontra la presenza di piccoli gruppi di tracce di forma sub-rettangolare, la maggior parte delle quali certamente pertinente a tombe. Presentano intorno ad una decina di tracce sia il nucleo occidentale (visibile anche su BM2010; dim. medie ca 2.3 x 0.7 m; Tav. 1, n. 28a; Fig. 1.43, B) sia quello orientale (dim. medie ca 2.4 x 1 m; Tav. 1, n. 28d; Fig. 1.44, B): in entrambi i casi le tracce non risultano inquadrabili cronologicamente, in quanto non si registrano configurazioni planimetriche particolari, se non una certa tendenza a disporsi con andamento parallelo; si riscontrano anche diversi orientamenti. Il settore centrale è più interessante, anche ai fini di una definizione cronologica e dei caratteri di utilizzo dell’area: le tracce sembrano dovute alla presenza della rete idrica (Tav. 1, n. 28b). Lungo i margini orientali della traccia di una strada rettilinea, ampia circa 2.5 m e che si segue per circa 315 m con andamento nordnord-ovest/sud-sud-est, si registrano delle tracce compatibili, per forma e dimensioni (ca 4.8 x 1.8 m), con almeno cinque tombe a grotticella, presumibilmente con volta sfondata - in alcuni casi se ne intuisce la traccia - e con gli accessi rivolti verso la strada, a contatto con essa (Fig. 1.43, A). Ai limiti settentrionali, la strada sembra piegare leggermente a nord, andando a formare un incrocio con la Strada Comunale di Ofena, di cui si è proposta la sovrapposizione ad un percorso antico (Ferreri e Panci 2017, 446). Se l’identificazione con tombe a grotticella risultasse corretta, tali contesti permetterebbero di datare l’impianto viario visibile in traccia all’avanzata età ellenistica, data l’evidente relazione con esso. L’orientamento di quest’asse è a sua volta probabilmente all’origine di una ripartizione catastale antica: sul lato ovest, infatti, si
31
Capestrano, I
Fig. 1.1. Localizzazione della necropoli di Capestrano nella regione Abruzzo (Italia).
Fig. 1.2. L’alta Valle del Tirino (AQ).
Fig. 1.3. La piana di Capestrano (AQ).
Fig. 1.4. L’abitato di Aufinum sul colle Sant’Antonino.
Fig.1.5. Ascia in bronzo, rinvenimento sporadico.
32
Le ricerche a Capestrano dal 1934 al 2012
Fig.1.6. Planimetria delle indagini di scavo del 1934 con indicazione del punto di ritrovamento della statua.
Fig. 1.7. Lettera datata 1937 a firma del Soprintedente Regio alle Antichità di Roma con la quale annuncia il ritrovamento di ulteriori due basi di statua e auspica la prosecuzione delle indagini archeologiche.
33
Capestrano, I
Fig. 1.8. Esposizione della statua del Guerriero di Capestrano nel Museo di Villa Giulia (Roma) nel 1945.
Fig. 1.10. La statua del Guerriero di Capestrano, dettaglio del volto.
Fig. 1.11. La statua del Guerriero di Capestrano, dettaglio della spada e del disco corazza. Fig. 1.9. La statua del Guerriero di Capestrano, VI sec. a.C
34
Le ricerche a Capestrano dal 1934 al 2012
Fig. 1.12. Balsamario - alabastron in vetro policromo blu e giallo del periodo italico-ellenistico. Figg. 1.13-1.14. Capestrano, saggio C, t. 126. Sepoltura neonatale in coppi contrapposti (prima e seconda fase di scavo).
Fig. 1.15. L’area di indagine archeologica nel 2003. Fig. 1.16. L’area di indagine archeologica nella zona di Presciano nel 2009.
Fig. 1.17. Capestrano, saggio D, foto generale dell’area di indagine archeologica nel 2003.
35
Capestrano, I
Fig. 1.18. Capestrano, t. 112. Spada e dettaglio dell’impugnatura.
Fig. 1.19. Capestrano, t. 112. Coltello.
Fig. 1.20. Capestrano, t. 112. Olletta.
Fig. 1.21. Capestrano, t. 172. Tomba a grotticella. Fig. 1.22. Capestrano, t. 172. Dettaglio dell’offerta alimentare, resti di suino (Sus scrofa L.).
36
Le ricerche a Capestrano dal 1934 al 2012
Figg. 1.23, 1.24, 1.25. Capestrano, t. 176. Tomba a fossa con deposizione di strumenti per il banchetto funebre. Visione generale del contesto e dettagli degli alari e del ripostiglio.
Fig. 1.26. Capestrano, t. 166. Esempio di ripostiglio.
37
Capestrano, I
Figg. 1.27, 1.28. Capestrano, t. 241. Tomba femminile di età arcaica con ricco corredo di vasellame bronzeo. Veduta generale e dettaglio in fase di scavo.
Figg. 1.29, 1.30. Capestrano, t. 207. Deposizione di vasellame bronzeo sugli arti inferiori del defunto. Visione generale e dettaglio in fase di scavo. Fig. 1.31. Capestrano, t. 214. Tomba a grotticella di una bambina di circa 4-6 anni che, oltre al consueto corredo del periodo, recava, vicino alla mano destra, una tanagrina in terracotta.
38
Le ricerche a Capestrano dal 1934 al 2012
Fig.1.32. Capestrano, t. 303. Veduta generale della “tomba recinto” che custodiva tre urne a incinerazione.
Fig. 1.33. Capestrano, t. 288. Cassetta litica per tomba a incinerazione.
Fig. 1.34. Capestrano, t. 341 e t. 340. Urne cinerarie.
39
Capestrano, I
Fig. 1.35. Capestrano, Fossascopana, scavi 1934 (in nero) e 1937: planimetria ricostruttiva (dati Agenzia del Territorio, SABAP-CH; SSABAP-RM; elab. S.L. Ferreri).
Fig. 1.36. Capestrano, Fossascopana, scavo 1934: sezioni ricostruttive (dati SABAP-CH; elab. S.L. Ferreri).
Fig. 1.37. Capestrano, Fossascopana-Monaresca (A) e Macero Bucci (B): fotointerpretazione e indagini archeologiche (dati Google, Regione Abruzzo, SABAP-CH; elab. S.L. Ferreri).
40
Le ricerche a Capestrano dal 1934 al 2012
Fig. 1.38. Capestrano, Pizzone-Fossascopana (A) e Fontanelle (B): fotointerpretazione e indagini archeologiche (dati Google, Regione Abruzzo, UniCH; elab. S.L. Ferreri).
Fig. 1.39. Capestrano, Maragone: fotointerpretazione (dati Google, Regione Abruzzo; elab. S.L. Ferreri).
Fig. 1.40. Capestrano, Vaturnina (A) e Vignera di Capponi (B): fotointerpretazione (dati Regione Abruzzo; elab. S.L. Ferreri).
41
Capestrano, I
Fig. 1.41. Capestrano, Vicenne-S. Maria di Presciano: fotointerpretazione e indagini archeologiche (dati Bing, Google, Regione Abruzzo, SABAP-CH; elab. S.L. Ferreri).
Fig. 1.42. Capestrano, Presciano-Rajo: fotointerpretazione e indagini archeologiche (dati CNR, Google, Regione Abruzzo, SABAP-CH, UniCH; elab. S.L. Ferreri).
42
Le ricerche a Capestrano dal 1934 al 2012
Fig. 1.43. Capestrano, Cesa (A-B): fotointerpretazione (dati Bing, Google, Regione Abruzzo; elab. S.L. Ferreri).
Fig. 1.44. Capestrano, Cesa (A-B) e Valle Cursore (C): fotointerpretazione (dati Google, Regione Abruzzo; elab. S.L. Ferreri). 43
CAPITOLO II La tipologia dei materiali dagli scavi nella necropoli Valeria Acconcia In questo capitolo 1 viene proposto un inquadramento complessivo dei materiali delle necropoli di Capestrano, indagate a partire dagli scavi del 1934 fino alle più recenti campagne di ricerca. Il criterio adottato è strettamente tipologico, con la consueta articolazione dei materiali in classi / forme / tipi, con l’integrazione, laddove necessario di varietà e varianti (queste ultime, intese nel senso di esemplari isolati che si distinguono dai tipi di riferimento per specifici caratteri morfologici o, in rari casi, decorativi; vedi Peroni 1967; 1998). Come si vedrà di seguito, la ricerca dei confronti è prevalentemente limitata a un’area geografica per lo più corrispondente all’Italia centrale, con particolare attenzione al comparto medio-adriatico, tenendo conto dei contesti meglio noti ed editi con maggiore accuratezza. Tra questi, rappresentano utili e necessari capisaldi le edizioni delle necropoli di Fossa (AQ), Bazzano-dall’età del Ferro al periodo tardo-arcaico (AQ), Campovalano (TE) e Alfedena (CH), che propongono anche un inquadramento cronologico aggiornato (Cosentino, d’Ercole e Mieli 2001; d’Ercole e Copersino 2003; d’Ercole e Benelli 2004; Weidig 2014; Chiaramonte Treré e d’Ercole 2003; Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010; d’Ercole, Martellone e Cesana 2016; Parise Badoni e Ruggeri Giove 1980; Parise Badoni et al. 1982; Parise Badoni 2002). A queste si aggiungono i lavori sulle altre necropoli abruzzesi, edite solo in parte, ad esempio quelle dell’area pescarese (Staffa 2001; 2003), teramana (per Atri, Baldelli e Ruggeri Giove 1982) o costiera meridionale (Papi 1979; Staffa 2000). Un’utile sintesi delle attestazioni di età ellenistica per il territorio abruzzese è proposta in Benelli e Rizzitelli 2010. Un contesto di particolare utilità, è quello della necropoli di Colfiorito di Foligno (PG),
nell’ambito della quale si riconoscono sostanziali affinità con le culture dell’area aquilana interna (Ponzi Bonomi 1997). Le necropoli preromane delle Marche offrono numerosi elementi di confronto, anche se la maggior parte dei contesti editi da questo comparto si inquadrano in un periodo lievemente più antico (si veda, ad esempio, Silvestrini e Sabbatini 2008). Di seguito, al fine di rendere più agevole la consultazione dei confronti, si elencano gli schemi di periodizzazione proposti per Bazzano e Alfedena. Per Campovalano viene qui adottata la scansione cronologica proposta in Acconcia 2014, elaborata sulla base dei contesti non disturbati della necropoli. Per quanto riguarda i confronti con i materiali di Fossa, mancando a Capestrano quasi completamente contesti riferibili all’età del Ferro e alle prime fasi del periodo Orientalizzante, si adottano le datazioni puntuali proposte in Fossa II e IV (d’Ercole e Benelli 2004; d’Ercole e Copersino 2003). Si riporta anche la periodizzazione della necropoli di Colfiorito. A tali periodizzazioni si farà riferimento nelle schede dei tipi, mentre l’inquadramento cronologico proposto sarà espresso in termini assoluti alla voce Datazione. Periodizzazione di Bazzano (Weidig 2014, 648): • Fase I (metà-inizio VII secolo a.C.); • Fase II, distinta in una fase IIA (secondo-terzo quarto del VII secolo), e fase IIB, a sua volta distinta in fase IIB1 (ultimo quarto del VIIprimo quarto del VI secolo a.C.); fase IIB2 (secondo-terzo quarto del VI secolo a.C.); • Orizzonte intermedio IIB2/III (terzo quarto del VI secolo a.C.); • Fase III (ultimo quarto del VI-prima metà del V secolo a.C.); • Fase IV (seconda metà del V secolo a.C. e avanzato).
1 Si ringrazia la dott.ssa Laura Sagripanti per aver contribuito alla documentazione grafica di questo capitolo.
45
Capestrano, I
Periodizzazione di Campovalano (Acconcia 2014, 82-87): • Metà/seconda metà del VII secolo a.C.; • Fine VII-prima metà del VI secolo a.C.; • Seconda metà-inizi del V secolo a.C.; • Prima metà del V secolo a.C. Per Campovalano, un consistente numero di sepolture non può essere ascritto puntualmente alle scansioni sopra elencate, e viene pertanto riferito genericamente al VI secolo a.C. (Acconcia 2014, 142-144, tabb. 1-5).
All’interno delle singole classi, le forme sono identificate con un numero arabo, con prevalente incremento alla decina; i tipi con numero arabo con incremento all’unità; le varietà e le varianti con le lettere dell’alfabeto minuscole. Per quanto riguarda il vasellame, le forme identificate per le classi A-F, H-L e O sono: anfore (10); anforette / amphoriskoi (20); vasi a collo (30); olle (40); ollette (50); olle biansate (60); ollette biansate (70); dolia (80); situle/vasi situliformi (90); oinochoai (100); olpai/brocche (110); lagynoi (120); balsamari/unguentari (130); pissidi (140); askoi (150); attingitoi (160); boccali (170); bicchieri (180); pocula (190); calici (200); kantharoi (210); tazze (220); scodelle (230); coppe (240); coppe biansate (250); coppette (260); coppette monoansate (265); kylikes (270); skyphoi (280); piatti (290); tegami (295); coperchi (300); vasi tripodati (310). Specificamente per il vasellame in lamina bronzea si individuano: calderoni (320); bacili (330); stamnoi (340); mestoli (350); colini (360). Il discrimine tra anfore/anforette e olle/ollette è posto intorno ai 25 cm di altezza; quello tra coppe e coppette, è posto intorno ai 13-14 cm di diametro e ai 5-6 cm in altezza. Le classi delle anfore da trasporto (G), delle lucerne (M) e dei balsamari ceramici (N), sono stati caratterizzati con una articolazione interna differente (si vedano le specifiche sezioni). Nell’ambito dell’instrumentum domesticum (Q) si individuano strumenti per la filatura/tessitura: fuseruole (10); pesi da telaio (20); pesi da rete (25); spolette (30); aghi (40). Strumenti per il trattamento dei cibi e delle bevande: spiedi (50); alari (60); grattugie (70); kreagrai (80); coltelli (90); mestoli (100). Utensili per il fissaggio di elementi in legno: chiodi (110); grappe (120). Nello strumentario per la cura della persona (R), si individuano: pinzette (10); forbici (20); strigili (30); specchi (40); rasoi (50). Per l’ornamento personale (S): cinturoni (10); fibule (20); armille (30); anelli (40); pendenti (50); vaghi (60); aghi crinali (70); fermatrecce (80); borchiette/bottoni (90). Per le armi (T): pugnali (10); foderi di pugnali (15); spade (20); foderi di spade (25); lance
Periodizzazione di Alfedena, scavi 1974-1979 (Parise Badoni 2002, 75, 87): • Fase I (fine VI-primi decenni del V secolo a.C.); • Fase II (decenni precedenti la metà-terzo quarto del V secolo a.C.); • Fase III (ultimo quarto del III-pieno IV secolo a.C.). Periodizzazione di Colfiorito di Foligno (Bonomi Ponzi 1997, 139-147): • Fase I (900-690 a.C.); • Fase II (VII secolo a.C.); • Fase IIIA (VI-prima metà del V secolo a.C.); • Fase IIIB (metà del V-metà del IV secolo a.C.); • Fase IV (seconda metà del IV-fine del III secolo a.C.). Nella tipologia che segue, le classi attestate nei corredi di Capestrano sono identificate da una lettera maiuscola. Si tratta dell’impasto grezzo (A); impasto buccheroide (B); ceramica etrusco-corinzia (C); ceramica depurata acroma (D); ceramica depurata a bande (E); ceramica di imitazione attica (F); anfore da trasporto (G); ceramica a vernice nera (H); ceramica comune (I); ceramica sigillata italica e tardo-italica (K); ceramica a pareti sottili (L); lucerne (M); balsamari ceramici (N); vasellame in lamina di bronzo (O); forme vascolari in vetro (P); instrumentum domesticum (Q); strumentario per la cura della persona (R); ornamenti personali (S); armi (T)2. 2
Sono stati esclusi dalla classificazione i materiali attestati in un numero troppo scarso di esemplari (ad es., le tanagrine, presenti con una sola attestazione) o di difficile inquadramento funzionale (ad es., le placchette di rivestimento di forma rattangolare) o conservati in
maniera troppo compromessa (ad es., la maggior parte dei calzari e dei ramponi). 46
La tipologia dei materiali
tirrenica, realizzate in bucchero o in impasto bruno.
(30); giavellotti (40); puntali (50); teste di mazza (60). All’interno di ciascuna scheda di tipo saranno elencati i contesti di rinvenimento (alla voce distribuzione), seguendo l’ordine con cui le varie necropoli di Capestrano sono prese in esame nei due volumi di questo lavoro, ovvero: nel Volume I, Fossascopana, scavi 2003-2009 (nelle figure, abbr. FSC 2003-2009); nel Volume II, Fossascopana, scavi 1934, 1964, 1965, 1973 (nelle figure, abbr. FSC 1934, 1964, 1965, 1973); Capo d’Acqua, scavi 1992 (nelle figure, abbr. CdA 1992); Fonte di Presciano, scavi 2010 (nelle figure, abbr. FP 2010); Fonte di Presciano, scavi 2011 (nelle figure, abbr. FP 2011): Via dell’Olmo, scavi 2011 (nelle figure, abbr. VdO 2011); Capo d’Acqua, scavi 2011 (nelle figure, abbr. CdA 2011); Fontanelle, scavi 2012 (nelle figure, abbr. CPF 2012).
VASI A COLLO (Forma 30). La definizione di “vaso a collo” è adottata in questa sede per distinguere gli esemplari di forma chiusa con collo distinto cilindrico molto sviluppato e con labbro prevalentemente svasato. In altri contesti, la stessa forma è definita olla o (in presenza delle anse) anforetta o anche, per alcuni esemplari dell’area picena, biconico. Il primo tipo presenta dimensioni superiori agli altri due ed è realizzato in impasto più grossolano e a mano: è plausibile quindi che si tratti di un vaso da conserva, mentre gli altri due possono essere identificati come vasi da mensa. In ambito medio-adriatico, la presenza di questa forma, a due o quattro anse, è abbastanza frequente, soprattutto nel comparto marchigiano nel corso dell’Orientalizzante (Stopponi 2003, 399-403).
IMPASTO GREZZO (A). Si ascrivono a questa classe forme vascolari con corpo ceramico ricco di inclusi di dimensioni varie (anche molto grandi), realizzate al tornio e a mano. La consistenza delle paste degli esemplari di età arcaica è solitamente molto friabile e raramente si conservano tracce di rivestimenti (ingobbi) o anche della stessa lisciatura delle superfici (più spesso, sulle forme “da mensa”, come i vasi a collo o i vasi potori). A quote cronologiche recenziori (età tardoarcaica ed ellenistica), le paste acquisiscono una maggiore compattezza, probabilmente grazie a un miglioramento delle competenze artigianali e, come si vedrà, le produzioni in impasto grezzo sono progressivamente sostituite da quelle di ceramica comune. All’interno della classe sono maggiormente attestate le forme chiuse, utilizzate per conservare gli alimenti o le bevande (tra queste, le olle trovano una specifica funzione come vasi contenitori dei ripostigli; vedi, 48), mentre più rare sono le forme aperte, che spesso coincidono con le coeve produzioni di impasto cd. “buccheroide” (vedi, 63-65). Non si può pertanto escludere che si tratti di tentativi di riprodurre in un impasto meno raffinato forme tipiche di una classe che, come si vedrà, a sua volta imita le ceramiche da mensa dell’area
Tipo A.30.1. Vaso a collo con orlo tagliato internamente e appena distinto, alto collo troncoconico distinto dalla spalla, ventre globulare con andamento irregolare, fondo piano; alla base del collo è applicato un cordone ondulato (Fig. 2.1). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 277, n. 1. Confronti. Il tipo non trova confronti puntuali, se non con un esemplare più antico, in Fossa: t. 387, n. 2 (prima metà VII secolo a.C.; d’Ercole e Benelli 2004, 161). Datazione. L’associazione con gli altri materiali del contesto di rinvenimento, suggerisce di inquadrare il tipo alla fine del VI secolo a.C. Tipo A.30.2. Vaso a collo biansato, labbro svasato e orlo assottigliato, collo troncoconico distinto, spalla carenata e ventre rastremato, fondo piano; anse a bastoncello a sezione compressa impostate in corrispondenza della spalla; nel punto di massima espansione del ventre sono applicate sei bugne ovoidali (Fig. 2.1). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 134, n. 1. Confronti. Vicino a Fossa: t. 208, n. 11 (tra il secondo e il terzo quarto del VI secolo a.C.; 47
Capestrano, I
rapporto alla posizione che olle e ollette occupano all’interno delle sepolture. Le prime, infatti, sono state rinvenute pressoché solo nei ripostigli (ovvero gli apprestamenti tipici delle sepolture preromane del territorio abruzzese, collocate solitamente in un angolo delle fosse, o anche in nicchie appositamente allestite); le ollette, invece, facevano parte del corredo vascolare disposto in corrispondenza dei resti dell’inumato.
d’Ercole e Benelli 2004, 86), anche se il profilo del tipo in esame coincide con quello, privo delle anse, dell’esemplare n. 10 della t. 64 di Fossa (decenni centrali del VII secolo a.C.; d’Ercole e Benelli 2004, 39). Datazione. L’associazione con il pugnale del Tipo T.10.1 (vedi, 141) nel corredo della tomba 134 di Fossascopana, suggerisce di circoscriverne la datazione a un orizzonte compreso tra l’ultimo quarto del VII e la prima metà del VI secolo a.C.
OLLE OVOIDI (40.A). Tipo A.30.3. Vaso a collo tetransato, labbro svasato e orlo lievemente ingrossato con risega interna, alto collo troncoconico distinto, ventre globulare, basso piede a tromba; anse a bastoncello a sezione circolare impostate dalla spalla al ventre (Fig. 2.1). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 178, n. 1. Confronti. Il profilo avvicina il tipo a un esemplare biansato e su alto piede da Fossa: t. 43, n. 14 (seconda metà del VII secolo a.C.; d’Ercole e Benelli 2004, 26). Si veda anche l’esemplare biansato n. 1 della t. 155 di Campovalano (prima metà VI secolo a.C.; Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 62). Datazione. Seconda metà/fine VII-prima metà VI secolo a.C.
Tipo A.40.A.1. Olla ovoide di grandi dimensioni con labbro diritto; orlo distinto ingrossato; spalla sfuggente; fondo piano profilato (Fig. 2.1). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 302, n. 1. Confronti. Si tratta di un tipo abbastanza generico, che trova confronti con le olle cilindro-ovoidi dell’area tirrenica e presenta una notevole durata dal periodo arcaico fino all’età ellenistica. Fossa: t. 209, n. 1 (la cui datazione è scarsamente puntualizzabile ed indicata come “precedente al III secolo a.C.”, per ragioni stratigrafiche; d’Ercole e Copersino 2003, 49). Datazione. VI-IV secolo a.C. (?). Tipo A.40.A.2. Olla ovoide con labbro lievemente svasato; orlo arrotondato; alta spalla arrotondata; fondo piano; in corrispondenza del punto di massima espansione del ventre sono applicate quattro bugne ovali (Fig. 2.1). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 296, n. 1. Confronti. Colfiorito di Foligno: tipo IIIA2 (Bonomi Ponzi 1997, 96). Datazione. L’associazione con la tazza di impasto buccheroide nel corredo della tomba 296 di Fossascopana, orienta la datazione del tipo alla seconda metà VI-prima metà V secolo a.C.
OLLE (Forma 40). Le olle sono attestate con una notevole varietà morfo-tipologica, legata da una parte alla funzione primaria di questi esemplari (prevalentemente vasi da conserva), dall’altra al fatto che fossero probabilmente realizzate da ceramisti non specializzati. In ragione di questa eterogeneità, gli esemplari presi in esame sono stati suddivisi in primo luogo per gruppi, sulla base dell’andamento del profilo: ovoide (40.A) e globulare (40.B). In ambedue i gruppi sono stati distinti tipi la cui altezza varia tra i 39 e i 53 cm (olle di grandi dimensioni, Tipi A.40.A.1, A.40.B.1-7), e altri con altezza tra i 25 e i 35 cm (olle di medie dimensioni, Tipi A.40.A.2-9, A.40.B.8-29). A tale proposito, va ribadito come in questa sede le olle di altezza inferiore ai 25 cm sono state inserite in una forma distinta (vedi avanti, le ollette, Forma 50). Tale distinzione è sembrata necessaria anche in
Tipo A.40.A.3. Olla ovoide con labbro svasato; orlo lievemente ingrossato e tagliato esternamente; spalla sfuggente; fondo piano (Fig. 2.1). Distribuzione. Via dell’Olmo, scavi 2011: tomba 1, n. 1. 48
La tipologia dei materiali
Confronti. Vicino al tipo C2, var. a delle olle di Bazzano, attestato nella fase III della stessa necropoli (Weidig 2014, 599). Cures Sabini: A. Zifferero in Guidi et al. 1996, 191, fig. 30, 2-3, 8 (VI-IV secolo a.C.). Datazione. Ultimo quarto VI-prima metà V secolo a.C.
a sezione quadrangolare; spalla arrotondata; fondo piano (Fig. 2.2). Distribuzione. Presciano, scavi 2010: tomba 41, n. 1. Datazione. Pur in mancanza di confronti puntuali, l’associazione con gli altri materiali nel contesto di rinvenimento (tra cui, ad es., una fibula Tipo S.20.A.2) suggerisce di inquadrare il tipo alla fine del VI secolo a.C.
Tipo A.40.A.4. Olla ovoide con labbro lievemente svasato; orlo distinto a mandorla; spalla sfuggente (Fig. 2.1). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009, t. 242, n. 1. Presciano, scavi 2010: tomba 8, n. 1. Confronti. Il tipo trova confronti con modelli di area tirrenica, ovvero con le olle cilindro-ovoidi con orlo a mandorla in impasto rosso-bruno, diffuse a partire dal VI fino all’età ellenistica. Il tipo è attestato a Fossa in età arcaica: t. 318, n. 11 (metà-terzo quarto VI secolo a.C.; d’Ercole e Benelli 2004, 132), ma anche in età ellenistica (tra IV e I secolo a.C.): con il tipo III delle olle, con specifica attestazione nella t. 204, n. 4 (prima metà III secolo; d’Ercole e Copersino 2003, 47 e 294). Datazione. L’associazione del tipo all’interno della tomba 8 di Presciano con un bacile a orlo ribattuto del Tipo O.330.B.4 (vedi, 112) suggerisce di datare il tipo alla fine del VI-V secolo a.C.
Tipo A.40.A.7. Olla ovoide con corto labbro diritto e distinto; orlo ingrossato a sezione quadrangolare e piano superiormente; spalla compressa; fondo piano (Fig. 2.2). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 219, n. 1; tomba 222, n. 1; vicino, l’esemplare n. 1 della tomba 259. Presciano, scavi 2010: tomba 49, n. 1. Confronti. Vicino al tipo C1, var. b di Bazzano, attestato nella fase III della necropoli (Weidig 2014, 599). Datazione. Fine VI-prima metà V secolo a.C. Tipo A.40.A.8. Olla ovoide con labbro lievemente rientrante; orlo ingrossato a sezione triangolare e tagliato superiormente; alta spalla arrotondata; ventre rastremato; fondo piano (Fig. 2.2). Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 5, n. 1. Datazione. Pur in mancanza di confronti puntuali, il contesto di rinvenimento orienta una datazione del tipo al periodo ellenistico (si veda il Volume II di questo lavoro).
Tipo A.40.A.5. Olla ovoide con labbro a tesa; orlo tagliato a sezione quadrangolare, segnato da una profonda scanalatura esternamente; spalla sfuggente; ventre rastremato; fondo piano (Fig. 2.2). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 261, n. 1. Presciano, scavi 2010: tomba 54, n. 1. Confronti. Fossa: t. 116, n. 7; t. 389, n. 4 (fine VI-inizi V secolo a.C.; d’Ercole e Benelli 2004, 47, 162). Datazione. Pur in mancanza di confronti puntuali, l’associazione con gli altri materiali nel contesto di rinvenimento (tra cui, ad es., un bacile in lamina bronzea Tipo O.330.B.3 e una fibula Tipo S.20.A.2) suggerisce di inquadrare il tipo alla fine del VI secolo a.C.
Tipo A.40.A.9. Olla ovoide con labbro lievemente rientrante; orlo ingrossato a sezione triangolare e tagliato superiormente; spalla sfuggente; ventre piriforme; fondo piano (Fig. 2.2). Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 34, n. 1. Datazione. Pur in mancanza di confronti puntuali, il contesto di rinvenimento orienta una datazione del tipo al periodo ellenistico (si veda il Volume II di questo lavoro). OLLE GLOBULARI (40.B).
Tipo A.40.A.6. Olla ovoide con labbro corto e lievemente rientrante; orlo ingrossato e distinto
Tipo A.40.B.1. Olla globulare di grandi dimensioni con corto labbro lievemente 49
Capestrano, I
svasato; orlo arrotondato appena distinto; spalla arrotondata; fondo piano; sulla spalla sono applicate quattro bugne coniche di piccole dimensioni (Fig. 2.2). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 271, n. 1. Confronti. Il tipo non trova confronti puntuali, è vicino a Fossa: t. 121, n. 13 (terzo quarto VI secolo a.C.; d’Ercole e Benelli 2004, 54). Datazione. La datazione del tipo è probabilmente da inquadrare alla fine del VI secolo a.C., vista l’associazione con un bacile a orlo perlinato del Tipo O.330.A.6 (vedi, 111).
Tipo A.40.B.5. Olla globulare di grandi dimensioni con alto labbro lievemente svasato; orlo distinto ricurvo a sezione triangolare, decorato all’esterno da una scanalatura orizzontale; alta spalla distinta; ventre a profilo carenato; fondo piano (Fig. 2.3). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 173, n. 1. Confronti. Per l’andamento del profilo, è genericamente avvicinabile al tipo B2, var. b di Bazzano, attestato nella fase IIB della necropoli (Weidig 2014, 595 e 599). Datazione. Seconda metà VI secolo a.C.
Tipo A.40.B.2. Olla globulare di grandi dimensioni con labbro lievemente svasato; orlo distinto e ingrossato; spalla arrotondata; ventre rastremato; fondo piano (Fig. 2.2). Distribuzione. Presciano, scavi 2010: tomba 48, n. 1. Confronti. Vicino al tipo precedente. Datazione. Fine del VI secolo a.C.
Tipo A.40.B.6. Olla globulare di grandi dimensioni con alto labbro lievemente svasato; orlo distinto e ricurvo, ingrossato a mandorla; spalla sfuggente; fondo piano (Fig. 2.3). Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: t. 36, n. 1. Datazione. Cures Sabini: A. Zifferero in Guidi et al. 1996, 191, fig. 30, nn. 16-18 (VI-IV secolo a.C.). L’associazione con il resto del corredo della tomba 36 di Fontanelle (pugnale del Tipo T.10.1, bacile del Tipo O.330.B.4 ne suggerisce una datazione alla prima metà del VI secolo a.C.; vedi, 112, 141 e il Volume II di questo lavoro).
Tipo A.40.B.3. Olla globulare di grandi dimensioni con corto labbro lievemente svasato; orlo ingrossato a sezione triangolare, decorato all’esterno da due scanalature orizzontali; alta spalla arrotondata; fondo piano (Fig. 2.3). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 249, n. 1. Fossascopana, scavi 1965: tomba 1, n. 1. Capo d’Acqua, scavi 2011; tomb1 15, n. 1. Confronti. Vicino al tipo B3 di Bazzano, attestato nella fase IIB della necropoli (Weidig 2014, 595. 599). Datazione. VI secolo a.C.
Tipo A.40.B.7. Olla globulare di grandi dimensioni con corto labbro lievemente svasato; orlo ingrossato e tagliato internamente; spalla sfuggente (Fig. 2.4). Distribuzione. Via dell’Olmo, scavi 2011: tomba 7, n. 1. Confronti. Pur trovandosi associato nel contesto di rinvenimento a materiali di età arcaica, ad esempio con il bacile di Tipo O.330.A.3, si tratta probabilmente di un tipo di lunga durata: esso trova infatti confronti a Fossa: t. 333, n. 9 (fine III-prima metà II secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 82). Datazione. VI secolo a.C.
Tipo A.40.B.4. Olla globulare di grandi dimensioni con labbro svasato; orlo ricurvo, ingrossato e arrotondato esternamente; spalla sfuggente (Fig. 2.3). Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 28, n. 1. Confronti. Vicino al tipo B3 di Bazzano (vedi sopra). Fossa: t. 382, n. 13 (prima metà VI secolo a.C.; d’Ercole e Benelli 2004, 156). Datazione. VI secolo a.C. Nel contesto di rinvenimento, ascrivibile al periodo ellenistico, i frammenti dell’olla ascritta al tipo in esame erano residuali.
Tipo A.40.B.8. Olla globulare con labbro lievemente svasato; orlo ingrossato a sezione triangolare, compresso superiormente; spalla sfuggente; fondo piano (Fig. 2.4). Distribuzione. Fossascopana, scavi 1934: tomba 4, n. 1. Datazione. Pur in mancanza di confronti puntuali, il contesto di rinvenimento orienta una 50
La tipologia dei materiali
del Tipo T.20.1 (vedi, 142-143) e, nella tomba 230, con un pugnale del Tipo T.10.1 (vedi, 141), ne suggerisce l’inquadramento come tipo di lunga durata, databile al VI secolo a.C.
datazione del tipo al periodo arcaico avanzato (si veda il Volume II di questo lavoro). Tipo A.40.B.9. Olla globulare di grandi dimensioni con labbro lievemente diritto; orlo distinto a tesa, a sezione quadrangolare; spalla sfuggente; fondo piano (Fig. 2.4). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 221, n. 1. Confronti. Vicino al tipo C1, var. a di Bazzano, attestato nella fase III della necropoli (Weidig 2014, 599). Fossa: t. 116, n. 7 (decenni finali VI-inizi V secolo a.C.). Datazione. Ultimo quarto VI-prima metà V secolo a.C.
Tipo A.40.B.14. Olla ovoide con labbro a colletto; orlo arrotondato; spalla arrotondata; ventre rastremato; fondo piano; sulla spalla sono applicate quattro prese semicircolari (Fig. 2.5). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 270, n. 1. Confronti. Trova un confronto generico con l’olla troncoconica n. 4 della t. 343=357 di Fossa, che presenta però collo troncoconico e labbro appena svasato (VI secolo a.C.; d’Ercole e Benelli 2004, 142). Datazione. VI secolo a.C.
Tipo A.40.B.10. Olla globulare di grandi dimensioni con corto labbro diritto; orlo distinto e ingrossato a sezione quadrangolare, piano superiormente; spalla sfuggente; fondo piano (Fig. 2.4). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 186, n. 1. Confronti. Vicino al tipo B4, var. a di Bazzano, attestato nella fase IIB2 della necropoli (Weidig 2014, 595). Fossa: t. 464, n. 2 (fine VI-V secolo a.C.). Datazione. VI secolo a.C.
Tipo A.40.B.15. Olla globulare con labbro svasato; orlo semplice arrotondato; spalla arrotondata; in corrispondenza della spalla sono applicate tre bugne ovali (Fig. 2.5). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 200, n. 1. Confronti. Il tipo si inquadra come una imitazione di modelli tirrenici di olle globulari in impasto rosso. Vicino a Fossa, t. 61, n. 6 (si tratta di un esemplare decorato a incisione); t. 232, n. 8 (prima metà VI secolo a.C.; d’Ercole e Benelli 2004, 34, 95). Datazione. Prima metà VI secolo a.C.
Tipo A.40.B.11. Olla globulare di grandi dimensioni con corto labbro lievemente rientrante; orlo distinto e ingrossato a sezione quadrangolare, tagliato superiormente; spalla lievemente compressa; fondo piano (Fig. 2.4). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 166, n. 1. Confronti. Vicino allo stesso tipo di B4, var. a di Bazzano (vedi tipo precedente). Datazione. VI secolo a.C.
Tipo A.40.B.16. Olla ovoide con labbro svasato; orlo tagliato esternamente; bassa spalla arrotondata; piede a disco (Fig. 2.5). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 171, n. 1. Fontanelle, scavi 2012: tomba 2, n. 1. Confronti. Vicino al tipo A2 di Bazzano, attestato nella fase IIB1 della necropoli (Weidig 2014, 595, 599). Datazione. VI secolo a.C.
In via altamente dubitativa si inserisce in questa sequenza come Tipi A.40.B.12 l’esemplare Fossascopana 2003-2009, tomba 157, n. 5, e 13 gli esemplari Fossascopana, tomba 230, n. 1; tomba 223, n. 1, di cui si conservano solo i labbri diritti, con gli orli distinti a sezione quadrangolare e tagliati superiormente (Fig. 2.4). Se il primo tipo si inquadra in età ellenistica sulla base del contesto di rinvenimento, per il secondo, l’associazione nel corredo della tomba 223 con una spada lunga
Tipo A.40.B.17. Olla globulare con labbro svasato; orlo lievemente ingrossato a sezione quadrangolare (Fig. 2.5). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 258, n. 1.
51
Capestrano, I
Confronti. Trova confronti con il tipo C2 di Bazzano, attestato nella fase III della necropoli (Weidig 2014, 599). Esso è però diffuso anche in età ellenistica, a Fossa: t. 130, n. 3; 7. 530, n. 3 (si tratta del tipo 2 delle olle, datato alla fine del III-prima metà del II secolo a.C.; 293-294). Datazione. Pur essendo di lunga durata, nel contesto di riferimento il tipo si inquadra tra la fine del VI e la prima metà del V secolo a.C.
Confronti. Vicino al tipo C3, var. B di Bazzano, attestato nella fase III della necropoli (Weidig 2014, 599). Datazione. Fine VI-prima metà V secolo a.C. Tipo A.40.B.18. Olla globulare con labbro svasato; orlo distinto lievemente ingrossato e arrotondato, con scanalatura superiore; spalla compressa; fondo piano (Fig. 2.5). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009, tomba 257, n. 1. Datazione. Pur in mancanza di confronti puntuali, l’associazione nel contesto di rinvenimento con materiali ascrivibili alla fine del VI secolo a.C. (scodella in impasto buccheroide Tipo B.230.A.7 e spada lunga Tipo T.20.1, vedi, 64, 142), suggerisce di inquadrare in questo orizzonte cronologico il tipo in esame.
Tipo A.40.B.22. Olla globulare con labbro diritto; breve orlo a tesa, lievemente ingrossato; spalla arrotondata; fondo piano (Fig. 2.6). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009, tomba 268, n. 1; tomba 276, n. 1. Fossascopana, scavi 1964: t. 4, n. 1. Confronti. Anche in questo caso, si rimanda tipo C2 di Bazzano (vedi tipo precedente). Datazione. Fine VI-prima metà V secolo a.C.
Tipo A.40.B.19. Olla globulare con labbro diritto; orlo ingrossato distinto a sezione quadrangolare, piano superiormente con una lieve insellatura; spalla compressa; ventre rastremato; fondo piano; sulla spalla sono applicate quattro prese semicircolari (Fig. 2.5). Distribuzione. Presciano, scavi 2010: tomba 52, n. 1. Datazione. Pur in mancanza di confronti puntuali, il contesto di rinvenimento orienta una datazione del tipo al periodo tardo-arcaico (si veda il Volume II di questo lavoro).
Tipo A.40.B.23. Olla globulare con corto labbro diritto; breve orlo a tesa, lievemente ingrossato; spalla compressa; fondo piano (Fig. 2.6). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009, tomba 283, n. 1; tomba 284, n. 1. Fossascopana, scavi 1934: tomba 6, n. 1 (con fondo convesso); tomba 19, n. 1. Scavi 1964, saggio 8, tomba 6, n. 1. Confronti. Anche in questo caso, si rimanda tipo C2 di Bazzano (vedi tipi precedenti). Fossa: t. 464, n. 2 (fine VI-V secolo a.C.; d’Ercole e Benelli 2004, 193). Datazione. Fine VI-prima metà V secolo a.C.
Tipo A.40.B.20. Olla globulare con corto labbro rientrante; orlo ricurvo, ingrossato e tagliato esternamente; spalla compressa; fondo piano (Fig. 2.5). Distribuzione. Presciano, scavi 2010: tomba 34, n. 1. Confronti. Il tipo è abbastanza generico, e trova confronti con Fossa: t. 123, n. 8 (prima metà I secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 43), pur essendo databile la tomba 34 di Presciano a un orizzonte più antico (comunque in età ellenistica). Datazione. III-I secolo a.C.
Tipo A.40.B.24. Olla globulare con alto labbro diritto; orlo ingrossato e distinto a sezione triangolare, segnato superiormente da una risega; spalla arrotondata; fondo piano (Fig. 2.6). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 125, n. 1. Confronti. Si tratta di un tipo di lunga durata, che trova confronti sia in età tardo-arcaica che in età ellenistica. A Fossa: t. 103, n. 2 (prima metà V secolo a.C.); t. 457, n. 5 (fine VI-prima metà V secolo a.C.) (d’Ercole e Benelli 2004, 46, 190); t. 169, n. 1 (fine III-II secolo a.C., ascritto al tipo 2 delle olle; d’Ercole e Copersino 2003, 44, 293-294).
Tipo A.40.B.21. Olla globulare con alto labbro diritto; orlo distinto a sezione triangolare; spalla arrotondata; fondo piano (Fig. 2.6). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009, tomba 260, n. 1. 52
La tipologia dei materiali
Fontanelle, scavi 2012: t. 1, n. 1; tomba 12, n. 1. Confronti. Il tipo si trova attestato prevalentemente in età ellenistica, con alcuni esempi più antichi, databili in età tardo-arcaica. Fossa: t. 449, n. 4 (V secolo a.C.; d’Ercole e Benelli 2004, 188); t. 213, n. 3; t. 418, n. 2; t. 539, n. 1 (fine IV-prima metà III secolo a.C.; ascritte al tipo 6 delle olle; d’Ercole e Copersino 2003, 51, 107, 152, 194). Datazione. V-prima metà III secolo a.C.
Datazione. Fine VI-prima metà III secolo a.C.; III-II secolo a.C. Tipo A.40.B.25. Olla globulare con labbro corto; orlo ingrossato e distinto a sezione quadrangolare, obliquo internamente, con una scanalatura orizzontale sulla superficie esterna; spalla arrotondata; fondo piano (Fig. 2.6). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 228, n. 1. Capo d’Acqua, scavi 2011: tomba 13, n. 1. Fontanelle, scavi 2012: tomba 31, n. 1; tomba 46, n. 1; vicino, anche l’esemplare n. 1 della tomba 14. Confronti. Il tipo presenta una lunga durata, a partire dal periodo tardo-arcaico fino a quello ellenistico. Fossa: t. 458, n. 3 (V/seconda metà V secolo a.C.; d’Ercole e Benelli 2004, 191); t. 282, n. 1 (fine III secolo a.C.; d’Ercole e Coperisno 2003, 70). Datazione. Gli esemplari rappresentativi sono stati rinvenuti prevalentemente di contesti di età ellenistica, tranne quello della tomba 13 di Capo d’Acqua, di età arcaica (si veda il Volume II di questo lavoro).
Tipo A.40.B.28. Olla globulare con labbro rientrante; orlo ingrossato e distinto a sezione quadrangolare, obliquo verso l’interno; spalla sfuggente; fondo piano profilato (Fig. 2.7). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 188, n. 1; tomba 291, n. 1. Presciano, scavi 2010: tomba 37, n. 1. Confronti. Si avvicina al tipo 7.3a1 della valle del Sagittario, in Dionisio 2015, 142 (IV-III secolo a.C.). Datazione. Fine IV-III secolo a.C. Tipo A.40.B.29. Olla globulare con corto labbro diritto; orlo distinto e appiattito; spalla arrotondata (Fig. 2.7). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 250, n. 1. Confronti. Vicino a Fossa: t. 265, n. 3 (seconda metà IV secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 67). Datazione. Seconda metà IV secolo a.C.
Tipo A.40.B.26. Olla globulare con labbro rientrante; orlo ingrossato e distinto, a sezione quadrangolare; spalla arrotondata; fondo piano (Fig. 2.6). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 123, n. 1; tomba 246, n. 1. Confronti. Fossa: t. 201, n. 3 (fine IV secolo a.C.; ascritto al tipo 1, var. 1; d’Ercole e Copersino 2003, 48, 192). Datazione. Sulla base delle associazioni di corredo presenti nei contesti di rinvenimento (vedi, 212-214, 295-296), è possibile inquadrare il tipo tra la fine del III e la prima metà del II secolo a.C.
OLLETTE (Forma 50). Anche in questo caso, si distinguono i gruppi delle ollette ovoidi (50.A) e globulari (50.B), ai quali si aggiunge il gruppo delle ollette troncoconiche (50.C). OLLETTE OVOIDI (50.A).
Tipo A.40.B.27. Olla globulare con labbro rientrante; orlo ingrossato e distinto a sezione triangolare, piano superiormente; spalla arrotondata; fondo piano (Fig. 2.7). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 131, n. 1; tomba 239, n. 1. Presciano, scavi 2010: tomba 53, n. 1 (con quattro bugne ovali applicate sulla spalla). Capo d’Acqua, scavi 2011: tomba 17, n. 1.
Tipo A.50.A.1. Olletta ovoide con labbro a colletto; orlo semplice arrotondato; spalla sfuggente; fondo piano; sulla spalla sono applicate tre bugne ovali (Fig. 2.7). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 171, n. 2. Presciano, scavi 2010: tomba 45, n. 1. Fontanelle, scavi 2012: tomba 44, n. 1; tomba 50, n. 2. 53
Capestrano, I
Confronti. Vicino al tipo IIIA2 di Colfiorito di Foligno (Bonomi Ponzi 1997, 96). Datazione. VI secolo a.C.
Datazione. Pur in mancanza di confronti puntuali, il contesto di rinvenimento orienta una datazione del tipo al periodo ellenistico.
Tipo A.50.A.2. Olletta ovoide con labbro lievemente svasato e orlo distinto; spalla sfuggente; fondo piano; quattro bugne ovali applicate sulla spalla (Fig. 2.7). Distribuzione. Presciano, scavi 2010: tomba 36, n. 1. Fontanelle, scavi 2012: tomba 3, n. 1; tomba 23, n. 1; tomba 43, n. 1 (probabilmente è ascrivibile allo stesso tipo l’esemplare n. 1 della tomba 10 dalla stessa necropoli). Confronti. Vicino a Fossa: t. 396, n. 1 (VI o V secolo a.C.): t. 343=350, n. 4 (VI secolo a.C.; d’Ercole e Benelli 2004, 142, 163). Datazione. VI-prima metà V secolo a.C.
Tipo A.50.B.3. Olletta globulare con ampio labbro rientrante; orlo ingrossato e distinto; spalla sfuggente; fondo piano. Distribuzione. Presciano, scavi 2010: tomba 35, n. 1. Confronti. Fossa: t. 324, n. 2 (V secolo a.C.; d’Ercole e Benelli 2004, 136). Datazione. Il tipo, abbastanza generico, ha probabilmente una lunga durata se, pur trovando confronti a Fossa in età tardo-arcaica, nel contesto di rinvenimento è associato a materiali di età ellenistica (V-III secolo a.C.). Tipo A.50.B.4. Olletta globulare con labbro rientrante; orlo ingrossato e distinto a sezione triangolare, piano superiormente; alta spalla arrotondata; fondo piano (corrisponde al tipo A.40.B.27; Fig. 2.8). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 216, n. 1. Confronti. Coincide, con dimensioni ridotte, con il Tipo A.40.B.27 (vedi, 53). Datazione. Fine IV-prima metà III secolo a.C.
Tipo A.50.A.3. Olletta globulare con labbro lievemente svasato; orlo assottigliato e tagliato internamente; collo cilindrico (Fig. 2.7). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 141, n. 1. Confronti. Si avvicina all’esemplare n. 2 della t. 387 di Fossa (prima metà VII secolo a.C.; d’Ercole e Benelli 2004, 161). Datazione. VII secolo a.C. (?).
OLLETTE TRONCOCONICHE (50.C). OLLETTE GLOBULARI (50.B). Tipo A.50.C.1. Olletta troncoconica con ampio labbro a colletto; orlo semplice tagliato superiormente; spalla appena distinta; in corrispondenza della spalla sono applicate due prese semicircolari (Fig. 2.8). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 251, n. 20. Datazione. L’esemplare di riferimento fa parte dei materiali residuali rinvenuti all’interno della tomba 251 di Fossascopana e trova confronti generici con alcune ollette dal territorio marchigiano (ascritte al Piceno IVA-B, come la t. 14 del fondo Fabiani di Numana o la tomba 225 dell’area Davanzali (Lollini 1976, fig. 13; Landolfi 1992; Delpino, Finocchi e Postrioti 2016, 296).
Tipo A.50.B.1. Olletta globulare con labbro diritto; orlo distinto a sezione triangolare, tagliato internamente; due scanalature orizzontali al di sopra della spalla; spalla arrotondata; fondo piano; in corrispondenza della spalla sono applicate tre bugne coniche (Fig. 2.7). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 166, n. 2. Confronti. Richiama l’esemplare n. 4 della t. 245 di Fossa (decenni finali VI-prima metà V secolo a.C.; d’Ercole e Benelli 2004, 98). Datazione. Ultimo quarto VI-prima metà V secolo a.C. Tipo A.50.B.2. Olletta globulare con corto labbro diritto; orlo distinto e ingrossato; spalla sfuggente; fondo piano (Fig. 2.7). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 214, n. 1.
Tipo A.50.C.2. Olletta troncoconica con ampio labbro lievemente svasato; orlo ricurvo arrotondato; spalla arrotondata; ventre rastremato; piede a disco; in corrispondenza 54
La tipologia dei materiali
sfuggente; fondo piano; anse a maniglia verticale impostate sulla spalla (Fig. 2.8). Distribuzione. Fossascopana, scavi 1934: tomba 5, n. 1. Confronti. Anche in questo caso, pur in mancanza di confronti diretti, è possibile che il tipo sia una rielaborazione locale di ollette stamnoidi in ceramica depurata o a fasce, si veda l’esemplare n. 3 dalla t. XI di Fratte (SA), genericamente ascrivibile al VI secolo a.C. (L. Tomay in Greco e Pontrandolfo 1990, 210). Il contesto di rinvenimento, inoltre, è ascrivibile alla fine del VI-inizi del V secolo a.C. per la presenza di un’olpe in lamina bronzea del Tipo O.110.1 (vedi, 108). Datazione. Fine VI-inizi V secolo a.C.
della spalla sono applicate quattro bugne ovali (Fig. 2.8). Distribuzione. Presciano, scavi 2010: tomba 40, n. 1. Confronti. Vicino a Imola, Montericco: t. 19, n. 3 (Von Eles Masi 1982, 50, tipo 3). Datazione. Il tipo è associato a una scodella Tipo B.230.A.5 ascrivibile al periodo tardoarcaico (fine VI-prima metà V secolo a.C.; vedi, 64). OLLETTE BIANSATE (Forma 70). Tipo A.70.1. Olletta globulare con corto labbro svasato; orlo ingrossato e tagliato esternamente; spalla compressa e carenata; ventre rastremato; fondo convesso; anse a maniglia orizzontali (Fig. 2.8). Distribuzione. Fossascopana, scavi 1934: tomba 18, n. 1. Confronti. Il tipo si ispira in maniera non stringente alle olle biansate in impasto rosso del comparto medio-tirrenico, pur non trovando confronti puntuali. Datazione. Il contesto di rinvenimento suggerisce un generico inquadramento in età arcaica (si veda il Volume II di questo lavoro).
DOLIA (Forma 80). Si ascrivono a questa forma i grandi contenitori con altezza superiore ai 60 cm. Tipo A.80.1. Dolio ovoide con labbro diritto; orlo distinto e arrotondato; collo distinto; spalla arrotondata; ventre a profilo ovoide; fondo piano (Fig. 2.9). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 331, n. 1. Datazione. Pur in mancanza di confronti puntuali, il contesto di rinvenimento orienta una datazione generica al periodo arcaico (vedi, 343-344).
Tipo A.70.2. Olletta globulare con corto labbro lievemente svasato; orlo ingrossato e arrotondato; spalla arrotondata; fondo piano; anse a maniglia impostate poco al di sotto della spalla (Fig. 2.8). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 245, n. 1. Confronti. Il tipo potrebbe richiamare in maniera estremamente dubitativa esemplari di olle stamnoidi in ceramica depurata: si veda ad esempio l’esemplare n. 15 della t. 5 del Migliaro a Cales (probabilmente, decenni centrali del VI secolo a.C.; Gilotta e Passaro 2012, 54). Imola, Montericco: tipo 2A delle olle (Von Eles Masi 1982, 350). Datazione. Il tipo nel contesto di rinvenimento è associato a una brocchetta in ceramica depurata (Tipo D.110.3) databile in età tardoarcaica (vedi, 67).
Tipo A.80.2. Dolio ovoide con corto labbro appena svasato; orlo distinto e ingrossato; spalla sfuggente; fondo piano (Fig. 2.9). Distribuzione. Fossascopana, scavi 1934: tomba 12, n. 2. Datazione. Pur in mancanza di confronti puntuali, il contesto di rinvenimento orienta una datazione generica al periodo arcaico (si veda il Volume II di questo lavoro). Tipo A.80.3. Dolio con corto labbro lievemente svasato; orlo ricurvo distinto e ingrossato; spalla sfuggente; fondo piano (Fig. 2.10). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 170, n. 1. Confronti. Fossa: t. 409, n. 5 (fine VI-primi decenni V secolo a.C.). Datazione. VI secolo a.C.
Tipo A.70.3. Olletta globulare con corto labbro rientrante; orlo ingrossato e distinto, a sezione triangolare, tagliato internamente; spalla 55
Capestrano, I
Confronti. Vicino a Fossa: tomba 547, n. 10 (decenni centrali VI secolo a.C.; d’Ercole e Benelli 2004, 207). Datazione. L’associazione nel contesto di rinvenimento con una fibula Tipo S.20.B.1 (vedi il Volume II di questo lavoro) suggerisce di estenderne la datazione fino agli inizi del V secolo a.C.
BROCCHE/OLPAI (Forma 110). Tipo A.110.1. Brocca globulare di piccole dimensioni con corto labbro svasato; orlo semplice; spalla arrotondata; fondo piano profilato; ansa sopraelevata a bastoncello, impostata dall’orlo alla spalla (Fig. 2.10). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 178, n. 2. Confronti. Corrisponde al tipo B4 di Bazzano, attestato nella fase IIB della necropoli (pref. IIB1; Weidig 2014, 555). Fossa: t. 382, n. 11; t. 403, n. 1 (prima metà-decenni centrali VI secolo a.C.; d’Ercole e Benelli 2004, 157). Datazione. Prima metà VI secolo a.C.
POCULA (Forma 190). Tipo A.190.1. Poculum globulare con labbro rientrante indistinto; orlo semplice arrotondato; fondo piano; poco al di sotto dell’orlo sono applicate quattro prese a lingua (Fig. 2.10). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 222, n. 2. Confronti. Trova confronti con materiali dalla necropoli di Cinturelli a Caporciano (AQ; d’Ercole, Martellone 2007b, 31, fig. 12) e con esemplari da contesti piceni degli inizi del V secolo a.C.: ad es. la t. 225 della necropoli di Numana (AN; Landolfi 1992). Si segnala un possibile confronto da Bazzano, dalla t. 1597, non inserita nel lavoro di J. Weidig (2014) ed edita in Chiaramonte Treré 2011, 137, fig. 1b (senza scala; probabilmente arcaica). Datazione. Fine VI-V secolo a.C.
Tipo A.110.2. Brocca ovoide di piccole dimensioni con alto labbro svasato; orlo semplice; spalla sfuggente; piede a disco; ansa sopraelevata a bastoncello compresso, impostata dall’orlo alla spalla (Fig. 2.10). Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 5, n. 2. Datazione. Guardiagrele (CH): t. 1 (attribuita alla seconda fase del sito, tardo-arcaica/inizi del periodo ellenistico; Iezzi 2001, 52). Il contesto di rinvenimento orienta una datazione al periodo ellenistico (si veda il Volume II di questo lavoro). ATTINGITOI (Forma 160).
Tipo A.190.2. Poculum troncoconico con labbro lievemente svasato; orlo semplice; vasca carenata; fondo piano; poco al di sotto dell’orlo sono applicate quattro prese a lingua (Fig. 2.10). Distribuzione. Presciano, scavi 2010: tomba 35, n. 2. Confronti. Fossa: t. 328, n. 9 (fine III-inizi II secolo a.C.; ascritto al tipo 3; d’Ercole e Copersino 2003, 70, 294). Datazione. III-II secolo a.C.
Tipo A.160.1. Attingitoio globulare con corto labbro a colletto; orlo semplice; fondo piano; ansa a bastoncello sormontante, impostata dall’orlo al punto di massima espansione del ventre (Fig. 2.10). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 261, n. 2. Confronti. Rimanda genericamente al tipo B1, var. b di Bazzano, attestato nella fase IIB2 (Weidig 2014, 554). Datazione. Seconda metà VI secolo a.C.
KANTHAROI (Forma 210). Tipo A.210.1. Kantharos carenato di piccole dimensioni, con labbro lievemente svasato; orlo semplice; carena arrotondata; fondo piano; anse a bastoncello sormontanti impostate dal labbro alla carena; sulla carena si conservano due bugne circolari (Fig. 2.11).
Tipo A.160.2. Attingitoio globulare con labbro rientrante; orlo semplice; fondo a disco; ansa a bastoncello sormontante, impostata dall’orlo alla spalla (Fig. 2.10). Distribuzione. Capo d’Acqua, scavi 2011: tomba 17, n. 2.
56
La tipologia dei materiali
bastoncello e datato dubitativamente alla prima metà del VI secolo a.C. (d’Ercole e Benelli 2004, 66, n. 5). Si possono istituire confronti puntuali anche con esemplari ascrivibili al periodo ellenistico dalla stessa necropoli (tt. 223, 402, 418, 447, 327/351; d’Ercole e Copersino 2003, 324-325). Ulteriori confronti si suggeriscono con un esemplare dalla tomba 4 del Piano a Navelli, datata problematicamente tra il pieno V e il IV-III secolo a.C. (vedi, S.L. Ferreri in Acconcia 2014, 272-273, con ampia discussione della bibliografia di riferimento). Datazione. V-III secolo a.C. (?).
Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 297, n. 2. Presciano, scavi 2010: tomba 36, n. 2. Confronti. Corrisponde al tipo B1 di Bazzano, attestato nella fase IIB1 (Weidig 2014, 507). Datazione. VI secolo a.C. Tipo A.210.2. Kantharos carenato di piccole dimensioni, con corto labbro lievemente svasato; orlo semplice distinto; carena arrotondata; piede a disco; anse a bastoncello sormontanti impostate dal labbro alla carena; sulla carena si conservano due bugne circolari (Fig. 2.11). Distribuzione. Fossascopana, scavi 1965, tomba 3, n. 1. Presciano, scavi 2010: tomba 1, n. 2. Confronti. Fossa: t. 245, n. 3 (decenni finali VIprima metà V secolo a.C.). Datazione. Decenni finali VI-prima metà V secolo a.C.
SCODELLE (Forma 230). Le scodelle sono distinte in tre gruppi: scodelle prive di anse (230.A); scodelle monoansate (230.B) e scodelle biansate (230.C). SCODELLE PRIVE DI ANSE (230.A).
TAZZE (Forma 220).
Tipo A.230.A.1. Scodella con vasca a calotta; labbro rientrante distinto; orlo semplice e arrotondato; fondo piano: in corrispondenza della carena sono applicate quattro bugne ovali (Fig. 2.11). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 182, n. 1. Confronti. Corrisponde alla Forma C di Bazzano, esemplare dalla t. 945, attestata nella fase IV della necropoli (Weidig 2014, 539). Datazione. L’associazione nel contesto di rinvenimento con fibule databili alla fine del VI-inizi V secolo a.C., suggerisce di rialzare la datazione del tipo almeno agli inizi del V secolo a.C.
Tipo A.220.1. Tazza ovoide con labbro lievemente rientrante; orlo semplice arrotondato; fondo piano; ansa sormontante (Fig. 2.11). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 141, n. 2. Presciano, scavi 2010: tomba 49, n. 2. Confronti. Si tratta di un tipo abbastanza generico, attestato tra VII e VI secolo a.C. Fossa: t. 325, n. 2 (fine VII-inizi VI secolo a.C.; d’Ercole e Benelli 2004, 137). Bazzano: tipo B2, var. a delle tazze, attestato tra la fine della fase I e la fase II della necropoli (Weidig 2014, 547). Datazione. VII secolo a.C.
Tipo A.230.A.2. Scodella con vasca a calotta; labbro diritto; orlo arrotondato e lievemente ingrossato (Fig. 2.11). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 206, n. 10. Confronti. Corrisponde al tipo A1 di Bazzano, attestato nella fase IIB della necropoli (Weidig 2014, 535). Datazione. VI secolo a.C. (l’esemplare di riferimento è residuale nella tomba 206).
Tipo A.220.2. Tazza carenata con labbro lievemente svasato; orlo semplice arrotondato; carena arrotondata; piede a disco; ansa a nastro sormontante, impostata dalla carena al labbro; in corrispondenza della carena sono applicate tre bugne ovali (Fig. 2.11). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 171, n. 3. Confronti. Corrisponde genericamente al Tipo B.220.1 (vedi, 63), diffuso dalla fine del VI secolo. Nella t. 163 di Fossa è attestato un esemplare frammentario con ansa a doppio 57
Capestrano, I
medio-adriatica, caratterizzata dall’uso di impasti abbastanza depurati e compatti che, attraverso processi di trattamento delle superfici e di cottura, tendono a riprodurre l’aspetto del vasellame in bucchero medio-tirrenico. Il colore delle superfici di queste forme è infatti variabile dal grigio al bruno scuro al nerastro, su cui sono spesso visibili aloni di cottura di colori diversi; la composizione delle paste è molto meno raffinata rispetto al bucchero tirrenico, la loro consistenza tendenzialmente più friabile; il vasellame presenta solitamente pareti più spesse e le superfici sono lucidate in maniera poco omogenea. Il repertorio morfologico adottato è quello del vasellame da mensa, ispirato a riprodurre modelli etruschi, sabini, faliscocapenati, elaborandoli in maniera autonoma. È plausibile che in Abruzzo fossero attive varie botteghe o cerchie artigianali dedite alla produzione di questa classe fortemente influenzate dalle aree limitrofe ma in possesso di minori competenze tecniche, come è stato sottolineato nella storia degli studi per l’area aquilana interna o per Campovalano (a tale riguardo si veda, E. Benelli in Benelli e Naso 2003, 199-205; Benelli e Weidig 2006; Acconcia 2012 con bibliografia di riferimento).
Tipo A.230.A.3. Scodella con vasca carenata; labbro lievemente svasata; orlo arrotondato e distinto (Fig. 2.11). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 112, n. 1. Confronti. Corrisponde al tipo 3 di Bazzano, attestato soprattutto nella fase III della necropoli (Weidig 2014, 529-530). Fine VIprima metà V secolo a.C. Fossa: t. 234, n. 4 (seconda metà VI secolo a.C.); t. 301, n. 8 (decenni finali VI secolo a.C.) (d’Ercole e Benelli 2004, 96, 122). Datazione. Ultimo quarto VI-prima metà V secolo a.C. SCODELLE MONOANSATE (230.B). Tipo A.230.B.1. Scodella monoansata di piccole dimensioni; labbro lievemente svasato; orlo semplice arrotondato; la vasca è distinta dal labbro da una carenatura scarsamente definita; fondo piano; ansa a maniglia impostata al di sopra della carena (Fig. 2.11). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 146, n. 1. Datazione. Genericamente confrontabile con un esemplare rinvenuto nella t. 6 della necropoli del Campo Sportivo ex Gesuiti a Pescara (fine VI-primi decenni VI secolo a.C.; Staffa 2003a, 561). Confronti. VI-prima metà V secolo a.C.
ANFORE (Forma 10). A fronte di una frequenza abbastanza elevata di questa forma e di quella dell’anforetta nelle altre necropoli aquilane e, in generale, nell’intero comparto abruzzese, i contesti di Capestrano hanno restituito un numero esiguo di esemplari, molti dei quali non inquadrabili in tipi specifici. Non è chiaro se tale lacuna sia legata a scelte nel rituale funerario o, come è più probabile, a una recenziorità della maggior parte dei contesti più antichi presi in esame, rispetto al periodo di maggiore diffusione di anfore e anforette (tra la fine del VII e il terzo quarto del VI secolo a.C.). Lo stesso fenomeno, del resto, si evidenzia per le olle/ollette. A tale proposito, va sottolineato che, nel comparto abruzzese, le anfore e le olle da mensa, realizzate in impasto bruno o in impasto buccheroide (con le rispettive varianti dimensionali) presentano strette ricorrenze morfologiche, dovute probabilmente a una tendenza alla forte ibridazione tra modelli di
COPPETTE (A.260). Tipo A.260.1. Coppetta a profilo globulare; labbro lievemente rientrante; orlo distinto e ingrossato a mandorla; piede ad anello (Fig. 2.11). Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 44, n. 2. Datazione. Pur in mancanza di confronti puntuali, il contesto di rinvenimento consente di inquadrare il tipo nel VI secolo a.C. (si veda il Volume II di questo lavoro). IMPASTO BUCCHEROIDE (B). Il termine “impasto buccheroide” è utilizzato in questa sede per identificare una specifica produzione di età arcaica e tardo-arcaica di area 58
La tipologia dei materiali
nel modello già ricordato a proposito degli esemplari di dimensioni superiori, diffuso tra la fine del VII e l’avanzato VI secolo a.C. (si rimanda, ancora a Benelli e Weidig 2006). Il secondo esemplare viene ascritto a un tipo distinto sulla base della presenza del piede a tromba, pur coincidendo sostanzialmente (per quanto conservato) con il precedente.
varia origine. In generale, la forma dell’anfora/anforetta globulare (più raramente ovoide) con collo distinto, labbro più o meno svasato e anse di solito sormontanti impostate sulla spalla, su piede a disco, ad anello o a tromba, deriva da modelli elaborati in area sabina e falisca e adottati dalle produzioni del comparto medio-adriatico tra la fine del VII e il VI secolo a.C. (Martelli 1977, 32-38; si veda ad esempio per Poggio Sommavilla, Alvino 1997, 62-64, nn. 6.1-6.8; Cantù 2010, 148-149, per il gruppo 8C ascritto alla seconda metà del VI secolo a.C.; per Capena, necropoli di San Martino: t. XXXVI: Sgubini Moretti 1973, 111, n. 196). Qui, si sviluppa un repertorio autonomo, ben leggibile nell’area aquilana ma anche in quella teramana (E. Benelli in Benelli e Naso 2003, 202-203; Benelli e Weidig 2006, 13; Benelli e Cifarelli 2011, 107; Acconcia 2012, 103-105, 109-111; 2014, 229-230). Come già più volte accennato, per anfore/anforette e olle/ollette, si adotta il discrimine dei 25 cm di altezza.
Tipo B.20.1. Anforetta globulare con collo distinto; labbro svasato; orlo semplice assottigliato; spalla compressa; ventre rastremato; piede a disco; anse a bastoncello impostate dalla spalla al ventre (Fig. 2.12). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 212, n. 1. Confronti. Corrisponde al tipo A1, var. c delle anforette di Bazzano, attestato specificamente nella t. 739, del terzo quarto del VI secolo a.C. (Weidig 2014, 560-561). A Fossa, il tipo è diffuso dalla prima metà dello stesso secolo: t. 157, n. 1; t. 163, n. 1; t. 382, n. 1 (prima metà VI secolo a.C.); t. 318 (metà/terzo quarto VI secolo a.C.) (d’Ercole e Benelli 2004, 60. 66, 132, 157). Collepietro (AQ), necropoli di Colle Santa Rosa: t. 2, n. 1; t. 4, n. 4 (Mieli 1998, 48, 53). A Campovalano, le anforette globulari con anse impostate sulla spalla sono attestate con una notevole varietà morfo-tipologica (C. Chiaramonte Treré in Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 141): corrispondono al tipo in esame gli esemplari, ambedue ascrivibili alla prima metà del VI secolo a.C., della t. 59, n. 2 (Chiaramonte Treré e d’Ercole 2003, 45); t. 95, n. 1 (Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 20). Teramo, necropoli de La Cona: tt.3 e 6 (fine VII-inizi VI secolo a.C.; Savini e Torrieri 2002, 43-46). Datazione. La presenza nel contesto di rinvenimento della brocca Tipo B.100.1 e di un pugnale a stami, consente di restringere l’orizzonte cronologico del tipo alla prima metà del VI secolo a.C.
Tipo B.10.1. Anfora globulare con collo distinto; labbro lievemente svasato; orlo assottigliato; basso piede ad anello; anse composte da due bastoncelli distinti, impostate in corrispondenza della spalla (Fig. 2.12). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 243, n. 1. Confronti. Vicino ad esemplari da Fossa caratterizzati da ventre rastremato e profilo slanciato e decorazione a stampigli, che E. Benelli ascrive a una produzione locale di livello qualitativo elevato, derivata da prototipi sabini e databile tra la metà del VI e la prima metà del V secolo a.C. (E. Benelli, in Benelli e Naso 2003, 204). L’esemplare di riferimento è il n. 1 della t. 436 di Fossa (seconda metà VI secolo a.C.; d’Ercole e Benelli 2004, 183). Si veda anche l’esemplare della t. 38 di Peltuinum (AQ): Acconcia, d’Ercole e Lerza 2011, 463, n. 2. Datazione. Seconda metà VI secolo a.C.
Tipo B.20.2. Anforetta globulare con collo distinto; labbro svasato; orlo semplice assottigliato; basso piede a tromba segnato esternamente da una scanalatura orizzontale; anse a nastro impostate dalla spalla al ventre (Fig. 2.12).
ANFORETTE (Forma 20). Dei due esemplari rappresentativi individuati nell’ambito delle necropoli di Capestrano, solo il primo si conserva integralmente e si inquadra 59
Capestrano, I
elaborato in Etruria meridionale, caratterizzato solitamente da labbro molto svasato e fondo piano (per la forma, si veda ten Kortenaar 2011, 86-95) e trasmesso all’area medio-adriatica tramite i territori interni sabino e capenate (per Capena, si vedano ad es. gli esemplari decorati ad excisione della t. 114 della necropoli di San Martino: Mura Sommella 2015, fig. 1). Esso viene recepito in territorio abruzzese e marchigiano nel corso del VII secolo a.C. e declinato variamente (si veda, a tale proposito, Chiaramonte Treré 2003, 70; Acconcia 2014, 108; Weidig 2014, 591-594; per il territorio piceno, gli esemplari della t. 93 e della t. 172 in loc. Crocifisso a Matelica: M.R. Ciuccarelli in Silvestrini e Sabbatini 2008, 99, nn. 109-110, 108-109, nn. 135-138, con bibliografia di riferimento). Come già accennato riguardo allo sviluppo delle anfore, per le cerchie produttive medio-adriatiche si registra un fenomeno di frequente ibridazione tra modelli di diversa provenienza, come dimostra soprattutto il caso di Campovalano. Nel caso in esame, ad esempio, si rileva una sovrapposizione di alcuni modelli noti proprio a Campovalano, rispetto quello dell’olla globulare biansata. L’esemplare della tomba 26 di Capo d’Acqua, infatti, presenta il collo e il labbro distinti rispetto alla spalla, come le anfore da mensa; la spalla rilevata (che non corrisponde al tipo canonico sfuggente e arrotondato dell’olla globulare medio-tirrenica) e il ventre rastremato richiamano ancora una volta le anfore (si vedano gli esemplari delle tt. 2, 63, 67, 136 e 166 di Campovalano), se non i biconici, come quello della t. 870 di Bazzano. I motivi incisi sull’olla, poi, trovano parziale corrispondenza proprio con quelli della decorazione del biconico e dell’anforetta della t. 870 di Bazzano e dell’anforetta della t. 1607, della fase IIB1 della necropoli. A tale proposito J. Weidig suggerisce di avvicinare gli esemplari di Bazzano a materiali prodotti da una stessa cerchia produttiva (“artista A”), i cui materiali circolano tra la Sabina, la conca aquilana e l’area picena (Weidig 2014, 586, 607). Datazione. Ultimo quarto VII-primo quarto VI secolo a.C.
Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 130, n. 1. Confronti. Vicino a Campovalano: t. 75, n. 1 (prima metà VI secolo a.C.; Chiaramonte Treré e d’Ercole 2003, 56). Datazione. È plausibile riconoscere per questo tipo un inquadramento cronologico vicino a quello proposto per il precedente, dal primo al terzo quarto del VI secolo a.C. VASI A COLLO (Forma 30). Tipo B.30.1. Vaso con alto collo troncoconico; labbro lievemente svasato; orlo semplice assottigliato; spalla compressa e ventre globulare; piede a disco; anse a bastoncello impostate in corrispondenza della spalla (Fig. 2.12). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 240, n.1. Datazione. Pur mancando confronti puntuali, l’associazione nel contesto di rinvenimento con un bacile del Tipo O.330.B.4 e con fibule del Tipo S.20.B.1 suggerisce una datazione del tipo tra la fine del VI e la prima metà del V secolo a.C. (vedi, 112, 128). OLLE BIANSATE (Forma 60). Tipo B.60.1. Olla biansata globulare con alto collo distinto; labbro lievemente svasato e orlo ingrossato; spalla rilevata e compressa; ventre rastremato; anse a maniglia impostate al di sotto della spalla. L’esemplare di riferimento presenta una decorazione incisa sul collo (due linee a zig-zag, che delimitano una serie di denti di lupo rivolti verso il basso), sulla spalla (archetti intrecciati e desinenti a motivi fitomorfi stilizzati – probabilmente foglie – intervallati da denti di lupo rivolti verso l’alto, delimitati verso il basso da una linea a zig-zag) e sul ventre (fiori di loto contrapposti, delimitati verso il fondo del vaso da due linee parallele; Fig. 2.12). Distribuzione. Capo d’Acqua, scavi 2011: t. 26, n. 1. Confronti. Vicino, Tolentino (MC), loc. S. Egidio: Percossi Serenelli 1992, 168, fig. 12a. L’esemplare non trova al momento confronti puntuali, anche se genericamente rimanda al modello dell’olla globulare biansata da mensa,
Tipo B.60.2. Olla biansata ovoide con labbro svasato e segnato sull’esterno da scanalature; orlo semplice appena distinto e tagliato 60
La tipologia dei materiali
Confronti. Come già accennato, si ispira ai modelli di anforette ovoidi sabine e capenati (vedi sopra, 60). Corrisponde al tipo 1, var. c di Bazzano, attestato nella fase IIB1 della necropoli (Weidig 2014, 575-576). Colfiorito di Foligno: tipo IIIA8 (Bonomi Ponzi 1997, 98). Atri (TE), necropoli della Pretara: Baldelli e Ruggeri Giove 1982, 633, n. 4 (primo-terzo quarto VI secolo a.C.). Datazione. VI secolo a.C.
esternamente; sul ventre sono applicati sei cordoni plastici verticali; fondo piano; anse composite, a ponticello, che dalla spalla si raccordano a un piattello complanare all’orlo (Fig. 2.12). Distribuzione. Capo d’Acqua, scavi 2011: t. 18, n. 1. Confronti. Si tratta di un tipo di olla che richiama la forma del cratere, noto a Campovalano: t. 134, n. 1; t. 236, n. 1 (prima metà VI secolo a.C.; Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti, 57, 89; vedi anche Chiaramonte Treré 2011, 137). Datazione. La presenza di un bacile del Tipo O.330.B.4 e di una spada lunga nel contesto di rinvenimento (vedi, 112), suggerisce di estendere l’inquadramento del tipo ai decenni centrali-seconda metà del VI secolo a.C.
OINOCHOAI (Forma 100). Tipo B.100.1. Oinochoe trilobata con alto collo cilindrico distinto e segnato da tre scanalature orizzontali; lobi laterali dell’orlo rilevati; spalla diritta; ansa composita sormontante, composta da due bastoncelli distinti uniti in corrispondenza del labbro e raccordati da un tratto orizzontale, rotelle applicate in corrispondenza del labbro (Fig. 2.12). Distribuzione. Capo d’Acqua, scavi 2011: tomba 22, n. 1. Confronti. Il tipo non trova confronti puntuali, ma potrebbe ispirarsi, visto lo sviluppo del labbro non eccessivamente rilevato e la presenza delle rotelle, a modelli in lamina bronzea, quali le oinochoai cd. “rodie”, presenti ad esempio a Campovalano tra la fine del VII e la prima metà del VI secolo a.C. (Shefton 1979; B. Grassi in Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti, 189; Acconcia 2014, 84). Datazione. Prima metà VI secolo a.C. (?).
OLLETTE BIANSATE (Forma 70). Il Tipo B.70.1 è inquadrabile nelle produzioni locali che si allineano allo sviluppo delle anforette globulari, variando sostanzialmente solo il tipo e l’impostazione delle anse (vedi, 60). Il Tipo B.70.2, invece, aderisce maggiormente ai modelli sabini delle anforette ovoidi su alto piede. Tipo B.70.1. Olletta biansata globulare con labbro distinto e svasato; orlo semplice assottigliato; spalla arrotondata; piede ad anello; anse a maniglia oblique impostate sulla spalla. L’esemplare di riferimento presenta una decorazione incisa sulla spalla (due fasce di denti di lupo campite superiormente da un fascio di tre linee incise; Fig. 2.12). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 112, n. 2. Confronti. Vicino al tipo IIIA10 di Colfiorito di Foligno (Bonomi Ponzi 1997, 100, con bibliografia di riferimento). Datazione. VI secolo a.C.
Tipo B.100.2. Oinochoe trilobata di piccole dimensioni; corto collo; orlo con lobi complanari; spalla compressa; ventre globulare; piede ad anello; ansa sormontante impostata dal labbro alla spalla (Fig. 2.12). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 170, n. 2. Confronti. Vicino a Fossa: t. 121, n. 12 (terzo quarto VI secolo a.C.; d’Ercole e Benelli 2004, 54). Datazione. La ricorrenza nel contesto di rinvenimento di un bacile del Tipo O.330.A.6 suggerisce di datare il tipo in esame alla seconda metà del VI secolo a.C.
Tipo B.70.2. Olletta biansata ovoide con labbro a colletto lievemente rientrante; orlo semplice; spalla arrotondata; alto piede a tromba; anse a maniglia pressoché verticali impostate sulla spalla (Fig.2.12). Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 30, n. 2. 61
Capestrano, I
fibule dei Tipi S.A.20.7-8, consente di inquadrare il tipo tra la fine del VI e la prima metà del V secolo a.C.
OLPAI/BROCCHE (Forma 110). Tipo B.110.1. Brocca globulare con collo distinto cilindrico; labbro lievemente svasato; orlo distinto appena ingrossato; spalla arrotondata; ansa sormontante a doppio bastoncello impostato dal labbro alla spalla. L’esemplare di riferimento presenta una ricca decorazione incisa in corrispondenza della spalla (motivi circolari, che riproducono probabilmente scudi con stemmi a clessidra e ruota raggiata, alternati a motivi fitomorfi a fiori di loro, campiti superiormente da fila di denti di lupo e fila di rombi; Fig. 2.13). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 212, n. 2. Confronti. Vicino a Campovalano: t. 2, nn. 1819 (prima metà VI secolo a.C.; Chiaramonte Treré e d’Ercole 2003, 16). Per la decorazione, si veda l’olla Tipo B.60.1. Datazione. Prima metà VI secolo a.C.
Tipo B.110.4. Brocca globulare di piccole dimensioni con corto collo distinto; labbro lievemente svasato; orlo assottigliato; spalla sfuggente; piede a disco; ansa sormontante a bastoncello, impostata dalla spalla al labbro (Fig. 2.13). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 197, n. 2; tomba 270, n. 2; tomba 291, n. 2 (dubitativamente). Fontanelle, scavi 2012: tomba 14, n. 2. Confronti. Vicino al tipo B3 di Bazzano, attestato nella fase II e al passaggio con la fase III della necropoli (Weidig 2014, 554-555). Campovalano: t. 74, nn. 7, 9 (prima metà VI secolo a.C.; Chiaramonte Treré e d’Ercole 2003, 54). Datazione. VI secolo a.C. Tipo B.110.5. Brocca globulare miniaturistica con corto collo distinto, decorato da un fascio di linee orizzontali a incisione; labbro lievemente rientrante; orlo ingrossato; spalla arrotondata e compressa; ansa sormontante a nastro, impostata dal labbro alla spalla (Fig. 2.13). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 200, n. 2. Confronti. Campovalano: t. 74, n. 8 (prima metà VI secolo a.C.; Chiaramonte Treré e d’Ercole 2003, 54); t. 180, n. 3 (seconda metà VI secolo a.C.; Chiaramonte Treré e d’Ercole 2003, 99). Datazione. VI secolo a.C.
Tipo B.110.2. Brocca globulare con collo distinto cilindrico, segnato da una carena; labbro lievemente svasato; orlo arrotondato; spalla arrotondata; ventre rastremato; ansa sormontante a finto triplo bastoncello; piede a disco. L’esemplare di riferimento presenta una ricca decorazione incisa dalla spalla al ventre (motivi circolari, che riproducono probabilmente scudi con stemmi a ruota raggiata, disposti su due registri alternati e campiti da motivi “ad ombrello” composti da fasci di linee, con inserti a denti di lupo; Fig. 2.13). Distribuzione. Via dell’Olmo, scavi 2011: t. 6, n. 1. Confronti. Senza confronti puntuali, vicina al tipo precedente. Datazione. Prima metà VI secolo a.C. (?).
ATTINGITOI (Forma 160). Tipo B.160.1. Attingitoio globulare con corto labbro distinto; orlo semplice; basso piede ad anello; sulla spalla sono applicate tre bugne circolari; ansa sormontante a doppio bastoncello, impostata dal labbro alla spalla (Fig. 2.13). Distribuzione. Via dell’Olmo, scavi 2011: tomba 7, n. 2. Confronti. Pescara, necropoli del Campo Sportivo ex Gesuiti: tomba 4 (fine VI-primi
Tipo B.110.3. Brocca globulare con corto collo distinto; labbro a colletto; orlo semplice; spalla arrotondata; ventre rastremato; fondo piano; ansa sormontante a bastoncello a sezione quadrangolare, impostata dal labbro alla spalla (Fig. 2.13). Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 15, n. 1; tomba 20, n. 1; tomba 25, n. 1. Datazione. Pur senza confronti puntuali, l’associazione nei contesti di rinvenimento con 62
La tipologia dei materiali
decenni V secolo a.C.; Staffa 2001, 87, fig. 81, 6; 2003, 558). Datazione. Fine VI-primi decenni V secolo a.C.
Tipo B.220.2. Tazza carenata di piccole dimensioni; labbro svasato distinto; orlo semplice; carena distinta, segnata da tre serie di tre cerchielli concentrici impressi; bassa vasca troncoconica; fondo piano; ansa a bastoncello impostata dal labbro alla carena (Fig. 2.13). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 273, n. 2. Confronti. L’esemplare di riferimento, pur richiamando tipi diffusi nel periodo orientalizzante (ad esempio le molte tazze/kyathos della t. 1 di Passo Gabella a Matelica, dell’ultimo quarto del VII secolo a.C., il cui profilo diverge però per il labbro maggiormente svasato; si veda A. Coen, in Silvestrini e Sabbatini 2008, 174, nn. 194-196) è stato rinvenuto all’interno di un “ripostiglio” deposto a un livello superficiale rispetto ai piani di deposizione delle tombe, del quale non è stato possibile individuare la sepoltura di riferimento, probabilmente pesantemente disturbata. Non è da escludersi, quindi, che esso vada piuttosto confrontato con le tazze attestate a Fossa nella fase recente della necropoli e già ricordate per il tipo precedente, e specificamente l’esemplare n. 5 dalla t. 402, anch’esso caratterizzato da stampigliatura sulla carena (inizi III secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 99). Datazione. Inizi III secolo a.C.
KANTHAROI (Forma 190). Tipo B.210.1. Kantharos con vasca troncoconica; labbro diritto; orlo semplice; fondo piano; anse a bastoncello sormontanti a sezione quadrangolare, impostate dalla vasca al labbro (Fig. 2.13). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 243, n. 2. Confronti. Vicino al tipo B3, var. a (“tazza”) di Bazzano, attestato nella fase III della necropoli (Weidig 2014, 548). Datazione. Fine VI-prima metà V secolo a.C. TAZZE (Forma 220). Tipo B.220.1. Tazza carenata con labbro svasato; orlo semplice tagliato o assottigliato; carena arrotondata, sulla quale sono applicate tre bugne di forma ovale appuntita; vasca rastremata; piede ad anello; ansa sormontante a nastro impostata dal labbro alla carena (Fig. 2.13). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 219, n. 2; tomba 277, n. 2; tomba 296, n. 2. Presciano, scavi 2010: tomba 45, n. 4. Fontanelle, scavi 2012: tomba 3, n. 3 (presenta una decorazione impressa composta da tre piedini ripetuta per tre volte sulla carena nei punti dove usualmente si trovano le bugne). Confronti. Si tratta di un tipo abbastanza standardizzato, realizzato anche in impasto grezzo e diffuso in area abruzzese tra la seconda metà-fine del VI e il IV-III secolo a.C. (a tale proposito, si rimanda alla discussione del Tipo A.220.2, 57). Si veda anche a Loreto Aprutino (PE), necropoli di Colle Fiorano, zona PEEP 1: t. 55 (fine VI-primi decenni V secolo a.C.; Staffa 2003a, 572), esemplari in ceramica depurata. Datazione. Gli esemplari in impasto buccheroide attestati a Capestrano, sembrano inquadrabili in età tardo-arcaica sulla base delle associazioni di corredo nei contesti di rinvenimento, tra gli ultimi decenni del VI e la prima metà del V secolo a.C.
SCODELLE (Forma 230). Le scodelle sono la forma aperta meglio attestata nell’ambito dell’impasto buccheroide. La maggior parte dei tipi (Tipi B.230.A.2-7), si può ascrivere a un modello con vasca carenata, più o meno profonda, che ricorre sia nel gruppo delle scodelle prive di anse (230.A), sia in quelli delle scodelle mono e biansate (230.B-C), concentrandosi tra gli ultimi decenni del VI e la prima metà del V secolo a.C. (Weidig 2014, 533). La variabilità interna alle scodelle carenate è solo in parte dovuta al loro sviluppo diacronico, mentre è probabile che la minore o maggiore profondità delle vasche rispetto alla loro ampiezza sia legata a ragioni funzionali. Esse sembrano avere svolto sia la funzione di vasi per il consumo di alimenti solidi o semiliquidi o, nei casi caratterizzati da vasca 63
Capestrano, I
profonda, anche quella di vasi potori (Acconcia 2014, 47-48, 246).
Datazione. Ultimo quarto VI-prima metà V secolo a.C.
SCODELLE PRIVE DI ANSE (230.A).
Tipo B.230.A.5. Scodella carenata con corto labbro lievemente svasato; orlo semplice; carena distinta; stretta vasca troncoconica; piede ad anello (Fig. 2.14). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 297, n. 4. Presciano, scavi 2010: tomba 40, n. 2. Fontanelle, scavi 2012: tomba 43, n. 3; tomba 50, n. 1. Confronti. Vicino al tipo 4, var. a delle scodelle di Bazzano (Weidig 2014, 531). Datazione. Ultimo quarto VI-prima metà V secolo a.C.
Tipo B.230.A.1. Scodella con ampia vasca a calotta a profilo continuo; orlo semplice tagliato esternamente; piede ad anello (Fig. 2.13). Distribuzione. Capo d’Acqua, scavi 1992: tomba 1, n. 2. Datazione. Pur in mancanza di confronti puntuali, l’associazione del tipo nel contesto di rinvenimento con materiali databili tra la fine del VII-inizi del VI secolo a.C. (ad es. il cinturone Tipo S.10.2), suggerisce di orientarne la datazione in questo orizzonte cronologico.
Tipo B.230.A.6. Scodella carenata con labbro lievemente svasato; orlo distinto arrotondato; carena arrotondata; ampia vasca troncoconica; alto piede ad anello (Fig. 2.14). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 200, n. 4; tomba 257, n. 2. Capo d’Acqua, scavi 2011: tomba 13, n. 2. Confronti. Vicino al tipo 1 delle scodelle di Bazzano, attestato alla fine del VI-inizi del V secolo a.C. (Weidig 2014, 525). Fossa: t. 194, n. 10; t. 457, n. 4 (fine VI-prima metà V secolo a.C.; d’Ercole e Benelli 2004, 81, 190). Datazione. Fine VI-prima metà V secolo a.C.
Tipo B.230.A.2. Scodella carenata con labbro diritto svasato; orlo distinto e arrotondato; carena appena accennata; vasca troncoconica; piede a disco (Fig. 2.13). Distribuzione. Presciano, scavi 2010: tomba 52, n. 3. Confronti. Genericamente vicino a Fossa: t. 234, n. 4 (metà-seconda metà VI secolo a.C.; d’Ercole e Benelli 2004, 96). Vicino anche al tipo delle scodelle biansate B.230.C.2 (si veda, I. Di Sabatino in Acconcia 2014, 282-283). Datazione. Metà del VI secolo a.C.
Tipo B.230.A.7. Scodella carenata con corto labbro lievemente svasato; orlo distinto a sezione triangolare, piano superiormente; carena alta e arrotondata; vasca troncoconica; piede ad anello (Fig. 2.14). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 200, n. 3. Fontanelle, scavi 2012: tomba 31, n. 2; tomba 50, n. 1. Confronti. Vicino al tipo 3 delle scodelle di Bazzano, attestato nella fase III della necropoli (Weidig 2014, 529-530). Fossa: t. 318, n. 10 (metà-terzo quarto VI secolo a.C.; d’Ercole e Benelli 2004, 132). Datazione. Seconda metà VI-prima metà V secolo a.C. Va segnalato come la tomba 50 di Fontanelle, da cui proviene uno degli esemplari rappresentativi del tipo, si dati in età ellenistica. Non è pertanto chiaro se la scodella in questione sia da considerare come una sorta di
Tipo B.230.A.3. Scodella carenata con labbro distinto svasato; orlo semplice; carena distinta; vasca globulare; piede ad anello (Fig. 2.13). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 277, n. 3. Confronti. Vicino al tipo 2, var. a delle scodelle di Bazzano (spec. esemplare della t. 884), attestato nella fase III della necropoli (Weidig 2014, 529). Datazione. Fine VI-primi decenni V secolo a.C. Tipo B.230.A.4. Scodella carenata con labbro distinto diritto; orlo semplice; carena distinta; profonda vasca troncoconica; basso piede ad anello (Fig. 2.14). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 251, n. 21. Confronti. Vicino al tipo 2 delle scodelle di Bazzano, attestato soprattutto nella fase III della necropoli (Weidig 2014, 528-529). 64
La tipologia dei materiali
cimelio o se il tipo in esame presenti una continuità estesa oltre il periodo tardo-arcaico.
impostate in corrispondenza della carena (Fig. 2.14). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 186, n. 2; tomba 266, n. 1. Confronti. Corrisponde al tipo E1 delle kylikes di Bazzano, attestato nella fase IIB2 della necropoli (Weidig 2014, 504-505). Datazione. Le associazioni di corredo nei contesti di rinvenimento, suggeriscono di inquadrare la datazione del tipo nella seconda metà del VI secolo a.C.
SCODELLE MONOANSATE (Forma 230.B). Tipo B.230.B.1. Scodella monoansata con corto labbro lievemente svasato; orlo semplice; alta carena distinta; stretta vasca troncoconica; piede ad anello; ansa a maniglia obliqua impostata sulla carena (Fig. 2.14). Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 1, n. 2. Confronti. Corrisponde al Tipo B.230.A.5. Pescara, necropoli del Campo Sportivo ex Gesuiti: tt. 6, 9 (fine VI-primi decenni V secolo a.C.; Staffa 2001, 89, fig. 87, 10; 2003, 561, 564). Loreto Aprutino (PE), necropoli in loc. Cappuccini: t. 43 (fine VI-primi decenni V secolo a.C.; Staffa 2003a, 572). Datazione. Fine VI-primi decenni V secolo a.C.
COPPE (Forma 240). Tipo B.240.1. Coppa con vasca a calotta emisferica; labbro diritto; orlo semplice; piede ad anello (Fig. 2.14). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 197, n. 3. Confronti. Si tratta di un tipo estremamente generico, che richiama il tipo 4 Rasmussen delle coppe in bucchero etrusco-meridionali (fine del VI-V secolo a.C.; Rasmussen 1979, 125). Si veda ad esempio, Roma, loc. via Aurelia, centro commerciale Colasanti: Rossi 2006, 527-529, nn. 1085-1086 (VI-V secolo a.C.). Per gli esemplari da Roma viene suggerito un richiamo generico a materiali dal “Semi-subterranean building” di Casale Pian Roseto (V -secondo quarto IV secolo a.C.; per cui, si veda Torelli, Ward-Perkins e Murray Threipland 1970, 75, “fine creamware bowls”, fig. 10, n. 2). Datazione. Fine VI-V secolo a.C.
SCODELLE BIANSATE (Forma 230.C). Tipo B.230.C.1. Scodella biansata con vasca a calotta; labbro continuo lievemente rientrante; orlo semplice arrotondato; fondo convesso; anse a maniglia impostate al di sotto dell’orlo (Fig. 2.14). Distribuzione. Fossascopana, scavi 1965: tomba 1, n. 2. Confronti. Vicino al tipo 26 degli scavi ad Alfedena del 1974-1979, inquadrabile nella fase II della necropoli (Parise Badoni et al. 1982, 10). Datazione. Inizi V secolo a.C. (?).
Tipo B.240.2 Coppa con vasca troncoconica carenata; labbro rientrante; orlo semplice; alto piede ad anello (Fig. 2.14). Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 23, n. 1. Confronti. Richiama il tipo 1 var. b1 delle coppe di Bazzano, attestato nella fase III della necropoli (Weidig 2014, 537), anche se l’esemplare della tomba 23 di Fontanelle presenta il labbro maggiormente rientrante e un accenno di carena sulla vasca. Vicino al tipo IIIA 14 di Colfiorito di Foligno (Bonomi Ponzi 1997, 100). Datazione. Fine VI-prima metà V secolo a.C.
Tipo B.230.C.2. Scodella biansata con ampia vasca carenata; labbro svasato; orlo semplice; carena distinta; vasca troncoconica; fondo a disco; anse a maniglia oblique impostate in corrispondenza della carena (Fig. 2.14). Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 42, n. 2. Datazione. Il contesto di rinvenimento suggerisce una datazione alla metà del VI secolo a.C.; si veda anche il Tipo B.230.A.2. Tipo B.230.C.3. Scodella biansata con vasca carenata; labbro svasato; orlo semplice; carena distinta; vasca troncoconica profonda; piede ad anello; anse a maniglia oblique
65
Capestrano, I
COPPETTE (Forma 260).
CERAMICA ETRUSCO-CORINZIA (C).
Tipo B.260.1. Coppetta a vasca emisferica; labbro diritto; orlo semplice; piede a tromba scarsamente sviluppato (Fig. 2.14). Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 15, n. 2. Datazione. L’esemplare di riferimento si avvicina a una coppa-coperchio dalla t. 8 di Colfiorito di Foligno, ascritta agli inizi del V secolo a.C. (Bonomi Ponzi 1997, 106, n. 8; tipo IIIA35). L’associazione nel contesto di rinvenimento con fibule dei Tipi S.A.20.7-8, consente di inquadrare il tipo tra la fine del VI e la prima metà del V secolo a.C.
PISSIDI (Forma 140). Tipo C.140.1. Pisside lenticolare con corto labbro distinto, lievemente svasato; orlo tagliato esternamente; spalla compressa; piede a disco; sulla spalla presenta un fascio di tre linee orizzontali incise (Fig. 2.15). Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 30, n. 3. Confronti. Poggio Buco, tomba VIII: Bartoloni 1972, 115, n. 31, fig. 53, tav. LXIXd (metà del VI secolo a.C.); Pellegrini 1989, 123, n. 407, tav. LXXXV (secondo quarto del VI secolo a.C.; tipo 407, varietà A). Esemplare nel Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia: Gabrielli 2010, 230, n. 329, fig. 13.b, (intorno al 575/70555/50 a.C.; gruppo B, tipo I.b/1). Cerveteri, Monte Abatone, tomba 531: Milano 1980, 182, n. 32, fig. 32 (secondo quarto del VI secolo a.C.). La forma è presente in bucchero a Cales, necropoli del Migliaro, tomba 69: Gilotta e Passaro 2012, 91, 69.19, tav. LVII, 4A e tav. LXXXIII, fig. 19 (prima metà del VI secolo a.C.). Vulci, Necropoli dell’Osteria, tomba 171: Rizzo 1990, 153, n. 8, fig. 329, in contesto datato al primo trentennio del VI secolo a.C. Datazione. Primo quarto/prima metà VI secolo a.C.
Tipo B.260.2. Coppetta a vasca emisferica; labbro fortemente rientrante; orlo semplice; piede a tromba (Fig. 2.14). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 249, n. 2. Confronti. Riproduce modelli della ceramica etrusco-corinzia, la cui presenza è attestata nell’area aquilana interna con una certa frequenza (E. Benelli, in Benelli e Naso 2003, 198). Si veda ad esempio a Bazzano, l’esemplare in ceramica etrusco-corinzia della t. 106 Finesa, datato alla fase IIB della necropoli. Si veda, per le attestazioni in area mediotirrenica: Mangani 1986, 29-30; Bosio e Pugnetti 1986, 111; Szilàgy 1998, 523-524. A Pontecagnano: Cuozzo e D’Andrea 1991, 88 (primo quarto VI secolo a.C.; tipo 46A2). Datazione. Fine VII-metà VI secolo a.C.
CERAMICA DEPURATA ACROMA (D). Si ascrive a questa classe il vasellame caratterizzato da una pasta estremamente depurata, di colore chiaro, lavorato al tornio, inquadrabile in orizzonti cronologici anche differenti (dal periodo arcaico a quello ellenistico avanzato).
KYLIKES (Forma 270). Tipo B.270.1. Kylix ovoide con labbro rientrante continuo; orlo semplice; basso piede ad anello; anse a maniglia oblique impostate nel punto di massima espansione del ventre (Fig. 2.14). Distribuzione. Via dell’Olmo, scavi 2011: tomba 6, n. 2. Confronti. Civitella Casanova (PE), necropoli di Vestea: t. 7 (VI secolo a.C.; d’Ercole e Martellone 2003, 112). Datazione. VI secolo a.C.
ANFORETTE (Forma 20). Tipo D.20.1. Anforetta a profilo troncoconico, con labbro svasato; orlo distinto rientrante, segnato internamente da una scanalatura; spalla sfuggente; fondo convesso; anse a nastro impostate dal labbro al punto di massima espansione del ventre (Fig. 2.15). Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 7, n. 1. 66
La tipologia dei materiali
Datazione. L’associazione nel contesto di rinvenimento con una coppetta in ceramica a vernice nera del Tipo H.260.C.1 suggerisce di inquadrare il tipo in esame nel II secolo a.C.
Confronti. Vicina a Fossa: t. 309, n. 3 (seconda metà VI secolo a.C.; d’Ercole e Benelli 2004, 127). Datazione. Seconda metà VI secolo a.C.
OLPAI/BROCCHE (Forma 110).
LAGYNOI (Forma 120).
Tipo D.110.1. Brocca ovoide di piccole dimensioni con labbro svasato; orlo semplice; collo distinto da lieve carenatura; piede a disco; ansa a nastro sormontante impostata dal labbro alla spalla (Fig. 2.15). Distribuzione. Presciano, scavi 2010: tomba 8, n. 2; tomba 52, n. 2. Confronti. In ceramica depurata acroma, a Fossa: t. 309 (prima metà V secolo a.C.; d’Ercole e Benelli 2004, 127). Loreto Aprutino (PE), necropoli dei Cappuccini, zona PEEP: t. 4 (fine VI-inizi V secolo a.C.; Staffa 2003b, 573). Navelli (AQ), necropoli del Piano: t. 62 (fine VI-inizi V secolo a.C.; F. Properzio in Acconcia 2014, 269). Datazione. Fine VI-prima metà V secolo a.C.
Tipo D.120.1. Lagynos globulare con labbro svasato; orlo semplice arrotondato; collo distinto; spalla sfuggente; ventre compresso; fondo a disco; ansa a falso triplo bastoncello, segnato da profonde scanalature, impostata dalla base del collo alla spalla (Fig. 2.15). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 190, n. 1. Confronti. Vicino a Fossa: t. 6, n. 4 (II-I secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 28). Perugia, necropoli del Palazzone: Lippolis 1984, 71, tipo C.4, n. 154 (I secolo a.C.). Datazione. Seconda metà II-inizi I secolo a.C. Tipo D.120.2. Lagynos piriforme con labbro svasato e distinto, segnato da una lieve carenatura; orlo lievemente ingrossato e arrotondato; spalla sfuggente segnata da una risega; ventre compresso; fondo piano; ansa a bastoncello, impostata dal labbro alla spalla, con andamento segnato da curva netta a gomito (Fig. 2.15). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 153, n. 1. Datazione. Il contesto di rinvenimento, nel quale si conservano una coppa Tipo H.240.A.12 e una coppetta Tipo H.260.C.3 (vedi, 74, 82), suggerisce di inquadrare il tipo nell’ambito del II secolo a.C.
Tipo D.110.2. Brocca globulare di piccole dimensioni con labbro distinto lievemente svasato, collo troncoconico; orlo assottigliato; spalla rilevata e lievemente compressa; basso piede ad anello; ansa a bastoncello sormontante, impostata dal labbro alla spalla (Fig. 2.15). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 177, n. 2. Confronti. Vicino al tipo B3 delle brocche di Bazzano, ascrivibile al VI secolo a.C. (Weidig 2014, 554-555). Campovalano: t. 2, nn. 18-19; t. 74, n. 9 (prima metà VI secolo a.C.; Chiaramonte Treré e d’Ercole 2003, 16, 54); t. 180, n. 2 (seconda metà VI secolo a.C.; Chiaramonte Treré e d’Ercole 2003, 99). Datazione. VI secolo a.C. (probabilmente seconda metà).
Tipo D.120.3. Lagynos troncoconica con orlo distinto svasato, segnato da una carenatura; orlo semplice e tagliato internamente; collo stretto e sinuoso; spalla arrotondata; ventre carenato; fondo piano; ansa a nastro impostata dalla base del labbro alla spalla (Fig. 2.15). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 151, n. 1. Confronti. Adria, necropoli di Piantamelon, ACB ‘96: t. 74, n. 19 (seconda metà II-inizi I secolo a.C.; Bonomi, Camerin e Tamassia 2000, 67). Portorecanati (PU): t. 85, n. 5 (attribuita ad età flavia; Mercando 1974b, 262). Vicino al tipo “carenato” del fondo Scataglini a Tarquinia:
Tipo D.110.3. Brocca globulare di piccole dimensioni con labbro svasato; orlo semplice; spalla sfuggente; piede a disco; ansa a bastoncello (?; Fig. 2.15). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 245, n. 2.
67
Capestrano, I
COPPE (Forma 240).
Serra Ridgway 1996, 280 (con distribuzione; prima metà II secolo a.C.). Datazione. II secolo a.C.
Tipo D.240.1. Coppa emisferica con labbro a tesa distinto da una profonda risega; orlo semplice arrotondato (Fig. 2.16). Distribuzione: Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 190, n. 3. Confronti. Datazione. Seconda metà II-inizi I secolo a.C.
Tipo D.120.4. Lagynos troncoconica con labbro distinto svasato; orlo rientrante distinto internamente da una risega; stretto collo sviluppato; spalla arrotondata; ventre rastremato; piede a disco; ansa a finto doppio bastoncello, impostata dalla base del labbro alla spalla, con andamento segnato da curva netta a gomito (Fig. 2.15). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 168, n. 1. Confronti. Perugia, necropoli del Palazzone: Lippolis 1984, 70, tipo C.3, n. 150 (I secolo a.C.). Datazione. Il contesto di rinvenimento, suggerisce di inquadrare il tipo agli inizi/prima metà del I secolo a.C.
COPPETTE (Forma 260). Tipo D.260.1. Coppetta emisferica con labbro rientrante; orlo semplice (Fig. 2.16). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 120, n. 1. Confronti. Potrebbe trattarsi di un frammento residuale di coppetta che riproduce tipi della ceramica etrusco-corinzia. Vedi, Fossa: t. 175, n. 3 (prima metà-metà VI secolo a.C.; d’Ercole e Benelli 2004, 72). Datazione. Prima metà VI secolo a.C. (?).
Tipo D.120.5. Lagynos troncoconica con stretto collo distinto; spalla compressa; ventre rastremato, distinto dalla spalla da una carena netta; piede a disco; l’ansa è probabilmente a nastro (Fig. 2.15). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 190, n. 2. Confronti: Perugia, necropoli del Palazzone: Lippolis 1984, 72, tipo C.6, n. 158 (I secolo a.C.). Datazione. Il contesto di rinvenimento suggerisce di inquadrare il tipo tra la fine del II e inizi del I secolo a.C.
PIATTI (Forma 290). Tipo D.290.1. Piatto di piccole dimensioni con vasca a calotta; parete rettilinea; orlo assottigliato; fondo piano distinto (Fig. 2.16). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 138, nn. 1-2. Confronti. Ostia (RM): Pavolini 2000, 190, fig. 46, n. 93 (I secolo d.C.-inizi II secolo d.C.). Tarquinia, fondo Scataglini: t. 172, n. 21 (da un contesto con materiali di età tardo-repubblicana a alto-imperiale; Serra Ridgway 1996, 272). Datazione. I secolo d.C.
POCULA (Forma 165). Tipo D.190.1. Poculum con vasca cilindrica e labbro diritto; orlo semplice; vasca distinta a carena arrotondata; fondo piano; segnato da due linee incise parallele al di sotto del labbro (Fig. 2.16). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 157, n. 1. Confronti: Fossa (AQ), tomba 333: d’Ercole e Copersino 2003, 80-83, n. 11 (fine III secolo a.C.- prima metà II secolo a.C.). Datazione. Il contesto di rinvenimento consente di puntualizzare la datazione del tipo alla prima metà del II secolo a.C.
CERAMICA A BANDE (E). OLLE (Forma 40). Tipo E.40.1. Olla ovoide con labbro svasato; orlo ingrossato, arrotondato esternamente e distinto all’interno da una risega orizzontale; spalla sfuggente; piede ad anello; sulla spalla sono applicate due bugne circolari. La decorazione sovradipinta, in colore brunorossiccio, si compone di: fascia ad archetti capovolti campiti da due bande orizzontali in corrispondenza del collo, sulla spalla e sul 68
La tipologia dei materiali
suggerisce una datazione alla seconda metà IIIinizi II secolo a.C. (vedi, 225-227).
ventre; una banda orizzontale al di sotto del punto di massima espansione del ventre (Fig. 2.16). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 107, n. 1. Confronti. Un’olla ovoide con decorazione sovradipinta a fasce, dentelli e onde policrome (rosso e nero) è attestata a Corfinio, nella t. 145, scavi 1880 della necropoli di Via di Pratola e attribuita al III secolo a.C. (Dionisio 2015, 142, 349, che la identifica come imitazione di ceramica tardolistata della Daunia). Datazione. III secolo a.C.
COPPE (Forma 240). Tipo E.240.1. Coppa con vasca profonda a profilo globulare; corto labbro distinto; orlo a mandorla; basso piede ad anello a profilo arrotondato. Una fascia a vernice nera riveste la parete esterna della vasca fino a più della sua metà; l’interno della vasca è completamente verniciato di nero (Fig. 2.16). Distribuzione. Presciano, scavi 2010: tomba 34, n. 2. Confronti. Corrisponde al tipo 19 degli scavi 1974-1979 di Alfedena, ascrivibile alla II fase della necropoli (Parise Badoni et al. 1982, 11; Parise Badoni 2002, 79). Gildone (CB), loc. Morgia della Chiusa: t. 12, n. 1 (seconda metà V secolo a.C.; Macchiarola 1989, 54) Datazione. Decenni centrali del V secolo a.C.
OLLETTE BIANSATE (Forma 70). Tipo E.70.1. Olletta stamnoide globulare con corto labbro a colletto; orlo distinto; spalla compressa, distinta dal ventre; piede ad anello; anse a maniglia con andamento verticale impostate in corrispondenza della spalla. Sulla spalla si conserva una decorazione sovradipinta a brevi fasce verticali in colore bruno; al di sotto delle anse, si conservano due bande orizzontali parallele; sulle anse, decorazione a tratti verticali (Fig. 2.16). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 144, n. 1. Confronti. Richiama produzioni in ceramica depurata sovradipinta, attestate in area frentana nella seconda metà del IV e identificate da C. Rizzitelli come imitazioni di ceramica daunia (Benelli e Rizzitelli 2010, 63; il luogo di produzione sarebbe da localizzare nello stesso territorio frentano o in area lucana). Si vedano, ad es. le ollette stamnoidi da Ortona, t. 1 e dalla t. 2 di Villalfonsina (Papi 1979, 27, 53-54, figg. 4a, 18a). Ascoli Satriano (FG): t. 4, n. 6; t. 62, n. 12; t. 69, n. 18 (Tiné Bertocchi 1985, 157, 194, 204). Nello stesso periodo si inquadrano alcune olle stamnoidi decorate a bande e motivi geometrici dall’Etruria meridionale, o anche produzioni alto-adriatiche: Tarquinia, fondo Scataglini: t. 49, n. 35 (fine IV-inizi III secolo a.C.; Serra Ridgway 1996, 62, 266-267); Adria: tipo ST1IIa (Robino 2003, 114-115, con distribuzione in area adriatica). A tale proposito, però, va precisato come il contesto di rinvenimento dell’esemplare rappresentativo del sito si dati in un orizzonte recenziore. Datazione. Il contesto di rinvenimento
CERAMICA DI IMITAZIONE ATTICA (?; F). L’attribuzione del tipo qui esaminato a una imitazione di ceramica attica non figurata della fine del VI-V secolo a.C. è proposta in questa sede in via altamente problematica. L’esemplare di riferimento presenta una pasta molto depurata, di colore arancio, e fasce sovradipinte in vernice rossa coprente. COPPETTE (Forma 260). Tipo F.260.1. Coppetta con vasca a calotta e labbro fortemente rientrante; orlo semplice; alto piede (probabilmente a tromba). Sull’esterno della vasca, due fasce orizzontali di colore rossastro e una sul piede; all’interno della vasca una fascia dello stesso colore sotto il labbro (Fig. 2.16). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 241, n. 2. Confronti. Trova confronti con il tipo Sparkes e Talcott “stemmed dish – convex and small” (ultimo quarto VI-primi decenni V secolo a.C.; Sparkes e Talcott 1970, 140, tav. 35, 982). Il profilo a labbro rientrante dell’esemplare, richiama gli esemplari a vernice nera delle tombe 41, 42, 195 di Campovalano, datati alla 69
Capestrano, I
prima metà del V secolo a.C. e attribuiti appunto a imitazioni della ceramica attica (C. Chiaramonte Treré, in Chiaramonte Treré e d’Ercole 2003, 112; R. Mantia, in Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 177-178). Datazione. L’associazione con gli altri materiali nel contesto di rinvenimento conferma la datazione del tipo alla fine del VI-inizi del V secolo a.C.
CERAMICA A VERNICE NERA (H). Come già rilevato per Fossa, i materiali in ceramica a vernice nera attestati nelle necropoli di Capestrano presentano un livello qualitativo non elevato, segnalato dall’uso di rivestimenti non omogenei, spesso opachi e scrostati, con frequenti aloni di cottura (C. Rizzitelli, in d’Ercole e Copersino 2003, 285). È plausibile che la maggior parte delle attestazioni vada quindi ascritta a produzioni locali o regionali, con rarissimi casi di materiali sicuramente riconoscibili come importazioni. Tra questi, le coppette dell’atelier des Petites Estampilles (Tipi H.260.A.3-4 e 15) e le coppe del Tipo H.240.C.13, probabilmente importate dalla Campania. Nel resto delle attestazioni, si riconosce una prevalente gravitazione verso l’area tirrenica, o comunque verso l’Etruria (con frequenti richiami al repertorio della campana B o “B-oide”), che ispira redazioni locali, ma anche sviluppi autonomi. Nella maggior parte degli esemplari di questo gruppo, le paste del vasellame presentano un colore variabile dal rosato all’arancio chiaro, con rari casi di paste di colore giallo chiaro. Meno frequenti i richiami al repertorio della campana A, leggibili soprattutto nel gruppo dei piatti a vasca troncoconica e labbro rientrante (H.290.B). A modelli diffusi in Campania tra la fine del IV e gli inizi del III secolo a.C. si ispira un numero limitato di esemplari (coppette Tipo H.260.B.1 e piatti Tipo H.290.C.4; forse la coppetta monoansata H.265.1). In generale, la stessa difficoltà di attribuzione ai più ampi raggruppamenti noti per l’area tirrenica, campana o anche nell’area adriatica settentrionale (fino alle locali produzioni del comparto marchigiano, sulle quali, Brecciaroli Taborelli 1996-1997; 2011; 2017), si registra per il resto del territorio appenninico interno (si veda, a tale proposito, Liberatore 1998; Capini 1984; Messineo 1997).
ANFORE DA TRASPORTO (G). In questa classe sono stati inseriti gli unici tre esemplari identificabili come pertinenti ad anfore da trasporto, due dei quali sono riferibili a produzioni tardo-repubblicane, mentre per il primo, un labbro realizzato in impasto grezzo, resta il dubbio che si tratti di un dolio. N. 1: Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 241, n. 1. Labbro diritto con orlo ricurvo (?; Fig. 2.16)). N. 2: Fossascopana, scavi 1973: tomba 1 a camera, sepoltura sul pavimento “a”, n. 1. Anfora di tipo rodio, con alto collo cilindrico; orlo a collarino; corpo ovoide a puntale corto; anse a bastoncello ad angolo rilevato (Fig. 2.16). Confronti. Empereur e Hesnard 1987, 19; Finkielszteim 2001, 50, tav. C, 18 (fine II-prima metà I secolo a.C.). Vedi, Fossa: t. 330, n. 62 (II-fine I secolo a.C./inizi I secolo d.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 218-219, con distribuzione). Ancona: t. 12, n. 3 (esemplare datato al 188-185 a.C. per il bollo; Colivicchi 2002, 114-115); t. 17, n. 3 (intorno al 150 a.C.; Colivicchi 2002, 133-134); t. 36, n. 3* (fine IIprimi del I secolo a.C.; Colivicchi 2002, 249250). Datazione. Fine II-prima metà I secolo a.C. N. 3. Fossascopana, scavi 1973: tomba 2 a camera, materiali presso la volta crollata, n. 1. Puntale di anfora, probabilmente dello stesso tipo precedente (Fig. 2.16).
OLPAI/BROCCHE (Forma 110). Tipo H.110.1. Brocca di piccole dimensioni a profilo piriforme; labbro continuo svasato; orlo semplice. tagliato esternamente; spalla sfuggente; basso piede ad anello a profilo
70
La tipologia dei materiali
tagliato internamente; spalla compressa; piede a disco; ansa a doppio pseudo-bastoncello non sormontante, impostata dal collo alla spalla (Fig. 2.17). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 251, n. 1. Datazione. Il contesto di rinvenimento suggerisce un inquadramento alla fine del I secolo a.C.
concavo; ansa a bastoncello non sormontante, impostata dal labbro alla spalla (Fig. 2.17). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 157, n. 2. Confronti: Serie Morel 5223- 5225 (fine IVinizi III secolo a.C.; produzioni locali o regionali, diffuse dall’Etruria, alla Campania al Sannio; Morel 1981, 342-343; Ferrara 2009, 161-162). Campochiaro (CB), santuario di Ercole: Capini 1984, 33, n. 73. Jesi (AN), officina di Aesis: Brecciaroli Taborelli 19961997, 173-174, fig. 93, nn. 396-398 (180-170 a.C.; ascritta alla serie Morel 5223). Datazione. Il contesto di rinvenimento suggerisce di ascrivere il tipo al II secolo a.C. (pref. prima metà).
Tipo H.120.3. Lagynos di piccole dimensioni a profilo cilindrico; alto collo cilindrico; labbro continuo appena svasato; orlo semplice indistinto; spalla compressa rilevata; basso piede ad anello a profilo concavo sagomato (Fig. 2.17). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 151, n. 2. Datazione. Il contesto di rinvenimento suggerisce di inquadrare il tipo nella seconda metà del II secolo a.C.
Tipo H.110.2. Brocca di piccole dimensioni a profilo ovoide; labbro distinto lievemente svasato; orlo ingrossato e distinto internamente; piede ad anello a profilo triangolare; ansa a bastoncello non sormontante, impostata dal collo al punto di massima espansione del ventre (Fig. 2.17). Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 52, n. 1. Confronti. Tipo Morel 5553a1 (prima metà III secolo a.C.; produzione locale o regionale; Morel 1981, 370). Datazione. Prima metà III secolo a.C. LAGYNOI
Tipo H.120.4. Lagynos a profilo cilindrico; alto collo cilindrico; labbro appena svasato; spalla compressa rilevata; basso piede ad anello a profilo triangolare, con fondo concavo; ansa a nastro con margini rilevati impostata dal collo alla spalla (Fig. 2.17). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 190, n. 4. Datazione. Il contesto di rinvenimento suggerisce di inquadrare il tipo nella seconda metà II-inizi I secolo a.C.
(Forma 120).
Tipo H.120.1 Lagynos di piccole dimensioni a profilo globulare espanso; alto collo; labbro continuo lievemente svasato; orlo ingrossato; spalla compressa; basso piede ad anello a profilo rettilineo; ansa a doppio pseudobastoncello non sormontante, impostata dal labbro alla spalla (Fig. 2.17). Distribuzione. Fossascopana, scavi 1964: tomba 5, saggio 8, n. 1. Confronti. Porto Recanati (PU): Mercando 1974b, 227, n. 1; 348, 1. Perugia, necropoli del Palazzone: Lippolis 1984, 35, forma 2, n. 4 (II secolo a.C.). Datazione. II-I secolo a.C.
Tipo H.120.5. Lagynos a profilo lenticolare; alto collo cilindrico; labbro continuo appena svasato; orlo semplice rientrante; spalla rilevata fortemente compressa; ventre rastremato; piede ad anello a profilo rettangolare; ansa a triplo pseudo-bastoncello impostata dal collo alla spalla (Fig. 2.17). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 214, n. 2 Confronti. Vicina alle serie Morel 5461-5462 (III secolo a.C.; gli esemplari di riferimento sono prodotti volterrani; Morel 1981, 365). Datazione. Il contesto di rinvenimento suggerisce di inquadrare il tipo nella seconda metà del II secolo a.C.
Tipo H.120.2. Lagynos di piccole dimensioni a profilo piriforme espanso; collo breve; labbro lievemente svasato; orlo distinto e rientrante, 71
Capestrano, I
Tipo H.120.6. Lagynos a profilo ovoide; basso collo concavo; labbro sagomato e lievemente svasato; orlo semplice; spalla sfuggente; piede a disco sagomato; ansa a nastro con margini rilevati impostata dalla base del labbro alla spalla (Fig. 2.17). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 156, n. 1. Confronti. Vicino ad Adria (RO), necropoli di Piantamelon/ACB ‘96: t. 85, n. 12 (II secolo a.C.; Bonomi, Camerin e Tamassia 2000, 61). Datazione. Il contesto di rinvenimento suggerisce di inquadrare il tipo alla fine del IIIprima metà II secolo a.C.
Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 278, n. 1. Confronti. Vicino alla serie Morel 3453, spec. al tipo 3453b (II secolo a.C.; probabilmente produzione locale o regionale; Morel 1981, 262). Datazione. II secolo a.C. COPPE (Forma 240). Le coppe e le coppette (il cui discrimine, come già accennato, si pone intorno ai 13-14 cm di diametro e ai 5-6 cm di altezza; vedi 46) presentano una notevole varietà tipologica, che ha reso necessaria la loro articolazione in gruppi, distinti sulla base dell’andamento della vasca (a profilo troncoconico; curvilineo continuo; distinto; con labbro distinto; con fondo concavo).
PISSIDI (Forma 140). Tipo H.140.1. Pisside cilindrica, con labbro lievemente svasato; orlo semplice; ampia base ad anello (Fig. 2.17). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 180, n. 1. Fossascopana, scavi 1973: tomba 1 a camera, sepoltura sul pavimento “c”, n. 2. Presciano, scavi 2010: tomba 50, n. 4. Confronti. Tipo Morel 7553a (II secolo a.C.; campana B; Morel 1981, 415). Datazione. II secolo a.C.
COPPE CON (240.A).
VASCA A PROFILO GLOBULARE
Tipo H.240.A.1. Coppa con vasca bassa e ampia a profilo globulare; labbro continuo rientrante; orlo assottigliato; piede ad anello (Fig. 2.17). Distribuzione. Presciano, scavi 2010: tomba 35, n. 3; tomba 38, n. 1. Confronti. Tipo Morel 2775c (prima metà III secolo a.C.; atelier des Petites Estampilles; Morel 1981, 222). Datazione. Prima metà III secolo a.C.
KANTHAROI (Forma 210). Tipo H.210.1. Kantharos a profilo troncoconico, con carena arrotondata alla base; labbro continuo lievemente svasato; orlo semplice; basso piede ad anello a profilo arrotondato; anse a nastro non sormontanti, impostate dal labbro alla carena (Fig. 2.17). Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 38, n. 1. Confronti. Vicino alla serie Morel 3451, spec. al tipo 3451f (metà II-I secolo a.C.; campana B; Morel 1981, 261-262). Datazione. Seconda metà II secolo a.C.
Tipo H.240.A.2. Coppa con vasca profonda a profilo globulare; labbro continuo lievemente rientrante; orlo ingrossato e distinto internamente; alto piede ad anello a profilo rettilineo (Fig. 2.17). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 227, n. 1. Presciano, scavi 2010: tomba 37, n. 2. Fontanelle, scavi 2012: tomba 35, n. 1. Confronti. Il tipo può essere riferito genericamente alla serie Morel 2784 (inizi del III secolo a.C.; atelier des Petites Estampilles; Morel 1981, 224). Datazione. Inizi III secolo a.C.
Tipo H.210.2. Kantharos a profilo troncoconico, con carena accentuata alla base; labbro continuo lievemente svasato; orlo semplice; piede a disco a profilo troncoconico; anse a nastro non sormontanti, impostate dal labbro alla spalla (Fig. 2.17).
Tipo H.240.A.3. Coppa con vasca profonda a profilo globulare; labbro continuo; orlo 72
La tipologia dei materiali
Tipo H.240.A.7. Coppa con vasca profonda a profilo globulare; corto labbro distinto e svasato; orlo assottigliato a sezione triangolare; piede ad anello a profilo quadrangolare (Fig. 2.18). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 122, n. 1. Fossascopana, scavi 1973: tomba 2 a camera, deposizione 3, n. 1. Confronti. Vicino a Jesi (AN), officina di Aesis: Brecciaroli Taborelli 1996-1997, 141, fig. 75, n. 231 (250/240-180/170 a.C.; ascritto alla serie Morel 2531). Datazione. Seconda metà/fine III-primi decenni II secolo a.C.
tagliato internamente a sezione triangolare; basso piede ad anello a profilo rettilineo, tagliato internamente (Fig. 2.17). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 147, n. 1. Confronti. Tipo Morel 2974a (terzo quarto II secolo a.C.; campana A; Morel 1981, 242). Datazione. Il contesto di rinvenimento suggerisce di inquadrare il tipo nella prima metà del II secolo a.C. Tipo H.240.A.4. Coppa con vasca profonda a profilo globulare; labbro continuo lievemente svasato; orlo semplice; piede ad anello a profilo rettilineo (Fig. 2.18). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 135, n. 1. Confronti. Vicino al tipo Morel 2587b (prima metà III secolo a.C.; area di Chieti; Morel 1981, 188). Datazione. Prima metà III secolo a.C.
Tipo H.240.A.8. Coppa con vasca profonda a profilo globulare; labbro distinto e svasato; orlo semplice ricurvo; basso piede ad anello a profilo quadrangolare (Fig. 2.18). Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 5, n. 3. Confronti. Vicino alla serie Morel 1552 (terzo quarto IV-metà III secolo a.C.; Campania meridionale; Morel 1981, 123). Fratte (SA): t. 2/1956, n. 2 (fine IV-inizi III secolo a.C.; M. Romito in Greco e Pontrandolfo 1990, 282). Pontecagnano: Serritella 2013, 138-139 (secondo quarto IV-inizi III secolo a.C.). Vedi anche, Rimini, area ex-Vescovado: F. Minak, in Mazzeo Saracino 2005, 123, n. 32 (ascritta alle specie Morel 1550 e 1560, con diffusione in area medio-adriatica; prima metà III secolo a.C.). Datazione. Metà IV-inizi III secolo a.C.
Tipo H.240.A.5. Coppa con vasca profonda a profilo globulare; labbro continuo; orlo lievemente ingrossato; basso piede ad anello a profilo sagomato. Sul fondo è impresso uno stampiglio circolare a rosetta con otto petali stilizzati di forma triangolare, privo di bottone centrale (Figg. 2.18, 2.23). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 199, n. 1. Datazione. Pur in mancanza di confronti puntuali, l’associazione con un piatto Tipo H.290.C.7 e una coppetta H.260.A.5 nel contesto di rinvenimento, suggerisce di inquadrare il tipo tra la fine del III e gli inizi/prima metà II secolo a.C.
Tipo H.240.A.9. Coppa con vasca profonda a profilo globulare; labbro distinto a tesa; orlo semplice; stretto piede ad anello a profilo sagomato (Fig. 2.18). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 188, n. 2; tomba 246, n. 2. Confronti. Vicino alla serie Morel 1551 (III secolo a.C.; produzione dell’Italia centrale e centro-meridionale; Morel 1981, 123). Campochiaro (CB), santuario di Ercole: Capini 1984, 16, n. 3. Datazione. I contesti di rinvenimento suggeriscono di inquadrare il tipo nella seconda metà III secolo a.C. (scendendo fino agli inizi del II secolo a.C.).
Tipo H.240.A.6. Coppa con vasca profonda a profilo globulare; labbro continuo; orlo ingrossato e compresso superiormente; piede ad anello a profilo concavo, sagomato internamente (Fig. 2.18). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 252, n. 1. Datazione. Pur in mancanza di confronti puntuali, l’associazione con un piatto del Tipo H.290.C.4 nel contesto di rinvenimento, suggerisce di inquadrare il tipo agli inizi del III secolo a.C.
73
Capestrano, I
assottigliato e compresso superiormente; piede ad anello a profilo concavo (Fig. 2.18). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 131, n. 2; tomba 147, n. 2. Fontanelle, scavi 2012: tomba 38, n. 2. Confronti. Come i precedenti, vicino alla serie Morel 2614 (II secolo a.C.). Adria (RO), necropoli Retratto-Donà: t. 4, n. 36 (II secolo a.C.; Tamassia 1993, 16). S. Maria di Zevio (VE), loc. Mirandola: Salzani 1996, 52; ascritta alla serie Morel 2615). Datazione. II secolo a.C. (sulla base dei contesti di rinvenimento, prob. prima metà).
Tipo H.240.A.10. Coppa con vasca profonda a profilo globulare; corto labbro distinto a tesa; orlo assottigliato; piede ad anello a profilo arrotondato (Fig. 2.18). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 199, n. 2. Datazione. Pur in mancanza di confronti puntuali, il contesto di rinvenimento ne suggerisce un inquadramento tra la fine del III e gli inizi/prima metà II secolo a.C. (Tipo H.240.A.5; vedi, 73). Tipo H.240.A.11. Coppa con vasca profonda a profilo globulare; labbro continuo sinuoso; orlo assottigliato; alto piede ad anello a profilo rettilineo (Fig. 2.18). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 123, n. 2. Confronti. Vicino alla serie Morel 2614 (II secolo a.C.; produzioni varie dell’area etrusca; Morel 1981, 191). Corfinio, loc. Impianata: t. 1, n. 1 (II secolo a.C.; Dionisio 2015, 393; ascritta alla serie Morel 2977, inizi II secolo a.C.). Adria (RO), necropoli Retratto-Donà: t. 2, n. 10 (II secolo a.C.; Tamassia 1993, 13). Paestum (SA), santuario alla foce del Sele: Ferrara 2017, 140-141, nn. 1739, 1749, 1752 (fuori tipologia). Datazione. Sulla base del contesto di rinvenimento, nel quale è attestato anche un piatto del Tipo H.290.D.1, si suggerisce di puntualizzare la datazione del tipo agli inizi/prima metà II secolo a.C. (se non alla fine del III).
Tipo H.240.A.14. Coppa con vasca bassa a profilo globulare compresso; labbro distinto a tesa; orlo distinto rientrante; basso piede ad anello a profilo quadrangolare (Fig. 2.18). Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 53, n. 1. Confronti. Il tipo non trova confronti puntuali, anche se l’andamento del labbro potrebbe richiamare quello attestato nelle serie Morel 1421 e 1441 (I secolo a.C.; Italia settentrionale; Morel 1981, 112-113). Si potrebbe ipotizzare pertanto una produzione locale che richiama modelli elaborati in Italia settentrionale. Datazione. I secolo a.C. (?). COPPE CON (240.B).
VASCA A PROFILO TRONCOCONICO
Tipo H.240.B.1. Coppa con vasca a profilo troncoconico; labbro continuo; orlo semplice; stretto piede ad anello a profilo arrotondato (Fig. 2.18). Distribuzione. Fossascopana, scavi 1973: tomba 2 a camera, materiali presso la volta crollata, n. 3. Confronti. Vicino al tipo Morel 2978 (II secolo a.C.; produzioni locali o regionali; Morel 1981, 243). Datazione. II secolo a.C.
Tipo H.240.A.12. Coppa con vasca profonda a profilo globulare; labbro continuo sinuoso; orlo assottigliato; alto piede ad anello a profilo rettilineo (Fig. 2.18). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 153, n. 2; tomba 167, n. 1. Confronti. Come il precedente, vicino alla serie Morel 2614, spec. tipo 2614d (140-130 a.C.; Morel 1981, 191). Peltuinum (AQ): Liberatore 1998, 179, n. 15 (ascritta alle serie Morel 27242725). Datazione. II secolo a.C. (sulla base dei contesti di rinvenimento, prob. prima metà).
Tipo H.240.B.2. Coppa con vasca a profilo troncoconico; labbro continuo lievemente rientrante; orlo semplice, tagliato esternamente; piede ad anello a profilo rettilineo. Sul fondo della vasca sono impressi a coppie asimmetriche quattro stampigli di forma circolare a palmetta a rilievo con sette petali e
Tipo H.240.A.13. Coppa con vasca profonda a profilo globulare; labbro continuo; orlo
74
La tipologia dei materiali
suggerisce di puntualizzare la datazione del tipo alla prima metà (se non primo quarto) del II secolo a.C.
tratto ricurvo inferiore; sulla stampigliatura sono ulteriormente impresse due file di tre e quattro cerchielli (Figg. 2.18, 2.23). Distribuzione. Presciano, scavi 2010: tomba 43, n. 1. Confronti. Il tipo non trova confronti puntuali ed è genericamente vicino ai tipi Morel 2825a e 2914a (rispettivamente databili al terzo quarto del II e alla fine III-prima metà II secolo a.C.; area etrusca ed etruschizzante; Morel 1981, 225, 235). Gli stampigli, invece, richiamano motivi dell’atelier des Petites Estampilles (prima metà III secolo a.C.; Bernardini 1986, 203, n. 130). Datazione. Fine III-prima metà II secolo a.C.
Tipo H.240.C.3. Coppa con vasca profonda a profilo distinto da carena bassa e arrotondata; labbro continuo svasato; orlo ingrossato; alto piede ad anello a profilo rettilineo (Fig. 2.18). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 144, n. 3. Confronti. Vicino ai tipi Morel 2645a-b (III ?-II secolo a.C.; campana A; Morel 1981, 199). Carsoli, area urbana: Pizzoferrato 2004, n. 1 (III-II secolo a.C.; ascritta al tipo Morel 2614c). Rimini, area ex-Vescovado: F. Minak, in Mazzeo Saracino 2005, 133, n. 112 (inizi III secolo a.C.; ascritta al tipo Morel 2672b). Datazione. III secolo a.C. Nel contesto di rinvenimento, il tipo è associato a una coppetta Tipo H.260.A.18 (seconda metà III-inizi II secolo a.C.) e skyphoi Tipo H.280.7.
COPPE A PROFILO DISTINTO (240.C). Tipo H.240.C.1. Coppa con vasca a profilo troncoconico, distinto da carena alta e accentuata; labbro continuo svasato; orlo da semplice ad assottigliato; piede ad anello a profilo da rettilineo ad arrotondato (Fig. 2.18). Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 28, n. 2; tomba 34, n. 2. Confronti. Il tipo, probabilmente prodotto locale, può essere problematicamente avvicinato al tipo Morel 2631a (ultimo terzo IV secolo a.C.; da Ordona; Morel 1981, 196). Trova confronti con produzioni di ceramica grezza attestate in area padana, Monte Bibele, necropoli di Monte Tamburino: t. 54, n. 16 (Vitali 2003). Datazione. Ultimo terzo IV secolo a.C.
Tipo H.240.C.4. Coppa con vasca profonda a profilo distinto da carena bassa; labbro continuo svasato; orlo distinto lievemente ingrossato; piede ad anello a profilo concavo. L’esemplare dalla tomba 2 a camera di Fossascopana presenta quattro stampigli di forma quadrata con doppia S centrale (Figg. 2.19, 2.23). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 190, n. 5. Fossascopana, scavi 1973: tomba 2 a camera, materiali presso la volta crollata, n. 4. Presciano, scavi 2010: tomba 50, n. 1 e, vicino, il n. 2. Confronti. Si ascrive alla serie Morel 2653 (IIinizi I secolo a.C.; tendenzialmente campana B, Etruria e aree circostanti; Morel 1981, 202). L’esemplare dalla tomba 2 di Fossascopana trova confronti puntuali con Fossa: t. 2, n. 14 (prima metà II secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 168; ascritta alla prima metà II secolo a.C.); t. 430, n. 16 (metà I secolo a.C.-età augustea; d’Ercole e Copersino 2003, 222) Tocco Casauria (PE): t. 4, n. 3 (ascritta al III secolo a.C.; Maurizio 1995, 147). Vedi anche, Fossa: t. 432, n. 8 (fine II-inizi I secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 117; ascritta al tipo Morel 2646f1, del II secolo a.C.); t. 504, n. 6 (metà II secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003,
Tipo H.240.C.2. Coppa con vasca a profilo troncoconico distinto da carena arrotondata; labbro continuo svasato; orlo distinto e ingrossato a sezione triangolare; piede ad anello concavo a profilo arrotondato (Fig. 2.18). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 169, n. 1. Confronti. Vicino al tipo 2645c (intorno al secondo quarto II secolo a.C.; campana A; Morel 1981, 199). Sulmona, loc. Fonte d’Amore: t. 40, n. 944 (fine II-prima metà I secolo a.C.; Dionisio 2015, 478). Vicino, Adria (RO), necropoli Retratto-Donà: t. 15, n. 280 (non oltre la metà del II secolo a.C.; Tamassia 1993, 52, ascritta al tipo Morel 2672c). Datazione. L’associazione con uno skyphos Tipo H.280.5 nel contesto di rinvenimento, 75
Capestrano, I
139; ascritta alla serie Morel 2653; databile dal II secolo a.C. all’età augustea); t. 518, n. 4 (primi decenni I secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 145; ascritta alla serie Morel 2652); t. 63, n. 18 (II-inizi I secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 183-184; ascritta al tipo Morel 2652a1, inizi del I secolo a.C.); t. 516, n. 17 (seconda metà II-primi decenni I secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 237; ascritta alla serie Morel 2652; inizi I secolo a.C.). Corfinio (AQ), loc. Impianata: t. 4, in. B, nn. 648-649 (inizi-prima metà II secolo a.C.; Dionisio 2015, 399-400; vedi anche Romito e Sangiovanni 2008, 207, fig. 6B, rif. alla metà del II secolo a.C.). Tocco Casauria (PE): t. 2, prima sepoltura, n. 2 (II secolo a.C.; Maurizio 1995, 140). Sentinum (AN): Brecciaroli Taborelli 2013, 30-31). Jesi (AN), officina di Aesis: Brecciaroli Taborelli 1996-1997, 150153, fig. 80, nn. 280-282 (150/140 a.C.-età augustea). Datazione. II (prob. metà)-inizi I secolo a.C.
Tipo H.240.C.7. Coppa con vasca profonda a profilo distinto da bassa carena arrotondata; labbro svasato sinuoso; orlo semplice; piede ad anello (Fig. 2.19). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 172, n. 1. Confronti. Vicino a Fossa: t. 502, n. 5 (metà II secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 136137; ascritta a produzioni regionali, riproduce il tipo Morel 2645b1 della campana A; Morel 1981, 199). Anversa degli Abruzzi, loc. Cimitero dei Pagani: t. 3, n. 303 (prima metà III secolo a.C.; Dionisio 2015, 314, attribuita al tipo Morel 2624a1; vedi anche Romito e Sangiovanni 2008, fig. 8). Datazione. Metà II secolo a.C. Tipo H.240.C.8. Coppa con vasca bassa a profilo distinto da bassa carena arrotondata; labbro svasato curvilineo; orlo semplice distinto; piede ad anello (Fig. 2.19). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 262, n. 1. Confronti. Vicino ai tipi Morel 2621f e h (prima metà II secolo a.C.; Lazio ed Etruria meridionale; Morel 1981, 198). Corfinio, loc. Impianata: t. 4, in. C (metà II secolo a.C.; Dionisio 2015, 403-404). Datazione. Prima metà-metà II secolo a.C.
Tipo H.240.C.5. Coppa con vasca profonda a profilo distinto da carena bassa; labbro continuo svasato; orlo lievemente ingrossato e tagliato esternamente; piede ad anello concavo a profilo arrotondato. Sul fondo, contenuti da due solcature concentriche, sono impressi quattro stampigli quadrati, disposti radialmente (Fig. 2.19). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 214, n. 3. Confronti. Vicino al tipo precedente. Datazione. II-inizi I secolo a.C.
Tipo H.240.C.9. Coppa con vasca bassa a profilo carenato; labbro continuo svasato; orlo semplice; ampio piede ad anello a profilo rettilineo (Fig. 2.19). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 168, n. 2. Confronti. Tipo Morel 2362a (80 a.C. ± 50; produzione locale o regionale; Morel 1981, 166). Fossa, t. 123, n. 4 (prima metà I secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 42); t. 401, n. 5 (fine II secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 96). Sulmona, loc. Fonte d’Amore: t. 40, n. 943 (fine II-prima metà I secolo a.C.; Dionisio 2015, 478; vedi anche Romito e Sangiovanni 2008, 219, fig. 12). Datazione. Fine II-prima metà I secolo a.C.
Tipo H.240.C.6. Coppa con vasca profonda a profilo distinto da carena bassa; labbro sinuoso svasato; orlo semplice; piede a disco segnato da una scanalatura orizzontale (Fig. 2.19). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 281, n. 1. Confronti. Confronti. Vicino al tipo Morel 2621 (280 a.C. ±25; Lazio ed Etruria meridionale; Morel 1981, 194). Datazione. Sulla base della presenza all’interno del contesto di rinvenimento di un piatto Tipo H.290.C.1, è possibile puntualizzare la datazione del tipo intorno alla metà del III secolo a.C. (se non nei decenni immediatamente successivi).
Tipo H.240.C.10. Coppa con vasca bassa a profilo carenato; labbro continuo svasato; orlo semplice; ampio piede ad anello a profilo rettilineo (Fig. 2.19). 76
La tipologia dei materiali
Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 239, n. 2; tomba 250, n. 2. Confronti. Tipo Morel 2586 (ultimi decenni IVprimi decenni II secolo a.C.; Campania; Morel 1981, 188). La stampigliatura corrisponde a Bernardini 1986, 173, n. 615, della ceramica di Teano. Si veda anche Aquinum (FR), santuario di Mefete: Nicosia 1976, 15, motivo n. 97. Datazione. Fine IV-prima metà III secolo a.C.
Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 151, n. 3. Fossascopana, scavi 1973: tomba a camera 1, sepoltura “c”, n. 2. Confronti. Come il precedente, si inquadra nel tipo Morel 2362a. Datazione. Fine II-prima metà I secolo a.C. Tipo H.240.C.11. Coppa con vasca bassa a profilo carenato; labbro continuo svasato; orlo semplice, segnato da una scanalatura orizzontale; ampio piede ad anello a profilo triangolare. (Fig. 2.19). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 180, n. 2. Confronti. Vicino alla serie Morel 2323, spec. tipo 2323f (ultimi decenni II-primi decenni I secolo a.C.; campana B; Morel 1981, 165). Fossa: t. 401, n. 5; t. 427, n. 5; t. 431, n. 4 (fine II-inizi I secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 96, 109, 113). Jesi (AN), officina di Aesis: Brecciaroli Taborelli 1996-1997, 139, fig. 73, n. 206 (120/110-50/40 a.C.). Datazione. Ultimo quarto-fine II secolo a.C.prima metà I secolo a.C.
COPPE
CON VASCA CONVESSO (240.D).
GLOBULARE
E
FONDO
Tomba H.240.D.1. Coppa con vasca a profilo emisferico; labbro rettilineo; orlo semplice; fondo convesso (Fig. 2.19). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 190, n. 6. Datazione. Malgrado la vicinanza al tipo Morel 2121c (fine III-metà II secolo a.C.; Morel 1981, 138), sulla base del contesto di rinvenimento, è possibile puntualizzare la datazione del tipo alla seconda metà II-inizi I secolo a.C. COPPE BIANSATE (Forma 250).
Tipo H.240.C.12. Coppa con vasca bassa a calotta a profilo distinto; labbro continuo sinuoso; orlo distinto e appena ingrossato; sul labbro sono incise tre linee orizzontali; ampio piede ad anello a profilo triangolare (Fig. 2.19). Distribuzione. Via dell’Olmo, scavi 2011: tomba 3, n. 1. Confronti. Vicino alla serie Morel 2323, spec. tipo 2323k (fine II-inizi I secolo a.C.; campana B; Morel 1981, 165). Basciano (TE), stipe votiva: Messineo 1997, 188, n. 1 (metà IIdecenni centrali del I secolo a.C.). Datazione. Seconda metà II-prima metà I secolo a.C.
Tipo H.250.1. Coppa con vasca a profilo troncoconico; labbro continuo lievemente rientrante; orlo semplice; anse bifide cd. “en oreilles” sormontanti rispetto all’orlo; piede ad anello a profilo concavo (Fig. 2.19). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 151, n. 4; tomba 180, n. 3; tomba 190, n. 7; tomba 214, n. 4. Fossascopana, scavi 1964: tomba 5, saggio 8, n. 2. Fossascopana, scavi 1973: tomba 1 a camera, sepoltura “c”, n. 3; tomba 2 a camera, materiali presso la volta crollata, nn. 8-9; deposizione 1, n. 1. Presciano, scavi 2010: tomba 50, n. 3. Via dell’Olmo, scavi 2011: tomba 3, n. 2. Confronti. Tipo Morel 3121b (II secolo a.C.; Etruria settentrionale e centrale; Morel 1981, 248). Datazione. II secolo a.C.
Tipo H.240.C.13. Coppa con ampia e bassa vasca a profilo distinto da carena arrotondata; labbro continuo lievemente svasato; orlo ingrossato e compresso superiormente; alto piede ad anello a profilo rettilineo. Stampigliatura sul fondo composta da quattro palmette disposte radialmente intorno a un motivo centrale circolare rappresentante un volto stilizzato, campite entro ampie rotellature (Figg. 2.19, 2.23).
Tipo H.250.2. Coppa con vasca a profilo troncoconico; labbro continuo svasato; orlo semplice; anse bifide cd. “en oreilles” non sormontanti rispetto all’orlo; stretto piede ad 77
Capestrano, I
impressi a coppie asimmetriche (Figg. 2.20, 2.23). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 179, n. 1. Confronti. Tipo Morel 2783g1 (fine IV-inizi III secolo a.C.; atelier des Petites Estampilles; Morel 1981, 224). Fossa: t. 307, n. 3 (prima metà III secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 73). Anversa degli Abruzzi, loc. Coccitelle: t. 22, n. 73 (fine IV-prima metà III secolo a.C.; Dionisio 2015, 243). Per gli stampigli, Bernardini 1986, 200, n. 100. Datazione. Fine IV-prima metà III secolo a.C.
anello a profilo arrotondato (Fig. 2.19). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 174, n. 1. Confronti. Tipo Morel 3121h (II secolo a.C.; Morel 1981, 248). Vicino a Fossa: t. 432, n. 9 (fine II-inizi I secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 117; ascritta alla serie Morel 3121). Datazione. II secolo a.C. COPPETTE (Forma 260). COPPETTE (260.A).
CON VASCA A PROFILO GLOBULARE
Tipo H.260.A.4. Coppetta con vasca bassa a profilo globulare; labbro continuo rientrante; orlo semplice, distinto internamente; basso piede ad anello a profilo concavo. All’interno della vasca, quattro stampigli ovali che racchiudono due file di tre e due cerchielli, impressi a coppie simmetriche (Figg. 2.20, 2.24). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 135, n. 2. Confronti. Tipo Morel 2783h1 (primi decenni III secolo a.C.; atelier des Petites Estampilles; Morel 1981, 224). Datazione. Primi decenni III secolo a.C.
Tipo H.260.A.1. Coppetta con vasca a profilo globulare; labbro continuo; orlo semplice; piede ad anello a profilo rettilineo (Fig. 2.19). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 122, n. 2. Confronti. Vicino al tipo Morel 2775c (fine IIIprima metà II secolo a.C.; area di Roma; Morel 1981, 222). Fossa: t. 406, n. 6 (fine III-inizi II secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 101). Portorecanati (PU): t. 121, n. 1 (Mercando 1974b, 286). Rimini, area ex-Vescovado: F. Minak, in Mazzeo Saracino 2005, 135 (acritta alla serie Morel 2774; metà III-metà II secolo a.C.). Datazione. Fine III-prima metà II secolo a.C.
Tipo H.260.A.5. Coppetta con vasca profonda a profilo globulare; labbro continuo rientrante; orlo semplice; piede ad anello a profilo da concavo ad arrotondato (Fig. 2.20). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 156, n. 2; tomba 199, n. 3. Fontanelle, scavi 2012: tomba 24, n. 1. Confronti. Vicino alla serie Morel 2914 (fine III-II secolo a.C.; produzioni dell’area etrusca o etruschizzante; Morel 1981, 235). Fossa: t. 224, nn. 9 e 11 (fine III-prima metà II secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 59, ascritta alla serie Morel 2914); t. 333, n. 7 (fine III-prima metà II secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, ascritta alla serie Morel 2764). Tocco Casauria (PE): t. 1, seconda sepoltura, n. 1 (metà III secolo a.C.; Maurizio 1995, 132); t. 2, prima sepoltura, n. 3 (II secolo a.C.; Maurizio 1995, 143). Jesi (AN), officina di Aesis: Brecciaroli Taborelli 1996-1997, 159 fig. 85, n. 331 (250/240-200/190 a.C.). Rimini, area exVescovado: F. Minak, in Mazzeo Saracino 2005,
Tipo H.260.A.2. Coppetta con vasca a profilo globulare; labbro continuo lievemente rientrante; orlo semplice; piede ad anello a profilo sagomato (Fig. 2.19). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 159, n. 1; tomba 280, n. 1. Fossascopana, scavi 1964: tomba 7, saggio 8, n. 1. Fossascopana, scavi 1973: tomba 2 a camera, deposizione n. 3, n. 2. Fontanelle, scavi 2012: tomba 38, n. 4. Confronti. Vicino alla serie Morel 2784 (fine IV-prima metà III secolo a.C.; Italia centrale; Morel 1981, 224). Datazione. Fine IV-prima metà III secolo a.C. Tipo H.260.A.3. Coppetta con vasca a profilo globulare; labbro continuo rientrante; orlo semplice; basso piede ad anello a profilo arrotondato. All’interno della vasca, quattro stampigli rappresentanti una palmetta a rilievo 78
La tipologia dei materiali
a.C./inizi I secolo d.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 200; ascritta alla specie 2250); t. 520, n. 12 (fine II-primi decenni I secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 242-244). Carsoli (AQ), area urbana: Pizzoferrato 2004, 140, n. 20 (datata alla metà-seconda metà III secolo a.C.). Corfinio, loc. Impianata: t. 4, in. B, n. 656 (inizi-prima metà II secolo a.C.; Dionisio 2015, 403). Peltuinum (AQ). Liberatore 1998, 179 n. 15 (ascritta alle serie Morel 2724-2725). Jesi (AN), officina di Aesis: Brecciaroli Taborelli 1996-1997, 161 fig. 86, n. 347 (250/240200/190 a.C.). Paestum (SA), santuario alla foce del Sele: Ferrara 2017, 137-139. Datazione. Seconda metà III- II secolo a.C.
135, n. 139 (ascritta al tipo Morel 2783h; metà III-metà II secolo a.C.). Datazione. Fine III-II secolo a.C. (prob. prima metà). Tipo H.260.A.6. Coppetta con vasca profonda a profilo globulare; labbro continuo e lievemente rientrante; orlo assottigliato; basso piede ad anello a profilo concavo (Fig. 2.20). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 216, n. 2. Confronti. Vicino alla serie Morel 2914 (fine III-II secolo a.C.; produzioni dell’area etrusca o etruschizzante; Morel 1981, 235). Jesi (AN), officina di Aesis: Brecciaroli Taborelli 19961997, 159 fig. 85, n. 335 (250/240-150 a.C.). Paestum (SA), santuario alla foce del Sele: Ferrara 2016, 137-139. Datazione. Fine III-II secolo a.C. (prob. prima metà).
Tipo H.260.A.9. Coppetta con vasca bassa a profilo globulare; labbro continuo lievemente rientrante; orlo tagliato esternamente, a sezione triangolare; alto e stretto piede ad anello a profilo rettilineo (Fig. 2.20). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 131, n. 4: tomba 164, n. 1; tomba 167, n. 2. Fontanelle, scavi 2012: tomba 35, n. 2; tomba 47, n. 1. Confronti. Il tipo non trova confronti puntuali nella classificazione del Morel, se non rimandi generici al tipo 2765a e al tipo 2914 (rispettivamente databili alla seconda metà III secolo a.C. e alla prima metà II secolo a.C.). Fossa: t. 110, n. 6 (seconda metà II secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 37, ascritta al tipo Morel 2825d1, attestata nel II secolo a.C.). Paestum (SA), santuario alla foce del Sele: Ferrara 2017, 137. Datazione. Seconda metà III-prima metà II secolo a.C.
Tipo H.260.A.7. Coppetta con vasca profonda a profilo globulare; labbro continuo; orlo assottigliato e tagliato esternamente; basso piede ad anello a profilo rettilineo (Fig. 2.20). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 281, n. 2 Confronti. Vicino alla serie Morel 2784 (inizi del III secolo a.C.; Italia centrale; Morel 1981, 224). Paestum (SA), santuario alla foce del Sele: Ferrara 2017, 137-139. Datazione. Prima metà III secolo a.C. Tipo H.260.A.8. Coppetta con vasca profonda a profilo globulare; labbro continuo lievemente rientrante; orlo tagliato esternamente, a sezione triangolare; basso piede ad anello a profilo da rettilineo ad arrotondato (Fig. 2.20). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 145, n. 1; tomba 157, n. 3; tomba 163, n. 1; tomba 282, n. 1. Fossascopana, scavi 1973: tomba 1 a camera, pulizia, n. 4. Confronti. Vicino alla serie Morel 2982 (III secolo a.C.; area etrusca o etruschizzante; Morel 1981, 244). Vicino a Fossa: t. 427, n. 6 (fine II-inizi I secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 109; ascritto al tipo Morel 2784d); t. 553, n. 1 (fine III-inizi II secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 150; ascritta alla serie Morel 2913); t. 330, n. 31 (fine II-fine I secolo
Tipo H.260.A.10. Coppetta miniaturistica con bassa vasca a profilo globulare; labbro rientrante; orlo semplice; stretto piede ad anello a profilo sagomato, concavo all’interno (Fig. 2.20). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 165, n. 1. Confronti. Rientra nella serie Morel 2783 come variante miniaturistica (fine IV-primo terzo III secolo a.C.; produzione dell’Italia centrale; Morel 1981, 223) o Morel 2787e1 (fine IVprimo terzo III secolo a.C.; Morel 1981, 225). 79
Capestrano, I
Vasto, stipe votiva di Fonte San Nicola (CH): Faustoferri 1997, 112-113, n. 101 (III-II secolo a.C.; attribuita al tipo Morel 2717j1). Datazione. Fine IV-primi decenni III secolo a.C.
ad anello a profilo concavo sagomato (Fig. 2.20). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 164, n. 2. Confronti. Vicino tipo Morel 2791b1 (III secolo a.C.; da Alba Fucens; Morel 1981, 226). Vasto, stipe votiva di Fonte San Nicola (CH): Faustoferri 1997, 112, n. 100 (III-II secolo a.C.; attribuita al tipo Morel 2791a1). Jesi (AN), officina di Aesis: Brecciaroli Taborelli 19961997, 157 fig. 83, n. 318 (III secolo a.C.). Datazione. III secolo a.C.
Tipo H.260.A.11. Coppetta miniaturistica con vasca profonda a profilo globulare; labbro continuo rientrante; orlo assottigliato; basso piede ad anello a profilo arrotondato (Fig. 2.20). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 252, n. 2 Confronti. Vicino serie Morel 2783 (fine IVprimo terzo III secolo a.C.; Morel 1981, 223). Datazione. Fine IV-primi decenni III secolo a.C.
Tipo H.260.A.15. Coppetta con vasca a profilo globulare; labbro continuo lievemente rientrante; orlo distinto e ingrossato, tagliato superiormente; basso piede ad anello a profilo concavo. Sul fondo sono impressi quattro stampigli a palmette a sette petali (Figg. 2.20, 2.23). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 129, n. 1. Confronti. Serie Morel 2672c (inizi III secolo a.C.; area etruschizzante, soprattutto la Sabina; Morel 1981, 204). Fossa: t. 428, n. 2 (prima metà III secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 111). Datazione. Prima metà III secolo a.C.
Tipo H.260.A.12. Coppetta miniaturistica con vasca a profilo lenticolare; labbro continuo rientrante; orlo semplice; basso piede ad anello a profilo arrotondato (Fig. 2.20). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 199, n. 4 Confronti. Anversa degli Abruzzi, loc. Coccitelle: t. 40, n. 155 (prima metà III secolo a.C.; Dionisio 2015, 268). Datazione. Sebbene il tipo possa essere avvicinato a una variante miniaturistica delle coppette della serie 2783 (fine IV-prima metà III secolo a.C.; Morel 1981, 223), il contesto di rinvenimento ne suggerisce un inquadramento nella prima metà II secolo a.C.
Tipo H.260.A.16. Coppetta con vasca a profilo globulare; labbro svasato; orlo distinto e ingrossato a fascia; basso piede ad anello sagomato, segnato esternamente da due incisioni orizzontali. Il labbro è decorato da serie di linee a zig-zag verticali alternate a motivi a stella (Fig. 2.20). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 279, n. 1. Confronti. La decorazione ricorre sulle coppette con orlo a fascia della serie Morel 2522 (vedi ad es. Bernardini 1986, 142), di cui il tipo sembra essere una rielaborazione. Datazione. In via altamente ipotetica si suggerisce per il tipo una datazione coerente con quella della serie Morel 2522: seconda metà III-inizi II secolo a.C.
Tipo H.260.A.13. Coppetta miniaturistica con vasca a profilo globulare compresso, distinto da bassa carena arrotondata; labbro continuo rientrante; orlo distinto internamente; alto piede cilindrico (Fig. 2.20). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 147, n. 3. Confronti. Vicino al tipo Morel 2783j1 (fine IV-inizi III secolo a.C., Morel 1981, 223-224). Datazione. Anche in questo caso, gli altri materiali presenti nel contesto di rinvenimento, e spec. il piatto Tipo H.290.C.7, suggerisce un inquadramento nella prima metà II secolo a.C.
Tipo H.260.A.17. Coppetta con vasca a profilo globulare compresso; labbro rientrante e orlo distinto a fascia a profilo triangolare; dislivello segnato da costolatura sul fondo interno della
Tipo H.260.A.14. Coppetta miniaturistica con vasca a profilo globulare compresso; labbro continuo molto rientrante; basso e ampio piede 80
La tipologia dei materiali
Datazione. Fine IV-inizi III secolo a.C.
vasca; basso piede ad anello a profilo arrotondato (Fig. 2.20). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 135, n. 3. Confronti. Serie Morel 2522 (220 a.C. ±30; Italia centrale e soprattutto Roma; Morel 1981, 176). Vasto, stipe votiva di Fonte San Nicola (CH): Faustoferri 1997, 111, nn. 86-90 (III-II secolo a.C.). Datazione. L’associazione all’interno del contesto di rinvenimento con la coppetta Tipo H.260.A.4 e il piatto H.290.C.4, suggerisce di inquadrare il tipo nella prima metà III secolo a.C.
Tipo H.260.B.2. Coppetta con vasca profonda a profilo troncoconico; labbro continuo; orlo lievemente ingrossato e tagliato internamente; la vasca è segnata alla base da una bassa carena e da una linea orizzontale incisa; alto piede ad anello a profilo concavo (Fig. 2.20). Distribuzione. Fossascopana, scavi 1934: tomba 9, nn. 1-2. Confronti. Esemplare identificativo del tipo Morel 2471a (II secolo a.C.; Morel 1981, 171). Vicino, Anversa degli Abruzzi, loc. Coccitelle: t. 41, n. 160 (prima metà III secolo a.C.; Dionisio 2015, 269; ascritta alla serie Morel 2411). Sulmona, loc. Fonte d’Amore: t. 6, n. 856 (attribuita alla fine IV-inizi III secolo a.C.; Dionisio 2015, 449-450; ascritta alla serie Morel 2411; vedi anche Romito e Sangiovanni 2008, 217). Datazione. II secolo a.C. L’associazione nel contesto di rinvenimento con un piatto Tipo H.290.C.7 suggerisce di puntualizzare la datazione del tipo alla prima metà del secolo.
Tipo H.260.A.18. Coppetta con vasca a profilo globulare compresso; labbro rientrante e orlo distinto a fascia a profilo triangolare; basso piede ad anello a profilo arrotondato (Fig. 2.20). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 144, n. 4. Confronti. Serie Morel 2524 (seconda metà IIIinizi II secolo a.C.; area etruschizzante; Morel 1981, 176). Jesi (AN), officina di Aesis: Brecciaroli Taborelli 1996-1997, 140, fig. 74, n. 219 (250/240-150/140 a.C.). Rimini, area exVescovado: F. Minak, in Mazzeo Saracino 2005, 127, nn. 69-71 (riferite alla specie Morel 2520; seconda metà III-inizi/metà II secolo a.C.). Datazione. Seconda metà III-prima metà II secolo a.C. COPPETTE
CON VASCA TRONCOCONICO (260.B).
A
COPPETTE (260.C).
CON VASCA A PROFILO DISTINTO
Tipo H.260.C.1. Coppetta miniaturistica con vasca a profilo distinto da carena accentuata; labbro continuo rientrante; orlo semplice; piede a disco a profilo troncoconico (Fig. 2.21). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 145, n. 2 Fontanelle, scavi 2012: tomba 7, n. 2. Confronti. Vicino al tipo Morel 2744c (II secolo a.C.; Morel 1981, 216). Pergola (PU): t. 1, n. 4 (con datazione proposta alla fine del I secolo a.C., da rivedere; Mercando 1974a, 94). Datazione. II secolo a.C.
PROFILO
Tipo H.260.B.1. Coppetta con vasca profonda a profilo troncoconico; labbro continuo lievemente rientrante; orlo appena ingrossato; la vasca è segnata alla base da una profonda scanalatura orizzontale; alto piede ad anello a profilo rettilineo (Fig. 2.20). Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 52, n. 2 Confronti. Vicino alle serie Morel 2423-2424 (fine IV-inizi III secolo a.C.; diffusa soprattutto in Campania; Morel 1981, 168-169). Pontecagnano: Serritella 2013, 141. Paestum (SA), santuario alla foce del Sele: Ferrara 2017, 122-123.
Tipo H.260.C.2. Coppetta miniaturistica con vasca profonda a profilo distinto da carena arrotondata; labbro continuo diritto; orlo semplice; basso piede ad anello a profilo triangolare (Fig. 2.21). Distribuzione. Fossascopana, scavi 1964: tomba 3, saggio 8, n. 1. Confronti. Esemplare di riferimento del tipo Morel 2848a (III secolo a.C.?; Morel 1981, 232). 81
Capestrano, I
Datazione. III secolo a.C.
Tipo H.260.C.7. Coppetta con vasca profonda a profilo distinto da bassa carena accentuata; labbro continuo svasato; orlo semplice; basso piede ad anello a profilo concavo (Fig. 2.21). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 151, n. 5; tomba 168, nn. 3 e 17; tomba 190, n. 8; tomba 214, n. 5. Fossascopana, scavi 1973, tomba 1 a camera, n. 2; tomba 2 a camera, deposizione 2, n. 2. Confronti. Vicino ai tipi Morel 1222d-e e g (tra le metà del II e la metà del I secolo a.C.; campana B; Morel 1981, 93). Fossa: t. 123, n. 5 (prima metà I secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 42-43; ascritta al tipo Morel 1222c1, ultimo quarto II-primo quarto I secolo a.C.); t. 431, n. 5 (fine II-inizi I secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, ascritta alla serie Morel 1225). Jesi (AN), officina di Aesis: Brecciaroli Taborelli 1996-1997, 109, fig. 55, n. 4 (ascritta alla serie 1222; 160-140 a.C.). Datazione. Metà II-metà I secolo a.C.
Tipo H.260.C.3. Coppetta con vasca bassa a profilo distinto da bassa carena arrotondata; labbro continuo; orlo semplice; piede ad anello a profilo rettilineo (Fig. 2.21). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 153, n. 3. Confronti. Vicino a Fossa: t. 401, n. 10 (fine II secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 96, ascritta al tipo Morel 2362a1). Datazione. II secolo a.C. Tipo H.260.C.4. Coppetta con vasca profonda a profilo distinto da bassa carena arrotondata; labbro continuo; orlo distinto e ricurvo; piede ad anello a profilo sagomato (Fig. 2.21). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 251, n. 2. Confronti. Vicino al tipo 2652b (I secolo a.C.; Etruria; Morel 1981, 202). Affine alle coppe in sigillata italica tipo Pucci 1981, XIV; Conspectus 8.1 (età augustea). Datazione. I secolo a.C.
COPPETTE CON VASCA EMISFERICA E FONDO CONVESSO (260.D).
Tipo H.260.C.5. Coppetta miniaturistica con vasca profonda a profilo cilindrico distinto da bassa carena arrotondata; labbro continuo lievemente svasato; orlo tagliato internamente; basso piede a disco, segnato sul fondo da scanalature concentriche (Fig. 2.21). Distribuzione. Fossascopana, scavi 1973: tomba 2 a camera, sepoltura 3, n. 3 Confronti. Potrebbe trattarsi di una variante miniaturistica del tipo Morel 7443a (II secolo a.C.; produzione sarda o campana A; Morel 1981, 409). Datazione. II secolo a.C.
Tipo H.260.D.1. Coppetta con vasca profonda a profilo emisferico; labbro continuo; orlo semplice; fondo convesso (Fig. 2.21). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 168, n. 4. Confronti. Vedi il Tipo H.240.D.1 (77). Datazione. Fine II-prima metà I secolo a.C. COPPETTE MONOANSATE (Forma 265). Tipo H.265.1. Coppetta monoansata con vasca profonda a profilo troncoconico; labbro distinto lievemente svasato; orlo semplice; piede ad anello a profilo arrotondato. Ansa (a maniglia, mancante nell’esemplare di riferimento), impostata al di sotto dell’orlo. Sul fondo della vasca sono impressi quattro stampigli a coppie asimmetriche, di forma ovale, rappresentanti palmette con nove foglie e due volute alla base (Figg. 2.21, 2.23). Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 26, n. 1. Confronti. Vicino alla serie Morel 6231 (Morel 1981, 394-395), spec. al tipo Morel 6263a (seconda metà IV secolo a.C.; Campania; Morel 1981, 396). Paestum (SA), santuario alla foce
Tipo H.260.C.6. Coppetta con vasca profonda a profilo distinto da bassa carena, impostata poco al di sopra del piede; labbro continuo svasato; orlo semplice; basso piede ad anello a profilo concavo (Fig. 2.21). Distribuzione. Via dell’Olmo, scavi 2011: tomba 3, n. 3. Confronti. Vicino al tipo Morel 1222h (II secolo a.C.; campana B; Morel 1981, 93). Datazione. II secolo a.C.
82
La tipologia dei materiali
Tipo H.280.3. Skyphos a profilo sinuoso; labbro continuo; orlo semplice; ventre a profilo concavo; basso piede ad anello a profilo sagomato; anse a maniglia orizzontali impostate in corrispondenza del labbro (Fig. 2.21). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 159, n. 2; tomba n. 228, n. 2. Presciano, scavi 2010: tomba 37, n. 3; tomba 43, n. 2. Confronti. Tipo Morel 4372a1 (prima metà III secolo a.C.; Morel 1981, 311). Vicino a Fossa: t. 333, n. 4 (da cui diverge per la posizione delle anse; fine III-prima metà II secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 80). Vasto, stipe votiva di Fonte San Nicola (CH): Faustoferri 1997, 111, n. 82 (III-II secolo a.C.; attribuita al tipo Morel 4373a2). Datazione. Prima metà III-prima metà II secolo a.C.
del Sele: Ferrara 2017, 117-118. Datazione. Sulla base degli altri materiali del contesto di rinvenimento (tra cui ad esempio una collana di pendenti in ambra Tipo S.50.5) il tipo può essere ascritto alla fine del IV-prima metà del III secolo a.C. SKYPHOI (Forma 280). Per la diffusione e la datazione degli skyphoi nell’area aquilana, si veda C. Rizzitelli in d’Ercole e Copersino 2003, 287-288, che ne rileva la presenza anche oltre il III secolo a.C., considerato nella classificazione del Morel il termine recenziore per la forma, attestata fin dal IV. Tipo H.280.1. Skyphos a profilo sinuoso; labbro svasato, segnato da tre linee incise; orlo semplice; ventre ingrossato al di sotto delle anse e vasca a profilo concavo; basso piede ad anello a profilo concavo; anse a maniglia oblique impostate alla base del labbro (Fig. 2.21). Distribuzione. Presciano, scavi 2010: tomba 50, n. 5. Confronti. Vicino alla serie Morel 4341 (seconda metà IV secolo a.C.; Morel 1981, 307). Datazione. Seconda metà IV secolo a.C.
Tipo H.280.4. Skyphos a profilo troncoconico; labbro continuo; orlo semplice; piede ad anello a profilo sagomato; anse a maniglia orizzontali impostate in corrispondenza del labbro (Fig. 2.21). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 239, n. 3. Confronti. Morel 4375b1 (ultimo terzo IV secolo a.C.; Morel 1981, 312). Corrisponde al tipo 8 degli skyphoi della fase ellenistica di Campovalano (A. Martellone in d’Ercole, Martellone e Cesana 2016, 121, esemplari nelle tt. 433, n. 4 e 584, n. 10), Datazione. Fine IV-prima metà III secolo a.C.
Tipo H.280.2. Skyphos a profilo sinuoso; labbro svasato; orlo da semplice ad assottigliato; alto piede ad anello a profilo rettilineo; anse a maniglia oblique impostate alla base del labbro (Fig. 2.21). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 122, n. 3; tomba 216, n. 3. Fossascopana, scavi 1934: tomba 10, n. 1. Fossascopana, scavi 1973: tomba 2, deposizione 3, n. 4. Confronti. Morel 4373a2 (ultimo quarto IV secolo a.C., vedi sopra; Morel 1981, 311). Fossa: t. 469, n. 13 (fine II secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 127; ascritto alla serie Morel 4393). Corrisponde al tipo 3 degli skyphoi di Campovalano (A. Martellone in d’Ercole, Martellone e Cesana 2016, 120-121, esemplare nella t. 525, n. 2). Datazione. Ultimo quarto IV-II secolo a.C.
I Tipi H.280.5-9 si inquadrano nella serie Morel 4363, la cui datazione si pone tra gli inizi/prima metà III e scende, come sopra accennato, fino agli inizi del II secolo a.C. (Morel 1981, 310). Tipo H.280.5. Skyphos a profilo troncoconico; labbro lievemente svasato; orlo semplice; vasca distinta in corrispondenza della sua porzione centrale e a profilo concavo sottostante; basso piede ad anello a profilo quadrangolare; anse a maniglia orizzontali impostate in corrispondenza del labbro (Fig. 2.21). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 131, n. 5; tomba 147, n. 4; tomba 163, n. 2; tomba 168, n. 5; tomba 169, n. 2. 83
Capestrano, I
tra la metà III e la prima metà del II secolo a.C.
Confronti. Fossa: t. 411, n. 2 (seconda metà IIIinizi II secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 103-104). Campochiaro (CB), stipe votiva: Capini 1984, 31, nn. 67, 69 (ascritto alla specie Morel 4370). Datazione. Seconda metà III-inizi II secolo a.C.
Tipo H.280.9. Skyphos a profilo troncoconico; labbro distinto svasato; orlo semplice; vasca distinta al di sotto delle anse e a profilo concavo sottostante; basso piede a disco a profilo sagomato; anse a maniglia orizzontali impostate in corrispondenza del labbro (Fig. 2.22). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 145, n. 3. Confronti. Fossa: t. 224, n. 8 (fine III-prima metà II secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 57; ascritto alla serie Morel 4341). Datazione. Fine III-prima metà II secolo a.C.
Tipo H.280.6. Skyphos a profilo troncoconico; labbro distinto lievemente svasato; orlo semplice; vasca distinta al di sotto delle anse; basso piede ad anello a profilo quadrangolare; anse a maniglia orizzontali impostate in corrispondenza del labbro (Fig. 2.21). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 167, n. 3. Datazione. Seconda metà III-inizi II secolo a.C.
Tipo H.280.10. Skyphos a profilo troncoconico; labbro lievemente svasato; orlo assottigliato; vasca distinta in corrispondenza della sua porzione centrale e a profilo cilindrico sottostante; basso piede ad anello a profilo sagomato, con fondo concavo; anse a maniglia orizzontali impostate in corrispondenza del labbro (Fig. 2.22). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 250, n. 3. Fossascopana, scavi 1964: tomba 8, saggio 8, n. 3. Fontanelle, scavi 2012: tomba 26, n. 2. Confronti. Tipo Morel 4331a (prima metà III secolo a.C.; Morel 1981, 306). Vicino a un esemplare sovradipinto da Manoppello (CH): t. 1 (Papi 1979, fig. 29b). Comino (CH), loc. Guardiagrele: t. 22, n. 16 (Riccitelli 2001, 59). Datazione. III secolo a.C. (prob. prima metà).
Tipo H.280.7. Skyphos a profilo troncoconico; labbro lievemente svasato; orlo semplice; vasca distinta al di sotto delle anse e a profilo concavo sottostante; piede ad anello a profilo quadrangolare; anse a maniglia orizzontali impostate in corrispondenza del labbro (Fig. 2.21). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 123, n. 3; tomba 144, nn. 5-6; tomba 246, n. 3. Confronti. Vicino al tipo 6 degli skyphoi della fase ellenistica di Campovalano (A. Martellone in d’Ercole, Martellone e Cesana 2016, 121, esemplari nelle tt. 397, n. 3 e 425, n. 2). Vasto, stipe votiva di Fonte San Nicola (CH): Faustoferri 1997, 111, nn. 83-85 (III-II secolo a.C.). Datazione. III-inizi II secolo a.C.
PIATTI (= “patere” del Morel; Forma 290).
Tipo H.280.8. Skyphos a profilo troncoconico; labbro distinto svasato; orlo semplice; vasca distinta al di sotto delle anse e a profilo concavo sottostante; basso piede ad anello a profilo sagomato, con fondo concavo; anse a maniglia oblique impostate in corrispondenza del labbro (Fig. 2.22). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 115, n. 1; tomba 281, n. 3; tomba 300, n. 1. Confronti. Fossa: t. 333, n. 3 (fine III-prima metà II secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 80; ascritto alla serie Morel 4363). Datazione. Sulla base delle associazioni nei contesti di rinvenimento, il tipo è inquadrabile
PIATTI AD AMPIA VASCA GLOBULARE (290.A). Tipo H.290.A.1. Piatto con ampia e bassa vasca a profilo globulare; labbro continuo rientrante; orlo semplice; alto piede ad anello a profilo rettilineo (Fig. 2.22). Distribuzione. Fossascopana, scavi 1973: tomba 2, materiali presso la volta crollata, n. 5. Datazione. Pur in mancanza di confronti puntuali, l’associazione nel contesto di rinvenimento con una coppa biansata del Tipo H.250.1 e con un piatto del Tipo H.290.B.3, consente di attribuire il tipo in esame al II 84
La tipologia dei materiali
Fossascopana, scavi 1973: tomba 2 a camera, materiali presso la volta crollata, n. 10, Confronti. Vicino al tipo Morel 2234e (seconda metà II secolo a.C.; campana A; Morel 1981, 151). Jesi (AN), officina di Aesis: Brecciaroli Taborelli 1996-1997, 137, n. 187 (150-50/40ascritto alla serie Morel 2252). Datazione. Seconda metà II secolo a.C. (-prima metà I secolo a.C.?).
secolo a.C. (prob. seconda metà). PIATTI
CON VASCA TRONCOCONICA E LABBRO RIENTRANTE (290.B.).
Tipo H.290.B.1. Piatto con vasca troncoconica profonda; labbro continuo; orlo tagliato esternamente; alto piede ad anello a profilo concavo (Fig. 2.22). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 190, n. 9. Confronti. Vicino al tipo Morel 2283a (I secolo a.C.; campana A; Morel 1981, 161). Richiama anche, per l’andamento della vasca (ma non per il piede e l’ispessimento delle pareti), Jesi (AN), officina di Aesis: Brecciaroli Taborelli 19961997, 134, fig. 71, n. 181 (ascritto al tipo Morel 2233f e datato tra il 250/240-150/140 a.C.). Adria (RO), necropoli Retratto-Donà: t. 15, n. 270 (III-non oltre la metà del II secolo a.C.; Tamassia 1993, 50). Paestum (SA), santuario alla foce del Sele: Ferrara 2017, 142-143 (inquadramento del tipo in produzioni locali tra la fine del IV e gli inizi del III secolo a.C., con attenzione alle produzioni recenziori di campana A del II-I secolo a.C.). Datazione. L’associazione con il resto dei materiali del corredo suggerisce una datazione del tipo alla metà-seconda metà del II secolo a.C.
Tipo H.290.B.4. Piatto con vasca troncoconica; corto labbro distinto lievemente rientrante; orlo semplice; piede ad anello a profilo rettilineo (Fig. 2.22). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 168, n. 7. Confronti. Vicino al tipo Morel 2252c (decenni intorno alla metà del II secolo a.C.; campana A; Morel 1981, 153). Adria (RO), necropoli Retratto-Donà: t. 15, n. 271 (III-non oltre la metà del II secolo a.C.; Tamassia 1993, 50). Portorecanati (PU): t. 114, n. 3 (datazione proposta, non oltre il I secolo a.C.; Mercando 1974b, 281). Datazione. 180-120 a.C. Tipo H.290.B.5. Piatto con vasca troncoconica; corto labbro distinto diritto; orlo semplice tagliato superiormente; piede ad anello a profilo rettilineo (Fig. 2.22). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 332, nn. 1-2; tomba 341, n. 2. Confronti. Vicino al tipo Morel 2272b (fine II secolo-I secolo a.C.; Adria (RO), produzione locale o regionale; a.C.; Morel 1981, 159). Vicino a Fossa: t. 124, n. 29 (metà II-inizi I secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 198200; ascritto al tipo Morel 2254b1, intorno al 120 a.C.). Portorecanati (PU): t. 48, n. 2 (I secolo a.C.; Mercando 1974b, 233); t. 198, n. 1 (fine dell’età repubblicana-età augustea; Mercando 1974b, 342). Datazione. Il contesto di associazione, con piatti in sigillata italica, suggerisce una datazione del tipo alla seconda metà/fine I secolo a.C.
Tipo H.290.B.2. Piatto con vasca troncoconica; labbro continuo; orlo tagliato esternamente e distinto internamente; alto piede a profilo rettilineo (Fig. 2.22). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 151, n. 6. Confronti: Vicino al tipo Morel 2283b (II secolo a.C.; da Teano, produzione locale o regionale; Morel 1981, 150). Basciano (TE), stipe votiva: Messineo 1997, 188, n. 12 (metà II-prima metà I secolo a.C.). Datazione. Seconda metà/fine II secolo a.C. Tipo H.290.B.3. Piatto con vasca troncoconica; labbro continuo lievemente rientrante; orlo semplice; piede ad anello a profilo rettilineo (Fig. 2.22). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 180, n. 4.
Tipo H.290.B.6. Piatto con vasca troncoconica; alto labbro distinto diritto; orlo semplice; alto piede ad anello a profilo rettilineo (Fig. 2.22).
85
Capestrano, I
Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 157, n. 4; tomba 168, n. 18. Presciano, scavi 2010: tomba 50, n. 6. Confronti. Vicino alla serie Morel 2253 (II secolo a.C.; produzioni locali o regionali; Morel 1981, 153). Fossa: t. 505, n. 5 (metà II secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 142); t. 330, n. 47 (II-fine I secolo a.C./I secolo d.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 217-218). Basciano (TE), stipe votiva: Messineo 1997, 188, n. 7 (metà IIprima metà I secolo a.C.). Datazione. I materiali associati nei contesti di rinvenimento suggeriscono di inquadrare il tipo tra la metà II e la prima metà I secolo a.C. (vedi, 235-236, 243-246 e il Volume II di questo lavoro).
Tipo H.290.B.9. Piatto con vasca troncoconica; labbro distinto diritto; orlo semplice; piede ad anello a profilo rettilineo (Fig. 2.22). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 190, n. 10. Confronti. Vicino alla serie Morel 2255 (IIprima metà I secolo a.C.; campana B; Morel 1981, 154-155). Vicino a Fossa: t. 516, n. 27 (seconda metà II-primi decenni I secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 240; ascritto alla serie Morel 2283; tra la seconda metà II-inizi I secolo a.C.). Basciano (TE), stipe votiva: Messineo 1997, 188, n. 2 (metà II-prima metà I secolo a.C.). Datazione. Seconda metà-inizi I secolo a.C. Tipo H.290.B.10. Piatto con vasca troncoconica bassa; labbro distinto; orlo semplice; basso piede ad anello a profilo da rettilineo a ingrossato (Fig. 2.22). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 168, n. 6; tomba 174, n. 2. Fossascopana, scavi 1973: tomba 1 a camera, deposizione sul pavimento “c”; tomba 2 a camera, deposizione 2 presso la volta crollata, n. 3. Via dell’Olmo, scavi 2011: tomba 3, n. 4. Confronti. Vicino al tipo Morel 2254a (II secolo a.C.; produzione locale o regionale; Morel 1981, 154). Vicino a Fossa, t. 330, n. 46 (II-fine I secolo a.C./inizi I secolo d.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 217; ascritto alla serie 2253, II secolo a.C.); t. 520, n. 21 (fine II-primi decenni I secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 244; ascritto alla serie Morel 2286). Basciano (TE), stipe votiva: Messineo 1997, 188, n. 9 (metà IIprima metà I secolo a.C.). Datazione. II-prima metà I secolo a.C.
Tipo H.290.B.7. Piatto con vasca troncoconica; labbro distinto diritto; orlo semplice; alto piede ad anello (Fig. 2.22). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 214, n. 6. Confronti. Vicino al tipo Morel 2283f (140-120 a.C.; campana A; Morel 1981, 161). Basciano (TE), stipe votiva: Messineo 1997, 188, n. 8 (metà II-prima metà I secolo a.C.). Tarquinia, fondo Scataglini: t. 33, n. 23 (Serra Ridgway 1996, 47, 250; ascritta al tipo Morel 2252a). Datazione. Seconda metà II secolo a.C. Tipo H.290.B.8. Piatto con vasca troncoconica carenata; labbro distinto diritto; orlo semplice; basso piede ad anello a profilo sagomato (Fig. 2.22). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 337, n. 5. Confronti. Per lo sviluppo della vasca, vicino al tipo Morel 2274b (prima metà I secolo a.C.; produzione Etruria meridionale; Morel 1981, 159). Vicino a Fossa: t. 63, n. 16 (fine II-inizi I secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 183; ascritto al tipo Morel 2284b1). Sentinum (AN): Brecciaroli Taborelli 2013, 29 (decenni centrali I secolo a.C., ascritto alla serie Morel 2286). Jesi (AN), officina di Aesis: Brecciaroli Taborelli 1996-1997, 173 fig. 72, nn. 194-195 (età augustea; ascritti alla serie Morel 2273). Datazione. Prima metà I secolo a.C.
Tipo H.290.B.11. Piatto con vasca troncoconica bassa; labbro nettamente distinto; orlo semplice; alto piede ad anello a profilo concavo (Fig. 2.22). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 190, n. 11. Fossascopana, scavi 1973: tomba 2 a camera, materiali presso la volta crollata, n. 11. Confronti. Vicino alla serie Morel 2286 (fine IImetà I secolo a.C.; campana B e officine etrusco-settentrionali; Morel 1981, 162). Fossa: t. 6, n. 2 (II-I secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 86
La tipologia dei materiali
2003, 28, attribuito al tipo Morel 2254c1). Basciano (TE), stipe votiva: Messineo 1997, 188, n. 13 (metà II-prima metà I secolo a.C.). Jesi (AN), officina di Aesis: Brecciaroli Taborelli 1996-1997, 138, fig. 73, n. 20.). Datazione. Seconda metà/fine II-metà I secolo a.C.
Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 38, n. 3. Datazione. Sulla base delle associazioni nel contesto di rinvenimento, ad esempio con un kantharos Tipo H.210.1 e una coppa H.240.A.13, si può suggerire un inquadramento nel II secolo a.C. (prob. prima metà).
PIATTI
Tipo H.290.C.4. Piatto con vasca troncoconica bassa; labbro svasato distinto; corto orlo a tesa ingrossato e ricurvo; piede ad anello a profilo rettilineo (Fig. 2.22). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 135, n. 4; tomba 252, n. 3. Confronti. Vicino al tipo Morel 1314g (intorno al 300 a.C.; soprattutto campana A; Morel 1981, 104). Pontecagnano: Serritella 1995, 146; t. 4436, n. 7. Datazione. Fine IV-inizi III secolo a.C.
CON VASCA TRONCOCONICA E LABBRO SVASATO DISTINTO (290.C).
Tipo H.290.C.1. Piatto con vasca troncoconica profonda; labbro svasato continuo; orlo lievemente ingrossato e distinto internamente; basso piede ad anello a profilo arrotondato (Fig. 2.22). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 281, n. 4. Confronti. Vicino al tipo Morel 2233c (metà III secolo a.C.; Minturno, produzione locale; Morel 1981, 149). Jesi (AN), officina di Aesis: Brecciaroli Taborelli 1996-1997, 176, nn. 176177 (250/240-150/140 a.C.). Datazione. Seconda metà III-metà II secolo a. C.
Tipo H.290.C.5. Piatto con vasca troncoconica profonda; labbro svasato distinto; orlo a tesa ingrossato e distinto internamente da una risega; alto piede ad anello a profilo rettilineo (Fig. 2.22). Distribuzione. Fossascopana, scavi 1964: tomba 8, saggio 8, n. 4. Confronti. Vicino al tipo Morel 1315a (seconda metà III-prima metà II secolo a.C.; produzione locale o regionale; Morel 1981, 104). Fossa: t. 224, n. 13 (fine III-prima metà II secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 57-58; ascritto al tipo Morel 1315b1). Paestum (SA), santuario alla foce del Sele: Ferrara 2017, 148-149. Datazione. Seconda metà III-prima metà II secolo a.C.
I Tipi H.290.C.2-3 sembrano inquadrabili nella serie Morel 1443 (160 a.C. ±40; campana B; Morel 1981, 101). Jesi (AN), officina di Aesis: Brecciaroli Taborelli 1996-1997, 115-117, n. 46 (160/50-120/110 a.C.). Tipo H.290.C.2. Piatto con vasca troncoconica profonda; labbro svasato distinto; orlo a tesa a profilo sinuoso; piede ad anello (Fig. 2.22). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 216, n. 4. Confronti. L’andamento dell’orlo potrebbe avvicinare il tipo alla serie Morel 1461 (intorno al 200 a.C.; produzione locale o regionale, dall’Umbria; Morel 1981, 116). Datazione. Sulla base delle associazioni nel contesto di rinvenimento, ad esempio con un piatto Tipo H.290.2, è possibile puntualizzare la datazione del tipo alla prima metà II secolo a.C.
Tipo H.290.C.6. Piatto con vasca troncoconica profonda; labbro svasato distinto; ampio orlo a tesa ricurvo, distinto internamente da una profonda risega; piede ad anello a profilo quadrangolare (Fig. 2.23). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 145, n. 4. Confronti. Tipo Morel 1315d (seconda metà IIIprima metà II secolo a.C.; produzione locale o regionale; Morel 1981, 104). Jesi (AN), officina di Aesis: Brecciaroli Taborelli 1996-1997, 114, fig. 57, n. 30 (250/240-150/140 a.C.). Datazione. Seconda metà III-prima metà II secolo a.C.
Tipo H.290.C.3. Piatto con vasca troncoconica profonda; labbro svasato distinto; orlo a tesa a profilo sinuoso; basso piede ad anello a profilo arrotondato (Fig. 2.22). Confronti. Vedi il tipo precedente. 87
Capestrano, I
Tipo H.290.C.7. Piatto con vasca troncoconica profonda; labbro svasato; ampio orlo a tesa ricurvo, assottigliato e distinto internamente da una bassa risega; basso piede ad anello a profilo da concavo ad arrotondato (Fig. 2.23). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 147, n. 5; tomba 199, n. 5. Fossascopana, scavi 1934: tomba 9, n. 3. Confronti. Tipo Morel 1274b1 (prima metà II secolo a.C.; area etruschizzante centrosettentrionale; Morel 1981, 101). Vicino a Fossa: t. 330, n. 45 (II-fine I secolo a.C./inizi I secolo d.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 216; ascritto alla specie Morel 1260). Datazione. Prima metà II secolo a.C.
profonda; labbro distinto; corto orlo a tesa; basso piede ad anello a profilo sagomato e segnato da una risega (Fig. 2.23). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 313, n. 1. Confronti. Pur senza confronti puntuali, il tipo è vicino a Jesi (AN), officina di Aesis: Brecciaroli Taborelli 1996-1997, 137, fig. 72, n. 193 (età augustea; ascritto alla serie Morel 2273 e attribuito alle ultime produzioni di vernice nera). Datazione. Decenni finali del I secolo a.C. Tipo H.290.E.2. Piatto con ampia e bassa vasca carenata; labbro distinto; corto orlo a tesa; alto piede ad anello a profilo distinto e ingrossato. Sul fondo, tra due fasci di incisioni concentriche, sono impressi quattro stampigli radiali di forma circolare, al cui interno sono contenuti motivi circolari (Fig. 2.23). Distribuzione. Fossascopana, scavi 1964: tomba 5, saggio 8, n. 3. Datazione. Pur mancando puntuali confronti, l’associazione con gli altri materiali del contesto di rinvenimento (tra questi, una coppa biansata Tipo H.250.1) suggerisce una datazione del tipo al II secolo a.C.
PIATTI
CON VASCA GLOBULARE E LABBRO SVASATO DISTINTO (290.D).
I Tipi H.290.D.1-2 si ascrivono ambedue alla serie Morel 1315 (spec. tipi 1315a-b; III secolo a.C.; Morel 1981, 104; vedi anche Brecciaroli Taborelli 1996-1997, 114 che puntualizza la datazione al periodo tra 250/240-150-140 a.C.). Tipo H.290.D.1. Piatto con vasca globulare profonda; labbro svasato distinto; orlo a tesa ricurvo, distinto internamente; basso piede ad anello a profilo rettilineo (Fig. 2.23). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 123, n. 4. Datazione. Metà III-metà II secolo a.C.
CERAMICA COMUNE (I). Nell’ambito della classe in esame sono inserite forme da mensa, da conserva e da fuoco, caratterizzate da impasti depurati abbastanza vari, databili nel corso del periodo ellenistico, fino agli inizi dell’età imperiale (fine IV secolo a.C.-I secolo d.C.). Nel caso di contenitori da mensa e da conserva, si registra l’utilizzo di impasti di colore tendenzialmente chiaro (dal rosato all’arancio, ma anche al bruno), di consistenza variabile (da morbida a molto dura), con superfici lisciate e levigate. I contenitori utilizzati nella loro funzione primaria per l’esposizione al fuoco, invece, sono tendenzialmente più scuri, con un impasto più resistente e ricco di inclusi di minute dimensioni. Come già accennato riguardo agli impasti grezzi, il grado di depurazione dei corpi ceramici e la loro resistenza e durezza, tendono ad aumentare verso la fine del periodo di utilizzo della necropoli, ovvero tra la fine del
Tipo H.290.D.2. Piatto con vasca globulare profonda; labbro svasato distinto; ampio orlo a tesa ricurvo, distinto internamente; piede ad anello a profilo sagomato. Stampiglio a rosetta centrale composta da sei petali ovali intorno a bottoncino centrale, separati da rami (Fig. 2.23). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 131, n. 5. Confronti. Per lo stampiglio, si veda, Aquinum (FR), santuario di Mefete: Nicosia 1976, 13, motivo n. 106. Datazione. Metà III-metà II secolo a.C. PIATTI
CON VASCA CARENATA SVASATO DISTINTO (290.E).
E
LABBRO
Tipo H.290.E.1. Piatto con vasca carenata 88
La tipologia dei materiali
Il tipo seguente è solo parzialmente definibile (non si esclude che vi sia pertinente il frammento dalla tomba 206, n. 2 degli scavi 2003-2009 di Fossascopana). Tipo I.20.4. Anforetta con labbro diritto; orlo ingrossato e distinto a sezione trapezoidale; anse a bastoncello impostate dal labbro (alla spalla) (Fig.2.24). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 213, n. 1. Datazione. Pur in mancanza di confronti puntuali, per il contesto di rinvenimento il tipo sembra inquadrabile tra la fine del I e la metà del II secolo d.C.
periodo repubblicano e gli inizi dell’età imperiale. ANFORETTE (Forma 20). Tipo I.20.1. Anforetta a profilo globulare; labbro lievemente svasato; orlo tagliato esternamente e sagomato; collo troncoconico; spalla compressa; piede a disco; anse a bastoncello impostate dal collo alla spalla (Fig.2.24). Distribuzione. Fossascopana, scavi 1964: tomba 7, saggio 8, n. 2. Confronti. Vicino a Monte Bibele (BO), necropoli di Monte Tamburino: t. 88, n. 13 (ultimi decenni IV-inizi III secolo a.C.; Vitali 2003, 301). Datazione. Fine IV-inizi III secolo a.C.
Tipo I.20.5. Anforetta con labbro distinto diritto; orlo ingrossato; anse a nastro impostate dal labbro al punto di massima espansione del ventre (Fig.2.24). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 290, n. 3. Confronti. Vedi, per un esemplare di dimensioni superiori, Pergola (PU): t. 1, n. 7 (Mercando 1974a, 96). Datazione. Il contesto di rinvenimento consente di puntualizzare inquadrare il tipo nel I secolo d.C.
Tipo I.20.2. Anforetta a profilo troncoconico; labbro distinto svasato; orlo assottigliato; spalla alta e compressa; ventre rastremato; ampio piede a disco; anse a nastro impostate dalla base del labbro al punto di massima espansione della spalla (Fig.2.24). Distribuzione. Fossascopana, scavi 1973: tomba 2 a camera, materiali presso la volta crollata, n. 13. Datazione. Pur mancando confronti puntuali per il tipo, il contesto di rinvenimento suggerisce una datazione al II-I secolo a.C. (vedi, il Volume II di questo lavoro).
OLLE (Forma 40). La sequenza tipologica delle olle in ceramica comune trova corrispondenze con quella delle olle in impasto (vedi, 48-53), nella sua scansione più recente. Anche in questo caso, la maggior parte degli esemplari è stata rinvenuta nella posizione del cd. “ripostiglio” e si datano prevalentemente tra il III e il II secolo a.C. I Tipi I.40.8-9, invece, sono stati rinvenuti all’interno di tombe a pozzetto, e avevano la funzione di cinerari (come le ollette del gruppo I.50.A, affini morfologicamente).
Tipo I.20.3. Anforetta a profilo ovoide; labbro svasato continuo; orlo lievemente ingrossato, con una insellatura interna; alto collo continuo; spalla sfuggente; piede ad anello a sezione quadrangolare; ansa a pseudo-triplo bastoncello impostata dalla base del labbro alla spalla. Presenta una decorazione a cerchielli impressi: una fila sul labbro; sul collo e sulla spalla, alternate, due gruppi di una e due file di cerchielli impressi (Fig.2.24). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 160, n. 1. Datazione. Pur in mancanza di confronti puntuali, per il contesto di rinvenimento il tipo sembra inquadrabile tra la fine del I e la metà del II secolo d.C.
Tipo I.40.1. Olla a profilo ovoide; labbro continuo svasato; orlo ingrossato distinto a sezione trapezoidale; spalla sfuggente; fondo piano; sulla spalla sono applicate sei bugne di forma circolare (Fig.2.24). Distribuzione. Presciano, scavi 2010: tomba 50, n. 7. Confronti. Richiama il tipo 3 delle olle di età ellenistica di Fossa (fine IV-III secolo a.C.; C. 89
Capestrano, I
Rizzitelli, in d’Ercole e Copersino 2003, 294). Pontecagnano: Serritella 2013, 151 (primi decenni III secolo a.C.). Datazione. Fine IV-III secolo a.C. Tipo I.40.2. Olla a profilo globulare; labbro svasato continuo; orlo lievemente ingrossato e tagliato superiormente, a sezione triangolare; spalla arrotondata; fondo piano (Fig.2.24). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 147, n. 6. Confronti. Fossa: t. 169, n. 1 (fine III-II secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 44). Datazione. Il contesto di rinvenimento consente di puntualizzare l’inquadramento cronologico del tipo nel II secolo a.C.
Tipo I.40.5. Olla a profilo globulare espanso; corto labbro lievemente svasato; orlo a tesa, ingrossato e distinto a sezione quadrangolare; spalla compressa; fondo piano (Fig.2.25). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 167, n. 4. Datazione. Pur in mancanza di confronti puntuali, l’associazione nel contesto di rinvenimento con una coppa Tipo H.240.A.12 e una coppetta Tipo H.260.A.9, consente di inquadrare il tipo nella prima metà del II secolo a.C. Tipo I.40.6. Olla a profilo globulare; labbro rientrante; orlo a tesa, a sezione triangolare; spalla arrotondata; fondo piano (Fig.2.25). Distribuzione. Presciano, scavi 2010: tomba 43, n. 3. Confronti. Vicino a Fossa: t. 235, n. 3 (fine IVinizi III secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 62). Vedi i Tipi A.40.B.27 e A.50.B.4 dell’impasto grezzo (vedi, 53-54). Datazione. Fine IV-inizi III secolo a.C.
Tipo I.40.3. Olla a profilo globulare; corto labbro lievemente svasato; orlo ingrossato e distinto, a sezione da trapezoidale a triangolare; spalla arrotondata; fondo piano (Fig.2.25). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 144, n. 7; tomba 163, n. 3; tomba 169, n. 3; tomba 281, n. 5. Fossascopana, scavi 1964: tomba 1, saggio 8, n. 1. Presciano, scavi 2010: tomba 38, n. 5. Confronti. Fossa: t. 104, n. 1; t. 201, n. 3 (fine IV secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 35, 46). Distribuzione. Seconda metà III-II secolo a.C.
Tipo I.40.7. Olla a profilo globulare; labbro rientrante; orlo a tesa, distinto e ingrossato a sezione piana; spalla estremamente compressa; ventre rastremato; fondo piano (Fig.2.25). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 174, n. 3. Confronti. Vedi il Tipo A.40.B.28 dell’impasto grezzo (vedi, 53). Datazione. L’associazione con gli altri materiali nel contesto di rinvenimento, suggerisce di inquadrare il tipo nell’ambito del II secolo a.C.
Tipo I.40.4. Olla a profilo globulare; corto labbro lievemente svasato; orlo a tesa, ingrossato e distinto a sezione triangolare, piano superiormente e segnato da una scanalatura; spalla compressa; fondo piano (Fig.2.25). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 180, n. 5. Confronti. Fossa: t. 265, n. 3 (seconda metà IV secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 66). Campochiaro (CB), santuario di Ercole: Capini 1984, 50, n. 151 (la maggior parte dei materiali dello scarico si data alla fine del IV-prima metà III secolo a.C., ma l’orizzonte cronologico per la chiusura dello scarico si pone intorno alla seconda metà II secolo a.C.). Datazione. Seconda metà del II secolo a.C.
Tipo I.40.8. Olla a profilo ovoide; alto labbro distinto e diritto; orlo distinto e ingrossato a profilo arrotondato; spalla sfuggente; fondo piano (Fig.2.26). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 310, n. 1; tomba 341, n. 1 Confronti. Fossa: t. 506, n. 2 (I secolo d.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 142). Datazione. Fine I secolo a.C.-inizi I secolo d.C. Tipo I.40.9. Olla a profilo ovoide; alto labbro distinto, lievemente svasato; orlo distinto a mandorla; spalla sfuggente; fondo piano (Fig.2.26).
90
La tipologia dei materiali
Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 138, n. 3; tomba 314, n. 1. Confronti. Perugia, necropoli del Palazzone: Lippolis 1984, 114, n. 54. Tarquinia (VT), fondo Scataglini: t. 28, n. 22 (età repubblicanaprima età imperiale; Serra Ridgway 1996, 25, 281). Datazione. I secolo d.C.
Confronti. Vicino a Fossa: t. 544, n. 2 (IV secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 155156). Datazione. L’associazione nel contesto di rinvenimento con una coppa Tipo H.240.A.12 e una coppetta Tipo H.260.C.3 (vedi, 74, 82), consente di inquadrare la datazione del tipo in esame nell’ambito del II secolo a.C.
OLLETTE (Forma 50).
Tipo I.50.A.2. Olletta a profilo globulare; corto labbro diritto e continuo; orlo distinto e ingrossato; spalla sfuggente; fondo piano; sulla spalla sono applicate quattro bugne di forma circolare(Fig.2.26). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 159, n. 3. Fontanelle, scavi 2012: tomba 26, n. 3. Confronti. Fossa: t. 209, n. 1 (priva delle bugne; prima della prima metà III secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 49). Datazione. Prima metà III secolo a.C.
Nell’ambito delle ollette, è sembrato opportuno procedere a una ulteriore articolazione in gruppi. Si registra infatti una tendenza all’addensamento intorno a due diversi livelli dimensionali, che coincide nelle grandi linee con la specifica destinazione degli esemplari in questione. Fanno parte del gruppo caratterizzato da uno sviluppo in altezza tra i 19/20 e i 25/26 cm (gruppo 50.A) alcune ollette utilizzate nei “rispostigli” del pieno periodo ellenistico (i Tipi I.50.A.1-3) ma, soprattutto, le ollette utilizzate come cinerari nelle sepolture della fine dell’età repubblicana-inizi età imperiale. Si tratta di tipi estremamente generici, caratterizzati da corpo ovoide o globulare, ma anche troncoconico, con labbro più o meno sviluppato. Le ollette del gruppo caratterizzato da uno sviluppo in altezza inferiore ai 19/20 cm (gruppo 50.B), invece, prevalentemente nelle sepolture del periodo più recente, compongono il set vascolare del corredo funerario. A fronte di una estrema varietà tipologica, le ollette fanno nella maggior parte dei casi riferimento a un modello ovoide/globulare con labbro svasato, più o meno distinto, che si trova attestato a partire dalla avanzata età ellenistica fino alla prima età imperiale, ed è realizzato in ceramica a pareti sottili, oltre che in ceramica comune. ALTEZZA (50.A).
COMPRESA
TRA
19/20-25/26
Tipo I.50.A.3 Olletta a profilo globulare; labbro lievemente svasato; orlo distinto assottigliato; spalla arrotondata; fondo piano (Fig.2.26). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 278, n. 2. Datazione. L’associazione nel contesto di rinvenimento con un kantharos Tipo H.210.2, consente di inquadrare il tipo nel II secolo a.C. Tipo I.50.A.4. Olletta a profilo tronco-ovoide; labbro diritto continuo; orlo semplice; spalla sfuggente; fondo piano (Fig.2.26). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 306, n. 1. Datazione. Il contesto di rinvenimento consente di inquadrare il tipo tra la fine del I secolo a.C. e la metà del I secolo d.C. (vedi, 330-331).
CM
Tipo I.50.A.5. Olletta a profilo tronco-ovoide; corto labbro distinto e svasato; orlo semplice; spalla sfuggente; fondo piano (Fig.2.26). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 311, n. 1; Datazione. Pur in mancanza di confronti puntuali, il rituale funerario adottato per la tomba 311 e la vicinanza agli altri tipi del gruppo I.50.A, consente di inquadrare il tipo nella prima età imperiale.
Tipo I.50.A.1. Olletta a profilo globulare; corto labbro distinto e svasato; orlo a sezione triangolare, con scanalatura interna; spalla arrotondata; fondo piano; sulla spalla sono applicate quattro bugne di forma ovale (Fig.2.26). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 153, n. 4. 91
Capestrano, I
Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 322, n. 1. Confronti. Isernia, loc. Quadrella: t. 114, n. 1 (I secolo d.C.; Terzani e Matteini Chiari 1997, 203). Datazione. I secolo d.C.
Tipo I.50.A.6. Olletta a profilo globulare; labbro distinto diritto; orlo distinto e ingrossato, a sezione triangolare; collo distinto; spalla sfuggente; fondo piano (Fig.2.27). Varietà a) labbro corto. Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 336, n. 1 Confronti. San Vittore di Cingoli (MC): t. 1bis, n. 1 (età flavia; Mercando 1974a, 108). Varietà b) labbro sviluppato e sagomato. Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 290, n. 1; tomba 305, n. 1; tomba 312, n. 1; tomba 328, n. 1; tomba 337, n. 1. Datazione. I secolo d.C.
Tipo I.50.A.11. Olletta a profilo ovoide; labbro distinto svasato; orlo semplice; spalla arrotondata; fondo piano (Fig.2.27). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 145, n. 5; tomba 172, n. 2. Fossascopana, scavi 1964: tomba 2, saggio 8, n. 1. Confronti. Fossa: t. 341, n. 2 (III secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 83). Roma e area di Roma: Olcese 2003, 78-79, tipo 1 (III-II secolo a.C.). Tarquinia (VT), fondo Scataglini: t. 28, n. 24 (età repubblicana-prima età imperiale; Serra Ridgway 1996, 42; 281) Datazione. I contesti di rinvenimento consentono di inquadrare il tipo nel II secolo a.C. (vedi, 227-228, 248-250 e il Volume II).
Tipo I.50.A.7. Olletta a profilo cilindro-ovoide; alto labbro distinto e lievemente svasato; orlo distinto e lievemente ingrossato, ricurvo; alta spalla compressa; fondo piano (Fig.2.27). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 340, n. 1 Confronti. Arquà Petrarca (PD): t. F1, n. 1 (metà I secolo a.C.; Gamba 1987, 248). Datazione. Metà-fine I secolo a.C.
Tipo I.50.A.12. Olletta a profilo ovoide; alto labbro distinto e svasato; orlo lievemente ingrossato a profilo arrotondato; spalla sfuggente e compressa; fondo piano (Fig.2.27). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 293, n. 1. Datazione. Pur in mancanza di confronti puntuali, il rituale funerario adottato per la tomba 293, l’associazione con gli altri materiali del contesto di rinvenimento e la vicinanza agli altri tipi del gruppo I.50.A, consentono di inquadrare il tipo nel I secolo d.C. (vedi, 91-93).
Tipo I.50.A.8. Olletta a profilo ovoide; labbro distinto e lievemente svasato; orlo distinto a mandorla; spalla arrotondata; fondo piano (Fig.2.27). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 334, n. 1. Confronti. Vicino al tipo precedente. Vicino a Piane di Falerone (AP): t. 1, n. 1 (età augustea; Mercando 1974a, 139). Datazione. Fine I secolo a.C.-inizi I secolo d.C. Tipo I.50.A.9. Olletta a profilo ovoide; alto labbro continuo e lievemente svasato; orlo ingrossato a sezione triangolare; spalla sfuggente; fondo piano (Fig.2.27). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 143, n. 1. Datazione. Il contesto di rinvenimento consente di inquadrare il tipo nel II secolo a.C. (vedi, 224-225).
Tipo I.50.A.13. Olletta a profilo ovoide/globulare; alto labbro distinto e diritto; orlo distinto e ingrossato a profilo arrotondato; spalla sfuggente; fondo piano (Fig.2.27). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 316, n. 1. Datazione. Pur in mancanza di confronti puntuali, il rituale funerario adottato per la tomba 316 e la vicinanza agli altri tipi del gruppo I.50.A, consente di inquadrare il tipo nella prima età imperiale.
Tipo I.50.A.10. Olletta a profilo ovoide slanciato; alto labbro continuo e lievemente svasato; orlo ingrossato a profilo arrotondato; spalla sfuggente; fondo piano (Fig.2.27).
Tipo I.50.A.14. Olletta a profilo ovoide; alto labbro distinto e diritto, a profilo sinuoso; orlo 92
La tipologia dei materiali
Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 306, n. 4; tomba 341, n. 3. Confronti. Fossa: t. 124, n. 32 (metà II secolo a.C.-inizi I secolo d.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 200). Datazione. Gli altri materiali nei contesti di rinvenimento consentono di inquadrare il tipo tra la fine del I secolo a.C. e gli inizi del I secolo d.C. (vedi, 330-331, 350-351).
distinto e lievemente ingrossato; spalla sfuggente; fondo piano (Fig.2.27). Distribuzione. Fossascopana, scavi 1964: tomba 1, saggio 8, n. 2. Confronti. Datazione. Pur in mancanza di confronti puntuali, il rituale funerario adottato per la tomba 1 (vedi il Volume II di questo lavoro) e la vicinanza agli altri tipi del gruppo I.50.A, consente di inquadrare il tipo nella prima età imperiale.
Tipo I.50.B.4. Olletta a profilo globulare; corto labbro distinto e lievemente svasato; orlo ingrossato a profilo arrotondato; spalla arrotondata; fondo piano (Fig.2.28). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 303, n. 5. Datazione. Gli altri materiali rinvenuti nel contesto di rinvenimento consentono di inquadrare il tipo nel I secolo d.C. (vedi, 327329).
Tipo I.50.A.15. Olletta a profilo globulare; alto labbro distinto e lievemente rientrante; orlo ingrossato; spalla arrotondata; fondo piano (Fig.2.27). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 295, n. 1. Confronti. Vicino a olle di Roma e dell’area romana: Olcese 2003, 81, tipo 3b (età tardorepubblicana). Datazione. Fine I secolo a.C.
Tipo I.50.B.5. Olletta a profilo globulare compresso; corto labbro distinto e lievemente svasato; orlo ingrossato a sezione triangolare; spalla compressa; fondo piano (Fig.2.28). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 337, n. 3 Datazione. Gli altri materiali nel contesto di rinvenimento consentono di inquadrare il tipo tra la fine del I secolo a.C. e gli inizi del I secolo d.C. (vedi, 348-349).
ALTEZZA FINO A 19/20 CM (50.B). Tipo I.50.B.1. Olletta a profilo troncoconico; labbro continuo lievemente svasato; orlo semplice; spalla sfuggente; fondo piano; sulla spalla sono applicate quattro bugne circolari (Fig.2.28). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 129, n. 2. Datazione. L’associazione nel contesto di rinvenimento con una coppetta Tipo H.260.A.15 (vedi, 80) consente di inquadrare il tipo nella prima metà del III secolo a.C.
Tipo I.50.B.6. Olletta a profilo biconico; corto labbro distinto e lievemente svasato; orlo distinto lievemente ingrossato e tagliato esternamente; spalla compressa; fondo piano (Fig.2.28). Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 21, n. 2. Confronti. Fossa: t. 493, n. 3 (fine IV-III secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 135). Datazione. Fine IV-III secolo a.C.
Tipo I.50.B.2. Olletta a profilo ovoide; corto labbro continuo e rientrante; orlo distinto lievemente ingrossato a sezione triangolare; spalla sfuggente (Fig.2.28). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 337, n. 6. Datazione. Gli altri materiali nel contesto di rinvenimento consentono di inquadrare il tipo tra la fine del I secolo a.C. e gli inizi del I secolo d.C. (vedi, 348-349).
Tipo I.50.B.7. Olletta a profilo biconico compresso; labbro continuo svasato; orlo semplice; spalla compressa; fondo piano (Fig.2.28). Distribuzione. Fossascopana, scavi 1973: tomba 2 a camera, materiali presso la volta crollata, n. 14.
Tipo I.50.B.3. Olletta a profilo globulare; corto labbro distinto e diritto; orlo semplice; spalla sfuggente; fondo piano (Fig.2.28). 93
Capestrano, I
(ultimi decenni III-primi decenni II secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 131); t. 504, n. 10; t. 505, n. 8 (metà II secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 140, 142). Pontecagnano: Serritella 2013, 151 (olletta dalla tomba 6168; primi decenni III secolo a.C.). Si ascrive al tipo “con labbro distinto” del fondo Scataglini a Tarquinia (VT): Serra Ridgway 1996, 281-282 (con distribuzione; età repubblicana- prima età imperiale). Varietà c) Profilo ovoide slanciato; labbro distinto. Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 120, n. 2; tomba 216, nn. 5-8; tomba 262, n. 3. Fossascopana, scavi 1973; tomba 2 a camera, deposizione 2, nn. 5-8; tomba 2, trincea 4, n. 1. Confronti. Portorecanati (PU): t. 27A, n. 7 (terzo quarto I secolo a.C.; Mercando 1974b, 208). Perugia, necropoli del Palazzone: Lippolis 1984, 92, tipo R.1, n. 268 (II-terzo quarto I secolo a.C.). Come la varietà precedente, si ascrive al tipo “con labbro distinto” del fondo Scataglini a Tarquinia (VT): Serra Ridgway 1996, 281-282 (con distribuzione; età repubblicana- prima età imperiale). Varietà d) Profilo ovoide continuo; labbro distinto. Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 168, n. 8; tomba 172, n. 4; tomba 303, nn. 1-3, 7-8; tomba 311, n. 3. Fossascopana, scavi 1973, tomba 2 a camera, materiali presso la volta crollata, n. 15. Presciano, scavi 2010: tomba 50, n. 8. Confronti. Fossa: t. 376, n. 2 (fine III-inizi II secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 91); t. 401 (fine II secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 97); t. 417, nn. 1-3 (fine III-prima metà II secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 104). Varietà e) Profilo ovoide con spalla arrotondata e rilevata, ventre rastremato; labbro distinto. Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 168, n. 10; tomba 263, n. 1. Fossascopana, scavi 1973, tomba 2 a camera, materiali presso la volta crollata, nn. 16-17. Confronti. Fossa: t. 503, n. 11 (metà II secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 137). Varietà f) Profilo ovoide sagomato; labbro distinto (meno svasato rispetto alle altre varietà).
Confronti. Vicino a, Ancona: t. 20, n. 1 (esemplare a vernice rossa; metà II secolo a.C.; Colivicchi 2002, 143). Datazione. II secolo a.C. Tipo I.50.B.8. Olletta a profilo ovoide; labbro corto lievemente svasato; orlo distinto assottigliato; spalla sfuggente; fondo piano (Fig.2.28). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 303, n. 6. Confronti. Vicino a Fossa: t. 63, n. 24 (prima metà II secolo a.C.-primi decenni I secolo d.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 186). Datazione. I secolo d.C. Nel tipo seguente, molto diffuso tra la fine del periodo repubblicano e gli inizi del periodo imperiale, si inquadrano numerosi esemplari accomunati da elementi ricorrenti (profilo ovoide, labbro svasato, orlo semplice), che sono però articolati in varietà, sulla base delle lievi differenze nella realizzazione. Tipo I.50.B.9. Olletta a profilo ovoide compresso; labbro svasato; orlo semplice; fondo piano (Fig.2.28). Varietà a) Profilo ovoide sagomato; labbro continuo o comunque scarsamente distinto. Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 135, n. 5; tomba 145, n. 6; tomba 167, n. 5; tomba 172, n. 3; t. 180, n. 6; tomba 262, n. 2; tomba 279, n. 2; Confronti. Fossa: t. 110, nn. 9-10 (seconda metà II secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 38); t. 169, n. 2 (fine III-II secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 45); t. 370, n. 11 (seconda metà II secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 90). Adria (RO), necropoli Retratto-Donà: t. 14, n. 254 (III secolo a.C.; Tamassia 1993, 47). Varietà b) Profilo ovoide espanso (pressoché globulare); labbro distinto. Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 115, n. 2; tomba 118, n. 1; toma 143, n. 2; tomba 151, n. 7; tomba 172, n. 5; tomba 214, n. 7; tomba 251, n. 3; tomba 308, n. 1; tomba 326, nn. 1-2. Fossascopana, scavi 1973: tomba 2 a camera, deposizione 2, n. 9. Confronti. Fossa: t. 122, n. 1 (II secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 40). T. 487, n. 3 94
La tipologia dei materiali
Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 319, n. 1; tomba 335, nn. 1-2; tomba 338, n. 1. Confronti. Portorecanati (PU): t. 63, n. 4 (età traianea; Mercando 1974b, 249). Varietà g) Profilo ovoide con ventre basso ed espanso; labbro continuo. Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 199, n. 6. Confronti. Fossa: t. 311, n. 2 (fine IV secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 74); t. 493, n. 3 (fine IV-III secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 134); t. 508, n. 2 (fine III secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 143). Datazione. III-I secolo a.C.
Tipo I.50.B.13. Olletta a profilo globulare; labbro svasato distinto; orlo semplice, lievemente rientrante internamente; spalla arrotondata ed espansa; ventre rastremato; fondo a disco (Fig.2.29). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 262, n. 4 Confronti. Perugia, necropoli del Palazzone: Lippolis 1984, 100, tipo R.4, n. 358 (II-I secolo a.C.). Datazione. L’associazione con gli altri materiali nel contesto di rinvenimento consente di inquadrare il tipo nel II secolo a.C. (vedi, 306). Tipo I.50.B.14. Olletta a profilo globulare; corto labbro distinto, lievemente svasato; spalla sfuggente; fondo piano (Fig.2.29). Varietà a) Orlo semplice. Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 306, n. 5; tomba 336, n. 4; tomba 341, n. 4. Confronti. Fossa: t. 1, n. 10 (prima metà I secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 161); t. 1 t. 124, n. 34 (metà II secolo a.C.-inizi I secolo d.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 200). Portorecanati (PU): t. 138, n. 1 (Mercando 1974b, 107). Varietà b) Orlo sagomato internamente con profonda scanalatura. Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 138, n. 4; tomba 168, n. 9; tomba 289, n. 1. Fossascopana, scavi 1973: tomba 2, a camera, materiali presso la volta crollata, n. 18. Confronti. Portorecanati (PU): t. 3, n. 22 (prima metà I secolo d.C.; Mercando 1974b, 157). Datazione. Fine I secolo a.C.-metà I secolo d.C.
Tipo I.50.B.10. Olletta a profilo piriforme; labbro continuo lievemente svasato; orlo distinto lievemente ingrossato; spalla sfuggente; fondo piano (Fig.2.29). Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 21, n. 1. Datazione. Gli altri materiali nel contesto di rinvenimento consentono di inquadrare il tipo tra la fine IV e il III secolo a.C. (vedi, il Volume II di questo lavoro). Tipo I.50.B.11. Olletta a profilo cilindrico; labbro svasato distinto; orlo semplice; fondo piano (Fig.2.29). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 190, n. 13. Confronti. Fossa: t. 401, n. 11 (fine II secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 97); t. 410, n. 5 (seconda metà II secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 102); t. 330, n. 39 (II secolo a.C.-inizi I secolo d.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 216). Datazione. Seconda metà II secolo a.C.-inizi I secolo a.C.
Tipo I.50.B.15. Olletta a profilo ovoide/piriforme; corto labbro svasato e distinto; orlo sagomato internamente; fondo piano rastremato (Fig.2.29). Varietà a) Profilo piriforme; labbro lievemente svasato. Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 217, n. 1; tomba 310, n. 3. Varietà b) Profilo ovoide con ventre espanso nella metà inferiore; labbro lievemente svasato.
Tipo I.50.B.12. Olletta a profilo cilindroovoide; corto labbro svasato e distinto; orlo semplice; spalla arrotondata e rilevata; fondo piano (Fig.2.29). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 311, n. 3. Confronti. Vicino al tipo 1/63 Ricci 1985, 259. Datazione. L’associazione con gli altri materiali nel contesto di rinvenimento consente di inquadrare il tipo nel I secolo d.C. (vedi, 333-334). 95
Capestrano, I
Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 213, n. 2; tomba 215, nn. 1-2; tomba 256, n. 1; tomba 287, n. 1. Confronti. Fossa: t. 520, nn. 27-29 (tra I secolo a.C. e I secolo d. C.; d’Ercole e Copersino 2003, 244-245). Vicino al tipo 1/117 Ricci 1985, 271 (età flavia-II secolo d.C.). Portorecanati (PU): t. 29, n. 8 (prima metà I secolo d.C.; Mercando 1974b, 213); t. 132, n. 11 (ultimo quarto I secolo d.C.; Mercando 1974b, 302). Varietà c) Profilo ovoide; labbro lievemente svasato; orlo con profonda scanalatura interna. Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 160, n. 2; tomba 183, n. 1; tomba 201, n. 1; tomba 206, n. 3; tomba 317, n. 1. Fossascopana, scavi 1973: tomba 2 a fossa, n. 2. Confronti. Portorecanati (PU): t. 214, n. 4 (associata a una moneta di età antonina; Mercando 1974b, 352). Datazione. I secolo a.C.-I secolo d.C.
maniglia verticali impostate in corrispondenza della spalla (Fig.2.29). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 164, n. 3. Confronti. Richiama il tipo Dionisio 7.5a1, attestato nella necropoli di Fonte d’Amore a Sulmona (t. 6; ascritto agli inizi III secolo a.C.; Dionisio 2015, 142). Datazione. L’associazione con gli altri materiali nel contesto di rinvenimento (tra cui una coppetta Tipo H.260.A.9), consente di datare il tipo in esame alla seconda metà del III secolo a.C. Tipo I.60.3. Olla biansata a profilo globulare; labbro diritto distinto; orlo distinto e ingrossato, a sezione quadrangolare; spalla arrotondata; fondo piano; anse a maniglia verticali impostate in corrispondenza della spalla (Fig.2.30). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 300, n. 2. Datazione. L’associazione nel contesto di rinvenimento con uno skyphos Tipo H.280.8 consente di inquadrare il tipo in esame tra la metà del III e la metà del II secolo a.C.
Tipo I.50.B.16. Olletta a profilo globulare; labbro distinto svasato; orlo sagomato con profonda scanalatura interna; ventre espanso; fondo piano pressoché indistinto (Fig.2.29). Distribuzione. Via dell’Olmo, scavi 2011: tomba 3, n. 5. Confronti. Vicino, Fossa: t. 381, n. 4 (fine III secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 93): Datazione. Fine III secolo a.C.
OLLETTE BIANSATE (Forma 70). Tipo I.70.1 Olletta biansata a profilo globulare; labbro svasato distinto; orlo semplice; spalla sfuggente compressa; fondo piano; anse a maniglia oblique impostate in corrispondenza della spalla (Fig.2.30). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 165, n. 2. Datazione. L’associazione con un kantharos Tipo I.210.1 e una coppetta H.260.A.10, consente di inquadrare il tipo in esame tra la fine del IV e la prima metà del III secolo a.C.
OLLE BIANSATE (Forma 60). Tipo I.60.1. Olla biansata a profilo globulare; labbro svasato continuo; orlo lievemente ingrossato; spalla arrotondata; fondo piano; anse a maniglia oblique impostate al di sotto del punto di massima espansione del ventre (Fig.2.29). Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 35, n. 3. Confronti. Fossa: t. 381, n. 4 (fine III secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 93). Perugia, necropoli del Palazzone: Lippolis 1984, 54, tipo A.2.c (inizi II secolo a.C.). Datazione. Fine III-inizi II secolo a.C.
Tipo I.70.2. Olletta biansata a profilo globulare; labbro lievemente svasato distinto; orlo ingrossato distinto a sezione trapezoidale; fondo a disco; anse a maniglia verticale impostate in corrispondenza della spalla (Fig.2.30). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 179, n. 2.
Tipo I.60.2. Olla biansata a profilo globulare; labbro svasato distinto; orlo semplice; spalla sfuggente compressa; fondo piano; anse a 96
La tipologia dei materiali
Confronti. Monte Bibele (BO), necropoli di Monte Tamburino: t. 16, n. 11; t. 90, n. 2 (Vmetà/fine IV secolo a.C.; Vitali 2003, 82, 308). Datazione. Fine IV secolo a.C.
labbro al punto di massima espansione del ventre (Fig.2.31). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 251, n. 4. Confronti. Isernia, loc. Quadrella: t. 28, n. 1 (fine I-II secolo d.C.; Terzani e Matteini Chiari 1997, 84); t. 100, n. 1 (secondo quarto III secolo d.C.; Terzani e Matteini Chiari 1997, 193); t. 112, n. 1 (seconda metà I-II secolo d.C.; Terzani e Matteini Chiari 1997, 197). Datazione. II secolo d.C.
Tipo I.70.3. Olletta biansata a profilo globulare/ovoide; corto labbro lievemente svasato; orlo lievemente ingrossato; spalla alta e arrotondata; fondo a disco; anse a maniglia pressoché verticali impostate in corrispondenza della spalla (Fig.2.30). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 122, n. 4. Confronti. Richiama il tipo Dionisio 7.5C1, attestato nella necropoli di Fonte d’Amore a Sulmona (t. 34; ascritto al III-II secolo a.C.; Dionisio 2015, 143). Datazione. L’associazione con gli altri materiali nel contesto di riferimento, consente di inquadrare il tipo tra la fine del III e la metà del II secolo a.C. (vedi, 211-212).
Tipo I.110.3. Brocca a profilo ovoide; labbro continuo lievemente svasato; orlo a fascia; alto collo troncoconico; spalla sfuggente; piede ad anello a profilo sagomato; ansa a bastoncello compresso a sezione trapezoidale, non sormontante, impostata dal labbro al punto di massima espansione del ventre. Sulla spalla, due file di cerchielli impressi sfalsati (Fig.2.31). Distribuzione. Fossascopana, scavi 1973: tomba 2 a camera, tomba a fossa, n. 1. Confronti. Roma e area romana: Olcese 2003, 93, tipo 2, n. 4 (I-II secolo d.C.). Datazione. I secolo d.C.
BROCCHE (Forma 110). Tipo I.110.1. Brocca a profilo globulare; labbro svasato continuo; orlo semplice; spalla sfuggente; fondo piano; ansa a bastoncello compresso, non sormontante, impostata dal labbro alla spalla (Fig.2.31). Distribuzione. Fossascopana, scavi 1973: tomba 2 a camera, deposizione 1, n. 4. Confronti. Campochiaro (CB), santuario di Ercole: Capini 1984, 53, nn. 152-153 (la maggior parte dei materiali dello scarico si data alla fine del IV-prima metà III secolo a.C., ma l’orizzonte cronologico per la chiusura dello scarico si pone intorno alla seconda metà II secolo a.C.). Rimini, area ex-Vescovado: F. Biondani in Mazzeo Saracino 2005, 224, n. 12 (brocca con ansa sormontante; età medio e tardo-repubblicana). Pergola (PU): t. 3, n. 8 (Mercando 1974a, 101). Roma e area romana: Olcese 2003, 93, tipo 1 (IV-I secolo a.C.). Datazione. Fine IV-III secolo a.C.
LAGYNOI (Forma 120). Tipo I.120.1. Lagynos di piccole dimensioni a profilo globulare compresso; labbro lievemente svasato; orlo semplice; alto collo cilindrico distinto; spalla compressa; ventre a profilo globulare; piede ad anello a profilo rettilineo; ansa a bastoncello non sormontante impostata dalla base del labbro alla spalla, a profilo angolato (Fig.2.31). Distribuzione. Fossascopana, scavi 1973: tomba 2 a camera, materiali presso la volta crollata, n. 19. Datazione. L’associazione con gli altri materiali nel contesto di rinvenimento consente di inquadrare il tipo tra il II e il I secolo a.C. (vedi, il Volume II di questo lavoro), Tipo I.120.2. Lagynos a profilo globulare; labbro diritto; orlo distinto a mandorla; collo troncoconico continuo; spalla sfuggente; fondo a disco; ansa a nastro non sormontante, a profilo angolato. Impostata dalla base del labbro alla spalla (Fig.2.31).
Tipo I.110.2. Brocca a profilo globulare; ampio labbro continuo, lievemente svasato; orlo distinto internamente da una risega; spalla sfuggente; fondo piano; ansa a nastro con margini rilevati non sormontante, impostata dal
97
Capestrano, I
rinvenimento con materiali databili nel II secolo a.C., consente di inquadrare il tipo in esame nello stesso orizzonte cronologico (vedi, 279280).
Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 121, n. 1. Datazione. L’associazione nel contesto di rinvenimento con una lucerna Tipo M.D.1, consente di ascrivere il tipo in esame all’avanzato I-II secolo d.C. (vedi, 105-106).
Tipo I.120.6. Lagynos di piccole dimensioni a profilo lenticolare compresso; labbro continuo lievemente svasato a profilo troncoconico; orlo semplice; alto collo a profilo troncoconico distinto da una cordonatura orizzontale; spalla compressa (Fig.2.31). Distribuzione. Fossascopana, scavi 1973: tomba 2 a camera, materiali presso la volta crollata, n. 20. Confronti. Perugia, necropoli del Palazzone: Lippolis 1984, 66, tipo C.2 (II secolo a.C.). Gabii, santuario di Giunone: Vegas e López 1982, n. 124 (I secolo a.C.). Datazione. II-I secolo a.C.
Tipo I.120.3. Lagynos a profilo globulare; labbro lievemente svasato; orlo semplice; alto collo cilindrico distinto; spalla arrotondata; fondo a disco; ansa a nastro non sormontante impostata dalla base del labbro alla spalla, a profilo angolato e rilevato (Fig.2.31). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 308, n. 2. Confronti. Vicino ad Ancona: t. 35, n. 1 (esemplare a fondo scialbato e sovradipinto a motivi geometrici; ultimi decenni II-primi del I secolo a.C.; Colivicchi 2002, 246). Tarquinia (VT), fondo Scataglini: t. 18, n. 42 (età augustea; Serra Ridgway 1996, 30, 280) Datazione. Fine I secolo a.C.-inizi I secolo d.C.
Tipo I.120.7. Lagynos a profilo lenticolare compresso; labbro continuo lievemente svasato a profilo troncoconico; orlo semplice; alto collo a profilo troncoconico distinto da una cordonatura orizzontale; spalla compressa a carena rilevata; ventre rastremato; fondo a disco; ansa a nastro a sezione ovoidale, non sormontante, impostata dalla base del labbro alla spalla (Fig.2.31). Distribuzione. Fossascopana, scavi 1973: tomba 2 a camera, materiali presso la volta crollata, n. 21. Confronti. Perugia, necropoli del Palazzone: Lippolis 1984, 72, tipo C.6 (I secolo a.C.). Si ascrive al tipo “carenato” del fondo Scataglini a Tarquinia (VT): Serra Ridgway 1996, 280 (con distribuzione; età repubblicana- prima età imperiale). Datazione. I secolo a.C.
Tipo I.120.4. Lagynos a profilo globulare compresso; labbro diritto con orlo sagomato lievemente rientrante; collo continuo a profilo troncoconico; spalla sfuggente; ansa a nastro impostata al di sotto del labbro (Fig.2.31). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 303, n. 9. Confronti. Vicino ad Ancona: t. 48, n. 2 (esemplare a fondo scialbato; prima metàsecondo quarto I secolo a.C.; Colivicchi 2002, 303). Portorecanati (PU): t. 220, n. 6 (Mercando 1974b, 359). Si ascrive al tipo “largo” del fondo Scataglini a Tarquinia (VT): Serra Ridgway 1996, 280 (con distribuzione; età repubblicanaprima età imperiale). Datazione. Fine I secolo a.C.-inizi I secolo d.C. Tipo I.120.5. Lagynos a profilo cilindrico; labbro diritto con orlo sagomato rientrante; collo distinto a profilo troncoconico; spalla fortemente compressa; ventre sagomato; fondo a disco; ansa a pseudo-triplo bastoncello non sormontante, impostata dalla base del labbro alla spalla, a profilo angolato (Fig.2.31). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 215, n. 3. Datazione. Pur in mancanza di confronti puntuali, l’associazione nel contesto di
Non sono inseriti nella sequenza tipologica gli esemplari (Fig.2.31): Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 310, n. 5 (vedi Perugia, necropoli del Palazzone: Lippolis 1984, 70, tipo C.3, I secolo a.C.).; tomba 327, n. 1 e tomba 332, n. 4.
98
La tipologia dei materiali
Tipo I.190.3. Poculum a profilo sinuoso; labbro continuo lievemente svasato; orlo semplice; fondo piano; al di sotto del labbro sono applicate quattro bugne (Fig.2.32). Varietà a) Profilo globulare. Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 123, n. 5; 131, n. 6. Varietà b) Profilo ovoide. Distribuzione Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 144, n. 8; tomba 252, n. 4; tomba 281, n. 6. Fossascopana, scavi 1964: tomba 3, saggio 8, n. 2; tomba 8, saggio 8, n. 6. Presciano, scavi 2010: tomba 43, n. 4. Fontanelle, scavi 2012; tomba 35, n. 4. Confronti. Vicino al tipo 3 di Fossa (diffuso fino alla fine del III secolo a.C.; C. Rizzitelli, in d’Ercole e Copersino 2003, 294). Datazione. III secolo a.C.
BICCHIERI (Forma 180). Tipo I.180.1. Bicchiere a profilo troncoconico; pareti rettilinee; orlo semplice; fondo piano sagomato (Fig.2.32). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 308, n. 3. Confronti. Fossa; t. 53, n. 12 (metà II secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 138). Perugia, necropoli del Palazzone: Lippolis 1984, 102, tipo R.6 (fine II-I secolo a.C.). Datazione. Fine I secolo a.C.-I secolo d.C. POCULA (Forma 190). Questa forma è attestata con un elevato numero di esemplari nell’ambito della ceramica comune, trovando corrispondenze anche nelle produzioni più recenti di impasto grezzo e nella ceramica depurata. In generale, il modello di vaso cilindrico utilizzato per bere, viene declinato con differenze minime nell’inflessione del labbro o nell’espansione della vasca.
KANTHAROI (Forma 210). Tipo I.210.1. Kantharos miniaturistico a profilo globulare; labbro distinto lievemente svasato; spalla arrotondata; fondo piano; anse a bastoncello sormontanti, impostate dal labbro al punto di massima espansione del ventre (Fig.2.32). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 165, n. 3. Confronti. Vicino a, Gildone (CB), loc. Morgia della Chiusa: t. 6, n. 2 (esemplare a vernice nera; fine IV-inizi III secolo a.C.; Macchiarola 1989, 45). Datazione. Fine IV-inizi III secolo a.C.
Tipo I.190.1. Poculum a profilo cilindrico; labbro rientrante continuo; orlo semplice; fondo piano; il labbro è segnato da una linea incisa (Fig.2.32). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 156, n. 3. Confronti. Vicino ai tipi successivi, anche se privo di bugne. Datazione. III secolo a.C. Tipo I.190.2. Poculum a profilo cilindrico; labbro diritto; orlo semplice; sul labbro sono applicate da tre a quattro bugne di forma cilindrica (Fig.2.32). Varietà a) Fondo piano. Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 122, n. 5; tomba 143, nn. 3-4; t. 145, n. 7; tomba 156, n. 4; tomba 164, nn. 4-5. Fossascopana, scavi 1964: tomba 8, saggio 8, n. 5. Varietà b) Fondo a disco. Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 153, n. 5. Confronti. Corrisponde al tipo 1 di Fossa (diffuso fino alla fine del III secolo a.C.; C. Rizzitelli, in d’Ercole e Copersino 2003, 294). Datazione. III secolo a.C.
TAZZE (Forma 220). Tipo I.220.1. Tazza miniaturistica a profilo troncoconico carenato; labbro continuo lievemente svasato; orlo semplice; fondo piano; ansa a nastro sormontante, impostata dal labbro alla carena (Fig.2.32). Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 26, n. 4. Datazione. Pur in mancanza di confronti puntuali, gli altri materiali del contesto di rinvenimento (vedi il Volume II di questo lavoro), tra cui ad esempio la coppetta Tipo H.265.1 e lo skyphos H.280.10, consentono di
99
Capestrano, I
inquadrare il tipo in esame nella prima metà del III secolo a.C.
sezione triangolare; carena arrotondata; basso piede ad anello (Fig.2.32). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 206, n. 1. Datazione. Pur in mancanza di confronti puntuali, l’esemplare di riferimento proviene da un contesto databile nel II secolo d.C. (vedi, 272-273).
SCODELLE (Forma 230). Tipo I.230.1. Scodella a profilo troncoconico; labbro lievemente rientrante; orlo semplice; fondo piano (Fig.2.32). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 303, n. 11. Datazione. Pur senza confronti puntuali, il contesto di rinvenimento consente di inquadrare il tipo tra la fine del I secolo a.C. e gli inizi del I secolo d.C. (vedi, 327-329).
TEGAMI (Forma 295). Tipo I.295.1. Tegame a profilo troncoconico; labbro svasato; orlo distinto; fondo piano; fondo interno della vasca convesso (Fig.2.32). Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 38, n. 6. Confronti. Rimini, area ex-Vescovado: F. Biondani in Mazzeo Saracino 2005, 243, n. 56 (con ampia bibliografia sulla diffusione del tipo, attestato tra il II secolo a.C. e l’età augustea). Datazione. II secolo a.C.
Tipo I.230.2. Scodella a profilo globulare; labbro continuo lievemente svasato; orlo distinto ingrossato a profilo arrotondato; basso piede ad anello a profilo rettilineo (Fig.2.32). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 153, n. 6. Datazione. Pur senza confronti puntuali, il contesto di rinvenimento consente di inquadrare il tipo nel II secolo a.C. (vedi, 233-234).
Tipo I.295.2. Tegame a profilo troncoconico; labbro lievemente rientrante; orlo semplice, segnato all’interno da una leggera scanalatura; fondo piano (Fig.2.32). Distribuzione. Fossascopana, scavi 1973: tomba 1 a camera, sepoltura sul pavimento “c”, n. 7. Confronti. Albintimilium: tipo 115 (fine II-I secolo a.C.; Olcese 1993, 225, con bibliografia di riferimento e diffusione estesa fino al I secolo d.C.). Cosa: “flat bottomed pans” (100 a.C.-50 d.C.; Dyson 1976, 119-120). Datazione. II-I secolo a.C.
COPPETTE (Forma 260). Tipo I.260.1. Coppetta a profilo globulare (?); labbro lievemente rientrante; orlo distinto e tagliato superiormente (Fig.2.32). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 213, n. 3. Datazione. Il rituale funerario a incinerazione e gli altri materiali nel contesto di rinvenimento suggeriscono di inquadrare il tipo, per quanto lacunoso, nel I secolo d.C. (vedi, 277-278).
Tipo I. 295.3. Tegame a profilo troncoconico; labbro lievemente rientrante; orlo distinto a profilo arrotondato, all’interno segnato da una profonda scanalatura funzionale all’appoggio del coperchio; fondo piano; la vasca è decorata internamente da due serie distinte di fasci di linee incise (Fig.2.33). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 335, n. 3. Confronti. Vicino al tipo precedente. Datazione. II-I secolo a.C.
Tipo I.260.2 Coppetta a profilo troncoconico; labbro continuo lievemente svasato; orlo tagliato esternamente; piede troncoconico (Fig.2.32). Distribuzione. Fossascopana, scavi 1964: tomba 8, saggio 8, n. 2 Datazione. Pur in mancanza di confronti puntuali, il contesto di rinvenimento consente di inquadrare il tipo nel II secolo a.C. (si veda il Volume II di questo lavoro).
Tipo I.295.4. Tegame a profilo troncoconico; labbro continuo lievemente svasato; orlo distinto e ingrossato a sezione quadrangolare; fondo piano (Fig.2.33).
Tipo I.260.3. Coppetta a profilo carenato; labbro lievemente svasato; orlo ingrossato a
100
La tipologia dei materiali
Datazione. Il contesto di rinvenimento consente di inquadrare il tipo tra la fine del I secolo a.C. e il I secolo d.C. (vedi, 335).
Distribuzione. Fossascopana, scavi 1973: tomba 2 a camera, materiali presso la volta crollata, n. 22. Confronti. Vicino a materiali da Rimini, area ex-Vescovado: F. Biondani in Mazzeo Saracino 2005, 244, n. 69 (prima età imperiale). Datazione. Fine I secolo a.C.
Tipo I.300.5. Coperchio con ampia vasca a profilo troncoconico; labbro svasato; orlo distinto e ingrossato; presa a pomello piano (Fig.2.33). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 138, n. 7; tomba 160, n. 3; tomba 293, n. 2; tomba 295, n. 2; tomba 310, n. 2. Fossascopana, scavi 1964: tomba 1, saggio 8, nn. 4-5; tomba 2, saggio 8, n. 2. Confronti. Vicino a Piane di Falerone (AP): t. 1, n. 2 (età augustea; Mercando 1974a, 139). Isernia, loc. Quadrella: t. 114, n. 2 (I secolo d.C.; Terzani e Matteini Chiari 1997, 203). Datazione. Fine I secolo a.C.-I secolo d.C.
COPERCHI (Forma 300). Tipo I.300.1. Coperchio a calotta globulare continua; labbro lievemente rientrante; orlo semplice; presa a pomello piano (Fig.2.33). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 144, n. 9; tomba 303, n. 2; tomba 332, n. 5. Datazione. I contesti di rinvenimento consentono di inquadrare il tipo tra la fine del I secolo a.C. e il I secolo d.C. (vedi, 225-227, 327-329, 344-345).
VASI TRIPODATI (Forma 310).
Tipo I.300.2. Coperchio a calotta troncoconica continua; orlo distinto lievemente ingrossato a profilo arrotondato; presa a pomello piano (Fig.2.33). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 337, n. 4. Confronti. Fossa: t. 506, n. 3 (I secolo d.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 142-143). San Vittore di Cingoli (MC): t. 1bis, n. 2 (età flavia; Mercando 1974a, 108). Datazione. I secolo d.C.
Tipo I.310.1. Vaso tripodato a profilo globulare compresso; labbro continuo lievemente svasato; orlo semplice; spalla sfuggente; fondo convesso; tre piedi cilindrici a sezione piena (Fig.2.33). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 168, n. 11. Datazione. Pur in mancanza di confronti puntuali, il contesto di rinvenimento consente di inquadrare il tipo alla fine del II-inizi del I secolo a.C. (vedi, 243-246).
Tipo I.300.3. Coperchio a calotta troncoconica a profilo sagomato da profonde scanalature orizzontali; labbro lievemente svasato; orlo semplice; presa a pomello piano (Fig.2.33). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 306, n. 2; tomba 311, n. 2; tomba 312, n. 2; tomba 334, n. 2; tomba 336, n. 2. Datazione. I contesti di rinvenimento consentono di inquadrare il tipo tra la fine del I secolo a.C. e il I secolo d.C. (vedi, 330-331, 333-334, 346-347).
CERAMICA SIGILLATA ITALICA (K).
ITALICA
E
TARDO-
BICCHIERI (Forma 180). Tipo K.180.1. Bicchiere a profilo troncoconico; labbro rettilineo lievemente svasato; orlo distinto a sezione quadrangolare (Fig.2.33). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 140, n. 1. Confronti. Pucci 1985, 397, forma XXXIX, var. 1 (I secolo d.C.). Datazione. I secolo d.C.
Tipo I.300.4. Coperchio a calotta troncoconica continua; labbro lievemente rientrante; orlo distinto; presa a pomello piano (Fig.2.33). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 314, n. 2.
COPPETTE (Forma 260). Tipo K.260.1. Coppetta con labbro svasato e carena ingrossata (Fig.2.33). 101
Capestrano, I
Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 337, n. 9. Confronti. Pucci 1985, 394, forma XXXI, var. 3 (prima del 20 a.C.-età giulio-claudia e oltre). Vicino a Conspectus, 114, tipo 36.2.1 (età tiberiana-fine I secolo d.C.). Datazione. Fine I secolo a.C.-I secolo d.C.
Tipo K.290.3 Piatto con ampia vasca a calotta troncoconica, carenata; labbro diritto; orlo semplice; alto piede ad anello a profilo sagomato; la vasca è decorata da due incisioni orizzontali al di sotto dell’orlo e da una testina barbata applicata a rilievo; due cerchi concentrici sono realizzati sul fondo (Fig.2.33). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 332, n. 6. Confronti. Pucci 1985, 385, forma X, var. 31 (età augustea-fine I secolo d.C.). Conspectus, 86, tipo 20.4.2 (età claudia). Portorecanati (PU): t. 181, n. 13 (età flavia; Mercando 1974b, 333). Datazione. Fine I secolo a.C.-I secolo d.C.
Tipo K.260.2. Coppetta a profilo troncoconico; labbro continuo lievemente rientrante; orlo semplice; in corrispondenza del labbro sono incise due linee parallele (Fig.2.33). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 317, n. 2. Confronti. Pucci 1985, 385, forma X, var. 31 (10 a.C.-inizi II secolo d.C.). Vicino a Conspectus, 112, forma 34 (tarda età tiberianaetà flavia). Portorecanati (PU): t. 27A, n. 5 (terzo quarto I secolo d.C.; Mercando 1974b, 208); t. 29, n. 4 (prima metà I secolo d.C.; Mercando 1974b, 211); t. 132, nn. 4-5 (ultimo quarto I secolo d.C.; Mercando 1974b, 299). Datazione. I secolo d.C.
Tipo K.290.4. Piatto a vasca troncoconica profonda; labbro svasato distinto, a fascia: orlo distinto ingrossato (Fig.2.34). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 315, n. 1. Confronti. Pucci 1985, 383, forma IX, var. 2 (10 a.C.-età tiberiana). Corrisponde al tipo Conspectus, 84, tipo 19.2 (età augustea-età tiberiana); per la decorazione applicata, vedi, Marini 2012, 6, tav. II, 11. Datazione. Fine I secolo a.C.-prima metà I secolo d.C.
PIATTI (Forma 290). Tipo K.290.1. Piatto con ampia vasca a calotta troncoconica; labbro continuo svasato; orlo semplice; piede ad anello a profilo rettilineo; sul fondo interno della vasca sono incisi tre fasci di linee concentriche (Fig.2.33). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 225, n. 1 Confronti. Pucci 1985, 381, forma VI, var. 2 (età augustea). Conspectus, 58, forma 4.3.2 (fine I secolo a.C.). Datazione. Fine I secolo a.C.-inizi I secolo d.C.
Tipo K.290.5. Piatto a vasca troncoconica profonda; labbro svasato distinto a fascia; sull’esterno del labbro è applicata alla barbottina un motivo zoomorfo a rilievo (delfino) (Fig.2.34). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 290, n. 4. Confronti. Pucci 1985, 383, forma IX, var. 7 (10 a.C.-età tiberiana). Datazione. I secolo d.C.
Tipo K.290.2. Piatto con vasca a calotta troncoconica, carenata; labbro diritto; orlo distinto ingrossato; piede ad anello a profilo sagomato; la vasca è decorata da due incisioni orizzontali; un fascio di tre cerchi concentrici è impresso sul fondo (Fig.2.33). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 332, n. 7. Confronti. Pucci 1985, 384, forma X, var. 18 (età augustea-fine I secolo d.C.). Conspectus, 82, tipo 18.2.2-3 (10 a.C.-età tiberiana). Datazione. Fine I secolo a.C.-I secolo d.C.
CERAMICA A PARETI SOTTILI (L). OLLETTE (Forma 50). Tipo L.50.1. Olletta a profilo ovoide; labbro distinto svasato; orlo ingrossato con scanalatura interna; spalla sfuggente; punto di massima espansione nella metà inferiore del
102
La tipologia dei materiali
ventre; piede a disco. Le pareti sono decorate da fasci di linee incise e da motivi plastici ovoidi impressi sulla superficie (Fig.2.34). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 315, n. 2. Confronti. Vicina al tipo Ricci 1/117 (età flaviaII secolo d.C.; Ricci 1985, 271). La decorazione a incavi profondi di forma ovoidale (“a ditate”) è attestata su forme aperte a pareti sottili da Cosa, di età augustea e tiberiana, dalla necropoli del fondo Scataglini a Tarquinia e da Musarna (Marabini Moevs 1973, 164; Serra Ridgway 1996, 263, fig. 170). Per i materiali da Cosa sono portate a confronto ollette rinvenute in Pannonia e datate al I secolo d.C. “Faltenbecher” confrontabili genericamente con il tipo in esame sono noti ad es. da Augst (Augusta Rauricorum): Furger 1990, fig. 8, 43 (I-II secolo d.C.) ma in generale dall’area centro e nord europea per tutta l’età imperiale (vedi, ad es. Pavić 2007; Darling e Precious 2014, 36, fig. 27, nn. 175-177). Datazione. I secolo d.C.
COPPETTE (Forma 260).
BICCHIERI (Forma 180).
Tipo L.260.2. Coppetta a profilo globulare con labbro a colletto distinto; vasca arrotondata; ventre rastremato. Sul punto di massima espansione della vasca sono impressi dei motivi semicircolari ottenuti con cerchielli impressi (Fig.2.34). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 138, n. 7. Datazione. Il contesto di rinvenimento suggerisce di datare il tipo alla fine del I secolo a.C.-I secolo d.C. (vedi, 221-222).
Tipo L.180.1. Bicchiere a profilo troncoconico; labbro rettilineo svasato; orlo distinto; fondo piano (Fig.2.34). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 251, n. 5. Confronti. Ricci 1985, 279, tipo 1/159 (età augustea). Datazione. Fine I secolo a.C.
Tipo L.260.1. Coppetta a profilo troncoconico carenato; ampio labbro diritto; orlo semplice; carena arrotondata; vasca rastremata; piede a disco. In corrispondenza del labbro sono incise due linee orizzontali; la vasca al di sopra della carena è decorata da motivi a tratti obliqui disposti su quattro registri alternati (Fig.2.34). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 206, n. 11. Confronti. Ricci 1985, 284, tipo 2\231, con decorazione 5m (attestato dall’età augustea fino al II d.C.). Rimini, area ex-Vescovado: F. Biondani in Mazzeo Saracino 2005, 201(ascritto al tipo Marabini XXXVI; databile tra l’età augustea e il II secolo d.C.). Portorecanati (PU): t. 29, n. 7 (prima metà I secolo d.C.; Mercando 1974b, 212-213); t. 38, n. 3 (età traianea; Mercando 1974b, 222); t. 55, n. 3 (inizi II secolo d.C.; Mercando 1974b, 241). Datazione. I-II secolo d.C.
COPPE (Forma 240). Tipo L.240.1. Coppa a profilo globulare; labbro continuo rientrante; orlo semplice (Fig.2.34). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 332, n. 8. Confronti. Ricci 1985, 293, tipo 2/418 (età claudia-età flavia). Portorecanati (PU): t. 107, n. 1 (primi decenni I secolo d.C.; Mercando 1974b, 276). Datazione. I secolo d.C.
103
Tipo L.260.3. Coppetta a profilo globulare; labbro distinto e diritto; orlo semplice; vasca arrotondata (Fig.2.34). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 317, n. 3. Confronti. Ricci 1985, 303, tipo 2/134. Isernia, loc. Quadrella: Terzani e Matteini Chiari 1997, 226, n. 49 (I secolo a.C.-età flavia; materiali dall’area della necropoli). Datazione. I secolo d.C.
Capestrano, I
Distribuzione. Fossascopana, scavi 1973, tomba 2 a camera, materiali presso la volta crollata, n. 26. Confronti. Corrisponde al tipo biconico dell’Esquilino (Esquilino 2; III-prima metà I secolo a.C., con addensamento tra la fine del II e gli inizi del I secolo a.C. Pavolini 1981, 144149; Pavolini 1987, 140). Saepinum: D’Alascio 2002, 32, 65. Di Niro 2007, 147, n. 280 (fine III-prima metà I secolo a.C.). Datazione. Metà II-terzo quarto I secolo a.C.
LUCERNE (M). LUCERNE REALIZZATE AL TORNIO (M.A). Tipo M.A.1. Lucerna con serbatoio globulare; becco ovoide (a vernice nera) (Fig.2.34). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 151, n. 8. Confronti. Rientra nel tipo Ricci C (Ricci 1973, 211-213). Vicino a, Di Niro 2007, 147, n. 279 (con ampia bibliografia di riferimento per il territorio sannitico; III-II secolo a.C.). Vicino a un esemplare di difficile puntualizzazione tipologica da Rimini, giardini ex-Vescovado: F. Minak in Mazzeo Saracino 2005, 156, n. 253 (II-metà I secolo a.C.; con rif. a Di Filippo Balestrazzi 1988, 33, tav. I, n. 5). Datazione. Il contesto di rinvenimento consente di inquadrare il tipo nella seconda metà-fine II secolo a.C. (vedi, 231-232).
Tipo M.A.4. Lucerna con serbatoio biconico; becco ad incudine; fondo piano; ansa ad anello impostata dal labbro al punto di massima espansione del serbatoio; intorno al foro di alimentazione è realizzata una decorazione radiale a tratti incisi; nel punto di innesto del becco, sono incisi due tratti orizzontali paralleli, raccordati da due tratti perpendicolari (Fig.2.34). Distribuzione. Fossascopana, scavi 1973, tomba 1 a camera, sepoltura sul pavimento “a”, n. 2. Confronti. Corrisponde al tipo a decorazione radiale diffuso tra l’ultimo quarto del II e la seconda metà del I secolo a.C. (130-50/30 a.C.; Pavolini 1987, 142; Di Filippo Balestrazzi 1988, 128-129, n. 174; D’Alascio 2002, 35). Ancona: t. 41, n. 2 (fine II-I quarto I secolo a.C.; Colivicchi 2002, 260-261). Datazione. Ultimo quarto II-seconda metà I secolo a.C.
Tipo M.A.2. Lucerna con serbatoio cilindrico; becco allungato e terminazione a incudine (a vernice nera) (Fig.2.34). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 168, n. 13; tomba 190, n. 14. Fossascopana, scavi 1964, tomba 5, saggio B, n. 4. Fossascopana, scavi 1973: tomba 2 a camera, materiali presso la volta crollata, nn. 23-25; tomba a camera 2, deposizione 1, n. 6. Confronti. Corrisponde al tipo cilindrico dell’Esquilino (Esquilino 1; soprattutto tra il 180 e il 50 a.C.; Pavolini 1981, 148-149, rif. a Ricci 1973, 225, tipo H; Pavolini 1987, 141). Fossa: t. 410, n. 6 (seconda metà II secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 102-103); t. 518, n. 9 (primi decenni I secolo d.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 146-147); t. 63, n. 33 (prima metà II secolo a.C.-primi decenni I secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 188). Rimini, area ex-Vescovado: F. Minak in Mazzeo Saracino 2005, 156, nn. 254-257. Datazione. II-I secolo a.C.
VOGELKOPFLAMPEN (M.B). Questo gruppo è l’ultimo ad essere prodotto in Italia durante l’età repubblicana e prosegue anche nel corso della prima età imperiale, fino al II secolo d.C. Dei due tipi attestati nei contesti esaminati, il primo sembra ascrivibile agli inizi della produzione (per l’ansa verticale e la decorazione naturalistica); il secondo può invece essere identificato come una elaborazione di dimensioni ridotte del tipo, in cui la decorazione a teste di uccello è fortemente stilizzata e ridotta a due ovali (Di Meo 2006a).
Tipo M.A.3. Lucerna con serbatoio biconico; becco allungato e terminazione triangolare; piede ad anello; ansa ad anello impostata dal labbro al punto di massima espansione del serbatoio (a vernice nera) (Fig.2.34).
Tipo M.B.1. Lucerna con serbatoio troncoconico; piccolo foro di alimentazione al centro della vasca, campito da due profonde 104
La tipologia dei materiali
Confronti. Tipo Dressel 11; Loeschcke 1919, tipo IV. Deneauve 1969, 126-127, tipo VA. Bailey 1980, tipo B. Datazione. Età augustea-fine I secolo d.C.
scanalature concentriche; becco continuo a forma di incudine; la vasca e il foro di accensione sono collegati da un breve canale, campito da due teste di uccello; fondo piano; ansa ad anello con solco centrale sormontante, impostata in corrispondenza della vasca (Fig.2.34). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 251, n. 6. Corrisponde al tipo Dressel 4. Confronti. Tipo Dressel 4. Deneauve 1969, 103104, tipo II. Fossa: t. 124, n. 37 (età augustea; d’Ercole e Copersino 2003, 200). Tarquinia, fondo Scataglini: Serra Ridgway 1996, 284 (50/30 a.C.-15 d.C.). Datazione. Metà/fine I secolo a.C.-inizi I secolo d.C.
Tipo M.C.2. Lucerna con serbatoio troncoconico; piccolo foro di alimentazione al centro della vasca, campita da due profonde scanalature concentriche e decorata a baccellature radiali; corto becco con terminazione a triangolo, delimitato da volute con una sola estremità arricciata; basso piedino ad anello (Fig.2.35). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 303, n. 12. Confronti. Tipo Dressel 9. Loeschcke 1919, tipo I. Deneauve 1969, 107-108, tipo IVA; 120, n. 366. Datazione. Età augustea-età claudia.
Tipo M.B.2. Lucerna di piccole dimensioni con serbatoio troncoconico; piccolo foro di alimentazione al centro della vasca, campita da due profonde scanalature concentriche; becco continuo a forma di incudine; il foro di accensione è campito da due teste di uccello stilizzate; fondo piano; ansa ad anello con solco centrale sormontante, impostata in corrispondenza della vasca (Fig.2.34). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 341, n. 5. Datazione. Il contesto di rinvenimento suggerisce di inquadrare il tipo tra la fine del I secolo a.C. e gli inizi del I secolo d.C.
Tipo M.C.3. Lucerna di piccole dimensioni con serbatoio troncoconico; piccolo foro di alimentazione al centro della vasca; vasca campita da un motivo continuo a piccoli ovoli; becco con terminazione triangolare, marginato da due volute stilizzate; ansa plastica conformata a foglia applicata su un occhiello (Fig.2.35). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 251, n. 7. Confronti. Per la diffusione delle lucerne a volute con ansa plastica, si veda Di Niro 2007, 154. Per il motivo a foglia applicato sull’ansa, Menzel 1954, 28, 95. Datazione. Il contesto di rinvenimento orienta la datazione del tipo alla fine del I secolo a.C. (vedi, 298-300).
LUCERNE A VOLUTE (M.C). Oltre agli esemplari chiaramente inquadrabili nei tipi che seguono, si ascrivono a questo gruppo il n. 2 dalla tomba 201; il n. 3 dalla tomba 217; il n. 9 dalla tomba 332 di Fossascopana, scavi 2003-2009.
Si ascrive al gruppo delle lucerne a volute, pur non potendosi definire la conformazione del becco, l’esemplare n. 6 della tomba 310 di Fossascopana, con serbatoio troncoconico; piccolo foro di alimentazione decentrato; vasca campita da due profonde scanalature concentriche e decorata con scena mitologica di Eracle e Nesso; basso piedino ad anello.
Tipo M.C.1. Lucerna con serbatoio troncoconico; piccolo foro di alimentazione al centro della vasca; campita da due profonde scanalature concentriche; volute sottili con ambedue le estremità arricciate ai margini del becco allungato, con estremità arrotondata, segnato anche da coppie di nervature laterali; basso piedino ad anello (Fig.2.35). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 308, n. 4.
LUCERNE A CANALE (M.D). Tipo M.D.1. Lucerna (tipo Firmalampen) con serbatoio troncoconico carenato; foro di 105
Capestrano, I
alimentazione al centro della vasca, al quale si aggiunge un forellino al centro del canale aperto che raccorda la vasca al becco; becco arrotondato; sono presenti due piccole borchie a sezione quadrangolare sulla spalla; fondo rientrante. Entro due incisioni circolari è ben nitido il bollo FORTIS (Fig.2.35). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 121, n. 2. Confronti. Tipo Dressel 5. Loeschcke 1919, 6769, tipo IX. Deneauve 1969, IXA. Bailey 1980, 272-279, tipo N. Per il bollo: CIL XV, 6450; Bailey 1980, 96. Datazione. Ultimo quarto I-II secolo d.C.
Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 217, n. 3. Confronti. Vicino al tipo precedente. Per il motivo, Deneauve 1969, 176, n. 773 Datazione. Fine I-inizi II secolo d.C.
Tipo M.D.2. Lucerna con serbatoio troncoconico; foro di alimentazione al centro della vasca; canale chiuso; sulla spalla due borchiette laterali rilevate; becco arrotondato; ansa verticale decorata da due solchi verticali paralleli (Fig.2.35). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 215, n. 4. Confronti. Loeschcke 1919, tipo IXb. Bailey 1980, tipo 9, VI. Di Niro 2007, 180, n. 351 (con riferimento ai tipi Loeschcke IX e X). Datazione. Prima metà II secolo d.C.
Tipo N.130.1. Balsamario fusiforme con labbro svasato e orlo a fascetta; collo troncoconico continuo; ventre scarsamente espanso; piede sagomato (Fig.2.36). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 168, n. 19. Confronti. Portorecanati (PU): t. 174, n. 3 (la t. 174 è datata all’età di Claudio per la presenza di una moneta; Mercando 1974b, 328). Datazione. Il contesto di rinvenimento suggerisce un inquadramento del tipo tra la fine del II e la prima metà del I secolo d.C. (vedi, 243-246).
Fuori tipologia (Fig.2.35) Tomba 326, n. 7. Scena gladiatoria (corrisponde al motivo Bailey 1980, tipo III (c) I; si veda anche Deneauve 1969, 112, n. 313. BALSAMARI CERAMICI (N.130).
LUCERNE A DISCO (M.E). Tipo M.E.1. Lucerna con serbatoio troncoconico compresso; foro di alimentazione al centro della vasca; spalla liscia e vasca non decorata; becco tondo distinto dalla spalla da un tratto orizzontale e delimitato; ansa ad anello decorata da un solco verticale (Fig.2.35). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 183, n. 2. Confronti. Loeschcke 1919, 49-50, tipo VIII. Deneauve 1969, 165, tipo VIIA (seconda metà I-inizi II secolo d.C.). Bailey 1980, 314-318, tipo P (tarda età flavia-inizi età antonina). Datazione. Fine I-inizi II secolo d.C.
Tipo N.130.2. Balsamario fusiforme con labbro svasato e orlo a fascetta; collo troncoconico continuo; ventre globulare; corto piede sagomato (Fig.2.36). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 144, n. 10. Confronti. Ancona: t. 32, nn. 2-3 (seconda metà-ultimo quarto II secolo a.C.; Colivicchi 2002, 221). Datazione. L’associazione nel contesto di rinvenimento con una coppa Tipo H.240.C.3 e una coppetta H.260.A.18, suggerisce di inquadrare il tipo in esame nel III secolo a.C. Tipo N.130.3. Balsamario fusiforme con labbro svasato e orlo a fascetta; collo cilindrico distinto; ventre globulare; alto piede sagomato (Fig.2.36). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 216, n. 9; tomba 281, n. 7; tomba 282, n. 2.
Tipo M.E.2. Lucerna con serbatoio troncoconico compresso; foro di alimentazione decentrato; spalla liscia e vasca decorata a stampo con rappresentazione di un’aquila; becco tondo; ansa ad anello decorata da due solchi verticali (Fig.2.35).
106
La tipologia dei materiali
Datazione. II secolo a.C.
Fossascopana, scavi 1973: tomba 2 a camera, materiali presso la volta crollata. Confronti. Ancona: t. 6, n. 7; t. 10, nn. 2-3 (fine III-inizi II secolo a.C.; Colivicchi 2002, 97, 108-109). Portorecanati (PU): t. 112, n. 1 (la datazione alla prima metà I secolo d.C. proposta è probabilmente da riconsiderare.; Mercando 1974b, 278). Si ascrive al tipo “fusiforme ovoide” del fondo Scataglini a Tarquinia (VT): Serra Ridgway 1996, 274 (con distribuzione; fine IV-ultimo quarto III secolo a.C.). Datazione. Tra la fine del III e la prima metà del II secolo a.C.
Tipo N.130.6. Balsamario ovoide; labbro svasato e orlo ingrossato; collo troncoconico continuo (Fig.2.36). Distribuzione. Fossascopana, scavi 1973: tomba 2 a camera, materiali presso la volta crollata, n. 37. Datazione. Il contesto di rinvenimento suggerisce un inquadramento nel II secolo a.C. (vedi, il Volume II di questo lavoro).
Tipo N.130.4. Balsamario fusiforme con labbro svasato e orlo a fascetta; collo cilindrico continuo; ventre affusolato; alto piede sagomato (Fig.2.36). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 172, n. 6; tomba 262, n. 5. Confronti. Fossa: t. 432, nn. 14-17 (fine II-inizi I secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 119). Vicino ad Ancona: t. 13, n. 2 (secondo quarto II secolo a.C.; Colivicchi 2002, 117). Datazione. Prima metà/metà II secolo a.C. Tipo N.130.5. Balsamario fusiforme con labbro svasato e orlo a fascetta; collo cilindrico distinto; ventre affusolato; alto piede sagomato (Fig.2.36). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 143, n. 5; tomba 151, n. 9; tomba 214, nn. 9-10. Fossascopana, scavi 1973: tomba 1 a camera, sepoltura sul pavimento “a”, nn. 3-5. Fossascopana, scavi 1973: tomba 2 a camera, materiali presso la volta crollata, nn. 27-35. Presciano, scavi 2010: tomba 50, nn. 9-11. Confronti. Fossa, t. 401, nn. 13-14 (fine II secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 97); t. 427, nn. 9-10 (fine II-inizi I secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 110-111); t. 488, nn. 6-7 (prima metà II secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 133). Ancona: t. 21, n. 1 (seconda metà-ultimi quarto II secolo a.C.; Colivicchi 2002, 146); t. 22, n. 2 (ultimo quarto II secolo a.C.; Colivicchi 2002, 149). Pergola (PU): t. 1, n. 5 (Mercando 1974a, 94). Si ascrive al tipo “fusiforme sottile” del fondo Scataglini a Tarquinia (VT): Serra Ridgway 1996, 274 (con distribuzione; ultimo quarto III-II secolo a.C.). 107
Tipo N. 130.7 Balsamario piriforme; labbro distinto svasato; orlo semplice; collo cilindrico distinto; vasca a profilo arrotondato; fondo piano (Fig.2.36). Varietà a) fino ai 7 cm. Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 309, n. 6; tomba 313, n. 3; tomba 341, nn. 8, 10-11. Fossascopana, scavi 1964, tomba 1, saggio 8, n. 7. Varietà b) dai 7 cm e oltre. Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 225, n. 2; tomba 313, n. 2; tomba 251, nn. 9-17; Tomba 290, n. 6; tomba 292, nn. 1-2; tomba 295, nn. 4-5; tomba 303, nn. 14-15, 17; tomba 306, nn. 8-13; tomba 308, nn. 5-7; tomba 328, n. 2; tomba 332, nn. 10-16; tomba 336, nn. 5-11; tomba 341, nn. 6-7, 9. Fossascopana, scavi 1964, tomba 1, saggio 8, n. 6. Confronti. Fossa: t. 63, nn. 34-35; t. 124, nn. 38-40 (diffuso tra la fine del I secolo a.C. e la metà del I secolo d.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 188, 200). Isernia, loc. Quadrella: t. 81, nn. 2-5 (I-inizi II secolo d.C.; Terzani e Matteini Chiari 1997, 151, 154); t. 92, nn. 1-7 (I secolo d.C.; Terzani e Matteini Chiari 1997, 160-161); t. 104, nn. 1-11 (età augusteotiberiana; Terzani e Matteini Chiari 1997, 181183). Si ascrive al tipo “piriforme” del fondo Scataglini a Tarquinia (VT): Serra Ridgway 1996, 274-275 (con distribuzione; età augustea). Datazione. Fine I secolo a.C.-metà I secolo d.C. Tipo N.130.8. Balsamari a profilo globulare; piede a disco (Fig.2.36). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 251, n. 8.
Capestrano, I
del tipo cd. “Schnabelkannen”. Labbro trilobato e fortemente obliquo; collo troncoconico distinto nettamente dalla spalla; spalla rilevata e arrotondata; ventre rastremato (per quanto scarsamente conservato in ambedue gli esemplari); ansa a profilo pentagonale, saldata al labbro con due diramazioni con terminazioni a goccia, sul ventre con attacco “ad àncora”, chiuso superiormente da un nodulo, composto da palmetta a nove foglie sotto due bracci ricurvi ad uncino verso l’alto (Fig. 2.37). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 241, n. 3. Fossascopana, scavi 1934: tomba 12, n. 3. Confronti. Trova confronti con esemplari ascrivibili al tipo più antico della produzione di questo gruppo (da localizzare, com’è noto, a Vulci), databile tra la seconda metà/fine del VI e la metà del V secolo a.C. (Boulomié 1968, 451-453; 1973, 230-233; Castoldi 1995, 36-37). Jurgeit 1999, 370-371, nn. 593-594, 599-600 (prima metà V secolo a.C.). Anche l’ansa con attacco “ad àncora” ne orienta la datazione allo stesso orizzonte (Bouloumié 1973, 233, tipo 1; Castoldi 1995, n. 37; Vorlauf 1997, 91, tipo 4). Camerino: Salvini 2003, 173, tav. II.a-b. Datazione. Ultimi decenni/fine VI-inizi V secolo a.C.
Confronti. Portorecanati (PU): t. XXVI, nn. 4-9 (età augustea-tiberiana; Mercando 1974b, 404). Datazione. I secolo d.C. VASELLAME IN LAMINA BRONZEA (O). La presenza di esemplari di questa classe nei corredi di Capestrano è, così come in altri contesti dell’Abruzzo antico, un indicatore di status emergente. Essa sembra concentrarsi soprattutto in età arcaica e tardo-arcaica e, nella storia degli studi è solitamente ascritta a fenomeni di importazione dall’Etruria (soprattutto Vulci e Volsinii), anche se, pur essendo evidente l’influenza dal comparto tirrenico, è possibile che alcuni materiali siano prodotti da officine locali. SITULE (Forma 90). L’unico esemplare ascritto a questa forma, rinvenuto nella tomba 186 di Fossascopana, è assimilabile alla forma degli stamnoi (vedi avanti, 112) ma, per le dimensioni superiori e per la presenza del manico mobile in ferro, viene identificato come situla “stamnoide”. Tipo O.90.1. Situla in lamina bronzea, con labbro svasato e orlo distinto ripiegato, spalla rilevata e arrotondata, ventre rastremato; in corrispondenza del labbro si conservano i resti degli attacchi per l’ansa mobile in verga di ferro semicircolare (Fig. 2.37). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 186, n. 3. Confronti. Si inquadra nel tipo C Giuliani Pomes (1954, 39-54) e risulta diffuso nella prima metà del V secolo a.C. Jurgeit 1999, 320, n. 528 (prima metà V secolo a.C.; diffusione soprattutto in Etruria padana). Vedi anche Castoldi 1995, 18-19. Poggio Sommavilla (RT): tt.1 e 32 (Alvino 1997, 67-68, nn. 6.18-19). Fratte (SA): tomba XLVIII, n. 6 (480 a.C. ca; L. Tomay in Greco e Pontrandolfo 1990, 246247). Datazione. Prima metà V secolo a.C.
OLPAI (Forma 110). Tipo O.110.1. Olpe in lamina bronzea con alto labbro svasato e distinto; spalla rilevata e arrotondata; ventre rastremato; fondo piano con lieve ombelicatura; ansa a fusione piena, a bastoncello sormontante, a sezione ovale o quadrangolare, impostata sul labbro e sul ventre, con terminazione a palmetta (Fig. 2.37). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 241, n. 4. Fossascopana, scavi 1934: t. 5, n. 2; t. 12, n. 4. Confronti. Bini, Caramella e Buccioli 1995, 32, n. 49, tav. XXII (fine VI-prima metà V secolo a.C.). Fratte (SA): t. 29, n. 6 (inizi V secolo a.C.; R. Donnarumma in Greco e Pontrandolfo 1990, 243). In generale, B.B. Shefton, M. Sannibale, in Sannibale 2008, 122-124 e, da ultimo, Montanaro 2015. Colfiorito di Foligno: tipo IIIB 33 (Bonomi Ponzi 1997, 129 Datazione. Prima metà V secolo a.C.
OINOCHOAI (Forma 100). Tipo O.100.1. Oinochoe in lamina bronzea in 108
La tipologia dei materiali
Tipo O.110.2. Olpe in lamina bronzea con corto labbro svasato e distinto; spalla scarsamente definita; fondo piano con lieve ombelicatura; ansa a fusione piena, a bastoncello sormontante, a sezione ovale, impostata all’esterno del labbro e sul ventre, con terminazione a palmetta (Fig. 2.37). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 186, n. 3. Confronti. Vicino a un esemplare dalla tomba “del Guerriero” di Vulci, databile agli ultimi decenni del VI secolo a.C. (Cristofani 1985, 248, n. 9.8). Orvieto, collezione Museo Claudio Faina: Caravale 2006, 41, n. 44 (fine VI-inizi V secolo a.C.). Sirolo-Numana, area Davanzali: t. 225 (inizi del V secolo a.C.; Landolfi 1992, 304-312). Datazione. Fine VI-inizi V secolo a.C.
sul labbro si impostano gli attacchi ad omega in ferro per il manico mobile in ferro, realizzato in verga a sezione circolare (Fig.2.38). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 112, n. 3; tomba 173, n. 2; tomba 223, n. 2 (dubitativamente per le condizioni di conservazione; Fig. 2.38). Fossascopana, scavi 1934: tomba 5, n. 3; tomba 12, n. 5. Confronti. Corrisponde al tipo 2 di Campovalano, specificamente agli esemplari dalle tt. 74, 175 e 180 della necropoli, i primi due databili nella prima metà del VI secolo a.C., il terzo nella seconda metà dello stesso secolo; secondo B. Grassi il tipo deriverebbe da modelli euboici diffusi tra l’Etruria e la Campania (Grassi 2000, 93-94; 2003b, 495-498; B. Grassi in Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 185). A Bazzano il tipo è attestato nella t. 447, della fase IIB2 (Weidig 2014, 489-491). Datazione. VI secolo a.C.
Tipo O. 110.3. Olpe in lamina bronzea di piccole dimensioni, con ampio labbro svasato, collo, continuo rispetto alla spalla; profilo sinuoso e ventre piriforme; fondo piano; ansa a fusione piena a bastoncello sormontante, a sezione ovale; impostata sul labbro e sul ventre, con terminazione di forma ovoidale, fissata con tre (sup.) e un chiodino (inf.) (Fig. 2.37). Distribuzione. Presciano, scavi 2010: tomba 18, n. 2. Confronti. Bellelli 1993, 81, n. 8 (prima metà V secolo a.C.). Jurgeit 1999, n. 669 (prima metà V secolo a.C.; attribuito a produzione vulcente). Corrisponde al tipo B1 di Bazzano, attestato nella fase III della necropoli (Weidig 2014, 463-464). Campovalano: t. 13, n. 2 (seconda metà VI-V secolo a.C.; Chiaramonte Treré e d’Ercole 2003, 26; Grassi 2003, 501, nt. 65; B. Grassi in Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 188). Vedi anche Weber 1983, 147-148 (fine VI-metà V secolo a.C.; tipo III.B.Etr). Datazione. Fine VI-prima metà V secolo a.C.
Tipo O.320.2. Calderone in lamina bronzea con labbro fortemente rientrante distinto e vasca emisferica, fondo piano composto da due lamine sovrapposte e fissate con ribattini; sul labbro si impostano gli attacchi trapezoidali in ferro per il manico mobile in ferro, realizzato in verga a sezione circolare (Fig. 2.38). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 230, n. 2. Confronti. Anche questo tipo può essere inquadrato nel tipo 2 di Campovalano (vedi prec.), e specificamente nell’esemplare n. 9 della t. 117, databile nella prima metà del VI secolo a.C. (Chiaramonte Treré e d’Ercole 2003, 65). Pescara, Campo Sportivo ex Gesuiti: t. 3 (ultimi decenni/fine VI secolo a.C.; Staffa 2003a, 558, 587-588). Datazione. VI secolo a.C. Tipo O.320.3. Calderone in lamina bronzea con labbro rientrante e fondo piano; sul labbro si impostano gli attacchi ad omega in ferro per il manico mobile in ferro, realizzato in verga a sezione circolare (Fig. 2.38). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 241, n. 6; tomba 244, n. 1; tomba 249, n. 3. Si ascrive al tipo anche l’esemplare molto frammentario nella tomba 183, n. 3. Fossascopana, scavi 1934: tomba 2, n. 1.
Si ascrivono a due esemplari della stessa forma tre anse a fusione piena dalle tombe 240 (n. 2) di Fossascopana; 22 (n. 4) e 30 (n. 4) di Fontanelle. CALDERONI (Forma 320). Tipo O.320.1. Calderone in lamina bronzea con labbro lievemente rientrante e fondo concavo; 109
Capestrano, I
provenienza degli esemplari attestati in Abruzzo da fabbriche locali o, quanto meno, dell’area medio-adriatica (Albanese Procelli 2006, 308; Weidig 2014, 471, nt. 1376).
Confronti. Si inquadra in un tipo definito “ibrido” da B. Grassi, diffuso a Campovalano in sepolture della seconda metà VI-inizi V secolo a.C. (B. Grassi in Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 185; Acconcia 2014, 87). Colfiorito di Foligno: tipo 37 della fase IIIA della necropoli (Bonomi Ponzi 1997, 107). Datazione. Seconda metà VI-inizi V secolo a.C.
Tipo O.330.A.1. Bacile in lamina bronzea a orlo perlinato, labbro ricurvo, vasca a calotta a profilo sinuoso indistinto, fondo concavo (Fig. 2.38). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 204, n. 2; tomba 207, n. 2. Fontanelle, scavi 2012: tomba 22, n. 3. Confronti. Si inquadra nel tipo B1 di Bazzano, a sua volta ascritto al tipo Krausse “Brolio” (la cui datazione si estende dalla metà del VII fino almeno alla metà del VI secolo a.C.; Krausse 1996, 260-262). Il tipo B1 di Bazzano è attestato soprattutto nella fase IIB della necropoli (Weidig 2014, 470-473). Fossa: t. 38, n. 2 (seconda metà VII secolo a.C.). Per Campovalano, dove il tipo risulta frequentemente attestato, con numerose varianti dimensionali e decorative, si veda Grassi 2000, 99-104; B. Grassi in Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 182. Datazione. Pur essendo il tipo diffuso per un arco cronologico abbastanza esteso (dalla seconda metà del VII secolo per l’intero VI secolo a.C.), sulla base dei materiali associati nei corredi delle tombe in cui esso è attestato, è possibile puntualizzarne la presenza a Capestrano nell’ambito del VI secolo a.C.
BACILI (Forma 330). I bacili sono distinti in questa sede in due gruppi: il primo caratterizzato dal labbro ricurvo e orlo decorato da perlinatura (A), il secondo privo di tale caratteristica decorazione, nell’ambito del quale si inseriscono i bacili con orlo diritto, quelli con labbro svasato o anche del cd. tipo “sannitico” (B). Per un inquadramento della forma dal punto di vista della funzione (vaso da lustrazioni / contenitori per l’offerta di cibi solidi, ecc.), del suo sviluppo morfo-tipologico, nonché della sua diffusione in area centro-italica, si rimanda ad Albanese Procelli 1985; 2006; Krausse 1996; Grassi 2000, 103-104; Weidig 2014, 467-481; Acconcia 2014, 47-49, 123-124, 248-250. BACILI A ORLO PERLINATO (O.330.A). Il gruppo è composto da pochi esemplari con vasca profonda a profilo sinuoso (Tipo O.330.A.1), corrispondenti al tipo cd. “Brolio” definito da D. Krausse, inquadrabile nella piena età arcaica. La maggior parte delle attestazioni, invece, è caratterizzata da vasca troncoconica più o meno profonda e fondo distinto. I tipi O.330.A.2-3, sembrano pressoché coevi al precedente, mentre i tipi O.330.A.4-6, corrispondenti al tipo Krausse “ImolaHundersingen”, si datano a un orizzonte recenziore, tra la fine del VI e il V secolo a.C. (Krausse 1996, 260-262 e 268, 421-423). Tale indicazione sembra pertanto confermare quanto emerge dall’analisi delle altre forme del vasellame metallico e quanto già rilevato in Weidig 2014, 473, circa la maggiore concentrazione delle sepolture più antiche di Capestrano in età arcaica avanzata. I tipi “Brolio” e “Imola” sono attribuiti a produzioni vulcente e orvietana, anche se allo stato attuale delle conoscenze non si può escludere una
Tipo O.330.A.2. Bacile in lamina bronzea a orlo perlinato, labbro ricurvo, vasca a profilo continuo diritto e lievemente rientrante, fondo piano distinto (Fig. 2.38). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 185, n. 1. Confronti. Vicino alla variante Pürgen del tipo Osovo-Pürgen di Krausse (avanzato VI-inizi V secolo a.C.; Krausse 1996, 257-259). A Campovalano, trova confronti con l’esemplare n. 16 della t. 469, ascritta alla prima metà VI secolo a.C. (Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 121). Datazione. Fine VI secolo a.C. Tipo O.330.A.3. Bacile in lamina bronzea a orlo perlinato, labbro ricurvo, vasca a profilo carenato a tesa diritta, fondo piano distinto (Fig. 2.38). 110
La tipologia dei materiali
“Imola-Hundersingen”. Fossa: t. 116, n. 1 (decenni finali VI-inizi V secolo a.C.; d’Ercole e Benelli 2004, 47). Datazione. Ultimo quarto VI-metà V secolo a.C.
Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 177, n. 3. Fossascopana, scavi 1934: tomba 11, n. 1. Presciano, scavi 2010: tomba 18, n. 3. Via dell’Olmo, scavi 2011: tomba 7, n. 4. Confronti. Si inquadra come il precedente nella variante Pürgen del tipo Osovo-Pürgen di Krausse. Campovalano: t. 173, n. 4 (prima metà VI secolo a.C.; Chiaramonte Treré e d’Ercole 2003, 88). Colfiorito di Foligno: tipo 38 della fase IIIA della necropoli (Bonomi Ponzi 1997, 107-109). Datazione. Seconda metà-fine VI secolo a.C.
BACILI A ORLO NON DECORATO (O.280.B). Tipo O.330.B.1. Bacile in lamina bronzea con orlo indistinto, vasca a calotta emisferica, fondo piano (Fig. 2.39). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 211, n. 1. Fontanelle, scavi 2012: tomba 30, n. 4; tomba 42, n. 3. Confronti. Bacili con orlo indistinto sono diffusi in Italia dall’avanzato VIII secolo a.C. (vedi, ad es. Mercuri 2004, 169-170 o i bacili attestati a Fossa nelle tombe 551 e 361, della avanzata età del Ferro: Acconcia 2014, 32-33), fino all’età ellenistica (Michetti 2013, 180, con bibliografia di riferimento). Per le attestazioni di età arcaica e tardo-arcaica, si veda Fossa: t. 16, n. 18 (prima metà V secolo a.C.; d’Ercole e Benelli 2004, 14). A Campovalano, è attestato un esemplare simile con orlo appena ingrossato nella t. 175 e uno con fondo concavo nella t. 550, databili ambedue alla prima metà del VI secolo a.C. (B. Grassi in Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 185; Acconcia 2014, 248-249). Datazione. VI secolo a.C.
Tipo O.330.A.4. Bacile in lamina bronzea a orlo perlinato, labbro ricurvo, vasca profonda a profilo troncoconico con tesa svasata, fondo indistinto (Fig. 2.39). Distribuzione. Fossascopana, scavi 1934: t. 3, n. 1. Fontanelle, scavi 2012: tomba 46, n. 3. Confronti. Si inquadra nella variante Hundersingen del tipo Krausse “ImolaHundersingen” (Krausse 1996, 265). Vicino al tipo B2 di Bazzano, diffuso nella fase III della necropoli (Weidig 2014, 473). Fossa: t. 389, n. 1 (fine VI-V secolo a.C.; d’Ercole e Benelli 2004, 163). Datazione. Ultimo quarto VI-inizi V secolo a.C. Tipo O.330.A.5. Bacile in lamina bronzea a orlo perlinato, labbro ricurvo, vasca bassa troncoconica a profilo svasato, fondo piano distinto (Fig. 2.39). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 112, n. 4; tomba 186, n. 5. Confronti. Si inquadra nella variante Imola del tipo Krausse “Imola-Hundersingen” (Krausse 1996, 266-269). Fossa: t. 227, n. 5 (prima metà V secolo a.C.; d’Ercole e Benelli 2004, 92). Datazione. Ultimo quarto VI-metà V secolo a.C.
Tipo O.330.B.2. Bacile in lamina bronzea con labbro svasato e ripiegato su una verga in ferro a sezione circolare, vasca troncoconica a profilo continuo (Fig. 2.39). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 198, n. 3. Confronti. Un bacile con labbro ripiegato su verga in ferro (ma con perlinatura sull’orlo) è attestato a Campovalano: t. 73, n. 7 (prima metà VI secolo a.C.; Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 16). Sono noti esempi di bacili con labbro ripiegato su verghe in piombo a Matelica (t. 1 di Villa Clara; E. Biocco in Silvestrini e Sabbatini 2008, 77, n. 64, seconda metà VII secolo a.C.) e Cales (t. 56 del Migliaro, della prima metà VI secolo a.C.; Gilotta e Passaro 2012, 64, n. 27 e 66-67, con ampia bibliografia di riferimento).
Tipo O.330.A.6. Bacile in lamina bronzea a orlo perlinato, labbro ricurvo, vasca troncoconica a profilo svasato, fondo distinto (Fig. 2.39). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 170, n. 3; tomba 271, n. 2. Confronti. Come i tipi precedenti, si inquadra nella variante Hundersingen del tipo Krausse 111
Capestrano, I
di Campovalano, almeno alla prima metà del VI secolo a.C. La sua diffusione si estende poi nel pieno V secolo.
Datazione. Sulla base dei materiali cui è associato nel corredo, si propone un inquadramento nell’ambito della seconda metà VI secolo a.C. (vedi, 268).
Tipo O.330.B.5. Bacile in lamina bronzea con breve orlo distinto e ribattuto verso l’esterno, vasca emisferica a profilo sinuoso, fondo piano distinto (Fig. 2.39). Distribuzione. Capo d’Acqua, scavi 2011: tomba 18, n. 2. Presciano, scavi 2011: tomba 1, n. 3. Confronti. Diverge dal tipo precedente, rispetto al quale è comunque coevo, solo per l’orlo ribattuto verso l’esterno e non ripiegato internamente. Pietrabbondante (BN), loc. Troccola: t. 1, n. 4 (prima metà V secolo a.C.; Isernia 1980, 133-134). Datazione. Fine VI-prima metà V secolo a.C.
Tipo O.330.B.3. Bacile in lamina bronzea con breve orlo distinto e a tesa, vasca emisferica, fondo piano indistinto (Fig. 2.39). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 173, n. 3. Presciano, scavi 2010: tomba 8, n. 3; tomba 54, n. 2. Confronti. Fossa: t. 273, n. 1); t. 278, n. 2; t. 478, n. 1; t. 319, n. 1 (fine VI-prima metà V secolo a.C.; d’Ercole e Benelli 2004, 111, 113, 133, 197). Vicino all’esemplare n. 1 dalla tomba 5 di Colle Quinzio-Civitella Casanova, Veste (PE; d’Ercole e Martellone 2003, 112). Pietrabbondante (BN), loc. Troccola: t. 1, n. 4 (prima metà V secolo a.C.; Isernia 1980, 133134). Datazione. Fine VI-prima metà V secolo a.C.
STAMNOI (Forma 340). Come già accennato, nell’ambito del vasellame metallico, sono attestati anche alcuni vasi per contenere di piccole dimensioni e probabilmente prodotti nell’Etruria interna (Bellelli 2002, 41, con disamina delle attestazioni nell’Appendice II, 51-52), identificati nella storia degli studi come stamnoi o anche ollette stamnoidi. Si tratta di una forma abbastanza standardizzata, riconducibile essenzialmente a un unico tipo.
Tipo O.330.B.4. Bacile in lamina bronzea con breve orlo distinto e ribattuto verso l’interno, vasca emisferica a profilo sinuoso, fondo piano distinto (=cd. “tipo sannitico”; Fig. 2.39). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 222, n. 5; tomba 240, n. 3; tomba 242, n. 2; tomba 254, n. 1. Fontanelle, scavi 2012: tomba 4, n. 2; tomba 36, n. 2. Confronti. Corrisponde al tipo Bottini C (1982, 19). Vedi anche Bellelli 1993, 24, n. 15. Si inquadra nel tipo D1 di Bazzano, diffuso nella fase III della necropoli (Weidig 2014, 482-484). A Campovalano il tipo è attestato nelle tombe 96 (prima metà VI) e 460 (seconda metà VI): vedi, B. Grassi in Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 184-185; Grassi 2003, 504-506. Alfedena, scavi 1974-1979: tipo 37, attestato nelle fasi I-II della necropoli (Parise Badoni et al. 1982, 19). Per questi bacili è stata ipotizzata una provenienza dall’area campana o sannitica, ma anche in questo caso è possibile che si tratti di prodotti locali. Datazione. L’inizio della produzione del tipo si ascrive all’avanzato VI secolo a.C., va probabilmente rialzata sulla base delle attestazioni nella necropoli di Fontanelle (vedi, il Volume II di questo lavoro) e della tomba 96
Tipo O.340.1. Stamnos in lamina bronzea con labbro svasato e orlo distinto ripiegato, spalla rilevata e arrotondata, ventre rastremato a profilo sinuoso, fondo piano (Fig. 2.39). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 185, n. 12; tomba 223, n. 3; tomba 241, n. 5; tomba 244, n. 2. Fossascopana, scavi 1934: t. 12, nn. 6-7; t. 2, n. 4. Fontanelle, scavi 2012: tomba 46, n. 2. Confronti. Bazzano: t. 890, n. 7, databile nella fase III della necropoli (Weidig 2014, 465). Campovalano: t. 42, n. 9 (prima metà V secolo a.C.; Chiaramonte Treré e d’Ercole 2003, 36; B. Grassi in Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 187-188). Pescara, Campo Sportivo ex Gesuiti: t. 3 (ultimi decenni/fine VI secolo a.C.; Staffa 2003a, 558, 587-588). Datazione. Fine VI-inizi V secolo a.C. 112
La tipologia dei materiali
MESTOLI (Forma 350). Tipo O.350.1. Mestolo con cucchiaio emisferico in lamina bronzea, manico a fusione piena a sezione rettangolare, con estremità di forma romboidale a sezione piana, terminante a becco ripiegato; applicato con due chiodini al cucchiaio (Fig. 2.39). Distribuzione. Fossascopana, scavi 1934: tomba 2, n. 3. Confronti. A Bazzano un esemplare con manico decorato è attestato nella tomba 953, della fase IIB2 (Weidig 2014, 444). A Campovalano, si avvicina al tipo in esame l’esemplare della tomba 42, n. 8, con manico biforcato a terminazione ornitomorfa (prima metà V secolo a.C.; Chiaramonte Treré e d’Ercole 2003, 35). Vedi anche, Castoldi 1995, 54-55, nn. 58-60 (esemplari datati tra la fine del VI e il V secolo a.C.); Sannibale 2008, 126-132. Datazione. Seconda metà VI/prima metà V secolo a.C.
VASELLAME IN VETRO (P). BALSAMARI (Forma 130). Tipo P.130.1. Balsamario piriforme; labbro svasato; collo cilindrico distinto; ventre a profilo globulare; fondo piano (Fig. 2.40). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 113, nn. 1, 4; tomba 314, n. 4. Confronti. Vicino a De Tommaso 1990, 52, tipo 21 (primo trentennio I secolo d.C.) e De Tommaso 1990, 63-64, tipo 39 (età augusteaprima metà I secolo d.C.). Vicino a Piane di Falerone (AP): t. 1, n. 7 (età augustea; Mercando 1974a, 139). Datazione. Fine I secolo a.C.-inizi I secolo d.C. Tipo P.130.2. Balsamario piriforme; labbro svasato; collo cilindrico distinto e sagomato; ventre a profilo ovoide; fondo piano (Fig. 2.39). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 113, n. 2. Confronti. Vicino a De Tommaso 1990, 83, gruppo/tipo 70 (età tiberiana-età traianea). Datazione. I secolo d.C.
COLINI (Forma 360). Tipo O.360.1. Colino con vasca piana e labbro diritto ribattuto, sul fondo è applicata una lamina forata; manico a fusione piena a doppia verga bronzea formante un occhiello, fissato con due chiodini (Fig. 2.39). Distribuzione. Fossascopana, scavi 1934: tomba 2, n. 4. Confronti. Si confronta con esemplari caratterizzati da manico più lungo e articolato. Vicino a Bini, Caramella e Buccioli 1995, 7678, tav. CLIV (fine VI-prima metà V secolo a.C.; tipo A, di produzione vulcente). Jurgeit 1999, 772 (fine VI-metà V secolo a.C.). Campovalano: t. 1, n. 8 (la tomba 1 è un contesto fortemente disturbato, probabilmente esito dell’accorpamento di più corredi, comunque databili intorno alla prima metà del V secolo a.C.; Chiaramonte Treré e d’Ercole 2003, 12). Datazione. Prima metà del V secolo a.C.
Tipo P.130.3. Balsamario piriforme; labbro svasato; collo cilindrico distinto e sagomato; ventre distinto a profilo allungato; fondo convesso (Fig. 2.40). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 293, n. 5. Confronti. Vicino a Scatozza Höricht 1986, 5862, forma 47, variante d (I-II secolo d.C.). Datazione. I secolo d.C. Tipo P.130.4. Balsamario piriforme; labbro svasato; collo cilindrico distinto e sagomato; ventre a profilo troncoconico; fondo piano (Fig. 2.40). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 322, n. 4. Confronti. Vicino al Gruppo/Tipo 67 De Tommaso (età tiberiana-prima età flavia; De Tommaso 1990, 81). San Vittore di Cingoli (MC): t. 1bis, n. 5 (età flavia; Mercando 1974a, 110). Datazione. I secolo d.C. Tipo P.130.5. Balsamario piriforme; labbro lievemente svasato; ampio collo cilindrico con 113
Capestrano, I
espansione verso il labbro; ventre a profilo ovoide sagomato; fondo piano (Fig. 2.40). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 322, n. 3. Confronti. De Tommaso 1990, 83, gruppo/tipo 70 (età tiberiana-età traianea). Datazione. I secolo d.C.
Fuori tipologia. Non viene inserito nella sequenza tipologica l’esemplare n. 4 dalla tomba 322 di Fossascopana, (Fig. 2.40) probabilmente il fondo ritagliato di un balsamario o di un’altra forma a profilo cilindrico, chiuso da un coperchio conico in lamina d’oro decorata a sbalzo (vedi, 344-345). Il contesto di rinvenimento consente di inquadrarlo nel I secolo d.C.
Tipo P.130.6. Balsamario piriforme; labbro lievemente svasato; ampio collo cilindrico con rigonfiamento alla base; ventre espanso a profilo troncoconico; fondo piano (Fig. 2.40). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 113, n. 3. Confronti. Vicino, De Tommaso 1990, 63, tipo 38 (età augustea-età claudia). Portorecanati (PU): t. 131, n. 1 (primo quarto I secolo d.C.; Mercando 1974b, 299). Datazione. I secolo d.C.
INSTRUMENTUM (Q). Nell’ambito dell’instrumentum si includono manufatti utilizzati per la filatura/tessitura (fusaiole, pesi da telaio, spolette e aghi) con l’aggiunta di alcuni esemplari di pesi di forma discoidale in pietra e in impasto, identificati dubitativamente come pesi da rete, forse utilizzati secondariamente per il telaio o come vaghi di collane. Vi sono poi strumenti utilizzati nella preparazione e nel trattamento di cibi e bevande (spiedi, alari, grattugie, kreagrai, coltelli); sono inclusi in questo gruppo anche i mestoli in ferro (attestati da un unico caso), mentre i corrispondenti in lamina di bronzo (così come i colini in bronzo) sono trattati nella classe del vasellame in lamina (per la classe O, vedi, 113). Sono infine trattati nell’instrumentum anche i chiodi e le grappe utilizzati per il fissaggio di elementi lignei di chiusura delle tombe a grotticella/camera o il fissaggio di elementi dei contenitori per le spoglie dei defunti o per letti funebri.
Tipo P.130.7. Balsamario piriforme; labbro lievemente svasato; stretto collo cilindrico con rigonfiamento verso il labbro; ventre espanso a profilo troncoconico; fondo piano (Fig. 2.40). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 318, n. 2. Datazione. I secolo d.C. Tipo P.130.8. Balsamario piriforme; ampio collo cilindrico con rigonfiamento alla base; ventre espanso a profilo globulare; fondo piano (Fig. 2.40). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 113, n. 5. Confronti. Tipo Isings 1957, 28b (60/70 d.C.inizi II secolo d.C.) Datazione. I secolo d.C.
FUSERUOLE (Forma 10). Tipo Q.10.1. Fuseruole in impasto biconiche (Fig. 2.41). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 121, n. 3; tomba 144, n. 11; tomba 153, n. 7; tomba 269, n. 1. Confronti. Si inquadrano nel tipo A5 di Bazzano (Weidig 2014, 419-421). A Fossa, sono attestate soprattutto dalla fase orientalizzante fino in età ellenistica (vedi, E. Benelli, C. Rizzitelli in d’Ercole e Copersino 2003, 325): t. 36, n. 17 (prima metà VII secolo a.C.); t. 399, n. 9 (primi decenni VI secolo a.C.) (d’Ercole e Benelli 2004, 21, 167); t. 223, n. 5 (prima metà III secolo a.C.; d’Ercole e
Tipo P.130.9. Balsamario piriforme; labbro svasato; lungo collo cilindrico distinto; ventre a profilo troncoconico; fondo piano (Fig. 2.40). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 206, nn. 5-7; tomba 215, nn. 5-9. Confronti. Vicino alla forma 46 ScatozzaHöricht 1986, 57-58. Ai tipi 33 e 46 De Tommaso (età flavia-metà II secolo d.C.; De Tommaso 1990, 59, 69). Portorecanati (PU): t. 12, n. 1 (Mercando 1974b, 175); t. 50, nn. 6-8 (I-II secolo d.C.; Mercando 1974b, 236) Datazione. I-II secolo d.C.
114
La tipologia dei materiali
PESI DA TELAIO (Forma 20).
Copersino 2003, 54). Datazione. Gli esemplari ascritti al tipo in esame fanno prevalentemente parte di corredi databili tra l’età ellenistica e la prima età imperiale. Solo quello della tomba 269 di Fossascopana si inquadra nel periodo tardoarcaico.
Tipo Q.20.1. Pesi da telaio in impasto a profilo tronco-piramidale (Fig. 2.41). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 259, n. 3. Confronti. La forma è molto comune e diffusa dall’età del Ferro al periodo ellenistico. Si veda, ad es. a Campovalano, per l’età arcaica, C. Buoite in Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 237-238 e il tipo 1 della classificazione dei materiali di età ellenistica (A. Martellone in d’Ercole, Martellone e Cesana 2016, 122). Datazione. Nel contesto di rinvenimento, è associato a materiali databili genericamente in età arcaica (VI secolo a.C.?).
Tipo Q.10.2. Fuseruole in impasto a profilo troncoconico (Fig. 2.41). Distribuzione. Presciano, scavi 2010: tomba 52, n. 3. Confronti. Si inquadrano nel tipo A3 di Bazzano, vicino agli esemplari delle tt. 51 Finesa e 817, della fase III della necropoli (Weidig 2014, 419). Fossa: t. 429, n. 19 (prima metà VI secolo a.C.; d’Ercole e Benelli 2004, 179). Datazione. VI-V secolo a.C.
PESI (DA TELAIO? DA RETE ?; Forma 25). Tipo Q.25.1. Pesi di forma discoidale, con foro passante (Fig. 2.41). Varietà a: in impasto. Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009, tomba 319, n. 4. Varietà b: in pietra. Distribuzione. Fossascopana, scavi 1965: tomba 3, n. 2. Datazione. Nel contesto di rinvenimento, molto disturbato, il tipo è associato a materiali di età imperiale.
Tipo Q.10.3. Fuseruole in impasto a profilo troncoconico carenato (Fig. 2.41). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 268, n. 2. Confronti. Si inquadrano nel tipo A3 di Bazzano, diffuso nelle fasi II e III della necropoli (Weidig 2014, 419). Fossa: t. 257, n. 10 (seconda metà VI secolo a.C.); t. 287, n. 6 (VI secolo a.C.) (d’Ercole e Benelli 2004, 101, 115). Campovalano: t. 67, n. 6 (VI secolo a.C.; Chiaramonte Treré e d’Ercole 2003, 52). Variante a: superficie decorata da sei cerchielli concentrici impressi, un allineamento di due segni a croce, motivo a zig-zag al di sotto della carena e scanalature presso l’estremità opposta (Fig. 2.41). Distribuzione. Fossascopana, scavi 1934: tomba 14, n. 1. Datazione. VI secolo a.C.
SPOLETTE (Forma 30). L’unico esemplare di questa forma, tipica delle sepolture femminili, rinvenuto completo di tutte le sue parti (due dischetti in avorio forati di chiusura di due cilindri in avorio, probabilmente tenuti insieme da chiodi in bronzo) è quello presente nella tomba 2 di Fossascopana. I due cilindri sono stati rinvenuti infilati nell’ago di una delle fibule che componevano il corredo, non è chiaro se anche i due dischetti fossero infilati nell’ago di un’altra fibula, essendo state trovate tracce di bronzo in prossimità dei fori, o se queste ultime derivassero dal chiodo che originariamente doveva tenere unita la struttura della spoletta. In altre tombe si rinvengono dischetti singoli in osso, che sono stati identificati come vaghi di collana (vedi, 139140), anche se non si può escludere una destinazione secondaria in quanto pars pro toto
Tipo Q.10.4. Fuseruole in impasto a profilo piriforme, con scanalature orizzontali (Fig. 2.41). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 240, n. 4. Confronti. Vicino a un esemplare da Fossa: t. 382, n. 14 (prima metà VI secolo a.C.; d’Ercole e Benelli 2004, 157). Datazione. VI secolo a.C.
115
Capestrano, I
SPIEDI (Forma 60).
di utensili originariamente realizzati per la filatura.
Gli spiedi sono attestati con tre tipi distinti sulla base della diversa conformazione dell’estremità superiore. Il tipo con testa a ricciolo e quello con testa ad occhiello sono sostanzialmente coevi, anche se il primo risulta in generale maggiormente diffuso, anche in altri contesti medio-adriatici (C. Buoite in Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 240). Il tipo a testa discoidale piena è invece tendenzialmente ascrivibile al periodo ellenistico e, anche nei confronti individuati (i più esaurienti, nella necropoli di Fossa) presenta dimensioni ridotte rispetto a quelli di età arcaica.
Tipo Q.30.1. Spolette in avorio/osso, composte da due cilindri e chiuse alle estremità da due dischi forati (Fig. 2.41). Distribuzione. Fossascopana, scavi 1934: tomba 2, n. 5. Confronti. Trova confronti con gli esemplari delle tombe 889 e 985 di Bazzano, della fase III (Weidig 2014, 422, con discussione della bibliografia di riferimento e della diffusione nelle Marche nel periodo Piceno IVB). Sirolo, area Quagliotti: t. 18 (Lollini 1985, fig. 15, nn. 11-12). Datazione. Fine VI-prima metà V secolo a.C.
Tipo Q.60.1. Spiedi in ferro con testa a ricciolo, verga a sezione quadrangolare o circolare (Fig. 2.42). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 112, n. 5; tomba 166, n. 3; tomba 173, n. 4; tomba 222, n. 6; tomba 230, nn. 5-8; tomba 240, n. 5; tomba 244, nn. 3-5; tomba 254, n. 2; tomba 266, n. 2; tomba 269, n. 2; tomba 271, n. 3; tomba 276, nn. 2-3; tomba 283, n. 2; tomba 284, n. 2. Presciano, scavi 2010: tomba 18, n. 4; tomba 35, n. 3 (frr. pertinenti almeno a 2 esemplari). Capo d’Acqua, scavi 2011: tomba 13, n. 3. Fontanelle, scavi 2012: tomba 4, nn. 3-6); tomba 36, n. 3 (2 es.); tomba 42, n. 4 (3 es.) Confronti. Corrisponde all’unico tipo attestato a Bazzano e ascritto al tipo VII, var. a della classificazione di Kohler, diffuso tra l’VIII e il IV secolo a.C. (Kohler 2000, 202; Weidig 2014, 449). Fossa, t. 227, n. 7 (prima metà/secondo quarto V secolo a.C.); t. 269, n. 6 (prima metà V secolo a.C.) (d’Ercole e Benelli 2004, 92, 103-104). A Campovalano, presenti soprattutto in contesti della prima metà del VI secolo a.C.: t. 37, n. 14; t. 66, n. 29; t. 74, n. 56; t. 119, n. 44 (Chiaramonte Treré e d’Ercole 2003, 31, 51, 56, 70); t. 133, n. 12 (Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 56). Datazione. VI-metà V secolo a.C.
AGHI (FIBULE AD AGO ?) (Forma 40). Tipo Q.50.1. Aghi in osso a profilo circolare ed estremità superiore piatta con due fori passanti (Fig. 2.41). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 315, nn. 3-7. Confronti. Roma, villino Fassi: Di Meo 2006b (età imperiale). Datazione. Sulla base del contesto di rinvenimento, è possibile ascrivere il tipo alla prima età imperiale. ALARI (Forma 50). Gli alari in ferro sono diffusi a partire dall’età Orientalizzante e arcaica nei contesti medioadriatici, in associazione agli spiedi, alludendo al consumo delle carni e alla loro cottura (C. Buoite, in Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 241; Weidig 2014, 451-453). Q.50.1. Alari in ferro con verga a sezione circolare, sostegni ricurvi con staffa angolata (Fig. 2.41). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 230, n. 3 Confronti. Vicino a un esemplare dalla t. 1 di Passo Gabella a Matelica: A. Coen in Silvestrini e Sabbatini 2008, 185, n. 227. Datazione. VI secolo a.C.
Tipo Q.60.2. Spiedi in ferro con testa circolare ad occhiello forato, verga a sezione quadrangolare o circolare (Fig. 2.42). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 219, n. 4; tomba 241, nn. 7-8; tomba 116
La tipologia dei materiali
257, n. 3; tomba 277, n. 4. Fossascopana, scavi 1964: tomba 4 del saggio 8, n. 2 (1 es.). Presciano, scavi 2010: tomba 40, n. 1 (1 es.). Presciano, scavi 2011, tomba 1, n. 4 (2 es.). Fontanelle, scavi 2012: tomba 39, n. 1; 46, n. 4 (2 es.). Confronti. Corrisponde al tipo VIII della classificazione di Kohler, databile tra la metà del VII e il IV secolo a.C. (Kohler 2000, 202). Fossa: t. 552, n. 1 (seconda metà VI secolo a.C.; d’Ercole e Benelli 2004, 207). A Campovalano è presente soprattutto in contesti della prima metà del VI secolo a.C.: t. 2, n. 54; t. 74, n. 56; t. 84, n. 13; t. 163, n. 40; t. 174, n. 32 (Chiaramonte Treré e d’Ercole 2003, 19, 56, 60, 77, 91); t. 69, n. 39; t. 133, n. 12 (Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 13, 56). Loreto Aprutino, necropoli dei Cappuccini, Area PEEP 2: t. 14 (Staffa 2003b, 86). Colfiorito di Foligno: tipo IIIA64 (fase III della necropoli; Bonomi Ponzi 1997, 114). Datazione. VI-metà V secolo a.C. Tipo Q.60.3. Spiedi in ferro di piccole dimensioni con testa circolare piena appiatta (Fig. 2.42). Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 38, n. 7. Confronti. Questo tipo è attestato in contesti recenziori rispetto ai due precedenti, in associazione con gli altri elementi tipici del banchetto di età ellenistico-repubblicana (kreagrai, coltelli). Fossa: t. 224, n. 5 (fine IIIprima metà II secolo a.C.); t. 370, n. 2 (seconda metà II secolo a.C.); t. 432, n. 4 (fine II-inizi I secolo a.C.); t. 469, n. 4 (fine II secolo a.C.); t. 505, n. 3 (metà II secolo a.C.); t. 518, n. 2 (primi decenni I secolo a.C.); t. 63, n. 9 (prima metà II-inizi I secolo a.C.); t. 330, n. 16 (II secolo a.C.-inizi I secolo d.C.) (d’Ercole e Copersino 2004, 57, 88, 115, 142, 145, 183, 211). Datazione. III-I secolo a.C.
trasmesso all’area medio-adriatica dal mondo etrusco (C. Buoite in Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 241-242). Tipo Q.70.1. Grattugie di forma trapezoidale, lama fissata da tre ribattini presso le estremità, con margini ripiegati verso il basso, fori disposti su file parallele (Fig. 2.42). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 186, n. 6. Fossascopana, scavi 1934: tomba 2, n. 6. Confronti. A Bazzano le grattugie sono attestate nella fase III della necropoli (Weidig 2014, 446-448; con tabella aggiornata della diffusione della forma tra VII e V secolo a.C.). A Campovalano è presente soprattutto in contesti della prima metà del VI secolo a.C.: t. 2, n. 46; t. 37, n. 10; t. 42, n. 13; t. 74, n. 24 (Chiaramonte Treré e d’Ercole 2003, 19, 31, 36, 55); t. 95, n. 25; t. 100, n. 25 (Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 22, 29). Colfiorito di Foligno: tipo IIIB34 (fase IIIB della necropoli; Bonomi Ponzi 1997, 131). Datazione. VI-prima metà V secolo a.C. COLTELLI (Forma 80). Si inquadrano in questa forma dell’instrumentum i coltelli che, per dimensioni e forma, nonché per associazione con altri elementi del corredo, non possono essere ascritti al gruppo dei coltelli affila-lama (analizzati con le armi, vedi 143) né ai “rasoicoltelli” (vedi, 120). Si tratta di soli due esemplari, databili in età ellenistica, e associati ad altri strumenti per il trattamento degli alimenti. Tipo Q.80.1. Coltello in ferro a lama allungata, dorso rettilineo, taglio obliquo, codolo rettilineo a sezione quadrangolare, con manico in legno (Fig. 2.42). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 216, n. 11. Confronti. Fossa: t. 38, n. 6 (seconda metà VII secolo a.C.) (d’Ercole e Benelli 2004, 23); Fossa: t. 224, n. 2 (fine III-prima metà II secolo a.C.); t. 505, n. 2 (metà II secolo a.C.); t. 124, n. 27 (metà II secolo a.C.-inizi I secolo d.C.); t. 330, n. 5 (II secolo a.C.-inizi I secolo d.C.) (d’Ercole e Copersino 2003, 57, 142, 198, 209).
GRATTUGIE (Forma 70). Com’è noto, le grattugie in bronzo deposte nelle sepolture di età Orientalizzante e arcaica, alludono all’uso di aromatizzare il vino con formaggio o spezie, attestato dai poemi omerici, 117
Capestrano, I
MESTOLI (Forma 100).
A Campovalano è presente nella prima metà VI secolo a.C.: t. 66, n. 28 (Chiaramonte Treré e d’Ercole 2003, 51); t. 358, n. 9 (Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 104). Datazione. Il tipo è attestato per un ampio arco cronologico, dall’età tardo-orientalizzante arcaica fino al periodo imperiale.
Tipo Q.100.1. Mestolo in ferro con verga a sezione circolare, estremità di forma circolare e manico distinto ingrossato (Fig. 2.43). Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 38, n. 9. Datazione. Sulla base delle associazioni di corredo, il tipo può essere ascritto al II secolo a.C. (vedi il Volume II di questo lavoro).
Tipo Q.80.2. Coltello in ferro a lama triangolare, dorso rettilineo lievemente ricurvo in prossimità della punta, taglio obliquo, codolo rettilineo a sezione quadrangolare (Fig. 2.42). Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 38, n. 7. Confronti. Fossa: t. 503, n. 2 (metà II secolo a.C.); t. 63, n. 4 (prima metà II-inizi I secolo a.C.); t. 520, n. 5 (fine II-primi decenni I secolo a.C.) (d’Ercole e Copersino 2003, 135, 182, 241). Datazione. II-I secolo a.C.
CHIODI (Forma 110). I chiodi sono attestati prevalentemente in sepolture di età ellenistica ed imperiale. In questa sede si definiscono tre tipi, caratterizzati da testa circolare e spillo a sezione quadrangolare e distinti sulla base delle dimensioni. Il tipo con spillo più lungo, è inquadrato tra 6.5 e 12 cm (Q.110.1), quello di dimensioni medio/corte tra 3 e 6 cm (Q.110.2); il tipo più piccolo, che probabilmente aveva funzione ornamentale, misura tra 1.5 e 2 cm (Q.110.3).
KREAGRAI (Forma 90). I due tipi individuati per questa classe, peraltro rappresentati da un singolo esemplare per tipo, si differenziano da quelli noti, ad esempio, nella necropoli di Fossa. Il primo di essi presenta una anomala estremità a forma di disco e il secondo è dotato di sette denti, fusi direttamente con la verga.
Tipo Q.110.1. Chiodi in ferro con spillo lungo a sezione quadrangolare e testa circolare piatta. Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 120, n. 9 (3 es.); tomba 121, n. 4 (2 es.); tomba 138, n. 11 (7 es.); tomba 140, n. 4 (1 es.); tomba 168, nn. 14-15 (2 es.); tomba 180, n. 7 (1 es.); tomba 183, n. 4 (8 es.); tomba 18, n. 10 (1 es.); tomba 190, n. 14 (4 es.); tomba 206, n. 8 (12 es.); tomba 213, n. 4 (2 es.); tomba 214, n. 13 (2 es.); t. 215, n. 10 (4 es. di cui due integri); tomba 217, n. 6 (4 es.); tomba 218, n. 1 (2 es.); tomba 251, n. 18 (11 es. di cui 7 integri); tomba 287, n. 2 (1 es.); tomba 290, n. 7 (2 es.); tomba 315, n. 8 (1 es.); tomba 327, n. 3 (4 es.). Fossascopana, scavi 1973: tomba 2 a camera, presso la volta crollata, n. 38 (7 es.); tomba 2 a camera, deposizione 1, n. 7.
Tipo Q.90.1. Kreagrai in ferro con verga a sezione quadrangolare, estremità di forma discoidale, tre denti (Fig. 2.43). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 216, n. 10. Confronti. Fossa: t. 224, n. 3 (fine III-prima metà II secolo a.C.); t. 503, n. 1 (metà II secolo a.C.) (d’Ercole e Copersino 2003, 57, 135). Datazione. II secolo a.C. Tipo Q.90.2. Kreagrai in ferro con verga a sezione quadrangolare, estremità avvolta ad occhiello, sette denti (Fig. 2.43). Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 38, n. 8. Datazione. Sulla base delle associazioni di corredo, il tipo può essere ascritto al II secolo a.C. (vedi il Volume II di questo lavoro).
Tipo Q.110.2. Chiodi in ferro con spillo corto a sezione quadrangolare e testa circolare piatta. Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 143, n. 6 (7 es. e 2 frr.); tomba 160, n. 4 (7 es.); tomba 174, n. 4 (3 es.); tomba 180, n. 7 (2 es.); tomba 185, n. 10 (1 es.); tomba 190, n. 15 (1 es.); tomba 202, n. 1 (3 es.); tomba 213, n.
118
La tipologia dei materiali
FORBICI (Forma 20).
4 (1 es.); tomba 290, n. 7 (2 es.); tomba 303, n. 18 (1 es.). Fossascopana, scavi 1973: tomba 1, sepoltura sul pavimento “a”, n. 7 (4 es. frammentari); tomba 2, deposizione infantile, n. 11.
Tipo R.20.1. Forbici con manici in ferro e lame triangolari in bronzo a sezione piana (Fig. 2.43). Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012, tomba 35, n. 13. Confronti. Corrisponde al tipo 1, var. 1 dei materiali ellenistici di Campovalano, attestato nella t. 352, n. 3 (d’Ercole, Martellone e Cesana 2016, 46, 127). Datazione. II secolo a.C.
Tipo Q.110.3. Chiodi in ferro di piccole dimensioni, con spillo corto a sezione quadrangolare e testa circolare convessa. Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 138, n. 5 (1 es.); tomba 140, nn. 5-6 (2 es.); tomba 213, n. 5 (4 es.); tomba 217, n. 7 (16 es.)
STRIGILI (Forma 30). GRAPPE (Forma 120). Tipo R.30.1. Strigili in ferro con ligula concava, capulus nastriforme a sezione rettangolare e saldato alla ligula (Fig. 2.43). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 147, n. 8: tomba 199, n. 7; tomba 216, n. 14; tomba 225, n. 7. Fossascopana, scavi 1964, saggio 8: tomba 3, n. 4. Fossascopana, scavi 1973: tomba 1, sepoltura sul pavimento “a”, nn. 8-9; tomba 2, presso la volta crollata, n. 40; tomba 2, deposizione 1, n. 8-9 (2 es.). Fontanelle, scavi 2012: tomba 35, n. 12. Confronti. Fossa: t. 401, n. 4 (fine II secolo a.C.); t. 469, n. 6 (fine II secolo a.C.); t. 2, n. 4 (prima metà II secolo a.C.); t. 124, nn. 23-24 (metà II secolo a.C.-inizi I secolo d.C.); t. 330, nn. 6-7 (II secolo a.C.-inizi I secolo d.C.); t. 520, nn. 16-17 (fine II-primi decenni I secolo a.C.) (d’Ercole e Copersino 2003, 96, 127, 168, 198, 209, 244, con bibliografia di riferimento). Corrisponde al tipo 1 dei materiali ellenistici di Campovalano, attestato nelle fasi I e II (A. Martellone in d’Ercole, Martellone e Cesana 2016, 127, 137). Ancona: t. 13, n. 5 (secondo quarto II secolo a.C.; Colivicchi 2002, 118); t. 17, n. 5 (intorno alla metà del II secolo a.C.; Colivicchi 2002, 135); t. 18, n. 10 (seconda metà II secolo a.C.; Colivicchi 2002, 139-140); t. 39, nn. 4-5 (seconda metà II-primi I secolo a.C.; Colivicchi 2002, 256-257). Datazione. II-inizi I secolo a.C.
Tipo Q.120.1. Grappe in ferro a sezione quadrangolare; verga piegata ad angolo retto; capocchia di forma circolare. Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 138, n. 13; tomba 314, nn. 5-7. Fossascopana, scavi 1973: tomba 2, presso la volta crollata, n. 39 (2 es.). Presciano, scavi 2010: tomba 50, n. 12 (2 es.) STRUMENTARIO PER LA CURA DELLA PERSONA (R). PINZETTE (Forma 10). Tipo R.10.1. Pinzette in ferro, con lame a sezione piana ed estremità espanse (Fig. 2.43). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 222, n. 10. Confronti. A Bazzano le pinzette sono attestate nel corso delle fasi III e IV (Weidig 2014, 412413). A Fossa, dal VI fino al III secolo a.C.: t. 318, n. 8 (metà-terzo quarto VI secolo a.C.); t. 332, n. 7 (secondo quarto VI secolo a.C.); t. 363, n. 17 (prima metà VI secolo a.C.); t. 405, n. 2 (prima metà V secolo a.C.); t. 480, n. 6 (decenni centrali VI secolo a.C.) (d’Ercole e Benelli 2004, 138, 172, 151, 198); t. 201, n. 1 (fine IV secolo a.C.); t. 402, n. 1 (inizi III secolo a.C.) (d’Ercole e Copersino 2003, 45). Vedi il tipo 1 dei materiali ellenistici di Campovalano (A. Martellone in d’Ercole, Martellone e Cesana 2016, 127). Datazione. VI secolo a.C.
SPECCHI (Forma 40). Tipo R.40.1. Specchi in bronzo di forma 119
Capestrano, I
rasoio, vedi la scheda del tipo) e il frammento di lama (n. 7) nella tomba 207 di Fossascopana (per il quale non è possibile proporre un inquadramento tipologico puntuale).
circolare. Varietà a: superficie riflettente leggermente concava e superficie posteriore piana, margini appena ispessiti (Fig. 2.44). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 190, n. 16. Confronti. Corvaro di Borgorose (RI), tumulo del Montariolo: tomba 143 (Alvino 2004, 73, n. 33, III secolo a.C.). Ancona: t. 28, n. 12 (inizi I secolo a.C.; Colivicchi 2002, 201); t. 35, n. 4 (ultimi decenni II-primi I secolo a.C.; Colivicchi 2002, 246); t. 41, n. 11 (fine II-inizi I secolo a.C.; Colivicchi 2001, 264). Varietà b: superficie riflettente e superficie posteriore piane (Fig. 2.44). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 214, n. 11. Fossascopana, scavi 1973: tomba 2 a camera, deposizione 1, n. 10. Confronti. Fossa: t. 63, n. 1 (prima metà II-inizi I secolo a.C.); t. 520, n. 2 (fine II-primi decenni I secolo a.C.) (d’Ercole e Copersino 2003, 182, 241). Ancona: t. 22, nn. 22-24 (ultimo quarto II secolo a.C.; Colivicchi 2002, 157-158): t. 26, n. 9 (ultimo quarto-fine II secolo a.C.; Colivicchi 2002, 187). Datazione. II-inizi I secolo a.C.
Tipo R.50.1. Rasoi semilunati in ferro a lama espansa, dorso concavo, taglio convesso; codolo a sezione quadrangolare in continuità con il dorso, forato per il fissaggio del rivestimento del manico in materiale deperibile (Fig. 2.44). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 177, n. 7; tomba 185, n. 2. Confronti. Corrisponde al tipo C1 di Bazzano, presente nel periodo IIB della necropoli (Weidig 2014, 405). Fossa: t. 116, n. 4 (decenni finali VI-inizi V secolo a.C.); t. 121, n. 8 (terzo quarto VI secolo a.C.) (d’Ercole e Benelli 2004, 18, 47, 54). Campovalano: t. 256, n. 6 (Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 94). Datazione. Fine VII-inizi V secolo a.C. Tipo R.50.2. Rasoi semilunati di piccole dimensioni in bronzo a lama espansa di forma triangolare, dorso concavo, taglio convesso e angolato, breve codolo a sezione piana di forma semicircolare in continuità con il dorso; lama e codolo sono forati per il fissaggio del rivestimento del manico in materiale deperibile (Fig. 2.44). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 207, n. 7. Confronti. Vicino al tipo precedente. Datazione. VI secolo a.C.
RASOI / COLTELLI-RASOI (Forma 50). Dal VI secolo a.C. in avanti, in area medioadriatica non sono più attestati i rasoi di forma lunata diffusi nell’età del Ferro e per gran parte del periodo Orientalizzante. Esclusivi come in area medio-tirrenica delle sepolture maschili, essi sono sostituiti da manufatti prodotti soprattutto in ferro, che progressivamente passano da una forma della lama semilunata e curva sia nel dorso che nel taglio, a esemplari caratterizzati da dorso tendente al rettilineo, che si sovrappongono morfologicamente ai piccoli coltelli. Come già messo in evidenza, però, i rasoi-coltelli di questo periodo, presentano la stessa distribuzione e posizione all’interno delle fosse di deposizione (Weidig 2014, 406-407; Acconcia 2014, 36, 72) e possono pertanto essere assimilati alla funzione degli esemplari più antichi. I rasoi nelle sepolture di Capestrano sono quasi tutti in ferro, con l’eccezione dell’esemplare della tomba 15 di Capo d’Acqua (anche se, per la sua identificazione come
Tipo R.50.3. Rasoi in ferro a lama allungata con taglio e dorso ricurvi, breve codolo a sezione piana (Fig. 2.44). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 211, n. 2; tomba 230, n. 9. Fossascopana, scavi 1934: tomba 3, n. 4. Fontanelle, scavi 2012: tomba 4, n. 12. Confronti. Corrisponde al tipo C2 di Bazzano, coevo al tipo precedente (Weidig 2014, 405). Fossa: t. 302, n. 4; t. 320, n. 2 (fine VII-prima metà VI secolo a.C.); t. 347 (prima metà/decenni centrali VI secolo a.C.) (d’Ercole e Benelli 2004, 123, 135, 144). Campovalano: t. 3, n. 11 (Chiaramonte Treré e d’Ercole 2003, 19); t. 95, n. 26; t. 100, n. 26 (Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 22, 29). 120
La tipologia dei materiali
Chiaramonte Treré e d’Ercole 2003, 87, n. 15, tav. 103; 88, n. 6, tav. 104; Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 44, nn. 37-38, tav. 55). Le placche sono realizzate a lamina piena o a traforo e decorate da file parallele di inserti con capo emisferico (“pallottole”). Il gruppo più diffuso in area centro-italica tra la fine del VII e la metà del VI secolo a.C. è quello cd. “Capena”, che comprende esemplari composti da due placche alle estremità, con aggancio a maniglia (non attestato tra i materiali di Capestrano) o con il sistema a ganci ed occhielli (Colonna 1958; Weidig 2014, 199-207, per la diffusione in Abruzzo e in Italia centrale del tipo, vedi la lista alle pagine 214-223) Gli esemplari a nove pallottole sarebbero di poco più antichi rispetto a quelli a dodici o a sedici pallottole. Appartiene al gruppo “Capena” il Tipo S.10.1 qui definito. Più rari sono gli esemplari composti da un numero più elevato di placche (almeno tre), alcune delle quali caratterizzate dalla lavorazione a traforo (Tipo S.10. 2). In via altamente ipotetica, sono compresi nell’ambito dei cinturoni anche alcuni elementi in lamina di bronzo di forma quadrangolare e rettangolare, forati presso le estremità per il passaggio di due o quattro chiodini (Tipo S.10.3). La diffusione limitata di questi manufatti anche nelle altre necropoli abruzzesi, rende problematica la loro identificazione. J. Weidig ha recentemente ascritto a un unico gruppo sia le laminette bronzee di semplice forma rettangolare e due fori passanti, che quelle di forma quadrangolare, a volte rinvenute piegate e combinate, a coppie, con resti di materiali deperibili (Weidig 2014, 426-428). Lo studioso ha inoltre sottolineato la varia distribuzione degli esemplari presenti a Bazzano in tombe maschili, femminili e infantili, suggerendone una interpretazione come rivestimenti di cinturoni, di stringhe per l’aggancio delle spade (come nella t. 912 di Bazzano) o, anche, di strumenti per la tessitura (nella t. 689). Va inoltre rilevato come gli esemplari delle tombe 166 di Fossascopana e 54 di Presciano questi materiali siano stati rinvenuti ripiegati all’interno delle olle del ripostiglio, secondo un uso attestato nella t. 104 Azzurra di Bazzano, nella 415 di Fossa (l’olla è ascritta al III secolo a.C., vedi avanti) e nella 30
Datazione. Fine VII-inizi V secolo a.C. Tipo R.50.4. Rasoi in ferro a lama allungata triangolare con dorso e taglio ricurvi; rivestimento del manico realizzato in legno e fascette in ferro (Fig. 2.44). Distribuzione, Fossascopana, scavi 1973, tomba 1, sepoltura sul pavimento “b”, n. 1. Confronti. Il tipo, attestato in un unico esemplare, si avvicina al tipo C3 di Bazzano, presente nella fase IIB2 della necropoli. Datazione. Il rinvenimento in associazione a una sepoltura di età ellenistica avanzata (si veda il Volume II di questo lavoro), suggerisce che l’esemplare di riferimento possa essere un elemento residuale o anche uno sviluppo recenziore rispetto agli altri tipi. Tipo R.50.5. Rasoi in bronzo con lama corta, taglio ricurvo, dorso rettilineo e breve codolo a sezione piana (Fig. 2.44). Distribuzione. Capo d’Acqua, scavi 2011: tomba 15, n. 8. Datazione. Pur in mancanza di confronti puntuali, il contesto di rinvenimento consente di inquadrare il tipo nell’ambito del periodo arcaico (si veda il Volume II di questo lavoro). ORNAMENTI (S). CINTURONI (Forma 10). I cinturoni nei contesti funerari in esame sono attestati in un numero ridotto di esemplari e sono pertanto identificabili quali indicatori del livello emergente delle sepolture in cui si rinvengono. Come nel resto del territorio medio-adriatico, tra l’Orientalizzante recente e il periodo arcaico, i cinturoni sono prevalentemente associati a sepolture femminili e sono composti da placche quadrangolari in bronzo, applicate su fasce in materiale deperibile, probabilmente cuoio, decorate a loro volta da motivi ottenuti da minuti ribattini/chiodini in bronzo, raramente recuperati integralmente in corso di scavo (a tale proposito, si veda la pianta della tomba 13 degli scavi del 1934 a Fossascopana, in Moretti 1936, 95, fig. 1; o la riproduzione dei cinturoni delle tombe 115, 172 e 173 di Campovalano, in 121
Capestrano, I
Fossa (d’Ercole e Benelli 2004, 55, n. 1), databile alla fine del VII-inizi del VI secolo a.C. Due esemplari simili sono stati recentemente rinvenuti nella necropoli del Piano a Navelli (AQ), inquadrabile nello stesso periodo (Acconcia 2015, 13, fig. 7.4). Datazione: ultimo quarto del VII-primo quarto del VI secolo a.C.
del Piano a Navelli, femminile, databile in una fase avanzata della necropoli (V-IV secolo a.C.). In questo senso, è possibile ipotizzare un uso rituale, ancora scarsamente perspicuo, diffuso a partire dal periodo tardo-arcaico fino a quello ellenistico. Allo stesso modo, il secondo esemplare della tomba 54 di Presciano, si trovava deposto ai piedi del defunto, come attestato nella t. 971 di Bazzano (individuo infantile).
Tipo S.10.3. Cinturoni (?) a placche rettangolari o quadrangolari, con due o quattro fori passanti alle estremità (Fig. 2.45). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 166, n. 4; Presciano, scavi 2010: tomba 53, n. 3. Confronti. Per l’esemplare della tomba 166 di Fossascopana, Fossa, t. 415, n. 1 (III secolo a.C.; d’Ercole e Benelli 2004, 241); Navelli, il Piano, t. 30 (S.L. Ferreri in Acconcia 2014, 273). Per gli esemplari della tomba 53 di Fossascopana, Bazzano t. 104 Azzurra, n. 2 (fase III); 689, n. 2; 912, n. 1 (fase III) (Weidig 2014, 960, 1083, 1192), inquadrabili tra la fase IIB2 e III della necropoli. Datazione. I confronti proposti suggeriscono di ascrivere il tipo a un orizzonte recenziore rispetto a quelli precedenti, dal secondo quarto del VI secolo a.C., fino alla prima età ellenistica.
Tipo S.10.1. Cinturoni a due placche piene decorate a pallottole, con aggancio ad occhielli. Varietà a: placche decorate da 9 pallottole (3 file da 3 pallottole; Fig. 2.45): Distribuzione. Fossascopana, scavi 1934: tomba 13, n. 1. Confronti. Si inquadra nel tipo 1, var. a di Bazzano, presente nella fase IIB1 della necropoli (Weidig 2014, 1239, n. 1). Datazione. Fine del VII-inizi del VI secolo a.C. Varietà b: placche decorate da 12 pallottole (4 file da 3 pallottole; Fig. 2.45): Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 30, n. 6. Confronti. Si inquadra nel tipo 1, var. b di Bazzano, attestato nella fase IIB, con una maggiore concentrazione nella sotto-fase IIB2 (Weidig 2014, 214). Fossa: t. 152, n. 2 (prima metà-decenni centrali del VI secolo a.C.); 334, n. 2 (fine del VII-inizi del VI secolo a.C.); 480, n. 1 (decenni centrali del VI secolo a.C.) (d’Ercole e Benelli 2004, 59, 139, 198 1. Datazione. Fine del VII-decenni centrali del VI secolo a.C.
Tipo S.10.4. Cinturoni con aggancio in filo di bronzo avvolto a doppia spirale (Fig. 2.45). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 177, n. 5. È incerta l’attribuzione dell’unico elemento rappresentativo del tipo, rinvenuto in corrispondenza delle ginocchia del defunto della tomba 177. Esemplari simili, adespoti, sono conservati a Kalsruhe e nella collezione Gorga insieme ai corrispondenti elementi per l’aggancio. Per il primo di essi F. Jurgeit ha proposto un’interpretazione come gancio di cintura in materiale deperibile, mentre per l’esemplare della Gorga è stata avanzata l’ipotesi che possa trattarsi della chiusura di una collana (Jurgeit 1990, 650, n. 1152; E. Biancifiori in Benedettini 2012, 262, n. 692). Per ambedue gli esemplari sono comunque richiamati confronti con materiali da Suessula dell’VIII secolo a.C., e con ganci di collane conservate al Museo di Villa Giulia e
Tipo S.10.2. Cinturone a due placche piene decorate a pallottole (all’estremità) e placca centrale decorata a traforo con motivo ornitomorfo distribuito su quattro riquadri (Fig.2.45). Distribuzione. Capo d’Acqua, scavi 1992: tomba 1, n. 3. Confronti. L’esemplare della tomba 1 del 1992 di Capo d’Acqua, conservato solo parzialmente, trova confronti puntuali con il cinturone della t. 705 di Bazzano (Weidig 2014, 200, 1104-1105, nn. 1-3), inquadrabile nella fase IIB1 della necropoli. È composto da due placche piene e tre a traforo il cinturone della tomba 139 di 122
La tipologia dei materiali
Weidig 2006, 12; in questa sede, si vedano i tipi S.A.1 e 3, S.B.2 e 4). L’area interna del territorio abruzzese, inoltre, sembra sviluppare soprattutto produzioni in ferro, mentre gli esemplari in bronzo che si rinvengono nelle necropoli dell’aquilano sono introdotti presumibilmente dall’area costiera (teramana e, soprattutto, pescarese), più aperta al contatto con la cultura materiale del Piceno, dove si localizzano varie produzioni abbastanza ben riconoscibili. Le fibule bronzee di Capestrano si ascrivono ai tipi ad arco semplice (definite “preCertosa” da E. Benelli in d’Ercole e Benelli 2004), ad arco a doppia ondulazione, (definite “tipo Loreto Aprutino-Caporciano” da J. Weidig), mentre sono sporadicamente attestati esemplari dei tipi Certosa centro-italiche o a molla bilaterale. È comunque evidente una notevole corrispondenza tra i tipi in ferro e in bronzo e, a tale proposito, va segnalato come i processi post-deposizionali di ossidazione e corrosione non consentono di leggere adeguatamente il trattamento originario degli esemplari in ferro, che potevano essere anche ageminati, come dimostrano casi di Fossa e Bazzano (è pertanto condivisibile quanto affermato da J. Weidig sulla minore puntualità nella definizione dei tipi in ferro proprio a causa dei diversi processi di conservazione; Weidig 2014, 229). Quanto sembra emergere dal quadro tratteggiato di seguito, inoltre, è una tendenza dei tipi in bronzo con arco ondulato a circolare con un lieve ritardo rispetto a quelli in ferro, così come dei tipi ad arco semplice a tutto sesto in bronzo rispetto a quelli ad arco rialzato in ferro. Gli esemplari in ferro, infatti, si datano dalla prima metà del VI secolo a.C. (se non dalla fine del VII), mentre quelli in bronzo sembrano coerentemente databili a partire dalla seconda metà dello stesso secolo. Un elemento che si rileva a Capestrano come in altri contesti dell’Abruzzo antico, poi, è la persistenza di alcune fogge dal periodo arcaico a quello ellenistico, segno forse di una certa inerzia nello sviluppo di mode o gusti ma, anche, possibile indicatore di un uso rituale di deporre manufatti conservati a lungo. Nella definizione dei tipi non sono stati considerati discriminanti gli avvolgimenti della molla (segnalati negli elenchi di distribuzione) né i motivi decorativi, estremamente variabili,
provenienti da Cerveteri o Palestrina (Colonna 1992, nota 23). L’esemplare della tomba di Fossascopana è stato rinvenuto senza il corrispondente elemento femmina: non è chiaro quindi se la sua presenza nella tomba possa essere l’esito di eventi post-deposizionali o della deposizione della pars pro toto di un manufatto più complesso. Le dimensioni dell’esemplare (largh. 6) e l’attribuzione a un individuo maschile sembrano escludere che possa trattarsi di un elemento di collana e suggeriscono di interpretarlo, se non come gancio di un cinturone, comunque di un elemento dell’abbigliamento in materiale deperibile (stoffa o cuoio). FIBULE (Forma 20). Le fibule sono il gruppo maggiormente rappresentato della classe degli ornamenti. In questa sede si è adottato un criterio di classificazione basato in primo luogo sullo sviluppo morfologico degli esemplari, successivamente articolato per tipi realizzati in bronzo e in ferro. Sono state individuate due famiglie tipologiche principali, ovvero quella delle fibule ad arco semplice (A), nella quale sono inquadrati i tipi ad arco a tutto sesto, ad arco rialzato, “Certosa”, e quella delle fibule ad arco ondulato (B), caratterizzata da tipi con arco a doppia o a tripla ondulazione. È incerta l’attribuzione a un tipo di fibule in ferro con staffa a disco di tre esemplari dalla tomba 11 di Presciano, e pertanto presi in esame separatamente (vedi, 130). I tipi presenti nelle necropoli di Capestrano presentano un notevole grado di standardizzazione e una ridotta varietà che va probabilmente riferita, come già accennato, alla quasi completa assenza di contesti dell’età del Ferro e degli inizi del periodo Orientalizzante (diverso, ad esempio, è il caso di Fossa e Bazzano, dove sono attestati tipi a drago a sanguisuga, ad arco rivestito ecc.). Proprio nell’Orientalizzante recente e nel periodo arcaico, infatti, si inquadra quella che E. Benelli e J. Weidig hanno efficacemente definito “koiné metallurgica medio-adriatica”, segnata appunto dalla diffusione di modelli ricorrenti, con varianti regionali legate alla minore o maggiore intraprendenza delle officine locali (Benelli e 123
Capestrano, I
avvolgimenti). Fossascopana, scavi 1934, tomba 12, n. 10 Fossascopana, scavi 1965: tomba 1, nn. 4-6 (molla a due avvolgimenti). Fossascopana, scavi 1973: tomba a camera 2, materiali presso la volta crollata, nn. 41-44 Presciano, scavi 2010: tomba 52, nn. 5-6. Via dell’Olmo, scavi 2011: tomba 1, nn. 3-5. Confronti. Corrisponde al tipo G1 di Bazzano, diffuso nella necropoli tra la fase IIB e III (Weidig 2014, 244-245). Fossa: t. 24, nn. 3-4 (fine VII-inizi VI secolo a.C.); t. 177, n. 3; t. 400, nn. 8-29 (primi decenni VI secolo a.C.); t. 258, nn. 1-3; t. 267, n. 2; t. 382, nn. 2-5, 7 (prima metà VI secolo a.C.); t.547, n. 6 (decenni centrali VI secolo a.C.); t. 290, nn. 5-6 (seconda metà VI-prima metà V secolo a.C.); t. 362, n. 1 (fine VI-V secolo a.C.) (d’Ercole e Benelli 2004, 18, 74, 101-102, 116, 149, 157, 169, 207). A Campovalano gli esemplari riferibili a questa varietà si datano prevalentemente nella prima metà del VI secolo a.C.: t. 2, n. 48; t. 57, n. 11; t. 75, nn. 22-27; t. 160, n. 9; t. 164, nn. 53-59; t. 174, n. 23; t. 176, nn. 5, 7-8 (Chiaramonte Treré e d’Ercole 2003, 19, 43, 58, 73, 82, 90, 94); t. 155, n. 18 (Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 63). Varietà b: staffa con estremità a bottone (Fig. 2.45). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 141, n. 4. Confronti. Per Bazzano, vedi sopra. Fossa: t. 47, n. 5 (fine VII-inizi VI secolo a.C.); t. 267, nn. 5-6 (prima metà VI secolo a.C.) (d’Ercole e Benelli 2004, 26, 102). Come già accennato, a Campovalano gli esemplari con staffa lunga ed estremità a bottone rappresentano il tipo prevalente tra le fibule in ferro ad arco semplice, datati nel corso della prima metà del VI secolo a.C.; tra i numerosi esempi, si vedano la t. 2, n. 47; t. 57, n. 12; t. 65, n. 6; t. 75, n. 28; t. 172, n. 16; t. 176, nn. 6, 9 (Chiaramonte Treré e d’Ercole 2003, 19, 43, 48; 58, 87); t. 103, nn. 2-6; t. 122, n. 28; t. 171, nn. 8-9; t. 207, nn. 7-8 (Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 31, 49, 66, 77); a questi si aggiunge quello della t. 180 (nn. 19-28), databile nella seconda metà del VI secolo a.C. (Chiaramonte Treré e d’Ercole 2003, 100-101) e quelli dai contesti genericamente ascrivibili al VI secolo a.C. (Acconcia 2014, 143-144, tabb. 3-5). Vicino al
che sono invece riportati nel catalogo. Come già accennato, infine, si distinguono i tipi in bronzo da quelli in ferro, per quanto corrispondenti, per la possibilità che l’uso distinto dei due metalli indichi anche produzioni differenti. FIBULE AD ARCO SEMPLICE (20.A). Tipo S.20.A.1. Fibule in ferro con arco semplice rialzato; staffa lunga con sezione “a virgola” e terminazione a ricciolo o a bottone; molla a due o tre avvolgimenti. Si tratta di uno dei tipi più diffusi nell’area aquilana interna tra la fine dell’Orientalizzante e l’età arcaica, caratterizzato dall’arco rialzato, che può arrivare a comporre un gomito molto accentuato. Gli esemplari di Capestrano presentano una notevole standardizzazione, con arco solo lievemente ingrossato e un campo di variabilità dimensionale attestato su misure abbastanza costanti, con solo due casi (le fibule nn. 3-4 della tomba 141 di Fossascopana) che sembrano ascrivibili a una variante miniaturistica (per Bazzano, è stata messa in evidenza l’associazione degli esemplari miniaturizzati con sepolture infantili: Weidig 2014, 244). La maggior parte delle fibule inquadrate in questo tipo presenta l’estremità della staffa piegata a comporre un ricciolo, mentre in un solo caso quest’ultima termina con un piccolo globetto applicato (“bottone”), anche se in altri contesti, come a Bazzano o Fossa, gli esemplari con questo tipo di estremità sono molto più frequenti e a Campovalano sono attestati in misura prevalente rispetto a quelli con estremità a ricciolo, in contesti della prima metà del VI secolo a.C. A tale proposito, G. Baratti (in Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 197) suggerisce una lieve anteriorità dei primi, anche se gli esemplari con estremità della staffa a ricciolo vi si trovano comunque associati in vari contesti, ad es. le tt. 2, 57, 75, 176. Le due terminazioni sono quindi inquadrate in varietà distinte. Varietà a: staffa con estremità a ricciolo (Fig. 2.45). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 130, nn. 2-5 (molla a tre avvolgimenti; allo stesso tipo, probabilmente, anche il n. 6); tomba 141, n. 3; tomba 170, n. 4; tomba 182, n. 3; tomba 198, n. 4; t. 268, n. 4 (molla a tre 124
La tipologia dei materiali
Loreto Aprutino, necropoli dei Cappuccini, zona PEEP: t. 40, n. 1; necropoli in proprietà Corolongo: t. 4, nn. 1-3; necropoli di Colle Carpini (Staffa 2003a, 588, 568-570, 576, 579, fig. 18, n. 23). A Campovalano, gli esemplari vicini al tipo in esame sono inquadrabili prevalentemente nella seconda metà/fine del VI-inizi del V secolo a.C.: t. 93, nn. 3-4 (Chiaramonte Treré e d’Ercole 2003, 62); t. 192, n. 4, t. 443, nn. 1-3 (Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 67-68, 116; vedi anche G. Baratti, 199); va rilevato come in questa necropoli le fibule in bronzo con arco a tutto sesto ed estremità a ricciolo senza nodulo fermapieghe tendano invece a datarsi nella prima metà del VI secolo (t. 60, n. 1, t. 64, n. 7, 448, n. 1, 467, n. 6; Chiaramonte Treré e d’Ercole 2003, 46, 47; Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 117, 120). Ancora a Campovalano, il tipo è attestato anche in età ellenistica, con esemplari inquadrati nel locale tipo 2, varietà 1, presente nella t. 511, n. 2 (A. Martellone in d’Ercole, Martellone e Cesana 2016, 132; il tipo ricorre in ambedue le fasi proposte per il periodo ellenistico). Datazione. Il tipo si inquadra nel periodo tra la seconda metà/fine del VI e la prima metà del V secolo a.C., con rare attestazioni in età ellenistica (Weidig 2014, 246, nota 605).
tipo III a 61 della necropoli di Colfiorito di Foligno, ascritto alla locale fase IIIA (Bonomi Ponzi 1997, 114). Datazione. Il tipo e la sua variante sono attestati tra la fine del VII/inizi del VI secolo a.C. e la fine del VI, fino a sporadiche attestazioni agli inizi del V. Anche a Capestrano la sua presenza in tombe del periodo arcaico sembra confermare tale datazione, pur essendo attestato anche in una delle sepolture della tomba a camera 2, ellenistica, scavata nel 1973 a Fossascopana. Tipo S.20.A.2. Fibule in bronzo con arco a tutto sesto; nodulo fermapieghe alla base dell’arco; staffa lunga con sezione “a virgola” e terminazione a ricciolo; molla a due o tre avvolgimenti (Fig. 2.45). Gli esemplari ascritti a questo tipo sono in qualche caso caratterizzati da decorazioni incise sulla staffa (tomba 276 di Fossascopana, nn. 45). L’esemplare della tomba 269 di Fossascopana, n. 3 presenta l’arco con un lieve rigonfiamento centrale. Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 267, n. 2 (molla a tre avvolgimenti; decorazione incisa sull’arco); tomba 269, n. 3 (molla a due avvolgimenti); tomba 276, nn. 4-7 (molla a due avvolgimenti). Presciano, scavi 2010: tomba 45, n. 6 (molla a tre avvolgimenti); tomba 41, n. 3 (molla a tre avvolgimenti); tomba 51, n. 1; tomba 54, n. 3 (molla a tre avvolgimenti). Confronti: corrisponde al tipo G2, var. a di Bazzano, spesso avvicinato al gruppo delle cd. “pre-Certosa”, attestato nelle fasi III e IV (Weidig 2014, 245-246, vedi la nota 607 per una disamina delle attestazioni). A Fossa: t. 162, n. 1 (ultimi decenni VI secolo a.C.); t. 194, n. 2 (fine VI-primi decenni V secolo a.C.); t. 375, n. 1 (ultimi decenni VI-primi decenni V secolo a.C.): t. 405, ind. A, n. 1 (prima metà V secolo a.C.); t. 476, n. 1 (seconda metà VI-primi decenni V secolo a.C.) (d’Ercole e Benelli 2004, 63, 80, 155, 172, 195). Navelli, necropoli del Piano: t. 62 (fine VI-inizi V secolo a.C.; F. Properzio in Acconcia 2014, 268). Nel territorio pescarese, il tipo sembra caratteristico dei contesti della fine del VI-inizi V secolo a.C., vedi ad es. a Pescara, Campo Sportivo ex Gesuiti: t. 6, n. 1 (Staffa 2003a, 561, 588). A
Tipo S.20.A.3. Fibule in ferro con arco semplice a tutto sesto; staffa lunga con sezione “a virgola” e terminazione a ricciolo; molla a due o tre avvolgimenti (Fig. 2.45). Il tipo corrisponde al precedente S.10.A.3, realizzato in ferro, anche se negli esemplari presi in esame non è possibile definire la presenza del nodulo fermapieghe alla base della staffa. Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 146, n. 2; tomba 148, n. 1 (molla a tre avvolgimenti); tomba 154, n. 1 (molla a due avvolgimenti); tomba 166, n. 5 (molla a due avvolgimenti); tomba 242, n. 3 (molla a due avvolgimenti); tomba 277, n. 5. Presciano, scavi 2010 (esemplari in cattivo stato di conservazione): tomba 2, n. 2; tomba 42; tomba 45, n. 2. Via dell’Olmo, scavi 2011: tomba 7, nn. 1-3 (molle a due avvolgimenti). Capo d’Acqua, scavi 2011: tomba 26, n. 2 125
Capestrano, I
(molla a due avvolgimenti). Fontanelle, scavi 2012 (esemplari in cattivo stato di conservazione): tomba 22, n. 4; tomba 43, n. 4; tomba 46, n. 5 (molla a due avvolgimenti). Confronti. Corrisponde al tipo G2 di Bazzano (vedi tipo precedente). A Fossa: t. 319, n. 3; t. 274, n. 2 (fine VI-prima metà V secolo a.C.); t. 382, n. 9 (prima metà VI secolo a.C.); t. 449, n. 3 (V secolo a.C.) (d’Ercole e Benelli 2004, 112, 133, 157, 188). Si avvicina al tipo in esame il tipo 53, var. B e C di Alfedena, scavi 19741979, da contesti della I e II fase della necropoli, anche se in questo caso l’arco è spesso lievemente ingrossato con sezione a losanga (Parise Badoni et al. 1982, 12). Datazione. Il tipo si inquadra nello stesso periodo del precedente S.A.10.2 (seconda metà/fine del VI-prima metà del V secolo a.C.). Tipo S.20.A.4. Fibule in ferro con arco semplice a tutto sesto; staffa corta con sezione “a virgola” e terminazione a ricciolo; molla a due o tre avvolgimenti. Questo tipo rappresenta lo sviluppo del precedente S.20.A.3. Caratterizzato da una staffa più corta, terminante a piccolo ricciolo, è presente già in età tardo-arcaica ma è attestato prevalentemente nel corso del periodo ellenistico. Allo stesso orizzonte si ascrivono esemplari caratterizzati dall’arco più assottigliato, inquadrati come varietà. Varietà a: piccolo arco a tutto sesto (Fig. 2.45). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 123, n. 6 (molla a due avvolgimenti); tomba 135, n. 6 (molla a due avvolgimenti); tomba 147, n. 7; tomba 167, n. 6 (molla a due avvolgimenti); tomba 199, n. 8 (molla a tre avvolgimenti); tomba 239, n. 4 (molla a due avvolgimenti); sono probabilmente pertinenti al tipo gli esemplari nella tomba 131, n. 7 (molla a due avvolgimenti); tomba 144, n. 12; tomba 161, n. 1; tomba 227, nn. 2-6 (molla a tre avvolgimenti); tomba 252, n. 5 (molla a due avvolgimenti). Presciano, scavi 2010: tomba 36, n. 3; tomba 37, n. 4; tomba 48, n. 2. Fontanelle, scavi 2012: tomba 53, n. 2. Confronti. Fossa: t. 256; t. 428, n. 1 (prima metà III secolo a.C.); t. 402, n. 2 (inizi III 126
secolo a.C.) (d’Ercole e Copersino 2003, 62, 66, 98, 111). Il tipo sembra presente già in età tardo-arcaica: a Campovalano, nella t. 195, la fibula n. 5 è associata con materiali ceramici della prima metà del V secolo a.C. (Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 68), ed è attestato nel successivo periodo ellenistico in esemplari ascritti al locale tipo 2, varietà 2, ad es. nelle tombe 338, n. 1; 344, n. 2; 395, n. 2; 414, n. 1 (A. Martellone in d’Ercole, Martellone e Cesana 2016, 132; il tipo ricorre in ambedue le fasi proposte per il periodo ellenistico). Ad Alfedena, si segnalano affinità con il tipo 3, varietà 1B degli scavi 1974-1979, attestato nella fase II e III (Parise Badoni et al. 1982, 11, 34; Parise Badoni 2002, 83-84). Varietà b: arco ampio e assottigliato (Fig. 2.45). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 156, n. 5 (molla a due avvolgimenti); tomba 163, n. 5 (molla a due avvolgimenti); tomba 188, nn. 3-4 (molla a due avvolgimenti). Fontanelle, scavi 2012: tomba 35, n. 8 (molla a tre avvolgimenti); tomba 50, n. 3. Confronti. Fossa: t. 69, n. 2 (ultimi decenni IVprimi decenni III secolo a.C.); tomba 76, n. 2 (ultimo quarto III secolo a.C.); t. 279, n. 3 (ultimo quarto del IV-primo quarto del III secolo a.C.); t. 328, n. 2 (fine III-inizi II secolo a.C.) (d’Ercole e Copersino 2003, 33, 69, 78). In età ellenistica, a Campovalano, è attestato nelle tombe 273, nn. 1-2; 297, n. 1; 361, n. 1; 365, n. 2; 421, n. 1; 427, n. 1 (fase I e II; A. Martellone in d’Ercole, Martellone e Cesana 2016, 132). Penna S. Andrea (TE): Guidobaldi 1995, 54 (rif. Al Periodo Piceno VI). Datazione. Sulla base dei confronti proposti, si suggerisce un avvio della produzione del tipo nell’ambito del V secolo a.C., e una sua continuità nel IV e III. Tipo S.20.A.5. Fibule in ferro con arco semplice, trapezoidale/ribassato; staffa lunga con sezione “a virgola” (Fig. 2.45). Tra il periodo arcaico e l’età ellenistica sono attestati alcuni esemplari di fibule in ferro spesso in cattivo stato di conservazione, accomunati dall’andamento irregolare dell’arco, con tendenza ad abbassarsi e a comporre una o due pieghe asimmetriche. Non è chiaro se si possa trattare di esemplari che imitano i tipi
La tipologia dei materiali
bronzei “Certosa” ad arco angolato (Naso 2003, 274, nn. 514-515; Acconcia 2015, 5, nota 18). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 267, n. 1; tomba 268, n. 5; tomba 271, n. 4; tomba 281, n. 8. Fontanelle, scavi 2012: tomba 1, nn. 5-7. Confronti. Il tipo non è attestato nella necropoli di Bazzano; è invece presente a Fossa: t. 290, nn. 3-4 (seconda metà VI-prima metà V secolo a.C.; d’Ercole e Benelli 2004, 116); t. 42, n. 2 (V-IV secolo a.C.); t. 220, n. 1 (fine IV-inizi III secolo a.C.) (d’Ercole e Copersino 2003, 31, 52). A Campovalano, il tipo trova confronti con il locale tipo 3, varietà 2 delle fibule ellenistiche, presente ad es. nelle tombe 350, n. 1; 433, n. 2; 542, n. 2 (A. Martellone in d’Ercole, Martellone e Cesana 2016, 132; ricorre nelle fasi IB e IIA del periodo ellenistico della necropoli). Camerano, contrada San Giovanni: t. t. 26, 29, 34, t. 42, t. 96, t. 47 (Lollini 1979, 56). Numana, area Davanzali: tomba 195, n. 32 (metà IV secolo a.C.; M. Landolfi in Berti, Bonomi e Landolfi 1997, 96); Numana-Sirolo, area Quagliotti: t. 25, n. 05.03 (seconda metà IV secolo a.C.; M. Landolfi in Berti, Bonomi e Landolfi 1997, 97). Datazione. Il tipo presenta una lunga durata, dall’avanzato VI secolo a.C. al periodo ellenistico. La maggior parte degli esemplari di Capestrano è attestato in contesti di età arcaica, tranne quello della tomba 281.
Pescara, datata al V secolo a.C. (Staffa 2001, 89, n. 6). Datazione. I confronti sopra proposti sembrano suggerire una recenziorità del tipo in esame rispetto al già ricordato S.20.A.3, anche se la presenza di quest’ultimo nella stessa tomba 182 di Fossascopana, orienta una datazione verso l’orizzonte più basso in cui il tipo con arco semplice a sezione circolare si pone, quindi verso la fine del VI-inizi del V secolo a.C. Tipo S.20.A.7. Fibule in bronzo ad arco semplice angolato / “Certosa” centro-italiche, staffa con sezione “a T”, arco a sezione circolare (Fig. 2.45). Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 25, n. 3. Confronti. Nella storia degli studi, questo tipo e quello successivo sono stati distinti da quello delle fibule “Certosa” proprie, e considerato come caratteristico dell’Italia centrale (Weidig 2014, 273, con discussione della bibliografia). Corrisponde al tipo N1 di Bazzano, attestato nella fase III della necropoli (Weidig 2014, 274-276, con ampia discussione delle attestazioni). Datazione. Fine VI-prima metà del V secolo a.C.
Tipo S.20.A.8. Fibule in bronzo ad arco semplice angolato / “Certosa” centro-italiche, Tipo S.20.A.6. Fibule in ferro con arco staffa con sezione “a T”, arco a sezione piatta, semplice a sezione quadrangolare, con borchia decorato da motivi a cerchi concentrici (Fig. conica applicata; staffa lunga con sezione “a J” 2.45). e terminazione sinusoide; molla a due Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 15, n. 3; tomba 20, nn. 2-5; tomba 25, nn. 4-6. avvolgimenti (Fig. 2.45). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: Confronti. Corrisponde al tipo N2, var. a delle fibule “Certosa” centro-italiche, di Bazzano, tomba 182, n. 2 Confronti. L’esemplare, di dimensioni superiori databile alla prima metà del V secolo a.C., con alla media, rappresenta probabilmente una maggiore concentrazione nei decenni l’evoluzione del tipo S.20.A.3 verso tipi ad arco centrali dello stesso (Weidig 2014, 277-280, a losanga, che trovano la migliore leggibilità con elenco delle attestazioni). Fossa: t. 227, n. nella necropoli di Alfedena. Si registra una 4 (prima metà/secondo quarto V secolo a.C.); vicinanza con i tipi 25 e 63 degli scavi 1974- t. 278, n. 1 (prima metà V secolo a.C.) 1979 nella necropoli, anche se questi ultimi (d’Ercole e Benelli 2004, 92, 113). Necropoli presentano l’arco meno rilevato e a losanga di Colfiorito di Foligno: tipo III A 47, ascritto pronunciata, attestati nella I e nella II fase alla locale fase IIIA (Bonomi Ponzi 1997, (Parise Badoni et al. 1982, 12; Parise Badoni 112). 2002, 79). Vicino a un esemplare dalla t. 10 Datazione. Prima metà del V secolo a.C. della necropoli del Campo Sportivo ex Gesuiti a 127
Capestrano, I
decorazioni geometriche sull’arco e sulla staffa, tra cui fasci di tratti, croci di S. Andrea, motivi a denti di lupo ecc. (descritte nel catalogo). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 150, n. 1 (molla a tre avvolgimenti); tomba 185, nn. 13-15 (molla a due avvolgimenti); tomba 240, nn. 6-7 (molla a tre avvolgimenti); tomba 241, nn. 9-12 (molla a tre avvolgimenti); è attribuibile allo stesso tipo probabilmente anche l’esemplare della tomba 198, n. 5. Fossascopana, scavi 1934: tomba 2, nn. 7-8 (molla a tre avvolgimenti). Capo d’Acqua, scavi 2011: tomba 17, n. 3 (molla a tre avvolgimenti). Presciano, scavi 2010: tomba 39, nn. 2-5 (molla a tre avvolgimenti). Confronti. Il tipo corrisponde al tipo I2 di Bazzano (“Loreto Aprutino-Caporciano”), diffuso nella fase III della necropoli (Weidig 2014, 258-260, con elenco delle attestazioni). Pescara, necropoli del Campo Sportivo ex Gesuiti: t. 6, n. 2 (fine VI-primi decenni V secolo a.C.; Staffa 2003a, 561, 588). Loreto Aprutino, necropoli di Colle Carpini (V secolo a.C.; Staffa 2003a, 579, fig. 18, n. 21). Datazione. Il tipo sembra concentrarsi tra la metà del VI e la prima metà del V secolo a.C.
Tipo S.20.A.9. Fibule in bronzo con arco rilevato a losanga e molla bilaterale (Fig. 2.45). L’unica attestazione di questo tipo si presenta lacunosa della staffa e di parte dell’arco. La sua definizione quindi non sicura: è comunque sembrato necessario inserirla in questa sede, trattandosi al momento anche dell’unico esemplare con molla bilaterale dalle necropoli. Diffusione. Fossascopana, scavi 2003-2009, tomba 159, n. 4. Confronti. L’esemplare può essere avvicinato a un gruppo di fibule diffuse nell’Abruzzo interno e costiero (Campovalano; Loreto Aprutino; Pettorano sul Gizio; Casale di Cocullo; Tocco da Casauria; Comino a Guardiagrele; Atessa), che già P.G. Guzzo definiva “sannitiche”, probabilmente influenzate da modelli celtici (Guzzo 1972, 56; per una disamina degli esemplari abruzzesi, si veda Tagliamonte e Raccar 2007, 214-215; anche Benelli e Rizzitelli 2010, 60). A Campovalano, gli esemplari di questo gruppo sono stati attribuiti al locale tipo 5 delle fibule di età ellenistica, attestato tra la fase IB e IIA (A. Martellone in d’Ercole, Martellone e Cesana 206, 132-133). Si veda anche la classe IV delle fibule della necropoli “del Nuovo Museo” a Pontecagnano (SA), datata nella seconda metà del IV secolo a.C. (Serritella 2013, 163). Datazione. Seconda metà/fine del IV-metà del III secolo a.C.
Tipo S.20.B.2. Fibule in ferro con arco a doppia ondulazione, asimmetrico, a sezione circolare; staffa lunga con sezione “a virgola” e terminazione a ricciolo; molla a due o tre avvolgimenti (Fig. 2.46). Il tipo, ampiamente diffuso in area centroitalica, nelle necropoli di Capestrano è attestato in un cospicuo numero di esemplari, ai quali vanno probabilmente aggiunti molti frammenti di difficile puntualizzazione tipologica. Sebbene la sua maggiore diffusione coincida con il periodo arcaico, a Capestrano sono noti anche alcuni esemplari da sepolture di età ellenistica (nelle tombe 161 e 212 di Fossascopana e nella tomba 53 di Fontanelle): non è chiaro se questi ultimi vadano identificati come produzioni tarde o, come già accennato, come cimeli; i due esemplari da Fossascopana presentano le due curve maggiormente angolate. Questo elemento potrebbe segnalare uno sviluppo interno al tipo. Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 129, n. 3 (molla a due avvolgimenti);
FIBULE CON ARCO ONDULATO (20.B). Tipo S.20.B.1. Fibule in bronzo con arco a doppia ondulazione, asimmetrico, a sezione circolare nella parte anteriore e a nastro in quella posteriore; staffa lunga “a virgola” e terminazione a ricciolo; molla a due o tre avvolgimenti (Fig. 2.46). Il tipo è diffuso nell’area costiera, specificamente nel pescarese, con un certo numero di attestazioni anche nell’area interna dell’Abruzzo antico, tanto da essere recentemente identificato come “tipo Loreto Aprutino-Caporciano” (vedi avanti). Esso è probabilmente prodotto proprio nell’area costiera e circola nell’aquilano ispirando le locali produzioni (vedi il successivo S.20.B.2). È caratterizzato dalla frequente presenza di 128
La tipologia dei materiali
tomba 130, n. 7; tomba 161, n. 2; tomba 212, nn. 5-6; tomba 242, n. 4 (molla a tre avvolgimenti); tomba 272, nn. 1-6 (molla a due avvolgimenti); tomba 274, nn. 1-2 (molla a due avvolgimenti). Presciano, scavi 2010: tomba 54, nn. 4-7. Via dell’Olmo, scavi 2011: tomba 7, n. 5 (molla a doppio avvolgimento). Fontanelle, scavi 2012: tomba 25, n. 2 (molla a doppio avvolgimento); tomba 30, nn. 7-11 (molla a doppio avvolgimento); tomba 53, n. 3. Confronti. Corrisponde al tipo I1 di Bazzano, attestato prevalentemente in ferro o in ferro con ageminature, dalla fase IIB1 alla fase III (Weidig 2014, 257, nota 628). Fossa: t. 159, nn. 1, 3-4; t. 184, n. 6; t. 208, n. 5 (secondo-terzo quarto VI secolo a.C.); t. 168, n. 11 (secondo quarto del VI secolo a.C.); t. 234, n. 1 (metà-seconda metà VI secolo a.C.); t. 269, nn. 2-3; t. 314, n. 5; t. 363, n. 8; t. 441, n. 1 (prima metà del VI secolo a.C.); t. 318, nn. 3, 5 (metà-terzo quarto VI secolo a.C.); t. 399, n. 1 (primi decenni VI secolo a.C.); t. 306, nn. 11, 14, 15, 17; t. 480, n. 2; t. 547, nn. 2-3, 5 (decenni centrali VI secolo a.C.) (d’Ercole e Benelli 2004, 60-61, 69, 79, 85, 96, 103, 125, 128, 132, 151, 165-166, 184, 198, 206-207). Navelli, Il Piano: t. 62 (fine VI-inizi V secolo a.C.; F. Properzio in Acconcia 2014, 29). A Campovalano, le fibule di questo tipo sono attestate fin dalla prima metà del VI secolo a.C., associate con esemplari in ferro ad arco rialzato ed estremità a bottone: t. 119, nn. 41-43 (Chiaramonte Treré e d’Ercole 2003, 70); t. 207, n. 7 (Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 77). Per gli esemplari rinvenuti nei contesti di età ellenistica, si veda il tipo 4, varietà 2 delle fibule ellenistiche di Campovalano, attestato nelle tombe 359, n. 1 (A. Martellone in d’Ercole, Martellone e Cesana 2016, 132; il tipo ricorre in ambedue le fasi proposte per il periodo ellenistico). Nelle tt. 4 e 30 della necropoli del Piano a Navelli sono venuti alla luce esemplari di fibule di questo tipo, la cui datazione è però al momento discussa, ma comunque recenziore rispetto alla piena età arcaica (l’inquadramento proposto per questi contesti è tra la metà del V e il III secolo a.C.; S.L. Ferreri in Acconcia 2014, 271, vedi nota 37). Datazione. Il tipo sembra prevalentemente attestato nell’ambito del VI secolo a.C., 129
soprattutto nei decenni centrali, anche se probabilmente viene prodotto fino all’età ellenistica. Tipo S.20.B.3. Fibule in bronzo con arco a tripla ondulazione, simmetrico a sezione circolare, con nodulo fermapieghe alla base dell’arco; staffa lunga con sezione “a virgola” e terminazione a ricciolo; molla a tre avvolgimenti (Fig. 2.46). Si tratta di un tipo scarsamente attestato nelle necropoli di Capestrano, in soli due contesti rispettivamente del periodo arcaico ed ellenistico. L’esemplare più recente è caratterizzato dalle dimensioni ridotte (inquadrato come variante). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 241, n. 13 (molla a tre avvolgimenti); Confronti. Corrisponde al tipo L1, var. a di Bazzano, che coincide con la diffusione delle fibule del tipo G2, var. a, ovvero il Tipo S.20.A.2 della presente classificazione (Weidig 2014, 262) Datazione. Il tipo sembra attestato a partire dalla fine del VI-prima metà del V secolo a.C. Variante a: dimensioni ridotte (Fig. 2.46). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 251, n. 22 (molla a tre avvolgimenti). Confronti. Corrisponde al tipo L1, var. b di Bazzano, attestato in almeno un contesto della fase IIB2 (t. 739; Weidig 2014, 263). Datazione. Fine del VI-prima metà del V secolo a.C. Tipo S.20.B.4. Fibule in ferro con arco a tripla ondulazione, simmetrico a sezione circolare; staffa lunga con sezione “a virgola” e terminazione a ricciolo; molla a due o tre avvolgimenti. Il tipo è presente con esemplari di dimensioni normali ma anche con un certo numero di fibule di dimensioni maggiori (7.4-12 di lunghezza e 3.6-5.4 di altezza). A tale proposito, va sottolineato come per le fibule con arco a doppia ondulazione J. Weidig abbia segnalato una associazione a sepolture di alto rango che potrebbe essere valida anche in questo caso (Weidig 2014, 257). Come per quello precedente, si rileva la maggiore concentrazione del tipo in età arcaica, ma anche una attestazione in età ellenistica (tomba 124 di Fossascopana).
Capestrano, I
Varietà a: dimensioni normali (Fig. 2.46). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 124, n. 1 (molla a doppio avvolgimento); tomba 130, n. 8 (molla a due avvolgimenti), n. 9 (molla a tre avvolgimenti); tomba 177, n. 4 (molla a due avvolgimenti); tomba 185, n. 3 (molla a due avvolgimenti); tomba 186, n. 8 (molla a due avvolgimenti); tomba 271, nn. 5-7 (molla a due avvolgimenti). Si possono ascrivere al tipo malgrado le cattive condizioni di rinvenimento: tomba 112, n. 6 (molla a doppio avvolgimento); tomba 170, nn. 5-6; tomba 171, n. 4; tomba 185, n. 4; tomba 186, nn. 7, 9-10 (molla a due avvolgimenti); tomba 204, n. 3; tomba 210, n. 2 Capo d’Acqua, scavi 1992: tomba 1, nn. 4-5. Via dell’Olmo, scavi 2011: tomba 7, n. 6. Capo d’Acqua, scavi 2011: tomba 15, n. 3; tomba 16, nn. 2-3 (molla a due avvolgimenti). Presciano, scavi 2010: tomba 49, nn. 3-5; tomba 52, nn. 7-10. Fontanelle, scavi 2012: tomba 22, nn. 5-11 (molla a due avvolgimenti); tomba 30, nn. 1215 (molla a due avvolgimenti); tomba 42, nn. 56 (molla a due avvolgimenti). Varietà b: dimensioni superiori (Fig. 2.46). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 112, n. 6 (molla a tre avvolgimenti); tomba 170, nn. 5-6; tomba 186, n. 8 (molla a due avvolgimenti); tomba 204, n. 3 (molla a tre avvolgimenti). Presciano, scavi 2010: tomba 16, n. 5. Confronti. Il tipo corrisponde al tipo L1 di Bazzano, attestato tra la fase IIB e III della necropoli (Weidig 2014, 262). Fossa: t. 159, n. 1 (secondo-terzo quarto VI secolo a.C.) (d’Ercole e Benelli 2004, 60). Pescara, Campo Sportivo ex Gesuiti: t. 3, n. 11 (ultimi decennifine VI secolo a.C.; Staffa 2003a, 558 e 588. A Campovalano, t. 66, nn. 21-22 (prima metà VI secolo a.C.; Chiaramonte Treré e d’Ercole 2003, 51; vedi anche G. Baratti in Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 198). Il tipo è attestato anche in età ellenistica nella necropoli del Piano a Navelli (AQ), nei contesti della fase più recente, ascrivibili come già accennato a un periodo tra la metà del V e il III secolo a.C. (S.L. Ferreri, in Acconcia 2014, 271, nota 38). Datazione. VI secolo a.C. 130
Fuori tipologia. Come già accennato, sono problematicamente ascritti a fibule i reperti nn. 1-3 dalla tomba 11 della necropoli di Presciano (Fig. 2.46). Si tratta di tre dischi in ferro, due dei quali del diametro di 5.4, uno di 4, per uno spessore di 0.2. Uno dei due dischi più grandi e quello più piccolo presentano tracce di una staffa di ferro saldata su una delle facce. Due dischi sono stati rinvenuti in corrispondenza del torace e l’altro presso i piedi dell’individuo infantile della tomba 11. Dischi simili sono associati a fibule con staffa a disco, che riproducono modelli in bronzo a due pezzi o con arco serpeggiante, come quelle delle tombe 83 e 551 di Fossa (in cui l’arco però è decorato a traforo); delle tombe 41 e 47 della necropoli di Comino a Guardiagrele o della tomba infantile 1505 di Bazzano. L’esemplare della tomba 83 di Fossa, richiama un esemplare da Matelica, loc. Brecce, tomba 77, datata al primo quarto dell’VIII secolo a.C. (Sabbatini 2008, 61-62, n. 10), mentre i due della tomba 551 potrebbero essere avvicinati ai tipi Lo Schiavo 336 (tipo San Marzano) e 338 (da Capua; Lo Schiavo 2010, 653-655, 656-657, il primo ascritto alla fase IFe2A; il secondo senza specifica cronologia ma comunque riferibile a quella del precedente). Gli esemplari di Guardiagrele, sono databili al IFe1 (Acconcia e d’Ercole 2012, 19). Per la fibula di Bazzano, inquadrata nel periodo tra la metà dell’VIII e la prima metà del VII secolo a.C., sono stati proposti confronti con esemplari dalla necropoli delle acciaierie di Terni e da Teramo-La Cona, dell’avanzata età del Ferro (Weidig 2014, 232-233). Per tutti gli esemplari portati a confronto, però, è evidente come il disco della staffa sia continuo rispetto ad essa. La combinazione di due dischi sul torace del defunto e la presenza della staffa applicata, potrebbero invece suggerire di riferire questi elementi a un tipo di fibula in ferro che riproduceva i modelli a doppia spirale o, anche, una fibula a quattro spirali in ferro (vedi, ad es. gli esemplari dalla t. 26 della necropoli della Cona a Teramo; d’Ercole e Martellone 2006, 255). Gli interventi post-deposizionali documentati in corso di scavo inducono a considerare un pesante disturbo di tali manufatti (vedi, il Volume II di questo lavoro).
La tipologia dei materiali
Confronti. L’esemplare è ascrivibile al periodo tardo-orientalizzante/arcaico per la sua presenza in associazione al cinturone S.10.2 (vedi, 122). Corrisponde al tipo 2, Forma D di Bazzano, inquadrabile nella fase IIB, soprattutto nella sottofase IIB1 (Weidig 2014, 347). Fossa: t. 177, n. 1 (prima metà VI secolo a.C.); t. 205, n. 1 (prima metà VI secolo a.C.) (d’Ercole e Benelli 2004, 74, 83). Cales, necropoli del Migliaro: t. 89, n. 99 (prima metà VI secolo a.C.; A. Izzo in Gilotta e Passaro 2012, 124). Datazione. Ultimo quarto del VII-prima metà del VI secolo a.C.
ARMILLE (Forma 30). La maggior parte degli esemplari in esame presenta la verga a sezione circolare, e vengono distinti in due famiglie: con verga a sezione circolare (famiglia tipologica A), mentre un solo tipo (rappresentato al momento da un unico esemplare) è del tipo a fascia (inquadrato nella famiglia B). Nella classificazione che segue, l’elemento discriminante per la definizione dei tipi è considerato esclusivamente lo sviluppo morfologico e non, come per le fibule, anche il metallo con cui i vari esemplari sono realizzati. Non è chiaro, infatti, se l’uso di un metallo o di un altro possa indicare produzioni distinte. Nel contesto in esame, la maggior parte degli esemplari (in bronzo e in ferro) sono associati con sepolture di individui sub-adulti, mentre quelli più complessi, ad esempio le varianti decorate del tipo S.30.2 o il tipo a sei avvolgimenti S.30.6, sono associati a sepolture di donne adulte. Solo il tipo in ferro a due avvolgimenti S.30.3, invece, è stato rinvenuto in una sepoltura di individuo maschio adulto. ARMILLE (30.A).
Tipo S.30.A.3. Armille con verga a sezione circolare, capi aperti ed estremità distinte e a fascia (Fig. 2.46). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 188, n. 5 (BR); l’esemplare, unico al momento per il tipo, è decorato sulle estremità da tre cerchielli impressi delimitati da tratti incisi. Serie di tratti incisi da sei a otto si leggono anche sulla verga. Confronti. Vicino ad esemplari da Loreto Aprutino: Papi 1980, 26, nn. 49-59, figg. 8.c-d. Datazione. Sulla base delle associazioni nel contesto di rinvenimento (ad es. con una coppa Tipo H.240.A.9) il tipo può essere inquadrato tra la seconda metà III e gli inizi II secolo a.C.
CON VERGA A SEZIONE CIRCOLARE
Tipo S.30.A.1. Armille con verga a sezione circolare e capi aperti sovrapposti (Fig. 2.46). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 129, n. 5 (BR); tomba 159, n. 5 (BR; con decorazioni ad angoli incisi sulle estremità); tomba 186, n. 15 (BR). Fontanelle, scavi 2012: tomba 14, n. 5 (BR); tomba 25, n. 7 (BR). Confronti. Si tratta di un tipo di lunga durata, inquadrabile nel tipo 2 del Gruppo II, Forma C di Bazzano, attestato nella fase IIB/IIB1 (Weidig 2014, 344-345; l’esemplare della tomba 159 di Fossascopana si avvicina alla var. b dello stesso tipo). È attestato a Fossa fin dall’età del Ferro (vedi il tipo 5; d’Ercole e Benelli 2004, 169). Alfedena, tipo 50 degli scavi 1974-1979 (Parise Badoni et al. 1982, 17).
Tipo S.30.A.4. Armille con verga a sezione circolare, con capi aperti; estremità distinte avvolte alla verga da una spirale a sei giri (Fig. 2.46). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 167, n. 7 (BR). Confronti. Fossa: t. 351, nn. 1-2 (prima metà III secolo a.C.; d’Ercole e Copersino 2003, 86). Vicino al tipo 3 della fase ellenistica di Campovalano, attestato nella t. 319, n. 2 e nella t. 604, nn. 5-6 (A. Martellone in d’Ercole, Martellone e Cesana 2016, 130). Datazione. Prima metà del III secolo a.C. Tipo S.30.A.5. Armille con verga a sezione circolare spessa, capi aperti a doppio avvolgimento (Fig. 2.46). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 212, n. 7 (FE). Capo d’Acqua, scavi 2011: tomba 26, nn. 4-5 (BR).
Tipo S.30.A.2. Armille con verga a sezione circolare, capi aperti sovrapposti e terminazioni a globetti (Fig. 2.46). Distribuzione. Capo d’Acqua, scavi 1992: tomba 1, nn. 6-7 (BR). 131
Capestrano, I
metà VI-inizi V secolo a.C.; Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 80-81). Pescara, Campo Sportivo ex Gesuiti: t. 6, n. 7 (fine VI-primi decenni V secolo a.C.; Staffa 2003a, 561). Datazione. VI secolo a.C.-inizi V secolo a.C. Varietà e: a otto avvolgimenti (Fig. 2.47). Distribuzione. Fossascopana, scavi 1934: tomba 14, n. 3 (BR). Confronti. Campovalano: t. 403, n. 5 (prima metà VI secolo a.C.; Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 111). Datazione. VI secolo a.C.
Fontanelle, scavi 2012: tomba 26, n. 5 (BR). Confronti. Si inquadra nel tipo 1 del Gruppo I, Forma A di Bazzano, attestato nella fase IIAIIB della necropoli (Weidig 2014, 337). Datazione. Pieno VII-VI secolo a.C. Tipo S.30.A.6. Armille con verga a sezione circolare sottile, capi aperti a più di due avvolgimenti. Il tipo con le sue varietà, caratterizzato da verga sottile e attestato a Capestrano solo con esemplari in bronzo, si inquadra nel tipo 3 del Gruppo I, Forma A di Bazzano, diffuso nella fase IIB della necropoli (Weidig 2014, 340). Varietà a: a tre avvolgimenti (Fig. 2.47). Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 27, nn. 4-5. Datazione. VI secolo a.C. Varietà b: a quattro avvolgimenti (Fig. 2.47). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 124, nn. 2-3 (BR; con tratti incisi in corrispondenza delle estremità). Fossascopana, scavi 1965: tomba 2, n. 1 (BR). Confronti. S. Benedetto in Perillis (AQ), necropoli di Colle S. Rosa: tomba 7, n. 3, datato al VI secolo a.C. (Mieli 1998, 60); Campovalano (TE), necropoli, tomba 47, n. 3 (prima metà del VI secolo a.C.; Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 38). Datazione. VI secolo a.C. Varietà c: a cinque avvolgimenti (Fig. 2.47). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 130, nn. 11-12 (BR); tomba 146, n. 3 (BR). Via dell’Olmo, scavi 2011: tomba 7, nn. 5-6 (BR). Confronti. Fossa: t. 415, nn. 2-3 (fine VII-prima metà VI secolo a.C.) (d’Ercole e Benelli 2004, 176). Datazione. VI secolo a.C. Varietà d: a sei avvolgimenti (Fig. 2.47). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 132, nn. 1-2 (BR; presentano tratti incisi in corrispondenza delle estremità). Capo d’Acqua, scavi 2011: tomba 26, nn. 6-7 (BR). Confronti. Campovalano: t. 214, n. 14 (seconda
ARMILLE A FASCIA (30.B). Tipo S.30.B.1. Armille a fascia con capi rettilinei, aperti e sovrapposti (Fig. 2.47). Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 41, n. 1 (BR). Confronti. Fossa: t. 162, n. 3 (ultimi decenni VI secolo a.C.; d’Ercole e Benelli 2004, 64). Datazione. Fine VI secolo a.C. Tipo S.30.B.2. Armille a fascia, con capi rastremati, aperti sovrapposti (Fig. 2.47). Distribuzione. Fossascopana, scavi 1934: tomba 14, n. 4 (BR; l’esemplare è decorato da fasci di solcature). Confronti. Fossa: t. 363, n. 2 (prima metà VI secolo a.C.) (d’Ercole e Benelli 2004, 150). Pescara, Campo sportivo ex Gesuiti: t. 6, nn. 4 e 11 (fine VI-primi decenni V secolo a.C.; Staffa 2003a, 561). Vicino a un esemplare dalla t 127 di Campovalano (prima metà VI secolo a.C.; Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 3839, n. 11). Montegiorgio (AP), loc. Montamboni, collezione Compagnoni Natali: Coen 2002-2003, 181, 194, n. 77, fig. 23, 2 (esemplare ascritto al Piceno IVA). Datazione. VI secolo-inizi del V secolo a.C. ANELLI (Forma 40). Come già è stato ampiamente sottolineato nella letteratura archeologica, gli anelli comprendono manufatti che in parte possono essere propriamente ascritti all’ornamento, soprattutto quelli digitali, ma anche utilizzati per comporre decorazioni complesse (tessute nelle stoffe) o per agganciare pendenti a fibule o altri elementi o, infine, quelli da sospensione, che nei contesti 132
La tipologia dei materiali
esaminati si rinvengono associati prevalentemente alle armi (questi ultimi non sono qui presi in considerazione). Elementi utili per definire la funzione primaria degli anelli sono, ovviamente, la posizione di rinvenimento (non è infrequente infatti rinvenirli ancora infilati alle falangi dei defunti), ma anche le dimensioni (Weidig 2014, 351; C. Buoite in Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 214). Nel complesso di seguito preso in esame, a parte gli anelli forniti di castone, la cui funzione sembra pertanto sicura, si rileva una maggiore concentrazione del diametro dei vari esemplari intorno ai 2 cm (1.7-2.1), plausibilmente utilizzati come anelli digitali per individui adulti o giovanili. In alcune sepolture di sub-adulti, si rileva la presenza di anellini digitali con diametro inferiore (vedi la tomba 162 con anelli di 1.2 di diametro). Sono inoltre presenti alcuni anelli di dimensioni superiori, tra 2.4 e 3.1 (tombe 216, 290, 303), forse anelli digitali di individui maschili adulti o anelli da sospensione. In questa sede, si propone di distinguere due famiglie tipologiche, ovvero quella degli anelli “semplici” (A) e quello degli anelli con castone (B); non sarà inoltre utilizzato come discrimine per definire i tipi il materiale utilizzato (ferro, bronzo, argento, oro e anche osso, specificato di seguito): contrariamente alle fibule, infatti, non è chiaro se l’uso di uno o l’altro materiale possa identificare produzioni distinte.
Fossascopana, scavi 1973: tomba 2, deposizione 1, nn. 9-12 (4 esemplari; BR). Presciano, scavi 2010: tomba 42, n. 5 (2 esemplari, funzionali all’aggancio di due pendenti; BR); tomba 45, n. 7 (BR); tomba 42, n. 7 (FE). Fontanelle, scavi 2012: tomba 53, n. 4 (BR); tomba 35, nn. 9-10 (OS). Nella tomba 11 di Presciano, scavi 2010 sono presenti 74 anelli in bronzo del diametro di 0.8, 16 tra 1.5-1.6 e uno del diam. di 3, probabilmente da riferire alla decorazione di una stoffa utilizzata come sudario. Confronti. Il tipo rientra nel tipo 1 della Forma A di Bazzano, diffuso tra la fine del VII e il VI secolo a.C. (Weidig 2014, 351). Fossa: t. 18, nn. 1-2 (prima metà VII secolo a.C.); t. 306, n. 6 (decenni centrali VI secolo a.C.) (d’Ercole e Benelli 2004, 16, 124); t. 69, n, 1 (ultimi decenni IV-inizi III secolo a.C.) (d’Ercole e Copersino 2003, 33). Datazione. Il tipo copre un arco cronologico abbastanza ampio, dal VII al III secolo a.C. Tipo S.40.A.2. Anelli semplici con verga sottile a sezione circolare e capi aperti; un capo è avvolto a comporre un cappio fissato da un bottoncino; l’altro capo, agganciato al cappio termina a ricciolo (Fig. 2.47). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 162, n. 1 (AU). Confronti. Il tipo non trova al momento confronti puntuali. Datazione. La datazione del tipo risulta problematica, mancando anche indizi desumibili dal resto del corredo funerario (vedi, 238).
ANELLI SEMPLICI (40.A). Tipo S.40.A.1. Anelli semplici con verga sottile a sezione circolare o compressa/quadrangolare (Fig. 2.47). Nella maggior parte dei casi, gli esemplari ascritti a questo tipo presentano la verga a sezione circolare, mentre solo le coppie di anelli delle tombe 2 del 1973 (nn. 9-10, vedi avanti) e 250 di Fossascopana hanno la verga a sezione quadrangolare. Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 182, n. 4 (BR); tomba 259, n. 5 (BR); tomba 303, n. 19 (BR); tomba 186, n. 16 (AG); tomba 188, n. 6 (AG); tomba 216, n. 12 (FE); tomba 250, nn. 4-5 (BR); tomba 268, n. 6; tomba 290, n. 11 (FE).
Tipo S.40.A.3. Anelli semplici con verga spessa a sezione circolare e costolatura centrale (Fig. 2.47). Distribuzione. Presciano, scavi 2010: tomba 42, n. 6 (BR). Confronti. Si inquadra nel tipo 1 della Forma D di Bazzano, spec. l’esemplare dalla t. 141 Finesa, della fase IIB2 (Weidig 2014, 363). Fossa: t. 524, n. 2 (prima metà VI secolo a.C.?; d’Ercole e Benelli 2004, 204). Datazione. VI secolo a.C.
133
Capestrano, I
Guzzo 1993, 167 (III secolo a.C.). Ancona: t. 33, n. 12 (seconda metà II secolo a.C.; Colivicchi 2002, 238); t. 34, n. 5 (ultimo quarto II-inizi I secolo a.C.; Colivicchi 2002, 228-229). Datazione. III-II secolo a.C.
Tipo S.40.A.4. Anelli semplici a fascia (Fig. 2.47). Distribuzione. Presciano, scavi 2010: tomba 42, n. 8 (AG). Fontanelle, scavi 2012: tomba 37, n. 2. Confronti. Il tipo non trova al momento confronti puntuali. Datazione. La presenza nel corredo della tomba 42 di Presciano di una fibula del tipo S.20.A.2, suggerisce un inquadramento alla fine del VIinizi del V secolo a.C.
PENDENTI (Forma 50).
Tipo S.40.A.5. Anelli semplici a fascia e forma rettangolare (Fig. 2.47). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 162, n. 2 (decorato con un motivo applicato, rappresentante un fallo; AU). Confronti. Il tipo non trova al momento confronti puntuali. Datazione. Come per il precedente S.40.A.2, datazione del tipo risulta problematica, mancando anche indizi desumibili dal resto del corredo funerario (vedi, 238). ANELLI CON CASTONE (40.B). Tipo S.40.B.1. Anelli con castone circolare e verga sottile a sezione compressa (Fig. 2.47). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 135, n. 7 (AG); tomba 281, n. 9 (AG): Fontanelle, scavi 2012: tomba 35, n. 11 (AG); tomba 53, n. 5 (con castone inciso; BR). Confronti. Pontecagnano, scavi del “Nuovo Museo”: Serritella 2013, 165, classe II (fine IVinizi II secolo a.C.). Ancona: t. 23, n. 1 (ultimo quarto II secolo a.C.; Colivicchi 2002, 165-166). Datazione. Fine IV-II secolo a.C. Tipo S.40.B.2. Anelli con castone ovale o a losanga e verga a fascetta (Fig. 2.47). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 144, n. 14 (castone inciso; BR); tomba 123, n. 7 (AG); tomba 144, n. 13 (castone inciso; AG); tomba 153, n. 8 (FE); tomba 156, n. 6 (tracce di decorazione incisa sul castone; BR). Confronti. Fossa: t. 76, n. 1; t. 491, n. 1 (ultimo quarto III secolo a.C.) (d’Ercole e Copersino 2003, 33, 133). Campovalano: t. 604, n. 3 (età ellenistica; d’Ercole, Martellone e Cesana 2016, 107). Vedi anche i tipi III.B, n. 2 e III.C in 134
Tipo S.50.1. Pendenti conici in lamina di bronzo ripiegata, con foro passante sulla sommità per l’aggancio con anelli (Fig. 2.48). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 124, n. 2; tomba 212, n. 8. Via dell’Olmo, scavi 2011: tomba 1, n. 6 (decorato con fasci di linee incise). Confronti. Si tratta di un tipo che solitamente si rinviene associato a fibule o anelli, in quantità superiori al singolo esemplare (C. Buoite in Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 203, registra il rinvenimento di tre esemplari per i contesti non disturbati). In contesti piceni, pendenti dello stesso tipo compongono ornamenti complessi, in un numero elevato di esemplari, ad esempio sui pettorali del “tipo San Genesio”, attestati soprattutto nella fase Piceno IVA (Seidel 2006, 111-112). Corrisponde al tipo 1 di Bazzano, attestato in sepolture infantili delle fasi IIA e IIB (Weidig 2014, 313-314, che ne tratteggia lo sviluppo a partire da contesti etrusco-laziali dell’VIII secolo a.C., fino agli esemplari di Alfedena nel V). Fossa, t. 160, n. 7 (esemplari decorati; prima metà VI secolo a.C.); t. 492, n. 4 (d’Ercole e Benelli 2004, 62, 202). Campovalano: t. 41, n. 7 (VI secolo a.C.), t. 162, n. 7 (prima metà VI secolo a.C.) (Chiaramonte Treré e d’Ercole 2003, 34, 74); t. 206, n. 6 (prima metà VI secolo a.C.), t. 214, n. 12 (seconda metà VI-inizi V secolo a.C.), t. 252, n, 6 (prima metà VI secolo a.C.), t. 257, n. 5 (prima metà VI secolo a.C.) (Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 76, 80, 93, 94); nella stessa necropoli sono anche attestati esemplari decorati con fasci di linee incise (t. 234, n. 3; t. 467, n. 7; Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 89, 120). Belmonte Piceno, Museo Pigorini: esemplari datati al VI secolo a.C. (Coen 2015, 216). Colfiorito di Foligno: tipo III A 50, diffuso nella locale fase IIIA (Bonomi Ponzi 1997, 112). Datazione. Ultimo quarto del VII-VI secolo a.C.
La tipologia dei materiali
Tipo S.50.5. Pendenti in ambra a testa femminile (Fig. 2.48). Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012, tomba 26, n. 11-13. Varietà a: grandi dimensioni. Varietà b: medie dimensioni. Varietà c: piccole dimensioni. Confronti. Il tipo compone con vaghi in ambra (vedi avanti) collane complesse, la cui diffusione è tipica dell’Abruzzo meridionale costiero, con attestazioni anche nell’area interna (vedi, Benelli e Rizzitelli 2010, 61-62; qui viene proposta una produzione risalente almeno alla seconda metà del IV secolo a.C., localizzata in centri della costa frentana, con riferimento a Papi 1979, 91-95, fig. 28). Fossa: t. 351, n. 3 (prima metà III secolo a.C.) (d’Ercole e Copersino 2003, 86). Bazzano: t. 883 (in d’Ercole e Copersino 2003, 374). Corrisponde al tipo 3 dei pendenti ellenistici di Campovalano, presente nelle tt. 320 (n. 4) e 416 (n. 4; A. Martellone in d’Ercole, Martellone e Cesana 2016, 130). Datazione. Fine del IV-prima metà del III secolo a.C.
Tipo S.50.2. Pendenti bivalvi in lamina di bronzo lanceolati, con appiccagnolo composto dalla stessa lamina ritagliata (Fig. 2.48). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 180, n. 8 (i due esemplari sono decorati da una fila di 12 puntini impressi su ambedue le facce). Confronti. Corrisponde al tipo 5 di Bazzano, attestato però in ferro nella tomba 245 della fase III (Weidig 2014, 332). Sirolo, area Davanzali: tomba 435 (Piceno IVA; Lollini 1985, fig. 7, n. 12; Datazione. VI secolo a.C.-inizi V secolo a.C. Tipo S.50.3. Pendenti bivalvi a bulla in lamina di bronzo o in ferro (Fig. 2.48). Sono attestati prevalentemente esemplari di dimensioni ridotte (diam. min. 1-diam. max. 1.8), singoli o in più esemplari a comporre collane o pendenti complessi. A proposito delle attestazioni note per Campovalano, C. Buoite sottolinea il legame con le sepolture infantili e femminili e il valore amuletico (Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 204-205). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 210, n. 8 (11 esemplari; BR) che compongono una collana con vaghi in ambra (vedi, 275). Presciano, scavi 2010: tomba 42, n. 5 (BR). Fontanelle, scavi 2012: tomba 23, n. 4 (BR). Confronti. Corrisponde al tipo 3, var. C di Bazzano, attestato sia in bronzo che in ferro in sepolture femminili o infantili della fase III della necropoli (Weidig 2014, 331). Campovalano: t. 40, n. 6, t. 177. n. 7 (prima metà VI secolo a.C.; Chiaramonte Treré e d’Ercole 2003, 32, 95). Datazione. VI secolo a.C.
Tipo S.50.6. Pendente composito composto da una verga piena in ferro, con lamina di forma rettangolare innestata da anellini e lamina inferiore alla quale sono sospese bulle in ferro (Fig. 2.48). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 130, nn. 13-14. Confronti. Non è possibile una ricostruzione puntuale di questo tipo, presente solo nella tomba 130 di Fossascopana e in pessimo stato di conservazione. Esso però sembra trovare confronti con un esemplare rinvenuto nella tomba 924 di Bazzano, della fase III, anch’essa femminile, rinvenuto in prossimità del capo della defunta, identificato come pendente o anche come copricapo (Weidig 2014, 221). Anche l’esemplare di Capestrano è stato rinvenuto in corrispondenza del collo della defunta, se ne propone quindi una interpretazione come pendente/collana. Datazione. Ultimo quarto del VI-prima metà V secolo a.C.
Tipo S.50.4. Pendenti cilindrici con estremità sferica in bronzo (Fig. 2.48). Distribuzione. Presciano, scavi 2010: Tomba 42, n. 5 Confronti. Trova confronti con il tipo 5 dei piccoli pendenti di Bazzano, specificamente con l’esemplare della tomba femminile 451, della fase III (Weidig 2014, 326) Datazione. Ultimo quarto del VI-prima metà V secolo a.C.
Tipo S.50.7. Pendente composto da una piastra in ferro di forma rettangolare nella quale sono 135
Capestrano, I
inseriti anellini in bronzo, nella parte inferiore sono appese piccole bulle in bronzo (Fig. 2.48). Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 37, n. 3. Datazione. Il contesto di rinvenimento suggerisce una datazione generica al VI secolo a.C. VAGHI (Forma 60). I vaghi sono distinti in primo luogo sulla base del materiale in cui sono realizzati: pasta vitrea, (A) ambra (B), bronzo (C), calcare (D) e osso (E). I motivi decorativi sono discriminanti per le varietà.
esemplare della tomba 50 di Fontanelle, di forma globulare e dimensioni maggiori della media (Tipo S.60.A.2, var. a) presenta una decorazione a 4 file di occhi più complessa. Il motivo policromo a zig-zag chiaro è presente fin dall’VIII secolo (ad esempio nella t. 19 di Scurcola Marsicana), ma si afferma anch’esso nel VI secolo a.C., con un incremento delle attestazioni dall’ultimo quarto del VI alla prima metà del V secolo a.C. (Bracci 2007, 50-52). Tipo S.60.A.1. Vaghi in pasta vitrea a profilo globulare. Ambedue gli esemplari ascritti al tipo presentano dimensioni maggiori del tipo a profilo compresso (1.3-1.4 cm). Varietà a: monocromi (Fig. 2.48). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 186, n. 17 (5 esemplari di colore verdegiallo iridescente). Varietà b: decorazione policroma a occhi blu su fondo bianco, disposti su 4 file da 6 (Fig. 2.48). Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 50, n. 4 (1 es. nero, con occhi a cerchi concentrici blu su fondo bianco). Datazione. Fine VI-II secolo a.C.
VAGHI IN PASTA VITREA (60.A). A Capestrano i vaghi in pasta vitrea si rinvengono prevalentemente all’interno di tombe femminili. In questa sede essi sono distinti in primo luogo sulla base della forma (globulare, compressa, a profilo troncoconico, piriforme) e, come varietà, in base al colore: ovvero se monocromi, con decorazione policroma a occhi o a zig-zag. In generale, i vaghi monocromi sono attestati dall’età del Ferro, sia in Abruzzo che in territorio marchigiano, già nell’VIII secolo a.C. sono affiancati dalle produzioni policrome e la loro frequenza tende a ridursi in età tardoarcaica ed ellenistica (Bracci 2007, 43, 48-49). A Capestrano sono attestati prevalentemente esemplari con una sola fila di 3-4 occhi equidistanti, del gruppo blu/celeste/giallo con occhi blu cerchiati su fondo bianco, che secondo F. Bracci compaiono nel Piceno a partire dal VI secolo a.C. e quelli a 4 coppie di occhi equidistanti, lievemente più recente e attestato fino al IV secolo (Bracci 2007, 52-53; C. Buoite in Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 210-211; Weidig 2014, 373)3. Un 3
Il caso di Fossa, sembra confermare questa sequenza. Qui, infatti, i vaghi monocromi sono presenti nel corso della fase 1 della necropoli (Cosentino, d’Ercole e Mieli 2001, 167) fino all’età ellenistica (t. 37, n. 5; t. 220, n. 5; t. 223, n. 6; d’Ercole e Copersino 2003, 30, 53, 55); quelli a occhi, a Fossa sono attestati dalla prima metà VI alla seconda metà del IV secolo a.C. (t. 162, n. 9; t. 194, n. 14; t. 227, n. 14; t. 301, n. 11; t. 309, n. 6; t. 429, n. 20; t. 524, n. 9; d’Ercole e Benelli 2004, 65, 81, 93, 122, 127, 205); t. 212, n. 4; t. 228, n. 4; t. 252, n. 9 (d’Ercole e 136
Tipo S.60.A.2. Vaghi in pasta vitrea a profilo compresso. Varietà a: monocromi (Fig. 2.48). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 138, n. 14 (1 es blu); tomba 188, n. 6 (4 blu e celeste). Fossascopana, scavi 1965: tomba 3, n. 4 (7 es. gialli; 22 neri). Presciano, scavi 2010: tomba 36, n. 4 (4 es. celesti; 2 gialli; 1 nero); tomba 42, n. 9 (7 neri; 1 celeste; 1 giallo; 1 nero); tomba 45, n. 8 (3 blu; 1 bianco). Fontanelle, scavi 2012: tomba 12, n. 2 (2 es. neri; 2 blu; 3 azzurri); tomba 23, n. 4 (1 blu; 2 arancione); tomba 24, n. 3 (1 nero); tomba 44, n. 1; tomba 50, n. 4 (1 nero; 1 blu; 1 arancione). Via dell’Olmo, scavi 2011: tomba 1, n. 8 (3 azzurri; 1 bianco; 1 nero); tomba 3, nn. 10-11 (1 nero, 1 azzurro). Copersino 2003, 50, 60, 65), più o meno in coincidenza con quelli a zig-zag: vedi, t. 179, n. 1, di incerta datazione; t. 194, n. 14; t. 301, n. 11) (d’Ercole e Benelli 2004, 75, 81, 122).
La tipologia dei materiali
Varietà b: decorazione policroma a occhi. Varietà b1: fondo blu con fila singola di 3 occhi blu su fondo bianco (Fig. 2.48). Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 23, n. 4 (7 es.). Varietà b2: fondo blu con fila singola di 3 occhi a cerchi concentrici blu su fondo bianco (Fig. 2.48). Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 259, n. 5 (1 es.) Varietà b3: fondo blu con fila singola di 4 occhi a cerchi concentrici blu su fondo bianco (Fig. 2.48). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 180, n. 9 (1 es.); tomba 186, n. 17 (4 es.). Presciano, tomba 45, n. 9 (2 es.); tomba 54, n. 8 (1 es.). Fontanelle, scavi 2012: tomba 37, n. 4 (5 es.). Varietà b4: fondo azzurro con fila singola di 3 occhi a cerchi concentrici blu su fondo bianco. Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 186, n. 17 (10 es.). Varietà b5: fondo azzurro con fila singola di 4 occhi a cerchi concentrici blu su fondo bianco. Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 186, n. 17 (3 es.); tomba 242, n. 5 (4 es.). Presciano, scavi 2010: tomba 45, n. 9 (1 es.). Fontanelle, scavi 2012: tomba 37, n. 4 (1 es.). Varietà b6: fondo giallo con fila singola di 4 occhi a cerchi concentrici blu su fondo bianco. Distribuzione. Presciano, scavi 2010, tomba 45, n. 9 (3 es.). Varietà b7: fondo blu con due file di 4 occhi a cerchi concentrici blu su fondo bianco. Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 2, n. 5 (2 es.); Varietà b8: fondo azzurro con due file di 4 occhi a cerchi concentrici blu su fondo bianco. Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 259, n. 5 (4 es.). Presciano, scavi 2010: tomba 54, n. 8 (14 es.). Varietà b9: fondo giallo con due file di 4 occhi a cerchi concentrici blu su fondo bianco (Fig. 2.48). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 186, n. 17 (6 es.); tomba 242, n. 5 (3 es.).
137
Scavi 1934: tomba 2 (8 es.). Presciano, scavi 2010: tomba 45, n. 9 (3 es.). Varietà b10: fondo bianco con 4 file di inserti circolari pieni blu. Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 44, n. 4. Varietà c: decorazione policroma a occhi e fila di globetti sporgenti. Varietà c1: fondo blu con fila singola di 4 occhi a cerchi concentrici blu su fondo bianco e fila di 3 globetti gialli (Fig. 2.48). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 186, n. 17 (n. 1 es.) Varietà c2: fondo azzurro con fila singola di 4 occhi a cerchi concentrici blu su fondo bianco e fila di 3 globetti gialli. Distribuzione. Presciano, scavi 2010: tomba 49, n. 11 (1 es.). Varietà d: decorazione policroma a occhi sporgenti e fila di globetti sporgenti. Varietà d1: fondo azzurro con 4 occhi sporgenti a cerchi concentrici blu su fondo bianco e fila di 3 globetti gialli. Distribuzione. Presciano, scavi 2010, tomba 49, n. 11 (2 es.). Varietà d2: fondo verde con 4 occhi sporgenti a cerchi concentrici blu su fondo bianco e fila di 3 globetti bianchi (Fig. 2.48). Distribuzione. Presciano, scavi 2010, tomba 49, n. 11 (1 es.). Varietà e: decorazione policroma con motivo a zig zag. Varietà e1: fondo blu con zig-zag bianca (Fig. 2.48). Distribuzione. Presciano, scavi 2010: tomba 45, n. 9 (1 es.); tomba 49, n. 11 (8 es.). Fontanelle, scavi 2012: tomba 43, n. 5 (1 es.). Varietà e2: fondo blu con zig-zag celeste. Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 210, n. 8 (5 es.). Varietà e3: fondo celeste con zig-zag bianco. Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 210, n. 8 (1). Presciano, scavi 2010: tomba 49, n. 11 (1 es.); tomba 52, n. 11 (3 es.). Varietà e4: fondo giallo con zig-zag blu. Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 210, n. 8 (4 es.). Varietà e5: fondo violaceo con zig-zag giallo.
Capestrano, I
Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 210, n. 8 (1 es.). Datazione. Data l’ampia diffusione di questo gruppo, si propone un ampio inquadramento cronologico tra l’avanzato VI e il II secolo a.C.
per la diffusione di tutti i tipi nel Piceno, vedi Negroni Catacchio 2003, 456, fig. 1. Tipo S.60.B.1. Vaghi in ambra di forma globulare (Fig. 2.49). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 130, n. 15 (1 es.; motivo a zig-zag intagliato). Datazione. Il contesto di rinvenimento suggerisce di inquadrare il tipo nella prima metà del VI secolo a.C. (vedi, 216-217).
Tipo S.60.A.3. Vaghi in pasta vitrea a profilo troncoconico. Varietà a: decorazione policroma a 4 occhi blu a cerchi concentrici su fondo bianco, campita da due file di globetti sporgenti (Fig. 2.48). Distribuzione. Presciano, scavi 2010: tomba 49, n. 11 (1 es. fondo verde con occhi a cerchi concentrici blu su fondo bianco e globetti bianchi). Varietà b: decorazione policroma con motivo a zig-zag (Fig. 2.48). Distribuzione. Presciano, scavi 2010: tomba 49, n. 11 (1 es. di colore blu con zig-zag bianco). Datazione. Per il contesto di rinvenimento, si suggerisce un inquadramento cronologico tra l’ultimo quarto del VI e la prima metà V secolo a.C.
Tipo S.60.B.2. Vaghi in ambra a profilo compresso (Fig. 2.49). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 124, n. 5 (2 es.); tomba 188, n. 6 (2 es.); tomba 210, n. 8 (1 es.). Presciano, scavi 2010: tomba 41, n. 9 (1 es.). Fontanelle, scavi 2012: tomba 44, n. 4 (3 es.). Confronti. Corrisponde al tipo 2 di Bazzano, presente in contesti della fase III (ultimo quarto del VI; Weidig 2014, 367). A Fossa, vaghi in ambra a profilo compresso sono attestati dagli inizi dell’Orientalizzante: t. 365, n. 9 (d’Ercole e Benelli 2004, 224), fino all’età ellenistica (t. 228, n. 3; d’Ercole e Copersino 2003, 60, datata al IV secolo a.C.). Datazione. Fine VI-IV secolo a.C. Tipo S.60.B.3. Vaghi in ambra ad anello (Fig. 2.49). Distribuzione. Presciano, scavi 2010: tomba 41, n. 4 (1 es.). Datazione. Per il contesto di rinvenimento, in associazione a una fibula del Tipo S.20.A.2 (vedi, 125-126), il tipo sembra inquadrabile tra la fine del VI e gli inizi del V secolo a.C.
Tipo S.60.A.4. Vaghi in pasta vitrea piriformi (Fig. 2.48). Distribuzione. Presciano, scavi 2010: tomba 52, n. 11 (1 es. blu e 1 verde con motivo a zig zag bianco). Confronti. Per la diffusione, vedi Bracci 2007, 44. E 50 (concentrazione degli esemplari nel Piceno IVB comunque tra l’ultimo quarto del VI e la prima metà del V secolo a.C.) Numana, Colle di Montalbano, tomba 54 Cimitero (intorno al 525 a.C.; G. Baldelli in Roma 1999, 222, nn. 294-306). Datazione. Fine VI-prima metà V secolo a.C.
Tipo S.60.B.4. Vaghi in ambra a profilo cilindrico (Fig. 2.49). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 186, n. 18 (14 es.); tomba 242, n. 5 (3 esemplari). Presciano, scavi 2010: tomba 54, n. 8 (3 es.). Fontanelle, scavi 2012: tomba 37, n. 4 (5 es.); tomba 44, n. 4 (1 es.). Confronti. Corrisponde al tipo 2 di Bazzano, presente in contesti della fase III (Weidig 2014, 367). Fossa, t. 301, nn. 10-11; t. 309, n. 6 (seconda metà VI secolo a.C.) (d’Ercole e Benelli 2004, 123, 127)
VAGHI IN AMBRA (60.B). Riguardi ai vaghi di ambra, J. Weidig rileva come in gran parte nell’Abruzzo nord-orientale (con alcune eccezioni, come la tomba 57 di Fossa), le perle di ambra (tipo 2 di Bazzano) compaiono nella fase III (Weidig 2014, 367) con l’eccezione del tipo a bulla o a ghianda con appiccagnolo, della fase IIB. Lo studioso puntualizza comunque che in altri contesti esse possono essere più antiche (364). In generale,
138
La tipologia dei materiali
Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 186, n. 18 (1 es.). Datazione. Visto il contesto di associazione, il tipo può essere inquadrato tra la fine del VI e la prima metà V secolo a.C.
Datazione. Seconda metà VI-seconda metà V secolo a.C. Tipo S.60.B.5. Vaghi in ambra a profilo troncoconico (Fig. 2.49). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 242, n. 5 (2 es.). Presciano, scavi 2010: tomba 54, n. 8 (3 es.). Fontanelle, scavi 2012: tomba 22, n. 15 (1 es.). Datazione. Vista l’associazione nei contesti di rinvenimento con materiali ascrivibili alla fine del VI-prima metà V secolo a.C. (bacili Tipo O.330.B.4; fibule Tipo S.20.A.2; si veda anche il Volume II di questo lavoro), il tipo in esame può essere inquadrato in questo orizzonte cronologico.
VAGHI IN BRONZO (60.C). Tipo S.60.C.1. Vaghi in bronzo di forma cilindrica di piccole dimensioni (Fig. 2.49). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 129, n. 4 (14 es.); tomba 188, n. 7 (1 es.). Fossascopana, scavi 1965: tomba 3, n. 4 (4 es.). Datazione. In base ai contesti di rinvenimento, il tipo può essere ascritto al periodo ellenistico (III-II secolo a.C.)
Tipo S.60.B.6. Vaghi in ambra a profilo fusiforme (Fig. 2.49). Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 23, n. 4 (1 es.); tomba 26, n. 11 (1 es.). Confronti. Corrisponde al tipo 2 di Bazzano, presente in contesti della fase III (ultimo quarto del VI; Weidig 2014, 367). Fossa, t. 301, nn. 10-11 (decenni finali VI secolo a.C.) (d’Ercole e Benelli 2004, 123); t. 351, n. 3 (prima metà III secolo a.C.) (d’Ercole e Copersino 2003, 86). Datazione. Il tipo si inquadra in un ampio orizzonte cronologico, tra l’età arcaica e l’età ellenistica. Tipo S.60.B.7. Vaghi in ambra discoidali (Fig. 2.49). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 186, n. 18 (6 es.); tomba 210, n. 8 (1 es.); tomba 242, n. 5 (4 esemplari). Presciano, scavi 2010: tomba 49, n. 11 (1 es.); tomba 54, n. 8 (1 es.). Fontanelle, scavi 2012: tomba 26, n. 11 (33 es.); tomba 37, n. 4 (1 es.). Confronti. Corrisponde al tipo 3 di Bazzano, presente in contesti della fase III (Weidig 2014, 367). Fossa, t. 301, nn. 10-11; t. 309, n. 6 (seconda metà VI secolo a.C.) (d’Ercole e Benelli 2004, 123). Datazione. Seconda metà VI-prima metà V secolo a.C.
Tipo S.60.C.2. Vaghi in bronzo a profilo compresso (Fig. 2.49). Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 22, n. 14 (1 es.). Confronti. Corrisponde al tipo 2 della necropoli di Bazzano, attestato nella tomba 1358 della fase III e ascritto al gruppo dei “bronzi macedoni” (Weidig 2014, 375-376). Datazione. Fine VI-prima metà V secolo a.C. VAGHI IN PIETRA CALCAREA (60.D). Tipo S.60.D.1. Vaghi in pietra calcarea di forma cilindrica (Fig. 2.49). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 129, n. 4 (4 es.). Datazione. In base al contesto di rinvenimento, il tipo può essere ascritto al periodo ellenistico (III-II secolo a.C.). Tipo S.60.D.2. Vaghi in pietra calcarea a denti di lupo (Fig. 2.49). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 129, n. 4 (7 es.). Datazione. In base al contesto di rinvenimento, il tipo può essere ascritto al periodo ellenistico (III-II secolo a.C.). VAGHI IN OSSO (60.E). A questa famiglia tipologica è ascritto un tipo caratterizzato da solcature concentriche, che sicuramente può essere identificato come elemento ornamentale, ma anche alcuni dischi
Tipo S.60.B.8. Vaghi in ambra a profilo discoidale con margini frastagliati (Fig. 2.49).
139
Capestrano, I
in osso isolati, che allo stesso modo potrebbero far parte di spolette (vedi per l’instrumentum, 115).
Datazione. VIII secolo a.C.
Tipo S.60.E.1. Vaghi in osso di forma discoidale (Fig. 2.49). Distribuzione. Presciano, scavi 2010: tomba 45, n. 9. Fontanelle, scavi 2012: tomba 23, n. 5; tomba 43, n. 6; tomba 53, n. 6. Datazione. In base al contesto di rinvenimento, il tipo può essere ascritto al periodo tardoarcaico (fine VI-prima metà V secolo a.C.)
Tipo S.90.1. Bottoni/borchiette a calotta emisferica sferiche con anellino posteriore (Fig. 2.49. Distribuzione. Presciano, scavi 2010: tomba 11, n. 13. Confronti. Gli esemplari trovano confronti con il tipo 1 della necropoli di Fossa, da contesti pesantemente disturbati della fase 1 (Cosentino, d’Ercole e Mieli 2001, 165). Datazione. VIII secolo a.C.
BOTTONI/BORCHIETTE (Forma 90).
Tipo S.60.E.2. Vaghi in osso di forma discoidale con profilo a losanga (Fig. 2.49). Distribuzione. Presciano, scavi 2010: tomba 45, n. 9. Datazione. In base al contesto di rinvenimento, il tipo può essere ascritto al periodo tardoarcaico (fine VI-prima metà V secolo a.C.).
PETTORALI/CHATELAÎNES (Forma 100). Tipo S.100.1. Pettorale composito (?) di filo di verga (Fig. 2.49). Alcuni frammenti di filo di verga di bronzo dagli scavi del 1934 sono dubitativamente attribuiti a un ornamento complesso, composto da elementi avvolti a zig-zag o a doppia spirale, connessi da catenelle in bronzo. Distribuzione. Fossascopana, scavi 1934: tomba 14, n. 2. Confronti. I frammenti presi in esame fanno probabilmente parte di un pettorale vicino alle chatelaînes note per l’area picena, l’area pescarese e la val di Sangro e ascritte al periodo tardo-orientalizzante/arcaico (Seidel 2006, 129130; vedi anche Faustoferri 2001). Datazione. Fine del VII-VI secolo a.C.
AGHI CRINALI (Forma 70). Tipo S.70.1. Aghi crinali in osso con estremità superiore sferica (Fig. 2.49). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: t. 216, n. 13. Via dell’Olmo, scavi 2011: tomba 3, n. 12 Datazione. In base al contesto di rinvenimento (vedi il Volume II di questo lavoro), il tipo può essere ascritto al periodo ellenistico (III-II secolo a.C.). Tipo S.70.2. Aghi crinali in osso con estremità superiore figurata (Fig. 2.49). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 214, n. 12 Datazione. In base al contesto di rinvenimento, il tipo può essere ascritto al periodo ellenistico (III-II secolo a.C.).
ARMI (T). Le necropoli di Capestrano restituiscono un quadro dell’armamento sostanzialmente in linea con quanto noto per le altre aree funerarie dell’Abruzzo interno. Nell’ambito del costume funerario maschile, sono esclusivamente attestate le armi offensive, che includono armi da taglio e da punta, armi da getto o da urto, con un solo esemplare di testa di mazza. Rimandando comunque all’analisi del rituale funerario nel Volume II di questo lavoro, va qui sottolineato come le lance e i giavellotti siano associati alle sepolture di individui adulti e giovanili (solitamente con una unità, più raramente, con due), mentre i pugnali e le spade
FERMATRECCE (Forma 80). Tipo S.80.1. Fermatrecce in bronzo a fascia (Fig. 2.49). Distribuzione. Presciano, scavi 2010: tomba 11, nn. 7-12. Confronti. Corrisponde al tipo 1 della necropoli di Fossa, attestato nella fase 1 (Cosentino, d’Ercole e Mieli 2001, 167). 140
La tipologia dei materiali
93) e diffuso in area aquilana, nella Sabina, nel Teramano e in Umbria. Vedi anche, Navelli (AQ), necropoli del Piano: tt. 82 e 101 (discussione in, I. Di Sabatino, in Acconcia et al. 2017, 75, 78). Cronologia. La diffusione del tipo si inquadra nell’area aquilana tra la fine/ultimo quarto del VII e la metà del VI secolo a.C.
sembrano deposte solo in quelle di individui adulti. La successione tra pugnali (presenti nel tipo ad antenne) e spade avviene, come nelle vicine Fossa e Bazzano, intorno alla metà del VI secolo a.C., attestando probabilmente un cambiamento nelle tattiche di guerra, (A. Naso, in Benelli e Naso 2003, 187-194; Weidig 2008, 125; 2014, 95-97, 122-123; d’Ercole e Martellone 2008, 153-154; d’Ercole 2010a, 147-148, 156-157; 2014, 43-44, 57). Anche a Capestrano, inoltre, si assiste a una rarefazione della presenza delle armi a partire dal V secolo a.C. (più probabilmente dalla metà dello stesso secolo), anche se esse non scompaiono del tutto, contrariamente ad esempio a quanto verificato a Fossa per l’età ellenistica. Questo elemento va letto probabilmente come una peculiarità delle comunità rappresentate dalle necropoli qui esaminate, che si allinea a fenomeni analoghi di continuità noti anche per altri comparti dell’Abruzzo antico (Benelli e Rizzitelli 2010, 111-112).
FODERI DI PUGNALI (Forma 15). Tipo T.15.1. Fodero in legno avvolto da due lamine in ferro, ripiegate e chiuse superiormente dalla lamina di sospensione, inferiormente dal puntale, composto a sua volta da una lamina terminale tenuta ferma da un disco e, all’estremità inferiore, da un inserto con testa discoidale; lamina di sospensione di forma rettangolare con chiusura monolaterale, chiusa da due ribattini e forata per l’aggancio di due catenelle di sospensione, composte da anelli in ferro (Fig. 2.50). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 134, n. 2; tomba 204, n. 4; tomba 212, n. 10; tomba 230, n. 9. Fontanelle, scavi 2012: tomba 27, n. 3; tomba 36, n. 4. Confronti. Inquadrabile nel tipo standardizzato più frequentemente associato al pugnale tipo 2 individuato da Weidig (2008, 115-116; 2014, 68-70). Datazione. Tra la fine/ultimo quarto del VII e la metà del VI secolo a.C.
PUGNALI (Forma 10). La forma è attestata nel tipo cd. “a stami”, con un numero ridotto di esemplari nelle necropoli di Capestrano, molti dei quali in cattive condizioni di conservazione. L’attribuzione di alcuni degli esemplari elencati di seguito, pertanto, è proposta in via altamente ipotetica. Per i pugnali a stami, vedi d’Ercole 2011, 4344.
SPADE (Forma 20).
Tipo T.10.1. Pugnali con elsa a pomolo centrale e quattro stami angolati a sezione circolare; codolo continuo a sezione circolare/quadrangolare, lama a costolatura pronunciata (Fig. 2.50). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 134, n. 2; tomba 230, n. 9. Fontanelle, scavi 2012: tomba 27, n. 3; tomba 36, n. 3. Si ascrivono in via ipotetica al tipo, i seguenti esemplari: Fossascopana, scavi 2003-2009, tomba 204, n. 4; tomba 212, n. 9. Fossascopana, scavi 1934: tomba 12, n. 9. Confronti. Viste anche le associazioni con i foderi, il tipo in esame sembra inquadrabile nel tipo 2 “standardizzato” individuato da J. Weidig (Weidig 2008, 111-119; Weidig 2014, 68. 92-
Le spade attestate nelle necropoli esaminate sono prevalentemente ascrivibili al tipo bitagliente con elsa a croce, definito nella letteratura archeologica come “tipo Capestrano” per la vicinanza all’esemplare rappresentato sulla statua del Guerriero (d’Ercole 2014, 57). La maggior parte degli esemplari presenta forti lacune, soprattutto in corrispondenza delle impugnature: queste ultime spesso si rivelano utili per definire un più puntuale inquadramento cronologico. Come si vedrà di seguito, infatti, il complesso dei materiali analizzati si colloca nel periodo di maggiore densità delle spade con elsa a croce nell’area abruzzese interna, tra la metà del VI e la metà del V secolo a.C. 141
Capestrano, I
lunghe bitaglienti, si veda anche Stary 1981, 445 (tipo W27); d’Ercole 2010a; da ultimo, d’Ercole 2014, 43-44; 2015b, 245-256. Datazione. Metà del VI-metà del V secolo a.C. Varietà a: lingua da presa con estremità scarsamente accentuate, lamine di rivestimento dell’elsa prolungate oltre la lingua da presa e poco sporgenti per l’innesto del pomo di forma circolare, il rivestimento metallico del pomo è fissato con chiodini e può essere lavorato a traforo (Fig. 2.51). Distribuzione varietà a. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 112, n. 7; tomba 249, n. 5. Fossascopana, scavi 1934: tomba 19, n. 2. Capo d’Acqua, scavi 2011: tomba 13, n. 4; tomba 18, n. 3 (dubitativamente). Confronti. Corrisponde al sistema di rivestimento dell’elsa e del pomo di tipo 1 del tipo di Bazzano sopra descritto (Weidig 2014, 99). Datazione. Metà-fine del VI/inizi del V secolo a.C. (Weidig 2014, 103) Varietà b: lingua da presa con estremità superiori accentuate, piegata a connettersi direttamente al pomo di forma circolare (Fig. 2.51). Distribuzione varietà b. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 177, n. 8; tomba 260, n. 3 (dubitativamente). Capo d’Acqua, scavi 2011: tomba 15, n. 4. Confronti. Corrisponde al sistema di rivestimento dell’elsa e del pomo di tipo 2 di Bazzano (Weidig 2014, 99, 106). Datazione. Fine del VI-prima metà del V secolo a.C. Varietà c: lingua da presa romboidale con estremità superiori accentuate; lamine di rivestimento che proseguono oltre l’estremità della lingua da presa componendo un pomo ad anello a sezione piana (Fig. 2.51). Distribuzione varietà c. Fontanelle, scavi 2012: tomba 42, n. 7. Confronti. La varietà c non trova al momento confronti puntuali. In via solo altamente ipotetica, esso potrebbe essere identificato come la semplificazione di modelli più elaborati noti per l’area picena, ad esempio l’elsa delle spade corte della tomba 182 del Crocifisso a Matelica, databili alla fine del VII secolo a.C., ornate da motivi a teste di serpenti affrontate (Sabbatini 2008, 209-212, nn. 246, 249, 251; Weidig 2014,
Diversamente, in area costiera questo tipo si diffonde con qualche decennio di anticipo (a Campovalano esso è presente già nella prima metà del VI secolo a.C.: Weidig 2014, 111). Tipo T.20.1. Spade lunghe in ferro (tra 65-80 cm lunghezza complessiva) con lama lanceolata bitagliente, caratterizzate da lieve rigonfiamento nel terzo inferiore; elsa a croce, presa di forma romboidale con estremità a due sporgenti; elsa rivestita da lamine in ferro applicate su guance in materiale deperibile (Fig. 2.51). Come già accennato, le condizioni di rinvenimento di molti esemplari consentono solo un generico inquadramento in questo tipo, mentre rari sono i casi in cui è possibile identificare (anche solo approssimativamente) il sistema di rivestimento dell’elsa e del pomo associato all’impugnatura, dettagliatamente analizzato per le spade di Bazzano (Weidig 2014, 99), che in questa sede è utilizzato come elemento discriminante per definire le varietà. Va segnalato a tale riguardo come a Capestrano sia attestato un tipo di pomo ad anello (varietà c), non presente a Bazzano o a Fossa. Distribuzione degli esemplari genericamente ascrivibili al tipo: Fossascopana, scavi 20032009: tomba 173, n. 5; tomba 185, n. 16 (mancante dell’impugnatura); tomba 207, n. 6; tomba 211, n. 3; tomba 222, n. 8: tomba 223, n. 5; tomba 244, n. 6; tomba 257, n. 4; tomba 266, n. 3. Fossascopana, scavi 1934: tomba 4, n. 2; tomba 12, nn. 11-12. Fonte di Presciano, scavi 2010: tomba 8, n. 5; tomba 18, n. 6; tomba 34, n. 5; tomba 53, n. 4; tomba 55, n. 1. Fonte di Presciano, scavi 2011: tomba 1, n. 6. Confronti. Questi esemplari si inquadrano nel tipo 1 di Bazzano, diffuso nell’area aquilana interna soprattutto a partire dalla metà del VI secolo a.C. (con una particolare concentrazione a Bazzano nella fase III, ovvero dall’ultimo quarto del VI) fino alla metà del V a.C., con alcune sporadiche attestazioni nella seconda metà dello stesso secolo (Weidig 2014, 101103; per un elenco puntuale delle spade lunghe in ferro dall’Italia centrale e una esauriente discussione dello sviluppo della forma e la sua cronologia, vedi anche 125-141). Sulle spade 142
La tipologia dei materiali
110; A. Naso in Naso, Tomedi 2015, 236). Cronologia. Il corredo della tomba 42 di Fontanelle si inquadra intorno alla metà del VI secolo a.C. (vedi, il Volume II di questo lavoro).
Tipo T.25.2. Fodero di spada in legno, con guarnizione superiore composta da due lamine quadrangolari in ferro fissate da chiodini; puntale rivestito da due placche in ferro chiuse su un elemento in materiale deperibile, probabilmente di forma semicircolare e decorato da volute in bronzo (Fig. 2.51). Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 42, n. 8. Datazione. Metà del VI secolo a.C.
FODERI DI SPADE (Forma 25). Le spade lunghe bitaglienti diffuse in area aquilana sono solitamente associate a foderi realizzati in legno, alcuni dei quali terminano superiormente con una guarnizione in ferro e inferiormente con puntali in ferro e osso/avorio (Weidig 2014, 100). Tra le spade rinvenute a Capestrano, vari esemplari conservano resti del fodero in legno, ma solo due foderi si presentano completi in quasi tutti i loro elementi. La spada della tomba 19 degli scavi del 1934 a Fossascopana conservava buona parte del fodero in legno ma solo un elemento in ferro di delimitazione superiore del puntale. Gli esemplari di seguito presentati non sembrano comunque trovare confronti puntuali con i foderi in ferro meglio noti, ad esempio quelli dalle tombe 69 e 95 di Campovalano, dalle tombe 67 e 411 di Bazzano, o con quello in bronzo dalla tomba 41 di Capena, dalla tomba 11 di Campo Valentino a Molina Aterno (PE) o dalla tomba 81 di Navelli (per Campovalano, Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 13, n. 35; 22, n. 22; Bazzano: Weidig 2014, 124; per Capena, Naso 2003, 140-141, n. 183 e A. Naso in Benelli, Naso 2003, 189 e 192; per Campo Valentino, Riccitelli 1998; per Navelli, I. Di Sabatino in Acconcia et. al. 2017, 78).
COLTELLI (Forma 30). Si inseriscono all’interno della classe delle armi anche alcuni esemplari di coltello a lama lunga, rinvenuti in sepolture maschili e associati alle spade con elsa a croce, identificati nella storia degli studi come strumenti per l’affilatura delle lame (Weidig 2014, 111; d’Ercole 2015b, 248). Tipo T.30.1. Coltello affila-lama a lama lunga diritta in ferro; codolo continuo di forma rettangolare, con immanicatura in materiale deperibile (Fig. 2.52). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 185, n. 6; tomba 207, n. 6. Confronti. Si inquadra nel tipo 1 di Bazzano, la cui maggiore concentrazione è attestata nella fase III della necropoli (Weidig 2014, 436). Datazione. Seconda metà/fine del VI-inizi del V secolo a.C. Tipo T.30.2. Coltello affila-lama in ferro a lama lunga con lieve rigonfiamento nella prima metà; codolo continuo di forma trapezoidale, con immanicatura realizzata in lamine di ferro fissate con chiodini (Fig. 2.52). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 112, n. 8. Capo d’Acqua, scavi 2011: tomba 24, n. 2. Confronti. Vicino al tipo 1, var. A di Bazzano, attestato nella fase III della necropoli. Per la lunghezza dell’esemplare rappresentativo di questo tipo, J. Weidig ha ipotizzato che possa essere stato utilizzato come arma (Weidig 2014, 436). Campovalano: t. 89, n. 4 (prima metà VI secolo a.C.; Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 18). Datazione. Seconda metà VI secolo a.C.
Tipo T.25.1. Fodero di spada in legno, con guarnizione superiore composta da due lamine rettangolari in ferro chiuse da chiodini e chiuse superiormente da lamine in bronzo rettangolari; puntale composto da una barra in ferro di forma rettangolare che chiude superiormente un elemento in materiale deperibile, di forma probabilmente semicircolare, decorato da due volute a ricciolo in ferro (Fig. 2.51). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 244, n. 6. Datazione. VI secolo a.C.
143
Capestrano, I
Treré e d’Ercole 2003, 28, 47, 62); t. 95, n. 52; t. 550, n. 13 (prima metà VI secolo a.C.; Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 26, 127) Datazione. VI secolo a.C.
PUNTE DI LANCIA (Forma 40). In questa sede si adottano le dimensioni dei singoli esemplari di punte di armi da getto o da urto (lunghezza) quale elemento discriminante tra lance e giavellotti. Si ascrivono alle punte di lancia gli esemplari con dimensioni superiori a 25 cm, distinti, oltre che sulla base della forma della lama, anche sulla base delle proporzioni tra lama e cannone (in questo senso, si preferisce adottare il criterio utilizzato in d’Ercole e Benelli 2004, 9 piuttosto che quello più articolato proposto in Weidig 2014, 161). Tra i materiali di Capestrano, si registrano tipi con cannone scarsamente sviluppato e lama più o meno allungata, concentrati soprattutto in età tardo-orientalizzante e arcaica (Tipi T.40.1-3); tipi in cui progressivamente il cannone tende ad allungarsi (Tipi 40.4-7), attestati anche in età tardo-arcaica ed ellenistica e, infine, un tipo con lungo cannone e lama ridotta, identificabile come pilum, nell’ambito del quale è stato inquadrato anche un esemplare di dimensioni inferiori al resto delle attestazioni (Tipo T.40.8; l’esemplare di dimensioni ridotte è quello della tomba 39 di Fontanelle, lungo complessivamente 20 cm). Per quanto riguarda la funzione dei singoli tipi (se si tratti di armi da lancio o per sferrare colpi diretti), essa non è chiaramente definibile, essendo la combinazione con i sauroteres attestata in un numero ridotto di casi, prevalentemente nell’ambito dei tipi arcaici T.40.2-3.
Tipo T.40.2. Punta di lancia in ferro con lama a foglia di lauro e costolatura centrale; cannone corto a sezione circolare. Lunghezza tra 25 e 36 cm (Fig. 2.52). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 112, n. 9 (con sauroter); tomba 177, n. 9 (con sauroter); tomba 185, n. 7; tomba 223, n. 6; tomba 230, nn. 11-12 (con sauroteres). Presciano, scavi 2010: tomba 18, nn. 7-8 (con sauroteres). Capo d’Acqua, scavi 2011: tomba 15, n. 5 (con sauroter). Fontanelle, scavi 2012: tomba 4, n. 9 (con sauroter); tomba 42, n. 9 (con sauroter). Confronti. Vicino al tipo G1 di Bazzano, attestato nella fase IIB-inizi III (Weidig 2014, 166). Fossa: t. 116, n. 3 (decenni finali del VIinizi del V secolo a.C.); t- 302, n. 3 (fine VIIprima metà VI secolo a.C.) (d’Ercole e Benelli 2004, 47, 123). Colle Cipolla (AQ): t. 14 (VI secolo a.C.; d’Ercole 2015b, 254, fig. 2. Campovalano: t. 66, nn. 25-26; t. 117, n. 14 (prima metà VI secolo a.C.; Chiaramonte Treré e d’Ercole 2003, 51, 65); t. 55, n. 13; t. 89, n. 1; t. 371, n. 12 (prima metà VI secolo a.C.; Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 10, 18, 105) Datazione. VI secolo a.C.
Tipo T.40.1. Punta di lancia in ferro con lama lievemente espansa nella metà inferiore e punta stretta e costolatura centrale; cannone a sezione circolare sviluppato per una lunghezza lievemente inferiore rispetto alla lama; costolatura centrale. Lunghezza 24.5-25 cm (Fig. 2.52). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 257, n. 5. Capo d’Acqua, scavi 2011: tomba 13, n. 5; tomba 18, n. 4 (vicino). Confronti. Vicino al tipo F3 di Bazzano, attestato nella fase IIB1 (Weidig 2014, 166). Fossa: t. 270, n. 3 (decenni centrali VI secolo a.C.; d’Ercole e Benelli 2004, 105). Campovalano: t. 31, n. 2; t. 63, n. 3; t. 93, nn. 11-12 (prima metà VI secolo a.C.; Chiaramonte
Tipo T.40.3. Punta di lancia in ferro con lama stretta, allungata a fiamma, a bassa costolatura centrale; cannone corto a sezione circolare. Lunghezza tra 36 e 46 cm (Fig. 2.52). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 173, n. 6 (con sauroter); tomba 249, n. 6; tomba 252, n. 6; tomba 291, n. 4. Fontanelle, scavi 2012: tomba 1, n. 8; tomba 35, n. 7. Confronti. Vicino al tipo H2 di Bazzano, attestato nella III fase della necropoli (Weidig 2014, 166). Fossa: t. 273, n. 4 (prima metà V secolo a.C.; d’Ercole e Benelli 2004, 112). Loreto Aprutino, necropoli di Colle Carpini: Staffa 2003a, 579, fig. 18, n. 30. Campovalano: t. 26, n. 3 (Chiaramonte Treré e d’Ercole 2003, 144
La tipologia dei materiali
quarto VI secolo a.C.); t. 302, n. 4 (prima metà VI secolo a.C.); t. 449, n. 2 (V secolo a.C.); t. 492, n. 5 (fine VI-prima metà V secolo a.C.) (d’Ercole e Benelli 2004, 76, 128, 188, 201). Campovalano: t. 91, n. 2; t. 97, n. 52 (prima metà VI secolo a.C.; Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 19, 26); nella stessa necropoli il tipo è attestato anche in età ellenistica: A. Martellone in d’Ercole, Martellone e Cesana 2016, 123, tipo 2 delle lance medie. Datazione. VI secolo a.C.
27); t. 69, n. 30; t. 131, n. 2; t. 460, n. 8; t. 496, n. 10 (prima metà VI secolo a.C.; Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 13, 55, 119, 123). Colfiorito di Foligno: tipo 65, diffuso nella fase IIIA della necropoli (Bonomi Ponzi 1997, 114116). Datazione. VI-prima metà del V secolo a.C. Tipo T.40.4. Punta di lancia in ferro con lama stretta allungata e costolatura centrale; cannone a sezione circolare, di lunghezza poco inferiore a quella della lama. Lunghezza tra 35 e 45 cm (Fig. 2.52). Distribuzione. Presciano, scavi 2010: tomba 37, n. 5; tomba 43, n. 5; tomba 53, n. 5. Confronti. Vicino al tipo H1 di Bazzano, attestato nella III fase della necropoli (Weidig 2014, 166). Campovalano: t. 38, n. 5 (prima metà VI secolo a.C.; Chiaramonte Treré e d’Ercole 2003, 32); t. 287, n. 5 (Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 98). Colfiorito di Foligno: tipo 44A, diffuso nella fase IIIB della necropoli (Bonomi Ponzi 1997, 132). Datazione. Dall’età tardo-arcaica al periodo ellenistico. Tipo T.40.5. Punta di lancia in ferro con lama a foglia di salice e costolatura centrale; stretto cannone con lunghezza superiore a quella della lama. Lunghezza 30 cm (Fig. 2.52). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 166, n. 6. Confronti. Il tipo, per quanto presente a Capestrano in un contesto di età arcaica, trova confronti anche in età più recente, come ad esempio nella tomba 1411 di Bazzano (seconda metà IV-III secolo a.C.; d’Ercole e Martellone 2008, 158). Campovalano: t. 510, n. 125 (VI secolo a.C.; Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 125). Datazione. VI secolo a.C.
Tipo T.40.7. Punta di lancia in ferro con lama affusolata a fiamma e costolatura centrale; stretto cannone a sezione circolare, di lunghezza poco inferiore a quella della lama. Lunghezza 46 cm (Fig. 2.53). Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 3, n. 5. Attestato anche in contesti di età ellenistica, ad esempio a Campovalano: A. Martellone in d’Ercole, Martellone e Cesana 2016, 123-124, tipo 2 delle lance lunghe. Confronti. Vicino al tipo F2 di Bazzano (Weidig 2014, 166). Datazione. Età arcaica. Tipo T.40.8. Punta di lancia in ferro con lama corta di forma romboidale e lungo cannone a sezione circolare. Lunghezza tra 20 e 49 cm (Fig. 2.53). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 169, n. 4. Presciano, scavi 2010: tomba 34, n. 6. Fontanelle, scavi 2012: tomba 39, n. 2; tomba 46, n. 7. Confronti. Vicino al tipo L2 di Bazzano, databile dalla fase III della necropoli in poi (Weidig 2014, 167) e identificato come pilum. Il tipo si diffonde comunque soprattutto in età ellenistica, come dimostra il caso di Campovalano: A. Martellone in d’Ercole, Martellone e Cesana 2016, 125, tipo 5 delle lance medie. Per la val di Sangro (Alfedena, Barrea) e l’area peligna (Casale di Cocullo): Benelli e Rizzitelli 2012, 71, 87. Loreto Aprutino, necropoli di Colle Carpini: Staffa 2003a, 579, fig. 18, n. 29. Datazione. Dall’età tardo-arcaica al periodo ellenistico.
Tipo T.40.6. Punta di lancia in ferro con metà inferiore della lama espansa e distinta e costolatura centrale; cannone a sezione circolare, di lunghezza poco inferiore a quella della lama. Lunghezza 40.6 (Fig. 2.53). Distribuzione. Capo d’Acqua, scavi 2011: tomba 24, n. 3 Confronti. Vicino al tipo F1 di Bazzano, attestato nella fase II della necropoli (Weidig 2014, 166). Fossa: t. 180, n. 2 (metà-terzo 145
Capestrano, I
PUNTE DI GIAVELLOTTO (Forma 50).
romboidale. Lunghezza 21.9 cm (Fig. 2.54). Distribuzione. Fossascopana, scavi 1934: tomba 12, n. 13. Confronti. Fossa: t. 434, n. 6 (prima metà VI secolo a.C.); t. 437 (fine VI-V secolo a.C.) (d’Ercole e Benelli 2004, 180, 184). Datazione. VI secolo a.C.
Tipo T.50.1. Punta di giavellotto in ferro con lama corta foliata; cannone a sezione circolare, di lunghezza poco inferiore a quella della lama. Lunghezza tra 16 e 20 cm (Fig. 2.53). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 112, n. 10 (con sauroter); tomba 134, n. 3; tomba 185, n. 8; tomba 260, n. 3; tomba 266, n. 4. Capo d’Acqua, scavi 2011: tomba 15, n. 6. Fontanelle, scavi 2012: tomba 4, n. 10; tomba 27, n. 4; tomba 36, n. 6 (con sauroter). Confronti. Vicino al tipo G3, Var. A di Bazzano, attestato nella fase IIB2 della necropoli (Weidig 2014, 166). Fossa: t. 347, nn. 2-3 (prima metà/decenni centrali VI secolo a.C.); t. 415, n. 8 (fine VII-prima metà VI secolo a.C.) (d’Ercole e Benelli 2004, 144, 176). Campovalano: t. 163, n. 33; t. 174, n. 28 (prima metà VI secolo a.C.; Chiaramonte Treré e d’Ercole 2003, 77, 91); t. 71, n. 4 (Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 14). Datazione. Fine VII-VI secolo a.C. Tipo T.50.2. Punta di giavellotto in ferro con lama deltoide; costolatura centrale; cannone corto a sezione circolare. Lunghezza tra 9.6 e 19 cm (Fig. 2.53). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 177, n. 10. Fontanelle, scavi 2012: tomba 36, n. 7 (con sauroter); tomba 42, n. 10. Confronti. Attestato anche in contesti di età ellenistica, ad esempio a Campovalano: A. Martellone in d’Ercole, Martellone e Cesana 2016, 125, tipo 2 delle lance corte. Datazione. Fine VII-VI secolo a.C.
Tipo T.50.5. Punta di giavellotto in ferro con lama lievemente espansa nella metà inferiore, costolatura centrale; cannone a sezione circolare, di lunghezza poco inferiore a quella della lama. Lunghezza 18 cm (Fig. 2.54). Distribuzione. Fontanelle, scavi 2012: tomba 5, n. 4. Confronti. Fossa: t. 273, n. 3 (prima metà V secolo a.C.; d’Ercole e Benelli 2004, 111). Corfinio, loc. Madonna delle Grazie: Dionisio 2015, 385, t. 1, cat. 599 (inizi II secolo a.C.). Datazione. III secolo a.C. Tipo T.50.6. Punta di giavellotto in ferro con lama indistinta rispetto al cannone a sezione circolare. Lunghezza 21.5 cm (Fig. 2.54). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 239, n. 5. Datazione. III secolo a.C. SAUROTERES (Forma 60). I puntali, la cui funzione era quella di bilanciare il peso delle lance e dei giavellotti, sono attestati in un solo tipo. In generale, vedi Weidig 2014, 179-180. Tipo T.60.1. Sauroter in ferro di forma conica allungata a sezione circolare. Lunghezza tra 7 e 12.5 cm (Fig. 2.54). Distribuzione. Fossascopana, scavi 2003-2009: tomba 112, n. 11-12; tomba 173, n. 7; tomba 177, n. 11; tomba 204, n. 5; tomba 211, n. 4; tomba 230, n. 13; tomba 260, n. 4; tomba 284, n. 4. Fonte di Presciano, scavi 2010: tomba 18, nn. 9-10. Capo d’Acqua, scavi 2011: tomba 15, n. 7; tomba 18, n. 5. Fontanelle, scavi 2012: tomba 4, n. 11; tomba 36, nn. 8-9; tomba 42, n. 11.
Tipo T.50.3. Punta di giavellotto in ferro con stretta lama allungata; cannone a sezione circolare, di lunghezza poco inferiore a quella della lama. Lunghezza 16.5 cm (Fig. 2.53). Distribuzione. Presciano, scavi 2010: tomba 8, n. 6. Confronti. Fossa: t. 121, n. 3 (terzo quarto VI secolo a.C.; d’Ercole e Benelli 2004, 54). Datazione. VI secolo a.C. Tipo T.50.4. Punta di giavellotto in ferro con lama romboidale; cannone lungo a sezione 146
La tipologia dei materiali
Confronti. Vedi, per Bazzano: Weidig 2014, 179-180. Campovalano: A. Martellone in d’Ercole, Martellone e Cesana 2016, 126, tipo 2. Datazione. La maggior parte degli esemplari attestati a Capestrano si datano tra la fine del VII e gli inizi del V secolo a.C. TESTE DI MAZZA (Forma 70). Sulla funzione di questi manufatti, innestati originariamente su un elemento in materiale deperibile, e la loro interpretazione anche come “insegne” di potere per individui maschili di livello emergente, vedi d’Ercole 2011, 44. Tipo T.70.1. Testa di mazza in ferro di forma ovoidale; foro passante per l’innesto di un elemento in legno (Fig. 2.54). Distribuzione. Fossascopana, scavi 1934: tomba 12, n. 14. Confronti. Corrisponde al tipo 2 di Bazzano, specificamente all’esemplare della tomba 953, della fase IIB2 (Weidig 2014, 185-186). Campovalano: t. 87, n. 4 (prima metà VI secolo a.C.; Chiaramonte Treré, d’Ercole e Scotti 2010, 17, n. 4). Datazione. VI secolo a.C.
147
Capestrano, I
148
La tipologia dei materiali
149
Capestrano, I
150
La tipologia dei materiali
151
Capestrano, I
152
La tipologia dei materiali
153
Capestrano, I
154
La tipologia dei materiali
155
Capestrano, I
156
La tipologia dei materiali
157
Capestrano, I
158
La tipologia dei materiali
159
Capestrano, I
160
La tipologia dei materiali
161
Capestrano, I
162
La tipologia dei materiali
163
Capestrano, I
164
La tipologia dei materiali
165
Capestrano, I
166
La tipologia dei materiali
167
Capestrano, I
168
La tipologia dei materiali
169
Capestrano, I
170
La tipologia dei materiali
171
Capestrano, I
172
La tipologia dei materiali
173
Capestrano, I
174
La tipologia dei materiali
175
Capestrano, I
176
La tipologia dei materiali
177
Capestrano, I
178
La tipologia dei materiali
179
Capestrano, I
180
La tipologia dei materiali
181
Capestrano, I
182
La tipologia dei materiali
183
Capestrano, I
184
La tipologia dei materiali
185
Capestrano, I
186
La tipologia dei materiali
187
Capestrano, I
188
La tipologia dei materiali
189
Capestrano, I
190
La tipologia dei materiali
191
Capestrano, I
192
La tipologia dei materiali
193
Capestrano, I
194
La tipologia dei materiali
195
Capestrano, I
196
La tipologia dei materiali
197
Capestrano, I
198
La tipologia dei materiali
199
Capestrano, I
200
La tipologia dei materiali
201
CAPITOLO III Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture Valeria Acconcia e Deneb Cesana Nel catalogo che segue e in quello contenuto nel secondo volume, i singoli contesti tombali sono stati descritti il più esaustivamente possibile sulla base della documentazione di scavo disponibile e dei materiali antropologici e di corredo conservati. Per ciascuna tomba sono fornite la descrizione della sepoltura e i dati tafonomici come documentati al momento del scavo. Seguono i dati antropologici 1 dello studio sui resti umani effettuato in fase di laboratorio e i dati archeologici relativi agli oggetti di corredo, sulla base dei quali sono state avanzate anche proposte di interpretazione del sesso e dell’età archeologici dei singoli individui, utili a sopperire l’assenza di informazioni desumibili dai resti antropologici, laddove essi non fossero conservati. Le misure delle tombe, così come quelle dei materiali, sono espresse in cm. Nelle schede delle sepolture2, per “ripostiglio”
si intende la composizione di un contenitore di forma chiusa di medie e grandi dimensioni, spesso associato a una forma vascolare per attingere, protetti da consistenti accumuli di spezzoni litici e deposti in corrispondenza del lato corto delle tombe a fossa di età arcaica, o alloggiati in nicchie ricavate nelle pareti delle fosse di età ellenistica (sul “ripostiglio”, vedi il II Volume di questo lavoro; Weidig 2014, 4142, 702-706; Acconcia 2014, 19-20). Per quanto riguarda i corredi, la loro descrizione segue un ordine funzionale, ovvero: 1) Vasellame ceramico e in lamina bronzea, per il consumo, la conservazione e la manipolazione di cibi e bevande, per la conservazione di oli e unguenti e per l’illuminazione (classi A-N, P); 2) Strumentario per la preparazione e la cottura dei cibi, per la filatura e la tessitura (classe Q); 3) Strumentario per la cura della persona (classe R); 4) Ornamenti (classe S); 5) Armi (classe T).
1
Lo studio antropologico è stato effettuato interamente da Deneb Cesana presso il Museo delle Paludi di Celano (AQ) e il deposito della Soprintendenza ABAP Abruzzo presso il comune di Capestrano (AQ) e riguarda tutti i materiali osteologici disponibili per l’analisi conservati in queste due sedi. Nella struttura del catalogo la parte antropologica privilegia un approccio descrittivo individuale con lo scopo di evidenziare la centralità del defunto. I dati antropologici e paleopatologici sono ricavati applicando le consolidate metodologie di ambito bio-archeologico e forense come proposto da Ortner (2003), Cattaneo e Grandi (2004), Schaefer, Black e Scheuer (2009) e Canci e Minozzi (2010). Nel caso delle incinerazioni si è fatto riferimento alle metodologie di indagine proposte da Schmidt e Symes (2015). Per ogni individuo quindi è fornita una sintesi sulle caratteristiche principali che hanno permesso di delineare il profilo biologico: stato di conservazione, determinazione del sesso, stima dell’età alla morte, rilievo di anomalie scheletriche e paleopatologie, calcolo della statura in vita. Le immagini relative ai singoli reperti scheletrici sono disponibili al link online e vengono nel testo indicate come “fig.antr.online”. Si rimanda al secondo volume per la pubblicazione dell’elaborazione dei dati antropologici e l’interpretazione popolazionistica e contestuale. 2 Per quanto riguarda la schedatura dei materiali archeologici, le differenze riscontrabili nella
Nelle schede dei materiali è proposto il rimando alla tipologia generale nella maggior parte dei casi. Le caratteristiche tecnologiche dei materiali ceramici sono descritte sulla base dell’osservazione autoptica, e la loro completezza dipende dal grado di conservazione dei singoli esemplari che, se integri, possono essere descritti negli impasti solo parzialmente.
pubblicazione di questi dati, così come nella resa delle tavole, sono riconducibili alla variabilità nella loro redazione. Valeria Acconcia si è occupata di uniformare e implementare in modo il più possibile organico tale documentazione e renderla fruibile in maniera omogenea. 203
Capestrano, I
scavo del 1934 (vedi, 4, 19). Sono attestate alcune tombe “a grotticella” di età ellenistica, particolarmente concentrate nel Saggio C (tombe 122, 143, 151, 157, 163, 172 e 174-175), dove sembrano disposte secondo un andamento circolare, con i corridoi di accesso rivolti verso l’esterno, probabilmente da riferire all’originaria presenza di un tumulo più antico (vedi, 5).
III.1. FOSSASCOPANA: LA CAMPAGNA 2003 (TOMBE 100-192) (Silvia D’Alessandro; Deneb Cesana per le analisi antropologiche)3. Come già accennato nel Capitolo I di questo volume (vedi, 8), i Saggi A, B ed E del 2003 non hanno restituito emergenze ascrivibili con sicurezza a contesti funerari. A tale proposito, quindi, non è stata effettuata una documentazione della planimetria generale delle sepolture, ma solo una di dettaglio di alcune delle fosse venute alla luce (vedi il catalogo di seguito). Proprio nell’ambito di questi saggi, sono state individuate fosse di forma rettangolare, prive di resti antropologici o materiali di corredo, che possono essere identificate come tombe disturbate e spoliate (tombe 100, 104-107, 127). Vi sono poi almeno due serie di tagli di forma rettangolare, localizzati nel Saggio B, che si dispongono, a gruppi di tre-quattro, a raggiera intorno a tagli più piccoli di forma quadrangolare: si tratta delle emergenze numerate come 101-103 e delle nn. 110-111, 117 e 119. Queste emergenze sono chiaramente identificabili come fosse da piantata per alberate, realizzate nell’area in età moderna. Ancora ad età moderna si possono ascrivere alcune strutture murarie a secco di scarsa consistenza, che in alcuni casi disturbavano le strutture funerarie preesistenti (vedi, ad esempio, l’US 241 rispetto alla tomba 175). La maggior parte delle sepolture indagate nei Saggi C e D, si acrivono alla tipologia della tomba a fossa con singolo inumato, attestata continuativamente dalla fine del VII secolo a.C. fino alla tarda età ellenistica. Più rare sono invece le sepolture a incinerazione della prima età imperiale (tombe 118, 120-121, 138, 140, 160, 189), rinvenute tutte nel Saggio D, a ridosso del percorso della strada antica (numerato alla planimetria alla Tav. 6 come US 411), a conferma di quanto già emerso nello
Tomba 100 (Saggio B; mancano sia il posizionamento generale che la planimetria di dettaglio). Fossa rettangolare, con sviluppo longitudinale in senso nord-ovest/sud-est (lungh. 140; largh. 56; prof. 50-80). Al momento dello scavo, era sconvolta e priva di materiali e resti antropologici: non è pertanto possibile definirne la funzione originaria e proporne un inquadramento cronologico puntuale. Come già accennato nell’introduzione a questo paragrafo, i numeri da 101 a 103 sono stati assegnati in corso di scavo a evidenze attribuite poi a interventi agricoli. Tomba 104 (Saggio B; mancano sia il posizionamento generale che la planimetria di dettaglio). Fossa di forma pressoché rettangolare, con sviluppo longitudinale in senso nord-ovest/sudest (lungh. 141; largh. 61; prof. 19-52). I margini sono irregolari, probabilmente a causa di interventi di disturbo avvenuti in antico; è stata inoltre riscontrata una notevole inclinazione del fondo da ovest verso est. Al suo interno non si conservano resti antropologici o materiali di corredo: non è pertanto possibile definirne la funzione originaria né proporne un inquadramento cronologico puntuale. Tomba 105 (Saggio A; mancano sia il posizionamento generale che la planimetria di dettaglio). Fossa rettangolare (lungh. 88; largh. 80; prof. 43), localizzata presso il limite settentrionale del Saggio A. L’evidenza è stata indagata solo parzialmente. Al suo interno non si conservano resti antropologici o materiali di corredo in giacitura primaria e la terra di riempimento ha
3
La schedatura delle tombe e dei rispettivi corredi per questo volume è stata curata da Silvia D’Alessandro e fa riferimento ai dati raccolti nell’ambito del progetto EQUAL “Terra dei Guerrieri” coordinato sotto la direzione scientifica di Vincenzo d’Ercole; la documentazione grafica delle sepolture e dei corredi è stata realizzata da Gianfranco Mieli. Le analisi antropologiche sono a cura di Deneb Cesana. 204
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
2.5YR 5.5/8. Realizzata al tornio. L’esemplare è parzialmente ricomposto da alcuni frammenti, lacunoso in corrispondenza del ventre. Tipo E.40.1.
restituito pochi frammenti ceramici concentrati nell’angolo sud-occidentale, suggerendo che l’evidenza sia stata pesantemente disturbata: non è pertanto possibile definirne la funzione originaria né proporne un inquadramento cronologico puntuale.
n. 2 (Tav. 26, 2): olletta in ceramica comune. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con abbondanti inclusi calcarei e micacei distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 5YR 2.5/1; superficie ruvida. Si conservano solo frammenti del ventre e del piede. Realizzata al tornio. L’esemplare non è ascrivibile a un tipo specifico.
Tomba 106 (Saggio A; mancano sia il posizionamento generale che la planimetria di dettaglio). Fossa rettangolare, con sviluppo longitudinale in senso nord-sud (lungh. 143; largh. 60; prof. 33). Al suo interno non si conservano resti antropologici o materiali di corredo in giacitura primaria, mentre la terra di riempimento ha restituito pochi frammenti di impasto buccheroide, di impasto grezzo e un frammento di ceramica a vernice nera, suggerendo che l’evidenza sia stata pesantemente disturbata: non è pertanto possibile definirne la funzione originaria né proporne un inquadramento cronologico puntuale.
Tomba 108 (Saggio D; Tavv. 6-7). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso nord-ovest/sud-est (lungh. 183, largh. 35; prof. 26); danneggiata dall’intervento del braccio meccanico nel corso dell’apertura di una trincea esplorativa, localizzata a ridosso e oltre il limite nordoccidentale del saggio di scavo. La deposizione è dorsale, primaria e probabilmente in uno spazio vuoto. Si conservano il cranio, orientato a ovest, e gli arti superiori piegati e convergenti al livello delle prime vertebre lombari. Dati antropologici. I resti umani, in condizioni di conservazione molto frammentarie, appartengono ad un individuo adulto di sesso maschile giovane, probabilmente con età compresa tra 17 e 25 anni. L’area nucale occipitale del cranio ed il profilo della mandibola, sebbene non integri, presentano caratteristiche di dimorfismo sessuale secondario decisamente maschili. La valutazione della stima dell’età alla morte è limitata all’osservazione dell’usura dentaria che risulta lieve e delle suture craniche che sono ben separate. Per quanto riguarda lo scheletro postcraniale, non si rilevano anomalie. Sono presenti frammenti di colonna vertebrale, di diafisi degli arti superiori ed inferiori ed alcuni elementi delle estremità di mani e piedi. Dati archeologici. La tomba è priva di materiali di corredo; si rinviene solo un frammento di coppo in corrispondenza dell’arto superiore destro. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Incerto.
Tomba 107 (Saggio C; Tav. 5, manca la planimetria di dettaglio). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare (lungh. max. cons. 90; largh. 71; prof. 60), localizzata lungo il limite sud-occidentale del Saggio C, in seguito alla realizzazione di una trincea di approfondimento con mezzo meccanico. Le difficoltà legate allo scavo ne hanno reso difficile realizzarne la documentazione sul campo. La tomba è stata disturbata in antico dal corridoio di accesso della tomba 163 (vedi, 238-239). Dati antropologici. La sepoltura risulta priva di resti antropologici. Dati archeologici. Sul fondo della fossa si conserva un’olla in ceramica a bande (n. 1), contenente un’olletta in ceramica comune (n. 2): si tratta probabilmente del ripostiglio. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Età ellenistica. n. 1 (Tav. 26, 1): olla in ceramica a bande. Diam. orlo 15; alt. 25.4. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con inclusi di minute dimensioni molto rari e distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10 YR 8.5/3; superficie liscia. Vernice distribuita in maniera disomogenea; colore vernice: Munsell 205
Capestrano, I
elementi del piede sinistro. Dati archeologici. All’interno del contenitore ligneo, si rinvengono una spada in ferro lungo il fianco destro del defunto (n. 7), sulla quale si trova adagiato un coltello in ferro (n. 8); a est della spada, una fibula in ferro (n. 6); ai piedi dell’inumato sono deposti i calzari in legno e ferro (n. 13) e un bacile ad orlo perlinato in bronzo (n. 4). All’esterno del contenitore ligneo, a est del defunto, si rinvengono un calderone in bronzo con manico in ferro in corrispondenza del bacino (n. 3); in corrispondenza dei piedi dell’inumato, una punta di lancia e una punta di giavellotto in ferro (nn. 9-10), con i rispettivi sauroteres (nn. 11-12) deposti nell’angolo opposto della fossa. Il ripostiglio è composto da un’olletta biansata in impasto buccheroide (n. 2) e pochi frammenti di una scodella in impasto (n. 1). Nell’angolo settentrionale della fossa, si rinvengono due spiedi in ferro (n. 5). Il sesso archeologico è determinabile come maschile. Inquadramento cronologico. Metà/seconda metà VI secolo a.C.
Tomba 109 (Saggio C; Tavv. 5, 7). Fossa di forma irregolare e indistinta, probabilmente disturbata dall’azione del braccio meccanico che, durante i lavori di apertura del Saggio C, sembra aver intaccato anche la vicina tomba 114 (vedi, 208). Non è pertanto chiaro se tale evidenza sia il resto di una sepoltura o solo l’esito di un pesante intervento di asporto che avrebbe danneggiato proprio la tomba 114. L’unica misura recuperabile è la profondità rispetto al margine superiore (30) del piano di deposizione della fossa 109, inclinato da est a ovest. Il riempimento si presenta pesantemente sconvolto e conserva frammenti antropologici che potrebbero appartenere alla vicina tomba 114, danneggiata dalla benna della ruspa e priva di resti scheletrici. Dati antropologici. I resti ossei di un individuo neonatale indicati inizialmente come pertinenti alla tomba 109 (vedi, 206), sono probabilmente da riferire alla 114. Dati archeologici. Non si rinvengono resti di corredo. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Incerto.
n. 1 (Tav. 27, 6): scodella carenata in impasto grezzo. Diam. orlo 18; alt. max. cons. 6.1. Impasto tenero e poroso, con numerosi vacuoli, frattura a scaglie, con numerosi inclusi di piccole e medie dimensioni distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 7.5YR 3/0. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Esemplare parzialmente ricomposto da più frammenti. Tipo A.230.A.3. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 118, fig. 11.
Come già accennato, i numeri da 110-111 sono stati assegnati in corso di scavo a evidenze attribuite poi a interventi agricoli (vedi, 204). Tomba 112 (Saggio C; Tavv. 5, 7). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso sud-nord (lungh. 310; largh. 135; prof. 100), localizzata lungo il margine occidentale del saggio di scavo. Ai piedi dell’inumato è presente il ripostiglio, probabilmente sconvolto, protetto da pietre e lastre di medie e grandi dimensioni. La deposizione è dorsale, primaria e in uno spazio vuoto; si conservano rari resti antropologici all’interno di un contenitore ligneo deposto sul fondo della fossa e delimitato da pietre di medie dimensioni. Si rileva la presenza di resti faunistici non determinabili. Dati antropologici. Il materiale osteologico umano appartiene ad un individuo adulto. Lo scheletro è incompleto e in uno stato di conservazione pessimo. Oltre ad alcuni elementi dentari, con usura limitata alle cuspidi, sono presenti frammenti di arto superiore sinistro, diafisi di entrambi gli arti inferiori,
n. 2 (Tav. 27, 7): olletta biansata in impasto buccheroide. Diam. orlo 10.4; alt. 8.5. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con rari inclusi di piccole e medie dimensioni distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 7.5YR 2/0. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Esemplare ricomposto da più frammenti. Tipo B.70.1. Bibliografia: d’Ercole e Martellone 2007a, 37, fig. 41; d’Ercole e Cella 2007b, 118, fig. 11. n. 3 (Tav. 27, 10): calderone con fondo concavo in lamina bronzea, con manico mobile in ferro. Diam. orlo 30.4; alt. 15.7. Patina verde sulla 206
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
cannone. Tipo T.40.2. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 118, fig. 11.
superficie. Lacunoso di parte della vasca e mancante del manico. Tipo O.320.1. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 118, fig. 11.
n. 10 (Tav. 27, 5): punta di giavellotto in ferro. Lungh. 17.6; lama: largh. max. 3.6; cannone: lungh. 6; diam. 2.5. Superficie corrosa e ossidata. Esemplare integro. Tipo T.50.1. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 118, fig. 11.
n. 4 (Tav. 27, 9): bacile a orlo perlinato con vasca a profilo svasato in lamina bronzea. Diam. orlo 29.2; alt. 5.3. Patina verde sulla superficie. Esemplare restaurato. Tipo O.330.A.5. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 118, fig. 11.
n. 11 (Tav. 27, 3): sauroter in ferro. Lungh. 8.2; diam. 2.1. Superficie corrosa e ossidata. Integro. Tipo T.60.1. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 118, fig. 11.
n. 5 (Tav. 27, 11): coppia di spiedi in ferro con testa a ricciolo. Lungh. 37.2 e 44.8; spessore 0.9 e 0.6. Superficie corrosa e ossidata. Esemplari frammentari; uno parzialmente ricomposto. Tipo Q.60.1. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 118, fig. 11.
n. 12 (Tav. 27, 4): sauroter in ferro. Lungh. 8.2; diam. 1.4. Superficie corrosa e ossidata. Integro. Tipo T.60.1. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 118, fig. 11.
n. 6 (Tav. 27, 12): fibula in ferro con arco a tripla ondulazione. Lungh. max. cons. 9.5; alt. 4.6. Superficie corrosa e ossidata. Esemplare lacunoso (manca parte dell’ago). Probabilmente ascrivibile al Tipo S.20.B.4. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 118, fig. 11.
n. 13: calzari in legno e ferro. Esemplari molto frammentari; le parti metalliche presentano una superficie ossidata e corrosa, con tracce di legno. I vari frammenti mostrano la presenza di una fascetta di ferro che avvolge la parte esterna dei calzari. Il calzare destro è meglio conservato del sinistro.
n. 7 (Tav. 27, 1): spada in ferro. Lungh. 80.5; lama: largh. max. 4.4; spessore lama 0.8; elsa: lungh. 11; spessore elsa 3. Superficie corrosa e ossidata. Esemplare restaurato; si conservano tracce di tessuto sull’impugnatura e buona parte del pomo a traforo. Tipo T.20.1, varietà a. Bibliografia: d’Ercole e Martellone 2007a, 37, fig. 42; d’Ercole e Cella 2007b, 118, fig. 11.
Tomba 113 (Saggio D; Tavv. 6, 7). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso ovest-est (lungh. 115; largh. 77; prof. non puntualizzata), realizzata intaccando profondamente la più antica tomba 139 (vedi, 223). La deposizione è in decubito laterale destro, in posizione fetale, primaria ed in uno spazio vuoto. Tra il materiale osteologico raccolto, oltre all’individuo principale, si registrano denti anteriori (incisivi e premolari) non attribuibili all’inumato e resti di fauna (tra cui, un molare e un astragalo di equide). Dati antropologici. I resti umani appartengono ad un individuo adulto di sesso femminile di età probabilmente compresa tra 35 e 45 anni. A causa dello stato di conservazione frammentario, la determinazione del sesso e la stima dell’età alla morte sono basati su pochi indicatori, in particolare la morfologia del
n. 8 (Tav. 27, 8): coltello affila-lama in ferro. Lungh. 30.7; largh. max. 4.8; spessore max. 0.7. Superficie corrosa e ossidata. Integro; si conservano tracce di tessuto sull’impugnatura. Tipo T.30.1. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 118, fig. 11. n. 9 (Tav. 27, 2): punta di lancia in ferro. Lungh. 30.5; lama: largh. max. 5; spessore: 0.9; cannone: lungh. 6.9; diam. 2.2. Superficie corrosa e ossidata. Esemplare integro; si conserva parte dell’asta lignea innestata nel 207
Capestrano, I
del braccio meccanico e manca della metà inferiore; è delimitato a est e a sud da spezzoni calcarei. I resti antropologici dovevano essere originariamente adagiati al di sotto del coppo, a diretto contatto col terreno. A ovest, ai limiti del Saggio C, si rinvengono i resti ossei di un individuo neonatale indicati inizialmente come pertinenti alla tomba 109 (vedi, 206), ma probabilmente da riferire alla 114. Dati antropologici. I resti umani conservati appartengono a un sub-adulto perinatale, in particolare si tratta di pochi frammenti di cranio e di diafisi delle ossa lunghe, ma anche delle corone dei denti molari decidui mandibolari. La lunghezza massima anteroposteriore della pars petrosa risulta di 34.6 mm, corrispondente a una età alla morte alla 38a settimana di gestazione. Inquadramento cronologico. Incerto.
processo mastoideo, il profilo della mandibola e l’usura dentaria corrispondente a una età matura di 35-45 anni. Dati archeologici. Fanno plausibilmente parte del corredo cinque balsamari in vetro rinvenuti nelle immediate vicinanze della sepoltura (nn. 1-5), in seguito all’utilizzo del braccio meccanico per l’apertura di una trincea all’interno del Saggio D. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. I secolo d.C. n. 1 (Tav. 26, 3): balsamario piriforme in vetro. Diam. orlo 2; alt. 7. Integro. Colore blu. Tipo P.130.1. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 121, fig. 18. n. 2 (Tav. 26, 4): balsamario piriforme in vetro. Dia. orlo 1.5; alt. 6. Integro. Colore blu. Tipo P.130.2. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 121, fig. 18.
Tomba 115 (Saggio C; Tavv. 5, 7). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso nord-est/sud-ovest (lungh. 115; largh. 40; prof. 12), localizzata nella porzione sud-orientale del Saggio C. In corrispondenza dell’angolo nord-occidentale della fossa, si conserva il ripostiglio. Deposizione dorsale, primaria e in uno spazio vuoto. Dati antropologici. L’inumato è un sub-adulto di circa 2-3 anni. Lo scheletro è abbastanza completo e ben conservato sia per quanto riguarda il cranio e gli elementi dentari, che il postcranio. Lo sviluppo degli elementi dentari corrisponde ad una età di 2 anni otto mesi. La completa fusione della sutura metopica nell’area della glabella sul frontale indica una età maggiore di 2 anni, mentre lo stato di maturazione scheletrica dell’arco delle vertebre cervicali al corpo vertebrale è compatibile con una età minore di 3-4 anni. I dati osteometrici relativi alla pars basilaris del cranio (W 22.5 mm; S 15.39 mm; L 23.02 mm) corrispondono ad una età tra 2 e 3 anni. Su quest’ultimo reperto si rileva una diffusa assenza di tessuto osseo che conferisce aspetto poroso, di eziologia non specifica (fig.antr.online 115_01A, 115_01B). Dati archeologici. Il ripostiglio è composto da uno skyphos in ceramica a vernice nera (n. 1) e un’olletta in ceramica comune (n. 2). Il sesso archeologico non è determinabile.
n. 3 (Tav. 26, 5): balsamario piriforme in vetro. Diam. orlo 1.5; diam. max. espansione 3.8; alt. 6. Mancante di parte del fondo. Colore blu. Tipo P.130.6. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 121, fig. 18. n. 4 (Tav. 26, 6): balsamario piriforme in vetro. Diam. orlo 1.6; alt. 5.1. Frammentario, mancante di parte del ventre e del collo. Colore blu. Tipo P.130.1. n. 5 (Tav. 26, 7): balsamario in vetro. Diam. orlo 1; alt. max. cons. 5.1. Frammentario, mancante del labbro. Colore giallo. Tipo P.130.8. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 121, fig. 18. Tomba 114 (Saggio C; non posizionata puntualmente nella planimetria generale, Tav. 7). Sepoltura neonatale in coppo, orientata lungo l’asse nord-est/sud-ovest (fossa: lungh. 64; largh. 30; prof. 30; coppo: lungh. 60; largh. 30), localizzata presso il margine nord-occidentale del Saggio C. Il coppo è disturbato dall’azione 208
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
vertebra e uno di costa, una falange di mano. Di conseguenza si può soltanto ipotizzare che si potesse trattare di un giovane adulto. I resti umani non mostrano traccia di uno stato di combustione avanzata. In totale il peso risulta di 111.85 gr. Dati archeologici. Nel riempimento della fossa sono stati rinvenuti vari frammenti ceramici (nn. 1-2); tre chiodi in ferro (nn. 4-5) relativi probabilmente a un contenitore ligneo; un chiodino in bronzo (n. 3) e un anello in ferro con castone (n. 6). Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Fine I secolo a.C.inizi I secolo d.C.
Inquadramento cronologico. Fine III-prima metà II secolo a.C. n. 1 (Tav. 26, 8): skyphos a profilo troncoconico in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 11; alt. 14.4. Impasto duro, compatto, frattura regolare; inclusi di dimensioni minute molto rari distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 10YR 6/4. Vernice opaca, poco omogenea ed evanide su gran parte della superficie del vaso; colore: Munsell 7.5YR 2/0. Realizzato al tornio. L’esemplare è privo di un’ansa. Tipo H.280.8. n. 2 (Tav. 26, 9): olletta ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 8.7; alt. 8.8. Impasto duro, poroso, frattura frastagliata, con frequenti inclusi di piccole e medie dimensioni; colore: Munsell 5YR 5/8. Superficie ruvida. Realizzata al tornio. L’esemplare è parzialmente ricomposto. Tipo I.50.B.9, varietà b.
n. 1 (Tav. 26, 10): olletta in ceramica comune. Diam. orlo 7.4; alt. max. cons. 5.3. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con frequenti inclusi di piccole e medie dimensioni, visibili anche sulla superficie esterna; colore: Munsell 7.5YR 8/4. Superficie scabra. Realizzata al tornio. Frammentaria, si conservano parti del labbro, della spalla e del ventre. Tipo I.50.B.9, varietà b.
Tomba 116 (Saggio C; Tavv. 5, 7). Fossa rettangolare, orientata lungo l’asse estovest (lungh. 128; largh. 56; prof. 27), localizzata nell’area sud-orientale del Saggio C. La fossa era priva di resti antropologici e di corredo: non è pertanto possibile definirne la funzione originaria né proporne un inquadramento cronologico.
n. 2 (Tav. 26, 11): olletta in ceramica comune. Diam. fondo 4.8; alt. max. cons. 4.4. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con frequenti inclusi di piccole dimensioni, visibili anche sulla superficie esterna; colore: Munsell 7.5YR 5/4.Superficie scabra. Realizzata al tornio. Frammentaria, si conserva solo parte del fondo.
Come già accennato nell’introduzione a questo paragrafo, il numero 117 è stato assegnato in corso di scavo a un’evidenza attribuita poi a interventi agricoli (vedi, 204).
n. 3: chiodo di bronzo. Diam. testa 0.6; lungh. 2; spessore 0.2. Superficie coperta di patina verde. Integro. Tipo non puntualizzabile.
Tomba 118 (Saggio D; Tavv. 6, 8). Tomba a incinerazione (lungh. 50; largh. 40; prof. non puntualizzabile), localizzata presso il limite nord-occidentale del Saggio D, sconvolta dai lavori agricoli. Con i pochissimi resti antropologici, sono stati raccolti anche reperti faunistici combusti, tra cui si segnala la presenza di malacofauna terrestre e di ossa di bovino (mandibola, dente molare, scapola, calcagno), equide (terza falange) e, probabilmente, suino (canino mal conservato). Dati antropologici. Il materiale osteologico umano relativo a questo contesto tombale è limitato a tre elementi dentati privi di usura, pochi frammenti di osso sacro, un frammento di
n. 4: due chiodi di ferro. Diam. testa 0.9 e 1.2; lungh. 1 e 1.3; spessori 0.3, 0.4. Superficie corrosa e ossidata. Integri. Tipo non puntualizzabile. n. 5: chiodo di ferro. Diam. testa 1.1; lungh. 2.9; spessore 0.3. Superficie ossidata e corrosa. Integro. Tipo non puntualizzabile. n. 6: anello di ferro con castone. Spessore verga 0.2-0.3; diam. anello 2; diam. castone 1.2. Superficie ossidata e corrosa. Lacunoso. Tipo non puntualizzabile. 209
Capestrano, I
estremamente frammentarie, non è possibile ascrivere l’esemplare a un tipo specifico.
Come già accennato nell’introduzione a questo paragrafo, il numero 119 è stato assegnato in corso di scavo a un’evidenza attribuita poi a interventi agricoli (vedi, 204).
n. 4 (Tav. 26, 18): lucerna. Lungh. max. cons. 2.5. Impasto duro, compatto, frattura netta, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 7/4. Superficie liscia. Realizzata a stampo. Si conserva solo parte della vasca e della decorazione del disco, circondato da tre linee incise, all’interno delle quali si riconoscono una fila di cerchielli impressi. Per le condizioni estremamente frammentarie, non è possibile ascrivere l’esemplare a un tipo specifico.
Tomba 120 (Saggio D; Tav. 6, manca la planimetria di dettaglio). Tomba a incinerazione realizzata in una fossa quadrangolare con angoli arrotondati (lungh. 73; largh. 54; prof. 35), localizzata presso il limite meridionale del saggio di scavo. Di tale evidenza non è stata realizzata planimetria di dettaglio. Nel riempimento si rinvengono pochi frammenti di ossa umane combuste probabilmente appartenenti al defunto e scarsi resti ossei. Dati antropologici. I resti dell’individuo della tomba in esame non risultano presenti in deposito quindi non disponibili all’analisi. Dati archeologici. Il riempimento della fossa ha restituito un frammento di coppetta in ceramica depurata acroma (n. 1); un frammento di olletta in ceramica comune (n. 2); frammenti di lucerne (nn. 3-4) e di balsamari in vetro (nn. 58). Sono stati rinvenuti anche tre chiodi in ferro (n. 9) e altri tre, più piccoli (non documentati nella Tav. 26), che appartengono plausibilmente a una cassetta lignea in cui era contenuto l’incinerato. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. I secolo d.C.
n. 5 (Tav. 26, 14): balsamario ceramico. Diam. fondo 1.8; alt. max. cons. 1.2 Impasto duro, compatto, frattura netta, privo di inclusi; colore: Munsell 7.5YR 7.8/4. Superficie polverosa. Realizzato al tornio. Si conserva solo parte del ventre ovoide e del fondo piano. Tipo non puntualizzabile. n. 6 (Tav. 26, 15): balsamario ceramico. Diam. fondo 1.9; alt. max. cons. 2.6 Impasto duro, compatto, frattura netta, privo di inclusi; colore: Munsell 7.5YR 5/0. Superficie polverosa. Realizzato al tornio. Si conservano solo ventre ovoide e del fondo convesso. Tipo non puntualizzabile. n. 7 (Tav. 26, 13): balsamario in vetro. Largh. max. 1.8; alt. max. cons. 5.6. Colore azzurro con iridescenze. Manca del labbro ed è deformato dal calore. Per le condizioni estremamente frammentarie, non è possibile ascrivere l’esemplare a un tipo specifico.
n. 1 (Tav. 26, 16): coppetta in ceramica depurata acroma. Diam. orlo 9.2; alt. max. cons. 11. Impasto duro, compatto, frattura netta, privo di inclusi; colore: Munsell 5YR 5.6/6. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Si conserva solo parte del labbro. Tipo D.260.1.
n. 8: balsamario in vetro. Diam. fondo 2.1. Colore azzurro con iridescenze. Si conserva solo parte del ventre arrotondato e del fondo piano. Per le condizioni estremamente frammentarie, non è possibile ascrivere l’esemplare a un tipo specifico.
n. 2 (Tav. 26, 12): olletta in ceramica comune. Diam. orlo 7.2; alt. max. cons. 3.5. Impasto duro, compatto, frattura netta, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 4/1. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Si conservano il labbro e parte della spalla. Tipo I.50.B.9, varietà c.
n. 9 (Tav. 26, 19): tre chiodi in ferro. Esemplari integri: diam. testa 1.1, 1.6; lungh. 7.7-7.6; spessore spillo 0.6, 0.9; esemplare frammentario: lungh. max. cons. 5; spessore spillo 0.6. Superficie corrosa e ossidata. Due si conservano integri, con l’estremità inferiore dello spillo ricurva; il terzo si conserva solo per
n. 3 (Tav. 26, 17): lucerna. Lungh. max. cons. 2.5. Impasto duro, compatto, frattura netta, privo di inclusi; colore: Munsell 7.5YR 8/4. Superficie liscia. Realizzata a stampo. Si conserva solo parte del disco. Per le condizioni 210
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
lo spillo. Tipo Q.110.1. Tomba 121 (Saggio D; Tav. 6, manca la planimetria di dettaglio). Tomba a incinerazione realizzata in una fossa di forma irregolarmente circolare (lungh. 50, largh. 45; prof. 32). L’evidenza non è stata documentata puntualmente ed è stata esclusivamente posizionata nella planimetria generale. Nel riempimento si rinvengono le ceneri probabilmente appartenenti al defunto e scarsi resti ossei. Dati antropologici. I resti dell’individuo della tomba in esame non risultano presenti in deposito quindi non disponibili all’analisi. Dati archeologici. Il corredo risulta sconvolto da interventi post-deposizionali e si compone di una brocca in ceramica comune (n. 1), una fuseruola in impasto (n. 3) e una lucerna (n. 4). Nel riempimento si rinvengono resti lignei combusti e alcuni legumi (probabilmente offerte alimentari); chiodi con terminazione ad uncino, entrambi molto corrosi, probabilmente pertinenti a una cassetta lignea funzionale a contenere i resti combusti (n. 4). La presenza della fuseruola potrebbe suggerire un’attribuzione a un individuo di sesso femminile. Inquadramento cronologico. Avanzato I-II secolo d.C. n. 1 (Tav. 28, 5): lagynos globulare di piccole dimensioni in ceramica comune. Diam. orlo 3.6; alt. 15. Impasto duro, compatto, frattura irregolare; con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 5YR tra 5/8 e 5/1. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Ricomposta da più frammenti. Tipo I.120.2. n. 2 (Tav. 28, 1): lucerna tipo “Firmalampen”. Diam. vasca 7; lungh. becco 3.3; alt. 3.4. Impasto duro, compatto, frattura regolare; con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 5YR tra 4/1 e 5/6. Superficie liscia. Presenta una lacuna sul fondo. Tipo M.D.1. n. 3 (Tav. 28, 4): fuseruola biconica in impasto. Diam. max. espansione 3; alt. 2.4. Impasto duro, poroso, frattura frastagliata; con frequenti 211
inclusi di piccole e medie dimensioni; colore: Munsell 2.5YR 3/0-4/6. Superficie liscia. Ricomposta da due frammenti. Tipo Q.10.1. n. 4 (Tav. 28, 2-3): due chiodi in ferro con estremità ripiegate. Diam. testa 2.8, 1.8; lungh. 9 e 7; spessore spillo 0.5. Superfici ossidate e corrose. Integri. Tipo Q.110.1. Tomba 122 (Saggio C; Tavv. 5, 8). Tomba ipogeica del tipo cd. “a grotticella”, tagliata nel banco geologico, rinvenuta a ridosso del limite orientale del saggio di scavo. La camera, orientata in senso nord-est/sud-ovest, presenta pianta rettangolare con angoli arrotondati (lungh. 190; largh. 100; prof. del fondo della camera dal piano attuale di calpestio 120; alt. max. cons. 114); è accessibile tramite un corridoio orientato in senso sud-est/nordovest, caratterizzato da piano continuo con un’inclinazione del 10% circa (lungh. max. cons. 200; largh. max. 65; largh. min. 56; prof. max. 149; prof. min. 121). L’ingresso alla camera, realizzato al centro del lato lungo sudoccidentale (luce 62), era chiuso presumibilmente da una tavola lignea esternamente posta a contatto con un masso in calcare di notevoli dimensioni. Il piano di deposizione presenta un dislivello di 29 rispetto a quello del corridoio di accesso e, lungo il lato corto orientale, si conserva una risega che raggiunge l’altezza massima di 10. Volta e pareti della camera, lisciate accuratamente, sono continue con andamento curvilineo, la volta risulta aver subito un crollo parziale. All’interno del corridoio di accesso, si rinvengono alcune pietre di medie dimensioni disposte in circolo e impostate su un primo livello di riempimento. Al momento dello scavo, la camera risultava completamente riempita di terra, successivamente al crollo di parte della volta. Era occupata nel senso della larghezza dalla deposizione di un individuo supino, con gli arti distesi e paralleli tra loro ed il cranio orientato verso nord-est. La deposizione è dorsale, primaria e avvenuta in uno spazio vuoto. Sulla base della distanza tra gli omeri e della posizione delle scapole si evince che originariamente il defunto doveva essere deposto su un piano rialzato in materiale deperibile: a seguito della sua decomposizione,
Capestrano, I
2.5/0. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.260.A.1.
i resti antropologici risultano collassati. Dati antropologici. I resti umani appartengono a un individuo adulto maschile di circa 45-49 anni. La valutazione dei caratteri sessuali secondari è limitata all’osservazione del cranio: la cresta nucale e la protuberanza occipitale, il margine sovraorbitario, l’arcata sopracciliare, il processo mastoideo, osso zigomatico, compatibili con un individuo maschile. Per la stima dell’età alla morte è disponibile una porzione si superficie auricolare di ileo destro con aspetto corrispondente a 45-49 anni. I denti sia mascellari che mandibolari mostrano una usura avanzata, particolarmente grave sul lato sinistro, corrispondente a una età di 35-45 anni. I distretti scheletrici principali dello scheletro postcraniale sono rappresentati e le singole ossa discretamente conservate. Non si rilevano anomalie. Dati archeologici. Il corredo si rinviene lungo il fianco sinistro del defunto: una coppa contenente all’interno un’altra di piccole dimensioni, entrambe in ceramica a vernice nera, era posta in corrispondenza dell’ingresso alla camera (nn. 1-2). Uno skyphos a vernice nera (n. 3) era adagiato in corrispondenza della mano sinistra del defunto; un poculum in ceramica comune, presso la tibia sinistra (n. 5); un’olletta biansata in ceramica comune (n. 4) presso lo stipite nord-orientale della camera. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Fine III-prima metà II secolo a.C.
n. 3 (Tav. 28, 6): skyphos a profilo sinuoso in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 11.4; alt. 12. Impasto duro, con rari inclusi di grandi dimensioni; colore: Munsell 10YR 8/4. Vernice non uniforme presente anche sul piede; colore: Munsell 2.5YR 2.5/0. Superficie liscia. Realizzato al tornio. Integro. Tipo H.280.2. n. 4 (Tav. 28, 8): olletta biansata globulare/ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 15; alt. 21.6. Impasto tenero, con abbondanti inclusi di dimensioni medi e grandi; colore: Munsell 7.5YR tra 7 e 6/6. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Integra. Tipo I.70.3. n. 5 (Tav. 28, 10): poculum a profilo cilindrico in ceramica comune. Diam. orlo 8.6; alt. 9.3. Impasto duro, con inclusi calcarei e micacei di medie e piccole dimensioni; colore: Munsell tra 5YR 3-2.5/1 e 5YR 4/4. Superficie polverosa. Realizzato al tornio. Integro. Tipo I.190.2, varietà a. Tomba 123 (Saggio D; Tavv. 6, 9). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso nord-ovest/sud-est (lungh. 210; largh. 98; prof. 136), localizzata nella zona meridionale del Saggio D. A ovest, la fossa taglia profondamente la tomba 125, lasciandone intatta solo l’olla del ripostiglio (resti antropologici probabilmente ascrivibili alla tomba 125 sono stati rinvenuti all’interno della 123; vedi, 212); essa disturba, inoltre, la tomba 124, a est. La fossa presenta una nicchia funzionale all’alloggiamento del ripostiglio, protetta da spezzoni litici di medie dimensioni, ricavata lungo il lato settentrionale, scavata a 1 metro dal piano di deposizione (largh. max. 80; prof. max. 18): quest’ultimo presenta una lieve pendenza da ovest verso est. La deposizione è dorsale, primaria ed in uno spazio vuoto; è completa, pur se in mediocre stato di conservazione. Dalla distanza tra gli omeri e dalla posizione delle scapole si desume come essa fosse originariamente alloggiata al di sopra di un piano rialzato in materiale deperibile, la cui decomposizione ha determinato il collasso
n. 1 (Tav. 28, 7): coppa a profilo globulare in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 19.6; alt. 7.2. Impasto duro, con inclusi molto rari di piccole dimensioni; distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR tra 7 e 6/8. Vernice scarsamente coprente, mal conservata e con evidenti tracce di impronte di immersione; colore: Munsell 7.5YR tra 4 e 3/0. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.240.A.7. n. 2 (Tav. 28, 9): coppetta a profilo globulare in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 11.8; alt. 5.1. Impasto molto duro, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 8/4. Vernice coprente, compatta e lucente, presenta tracce di impronte di immersione sul piede; colore: Munsell 2.5YR 212
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
al tornio. Mancante di parte dell’orlo e frammentaria in corrispondenza della spalla. Tipo A.40.B.26.
dei resti antropologici. Il cranio è rivolto a est; gli arti superiori, distesi, convergono sulla zona del basso bacino. All’interno del riempimento, sono stati raccolte ossa di animali la cui specie di appartenenza non è determinabile (frammenti craniali e un dente incisivo). Dati antropologici. Lo scheletro appartiene a un adulto femminile di oltre 45 anni. Lo stato di conservazione è frammentario e lacunoso, infatti la stima dell’età alla morte è limitata all’osservazione dell’usura dentaria, molto avanzata. Alcuni denti risultano persi ante mortem e si documenta il riassorbimento osseo dell’alveolo, in particolare in corrispondenza del primo e secondo molare della mandibola sinistra. Durante il recupero dello scheletro, l’antropologo sul campo ha documentato il rinvenimento di “un corpo solido estraneo di forma quasi sferica con 1.5 di diametro, per il quale ipotizza un’interpretazione come cisti intracranica”. Tale reperto risulta in fase di studio. A parte, con la denominazione “ossa dal riempimento”, è conservata una ulna appartenente ad un sub-adulto, di un bambino probabilmente di circa 1 anno. Ulteriori reperti osteologici denominati “ossa dal riempimento, sul fondo”, includono frammenti di cranio, una falange di mano umana di adulto, costole e pochi frammenti. Dati archeologici. Il corredo si compone di una fibula in ferro con pendaglio posta sullo sterno della defunta (n. 6); di un anello in argento in corrispondenza delle dita della mano sinistra (n. 7). Una coppa in ceramica a vernice nera (contenente al momento del rinvenimento resti di fauna) si rinviene sulla tibia sinistra (n. 2); un piatto in ceramica a vernice nera (n. 4) e un poculum in ceramica comune (n. 5) sul piede destro. Il ripostiglio è composto da un’olla in ceramica comune, al suo interno è deposto uno skyphos in ceramica a vernice nera (nn. 1, 3). Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Fine III-prima metà II secolo a.C.
n. 2 (Tav. 29, 4): coppa a profilo globulare in ceramica in vernice nera. Diam. orlo 18.6; alt. 7.2. Impasto duro, compatto, frattura regolare; privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 8.5/6. Vernice coprente, uniforme, con colature sulla vasca e sul piede; colore: Munsell 7.5YR 2.5/0; parte inferiore del piede esterno risparmiata; impronte di immersione sulla vasca. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Leggermente lacunosa a livello dell’orlo. Tipo H.240.A.11. n. 3 (Tav. 29, 1): skyphos a profilo troncoconico in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 8.8; alt. 9.4. Impasto duro, compatto, frattura regolare; privo di inclusi; colore: Munsell 5 YR 7/2. Vernice lucida, ben conservata; colore: Munsell 2.5YR 2.5/0. Superficie liscia. Realizzato al tornio. Il piede presenta una lacuna. Tipo H.280.7. n. 4 (Tav. 29, 3): piatto con vasca globulare e labbro svasato in ceramica in vernice nera. Diam. orlo 16; alt. 4. Impasto duro, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 8/3. Vernice nera uniforme; colore: Munsell 7.5YR 2/0; fondo esterno risparmiato; impronte di immersione sulla vasca. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.290.D.1. n. 5 (Tav. 29, 5): poculum a profilo sinuoso in ceramica comune. Diam. orlo 8.6; alt. 8.7. Impasto duro, con inclusi molto rari di minute dimensioni, distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 2.5YR 3/0-5/4. Superficie liscia. Realizzato al tornio. Integro. Tipo I.190.3, varietà a. n. 6 (Tav. 29, 6): fibula in ferro con piccolo arco semplice a tutto sesto, con pendaglio concrezionato sull’arco. Fibula: lungh. max. cons. 5.3; alt. 3.5; pendaglio: lungh. 9; spessore 0.9. Superficie ossidata e corrosa. Parzialmente ricomposta; si conservano tracce di tessuto sull’arco e sul pendaglio. Tipo S.20.A.4, varietà a.
n. 1 (Tav. 29, 7): olla globulare in impasto grezzo. Diam. orlo 17; alt. 33.8. Impasto duro, poroso, frattura frastagliata, con abbondanti inclusi di medie e grandi dimensioni; colore: Munsell 5YR 7/4. Superficie liscia. Realizzata
n. 7 (Tav. 29, 2): anello in argento con castone a 213
Capestrano, I
losanga. Diam. 1.8; spessore 0.13; lungh. castone 1.4; largh. castone 0.9. Integro. Tipo S.40.B.2.
verde sulla superficie. Integra. Si conserva una decorazione a quattro tratti obliqui incisi sulle estremità. Tipo S.30.A.6, varietà b.
Tomba 124 (Saggio D; Tavv. 6, 9). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso est-ovest (lungh. max. cons. 110; largh. 60; prof. 15), tagliata a ovest dalla tomba 123, con la conseguente asportazione di tibie e piedi dell’inumato. La deposizione è dorsale, primaria e posta all’interno di un contenitore ligneo direttamente sul piano di fondo della fossa. Sulla base della posizione degli arti superiori, aderenti al torace, si può ipotizzare che il defunto fosse avvolto in fasce o in un sudario; gli arti inferiori, per quanto conservati, erano distesi. Dati antropologici. Si recuperano i resti osteologici di un sub-adulto il cui sviluppo dentario è compatibile con una età di 4 anni 12 mesi. Lo scheletro è abbastanza completo e include cranio, arti superiori, colonna vertebrale, cassa toracica, arti inferiori. Lo stato di avanzamento della maturazione dell’osso occipitale corrisponde a una età minore di 5-7 anni. Le misure di lunghezza massima, lunghezza sagittale e larghezza della pars basilaris corrispondono a una età di circa 2 anni e mezzo. Lo stadio di maturazione scheletrica delle vertebre lombari corrisponde a una età maggiore di 2-3 anni, mentre le vertebre toraciche e le vertebre cervicali corrispondono a una età minore di 3-5 anni. Dati archeologici. Il corredo si compone di due armille a spirale in bronzo, al polso destro e a quello sinistro (nn. 2-3); sull’emitorace destro è posta una fibula frammentaria in ferro (n. 1); nella terra di riempimento si rinvengono due pendagli in bronzo e due perline in ambra (nn. 4-5). Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. VI secolo a.C.
n. 3 (Tav. 30, 2): armilla in bronzo con verga a sezione circolare a quattro avvolgimenti. Diam. 4; larghezza 1.3; pessore verga 3. Patina verde sulla superficie. Integra. Si conserva una decorazione a quattro tratti obliqui incisi sulle estremità. Tipo S.30.A.6, varietà b. n. 4 (Tav. 30, 5): coppia di pendenti conici in lamina di bronzo. Lungh. 4.4 e 3.5; largh. max. 1.1 e 1.2. Patina verde sulla superficie. Uno è integro, l’altro frammentario nella parte inferiore. Tipo S.50.1. n. 5 (Tav. 30, 4): 2 vaghi in ambra a profilo compresso. Diam. 0.7 e 0.8; alt. 0.3 e 0.5. Tipo S.60.B.2. Tomba 125 (Saggio D; Tavv. 6, 9). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, profondamente disturbata dalle tombe 123 (a est) e 190 (a ovest; vedi, 212-213, 263-264). La tomba è orientata lungo l’asse ovest-est e si conserva per una lungh. max. di 45, largh. max. di 53 e prof. di 132. L’evidenza a sua volta disturba la tomba 185 (vedi, 258-259). Posto nell’angolo nord-ovest della fossa, si conserva il ripostiglio. Dati antropologici. Non risultano recuperati reperti antropologici, anche se in fase di scavo era stata segnalata la presenza di resti di cranio e tibia. Dati archeologici. L’unico elemento di corredo conservato è probabilmente un’olla in impasto, probabilmente pertinente al ripostiglio, (n. 1) rinvenuta nel corso dello scavo della tomba 123. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. La sepoltura risulta anteriore alla tomba 123; sulla base della datazione dell’olla, essa potrebbe essere ascritta sia al periodo tardo-arcaico (fine VI-V secolo a.C.) che al periodo ellenistico (III secolo a.C.).
n. 1 (Tav. 30, 3): fibula in ferro con arco a tripla (?) ondulazione. Lungh. max. ric. 5; alt. ric. 4. Superficie corrosa e ossidata. Lacunosa di parte dell’arco. Probabilmente ascrivibile al Tipo S.20.B.4.
n. 1 (Tav. 29, 8): olla globulare in impasto grezzo. Diam. orlo 20.8; alt. 35. Impasto duro, con frequenti inclusi di piccole e medie dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 5YR 7.5/6. R. Superficie liscia.
n. 2 (Tav. 30, 1): armilla in bronzo con verga a sezione circolare a quattro avvolgimenti. Diam. 4.1; larghezza 1.3; spessore verga 0.3. Patina 214
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Non essendo presenti materiali di corredo, non è possibile proporre un inquadramento cronologico puntuale, se non una generica recenziorità rispetto alla tomba 153, databile nel II secolo a.C. (vedi, 233).
Realizzata al tornio. Integra. Tipo A.40.B.24. Tomba 126 (Saggio C; Tavv. 5, 9). Sepoltura neonatale in coppi sovrapposti, alloggiata all’interno di una fossa di piccole dimensioni orientata in senso nord-est/sud-ovest (fossa: lungh. 100; largh. 50; prof. 20; coppo: lungh. 60; largh. 30), localizzata nella porzione sud-occidentale del Saggio C. I coppi, frammentari nella parte inferiore, sono delimitati da ciottoli calcarei. Dati antropologici. I reperti osteologici appartengono ad un neonato. Lo scheletro è completo e ben conservato. Le misure di lunghezza massima, di lunghezza sagittale e di larghezza della pars basilaris indicano una età alla morte al termine della 40a settimana di gestazione. Dati archeologici. Mancano elementi di corredo. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Non essendo presenti materiali di corredo, non è possibile proporre un inquadramento cronologico puntuale.
Tomba 129 (Saggio D; Tavv. 6, 9). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso nord-ovest/sud-est (lungh. 124; largh. 51; prof. 28), localizzata nel settore nord-occidentale del Saggio D. Sul lato lungo occidentale, in corrispondenza dell’angolo meridionale della fossa, a 4 dal piano di deposizione, si apre una nicchia ovale per l’alloggiamento del ripostiglio (largh. 30; prof. 23; alt. 22). Deposizione dorsale, primaria. Dati antropologici. Si recupera uno scheletro di sub-adulto in pessime condizioni di preservazione, di cui si individuano frammenti di cranio e di mandibola, nove denti decidui e sette elementi dentari permanenti con le corone in formazione, le diafisi di tibie destra e sinistra. Lo stato di sviluppo della amelogenesi dentaria permette di determinare una età alla morte di circa 4 anni 12 mesi. Dati archeologici. Il corredo si compone di una fibula in ferro, rinvenuta in condizioni frammentarie in corrispondenza dello sterno dell’inumato (n. 3); un’armilla in verga di bronzo posta all’altezza dell’anca destra (n. 5); una coppetta in ceramica a vernice nera, rinvenuta presso i piedi (n. 1). Il ripostiglio è composto da un’olletta in ceramica comune (n. 2). Nella terra del riempimento e sul piano di inumazione sono rinvenuti elementi sparsi di una collana composita, con grani in lamina bronzea fortemente ossidati, alternati con pendenti di pietra calcarea (n. 4). Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Prima metà del III secolo a.C.
All’interno del Saggio E (Tav. 1, mancano sia il posizionamento generale che la planimetria di dettaglio) viene individuata una fossa di forma irregolare riempita di terra di colore giallastro, inizialmente numerata come tomba 127. Non ha però restituito alcuna indicazione per una sua identificazione come evidenza funeraria. Tomba 128 (Saggio D; Tavv. 6, 9). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso sud-est/nord-ovest (lungh. 110; largh. 50; prof. 24), localizzata nella porzione centrale del Saggio D. Taglia a nord la tomba 153 (vedi, 233-234). Dati antropologici. Si conservano pochi elementi osteologici, tra cui frammenti di cranio, alcuni elementi dentari e una diafisi di femore. La presenza di un primo molare mascellare deciduo, di un incisivo e di un canino mandibolare con corona in formazione permettono di attribuire questi resti umani a un infante di circa 4-5 anni. Dati archeologici. La tomba risulta priva di materiali di corredo; nella terra di riempimento sono stati rinvenuti minuti frammenti ceramici.
n. 1 (Tav. 30, 9): coppetta a profilo globulare in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 11; alt. 5. Impasto duro, privo di inclusi; colore: Munsell 2.5YR 5/6. Vernice lucida, coprente, uniforme, con colature sulla vasca e sul piede; colore: Munsell 2.5YR 2.5/0; parte inferiore della vasca, piede e fondo esterno risparmiati; 215
Capestrano, I
permanenti sono identificabili e permettono di determinarne l’età alla morte, probabilmente, di circa 4 anni 12 mesi. Dati archeologici. Un’anforetta in impasto buccheroide (n. 1) è rinvenuta in frammenti in prossimità del cranio, presso l’angolo sudorientale della tomba e ai piedi del defunto. È possibile ipotizzarne la rottura intenzionale, prima della chiusura della fossa, secondo una pratica funeraria nota anche altrove in area aquilana nel corso dell’età arcaica (Weidig 2014, 696-700). Due armille in bronzo si rinvengono nella originaria posizione dell’omero sinistro (nn. 13-14). Un gruppo di nove fibule, indistinguibili al momento dello scavo a causa dell’ossidazione, si trova in corrispondenza del torace (nn. 2-10), cui si aggiungono frammenti di almeno altre due fibule non reintegrabili; un pendaglio con bulle è poggiato al di sotto del cranio, in corrispondenza del torace (n. 12). Un secondo pendaglio si trova al di sotto del primo, insieme a un vago di collana in ambra (nn. 11 e 15). Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Prima metà/metà VI secolo a.C.
impronte di immersione sulla vasca. Superficie liscia. Sul fondo della vasca, sono impressi quattro stampigli a palmette a sei petali con estremità piegate a volute inserite in un cartiglio rotondo. Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.260.A.15. n. 2 (Tav. 30, 10): olletta troncoconica in ceramica comune. Diam. orlo 14.2; alt. 17. Impasto duro, poroso con rari vacuoli, frattura irregolare, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 2.5YR 3/0-5/4. Superficie ruvida. La fattura è piuttosto grossolana e la colorazione presenta diverse imperfezioni sulla parete esterna; superficie irregolare e abrasioni evidenti all’interno. Realizzata a mano. L’orlo è frammentario. Tipo I.50.B.1. n. 3 (Tav. 30, 6): fibula in ferro con arco a doppia ondulazione. Lungh. max. ric. 6.5; alt. max. ric. 3.2Superficie corrosa e ossidata. Frammentaria in corrispondenza dell’arco e dell’ago. Tipo S.20.B.2. n. 4 (Tav. 30, 8): collana composta da 14 vaghi in bronzo cilindrici del tipo 129.60.C.1 (lungh. 0.6-0.2; diam. 0.2); 4 vaghi in pietra calcarea cilindrici del Tipo S.60.D.1 (lungh. 0.8-0.3; diam. 0.2); 7 vaghi in pietra calcarea a dente di lupo del Tipo S.60.D.2 (lungh. 1.2-1.1; spessore 0.1). Integri.
n. 1 (Tav. 30, 22): anforetta in impasto buccheroide. Diam. orlo 10; diam. piede 7.6. Impasto duro compatto, frattura irregolare, con inclusi rari di minute dimensioni distribuiti in maniera disomogenea; colore Munsell 7.5Y 3/0. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Frammentaria, si conservano parti del labbro, del ventre, del piede e delle anse. Tipo B.20.2.
n. 54 (Tav. 30, 7): armilla in bronzo con capi aperti sovrapposti. Diam. 4; spessore verga 0.5. Patina verde sulla superficie. Integra. Tipo S.30.A.1.
n. 2 (Tav. 30, 11): fibula in ferro con arco semplice rialzato. Lungh. 6.8; alt. 3.3. Superficie corrosa e ossidata. Frammentaria in corrispondenza dell’ago. Tipo S.20.A.1, varietà a.
Tomba 130 (Saggio D; Tavv. 6, 9). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare orientata in senso sud-est/nord-ovest (lungh. 150; largh. 60; prof. 15), localizzata nel settore sud-occidentale del Saggio D. L’evidenza è disturbata da un’azione di asporto in corrispondenza del bacino dell’inumato e a sud dalla tomba a camera 190 (vedi 263-266). Deposizione dorsale, primaria, di cui si conservano solo frammenti del cranio. Dati antropologici. Si recuperano i resti di un sub-adulto in pessimo stato di conservazione. Soltanto alcuni elementi dentari decidui e
n. 3 (Tav. 30, 12): fibula in ferro con arco semplice rialzato. Lungh. max. ric. 4; alt. 4.4. Superficie corrosa e ossidata. Parzialmente ricomposta da tre frammenti. Tipo S.20.A.1, varietà a. n. 4 (Tav. 30, 13): fibula in ferro con arco semplice rialzato. Lungh. 6.4; alt. 3.3. Superficie corrosa e ossidata. Frammentaria. 216
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
cons. 6, diam. 0.3. Superficie corrosa e ossidata. Frammentaria. Tipo S.50.6.
Tipo S.20.A.1, varietà a. n. 5 (Tav. 30, 14): fibula in ferro con arco semplice rialzato. Lungh. 6.8; alt. 3. Superficie corrosa e ossidata. Parzialmente ricomposta da due frammenti. Tipo S.20.A.1, varietà a.
n. 14 (Tav. 30, 20): 10 pendenti sferoidali pertinenti a un pendaglio in ferro e frammento dell’aggancio (vedi n. 13). Diam. max. pendenti sferoidali 4; diam. min. 1. Superficie corrosa e ossidata. Parzialmente ricomponibile. Tipo S.50.6.
n. 6 (Tav. 30, 18): fibula in ferro con arco semplice. Lungh. max. cons. 3.4; alt. 3.2. Superficie corrosa e ossidata. Frammentaria. Probabilmente ascrivibile al Tipo S.20.A.1 (senza varietà).
n. 15 (Tav. 30, 23): vago in ambra globulare. Diam. 1.1; spessore 0.7. Integro. Decorato con motivo a zig-zag intagliato. Tipo S.60.B.1.
n. 7 (Tav. 30, 16): fibula in ferro con arco a doppia ondulazione. Lungh. max. ric. 6; alt. max. ric. 3. Superficie corrosa e ossidata. Frammentaria. Tipo S.20.B.2.
Tomba 131 (Saggio D; Tavv. 6, 9). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare orientata in senso nord-ovest/sud-est (lungh. 195; largh. 70; prof. 115), localizzata nei pressi del limite occidentale di scavo. Una nicchia per l’alloggiamento del ripostiglio è ricavata presso l’angolo sud-orientale, in corrispondenza del capo dell’inumato (largh. 40; prof. 25). Si conservano tracce della cassa lignea, che accoglie la deposizione dorsale, primaria e in spazio vuoto; gli arti superiori, in posizione distesa, convergono sulla zona pelvica. Sulla base della distanza tra gli omeri, è possibile che la cassa lignea fosse originariamente rialzata rispetto al fondo della fossa e che la sua decomposizione abbia determinato il collasso dei resti antropologici. Dati antropologici. I reperti osteologici appartengono ad un individuo adulto di sesso maschile e di età avanzata ma non determinabile a causa delle condizioni di conservazione pessime. Tra i frammenti di cranio è possibile osservare un processo mastoideo robusto e verticalizzato. Una porzione di mandibola conserva alcuni elementi dentari con usura avanzata, altri denti sono stati recuperati singolarmente, ma risultano danneggiati a causa dei processi tafonomici e postdeposizionali. Dati archeologici. I materiali del corredo si recuperano all’interno del contenitore ligneo: un’olletta in ceramica comune a sud dei piedi dell’inumato (n. 6); in prossimità dei piedi, si rinvengono una coppa, un piatto e una coppetta in ceramica a vernice nera (nn. 2-3, 5); in corrispondenza del torace dell’inumato si rinviene una fibula in ferro (n. 7). Il ripostiglio
n. 8 (Tav. 30, 15): fibula in ferro con arco a tripla ondulazione. Lungh. 7.5; alt. 3. Superficie corrosa e ossidata. Parzialmente ricomposta da tre frammenti. Tipo S.20.B.4. n. 9 (Tav. 30, 17): fibula in ferro con arco a tripla ondulazione. Lungh. max. ric. 6.8; alt. max. ric. 3.3. Superficie corrosa e ossidata. Frammentaria. Tipo S.20.B.4. n. 10 (Tav. 30, 21): fibula in ferro. Lungh. max. cons. staffa 3.5. Superficie corrosa e ossidata. Frammentaria. Staffa lunga con sezione a “J”. Unitamente vengono rintracciati numerosi frammenti in ferro probabilmente pertinenti all’arco. Non è possibile definirne puntualmente il tipo. n. 11 (Tav. 30, 24): armilla in bronzo con verga a sezione circolare a cinque avvolgimenti. Diam. 4.7; spessore verga 0.2. Patina verde in superficie. Integra. Tipo S.30.A.6, varietà c. n. 12 (Tav. 30, 25): armilla in bronzo con verga a sezione circolare a cinque avvolgimenti. Diam. 4.7; spessore verga 0.2. Patina verde in superficie. Integra. Tipo S.30.A.6, varietà c. n. 13 (Tav. 30, 19): frammento di pendente compositoin ferro (probabilmente connesso al successivo n. 14) composto da una verga innestata su una lamina alla quale sono appesi anellini per agganciare pendenti sferoidali. Lamina: largh. max. cons. 6; verga: alt. max. 217
Capestrano, I
è composto da un’olla in impasto (n. 1), a sua volta contenente uno skyphos in ceramica vernice nera (n. 4). Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. (Fine III)-prima metà II secolo a.C.
fondo esterno risparmiato. Superficie liscia. Sul fondo della vasca, in posizione centrale, uno stampiglio circolare impresso con motivo floreale, con petali intervallati da rametti; campito all’interno di una rotellatura. Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.290.D.2.
n. 1 (Tav. 31, 8): olla globulare in impasto grezzo. Diam. orlo 24; alt. 32.5. Impasto duro, poroso con rari vacuoli, frattura frastagliata, con abbondanti inclusi di piccole e medie dimensioni; colore: Munsell 5YR 7.5/6. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Frammentario in corrispondenza del labbro e della spalla. Due fori sono realizzati in corrispondenza della spalla. Tipo A.40.B.27.
n. 6 (Tav. 31, 3): poculum in ceramica comune. Diam. orlo 8.6; alt. 10.8. Impasto duro, con frequenti inclusi di piccole e medie dimensioni; colore: Munsell 5YR 7.5/8. Superficie liscia. Realizzato al tornio. Integra. Tipo I.190.3, varietà a. n. 7 (Tav. 31, 6): fibula in ferro con arco semplice. Lungh. max. cons. 4. Superficie corrosa e ossidata. Frammentaria, mancante di parte dell’arco e dell’ago Si conservano tracce di tessuto. Probabilmente ascrivibile al Tipo S.20.A.4, varietà a.
n. 2 (Tav. 31, 4): coppa a profilo globulare in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 18.7; alt. 6.2. Impasto duro, privo di inclusi; colore Munsell 2.5YR 6/6. Vernice opaca, non uniforme; colore: Munsell 2.5YR 2.5/0; colature sul piede e sul fondo, fondo esterno risparmiato, impronte di immersione tra la vasca e il piede. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.240.A.13.
n. 8 (Tav. 31, 1): calzari in ferro e legno. Lungh. max. ric. 20.2. Superficie corrosa e ossidata. Frammentario. Non è possibile inquadrare i frammenti in uno specifico tipo.
n. 4 (Tav. 31, 7): skyphos a profilo troncoconico in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 10.5; alt. 11.9. Impasto duro, privo di inclusi; colore: Munsell 5YR 7.5/6. Vernice opaca non uniforme; colore: Munsell 5YR tra 4.5/1 e 6.5/8. Superficie liscia. Realizzato al tornio. Integro. Tipo H.280.5.
Tomba 132 (Saggio D; Tavv. 6, 10). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso nord-sud (largh. 60; lungh. 140; prof. 30), localizzata nella porzione occidentale del saggio di scavo. Sul piano di deposizione si rinvengono tre spezzoni litici di grandi dimensioni allineati in senso nord-sud, probabilmente funzionali a contenere la sepoltura che doveva essere originariamente posta a ovest. Dati antropologici. La sepoltura risulta priva di resti antropologici. Dati archeologici. Si rinvengono due armille in bronzo (nn. 1-2). Il sesso archeologico non è determinabile; le dimensioni della fossa ne suggeriscono una identificazione come sepoltura infantile. Inquadramento cronologico. VI secolo a.C. (?).
n. 5 (Tav. 31, 5): piatto con vasca globulare e labbro svasato in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 19; alt. 4. Impasto duro, compatto, privo di inclusi; colore Munsell 5YR 7/3. Vernice lucente, uniforme con iridescenze sulla superficie esterna; colore: Munsell 2.5YR 2.5/0;
n. 1 (Tav. 31, 9): armilla in bronzo con verga a sezione circolare a sei avvolgimenti. Diam. 4.6; largh. max. 2.6; spessore verga 0.4. Patina verde sulla superficie. Integra. Si conserva una decorazione a tre serie di tre tratti incisi sulle estremità. Tipo S.30.A.6, varietà d.
n. 3 (Tav. 31, 2): coppetta a profilo globulare in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 12.4; alt. 5.8. Impasto duro, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 8/4. Vernice compatta, lucente; colore: Munsell 7.5YR 2/0; colature sul fondo esterno risparmiato. Superficie liscia. Tracce di empilement sul fondo interno. Realizzata al tornio. Integra. Segni graffiti irregolarmente sulla vasca. Tipo H.260.A.9.
218
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
Realizzato a mano. Ricomposto da numerosi frammenti. Tipo A.30.2.
n. 2 (Tav. 31, 10): armilla in bronzo con verga a sezione circolare a sei avvolgimenti. Diam. 4.6 largh. max. 2.6; spessore verga 0.4. Patina verde sulla superficie. Si conserva una decorazione a tre serie di tre tratti incisi sulle estremità.Integra. Tipo S.30.A.6, varietà d.
n. 2 (Tav. 32, 1): pugnale a stami con fodero in ferro e legno, e anelli di sospensione. Pugnale: lungh. max. conservata 18; lama: lungh. max. cons. lama 6.2, lungh. codolo 8, lungh. elsa, 3.8, largh. max. cons. 3.2; spessore max. 0.56. Fodero: lungh. max. cons. 26.6, largh. max. 4; spessore 1.4. Superficie corrosa e ossidata. Parzialmente ricomposta. Tipo T.10.1; fodero tipo T.15.1.
Tomba 133 (Saggio D; Tavv. 6, 10). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare orientata in senso nord-ovest/sud-est (lungh. 130; largh. max. cons. 84; prof. 14), localizzata nell’area centrale del saggio di scavo. L’evidenza risulta quasi completamente disturbata dall’impianto della tomba 192 (vedi, 266). Non si rinvengono resti antropologici.
n. 3 (Tav. 32, 2): punta di giavellotto in ferro. Lungh. 16; lama: largh. max. 2.7; spessore max. 0.6; cannone: lungh. 7.3; diam. 1.8. Superficie corrosa e ossidata. Integra. Tracce di legno nel cannone. Tipo T.50.1.
Tomba 134 (Saggio D; Tavv. 6, 10). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso sud-est/nord-ovest (lungh. 255; largh. 105; prof. 16), localizzata nella porzione occidentale del saggio di scavo. È tagliata dall’impianto della tomba 135 in corrispondenza dell’angolo meridionale (vedi scheda successiva). Si registrano tracce del contenitore ligneo nella parte occidentale della fossa. A ridosso dell’angolo settentrionale è alloggiato il ripostiglio, protetto da spezzoni litici. La deposizione è dorsale, primaria e nello spazio vuoto del contenitore ligneo. Dati antropologici. Lo stato di conservazione dei resti umani è pessimo. Si recuperano pochi frammenti di tibia sia destra che sinistra, forse appartenenti ad un individuo adulto. Dati archeologici. Il corredo è composto da un pugnale a stami con fodero (n. 2) posto presso la tibia destra; una punta di lancia in ferro (n. 3) ai piedi dell’inumato nell’angolo occidentale del contenitore ligneo. Il ripostiglio è composto da un vaso a collo in impasto (n. 1). Sulla base del corredo la sepoltura si ascrive a un individuo maschile adulto. Inquadramento cronologico. Ultimo quarto VIIprima metà VI secolo a.C.
Tomba 135 (Saggio D; Tavv. 6, 10). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso nord-ovest/sud-est (lungh. 235; largh. 100; prof. 160), localizzata a ridosso del limite occidentale del Saggio D. La fossa è disturbata superficialmente da una trincea esplorativa aperta in corso di scavo e taglia l’angolo settentrionale della tomba 134 (vedi scheda precedente). Il piano di deposizione presenta tracce della cassa lignea, all’interno della quale si conserva la deposizione dorsale, primaria e in spazio vuoto; il cranio è orientato a nord-ovest; l’arto superiore destro è leggermente piegato sul bacino; l’altro, mal conservato, è disteso. Dati antropologici. I resti umani appartengono a un individuo adulto femminile di età compresa tra 30 e 39 anni. Lo stato di conservazione è abbastanza buono e completo. Per la stima dell’età alla morte sono disponibili gli elementi dentari, con una usura limitata al primo molare (17-25 anni), e l’aspetto della superficie auricolare dell’ileo lievemente granulare con aree di microporosità corrispondente a una età tra 30 e 39 anni circa. Infine, osservando la dentatura, si rileva la presenza di una anomalia epigenetica di entrambi i terzi molari mascellari denominata morfologia “a piolo”. Dati archeologici. Il corredo vascolare si concentra all’interno del contenitore ligneo, presso il lato corto ai piedi dell’inumato: una
n. 1 (Tav. 32, 3): vaso a collo biansato in impasto grezzo. Diam. orlo 15.5; alt. 27.5. Impasto tenero, poroso con abbondanti vacuoli distribuiti in maniera omogenea, frattura frastagliata, con frequenti inclusi di piccole e medie dimensioni; colore: Munsell 2.5YR 4/6. Superficie liscia. Vi si registrano irregolarità. 219
Capestrano, I
ceramica a vernice nera. Diam. orlo 6.8; alt. 4.6. Impasto tenero, con inclusi molto rari di minute dimensioni, distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 3/0. Vernice opaca, evanide; colore: Munsell 7.5YR 3/0. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.260.A.17.
coppa e due coppette in ceramica a vernice nera, nell’angolo sud-occidentale (nn. 1-3); un’olletta in ceramica comune (n. 5) e un piatto in ceramica a vernice nera (n. 4) presso la tibia destra; un anello in argento e una fibula in ferro sono in corrispondenza della mano sinistra (nn. 6-7). Dalla terra di riempimento provengono alcuni frammenti di impasto buccheroide ed un elemento in ferro di forma rettangolare irregolare. La presenza dell’anello in argento potrebbe confermare l’attribuzione a un individuo femminile adulto. Inquadramento cronologico. (Fine IV)-prima metà III secolo a.C.
n. 4 (Tav. 32, 7): piatto con vasca troncoconica e labbro svasato in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 15; alt. 3. Impasto duro , con inclusi molto rari di minute dimensioni, distribuiti in maniera omogenea; colore Munsell 7.5YR 8/4. Vernice opaca ben conservata su tutte le superfici; colore: Munsell 7.5YR 3/0. Sul fondo della vasca presenta una decorazione costituita da due giri di rotellatura. Realizzato al tornio. Integro. Tipo H.290.C.4.
n. 1 (Tav. 32, 8): coppa a profilo globulare in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 18.6; alt. 8. Impasto duro compatto, frattura regolare, con inclusi molto rari di minute dimensioni, distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 2.5YR 7/5. Vernice lucida, ben conservata su tutte le superfici; colore: Munsell 2.5YR 2.5/0. In prossimità del piede si notano colature per l’immersione nella vernice. Sul fondo della vasca è presente una decorazione a rotellatura; sul fondo, risparmiato dalla vernice, è presente un’incisione, probabilmente un segno alfabetico (potrebbe trattarsi di una E) o un tridente. Realizzata al tornio. Ricomposta da vari frammenti. Tipo H.249.A.4.
n. 5 (Tav. 32, 9): olletta ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 9.8; alt. 12. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenera; colore: Munsell 2.5YR tra 6/6 e 3/0. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Ricomposta da vari frammenti e parzialmente reintegrata. Tipo I.50.B.9, varietà a. n. 6 (Tav. 32, 4): fibula in ferro con piccolo arco semplice a tutto sesto. Lungh. 4.5; alt. 2.7. Superficie corrosa e ossidata. Integra. Presenta tracce di tessuto sull’ arco e sulla staffa. Tipo S.20.A.4, varietà a.
n. 2 (Tav. 32, 10): coppetta a profilo globulare in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 12.6; alt. 4.8. Impasto duro compatto, frattura regolare, con inclusi molto rari di minute dimensioni, distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 2.5YR 7/6. Vernice lucida, ben conservata; colore: Munsell 2.5YR 2.5/0. Sulla superficie esterna presenta piccole lacune della vernice; in prossimità del piede si notano colature lasciate dalle impronte di immersione nella vernice. L’interno del piede risulta essere stato risparmiato. Superficie liscia. Sul fondo della vasca sono impressi quattro stampigli in cartiglio ovale, campiti da due file a due o tre tratti, e da un’incisione effettuata dopo la verniciatura (si tratta del segno alfabetico V). Realizzata al tornio. Manca parte dell’orlo. Tipo H.260.A.4.
n. 7 (Tav. 32, 6): anello in argento con castone circolare. Diam. 2.1. Integro. Tipo S.40.B.1. Tomba 136 (Saggio D; Tavv. 6, 10). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso nord-ovest/sud-est (lungh. 85; largh. 45; prof. 50), localizzata presso il margine sud-occidentale del Saggio D. La fossa taglia parzialmente il riempimento della tomba 188 (vedi, 261-263). All’interno della fossa si rinvengono spezzoni litici di medie dimensioni disposti lungo i margini. La deposizione è dorsale, primaria e in spazio vuoto. Dati antropologici. Lo scheletro, abbastanza completo e discretamente conservato, appartiene ad un individuo immaturo (subadulto). La lunghezza massima della rocca
n. 3 (Tav. 32, 5): coppetta a profilo globulare in 220
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
est/nord-ovest (lungh. 120; largh. 62; prof. 40), localizzata nella porzione meridionale del Saggio D. Il riempimento della fossa è costituito da terra frammista a carbone, concentrato soprattutto nella parte centrale, ossa con diversi gradi di combustione e frammenti ceramici e vetrosi. I resti antropologici e faunistici sono in parte deposti all’interno di un’olla in ceramica comune posizionata nel mezzo della fossa chiusa da un coperchio (n. 4; al suo interno sono stati rinvenuti il relativo coperchio n. 7: un balsamario in vetro deformato dal calore n. 10 e un coperchio in osso n. 15). I reperti faunistici mostrano il medesimo aspetto combusto e deformato e la stessa colorazione dei resti dell’individuo incinerato. Indicativamente le ossa animali determinabili appartengono all’arto anteriore e posteriore di suino. Dall’attività di setacciatura proviene un consistente campionamento di conchiglie, ovvero malacofauna terrestre di piccole dimensioni. Dati antropologici. Il materiale analizzato proviene dallo svuotamento dell’urna senza un accurato microscavo, per cui non è più possibile raccogliere informazioni sulla stratificazione all’interno del contenitore sepolcrale e sull’ossilegio, ovvero l’ordine con cui intenzionalmente sono stati deposti i frammenti di ossa raccolti dalla pira funebre. Gli elementi scheletrici sono ancora identificabili e tutti i distretti scheletrici sono presenti, incluse le estremità degli arti (mani e piedi). La colorazione dei reperti osteologici è compatibile con una combustione avvenuta ad una temperatura di circa 600° - 700°. In generale il loro colore in superficie è bianco, anche se alcuni tratti della colonna vertebrale presentano una colorazione nera non calcinata, gli elementi dentari sono preservati solo nella porzione di radice. Inoltre alcune ossa recano tracce di ossidazione dovute al contatto con oggetti metallici del corredo, per esempio una costola (fig.antr.online 138_01). Deformazioni e fessurazioni sono il segno caratteristico dovuto all’azione del fuoco e si osservano sia sulle ossa lunghe che sulle vertebre (fig.antr.online 138_02A,B,C,D,E,F,G,H,I). Si può ipotizzare che questi resti appartengano a un individuo femminile adulto giovane, tuttavia l’osservazione delle caratteristiche sessuali
petrosa misura 36 mm, corrisponde ad una età alla morte perinatale, più precisamente alla 38a40a settimana di gestazione. Il grado di sviluppo e lo stadio di eruzione degli elementi dentari decidui è compatibile con una età sicuramente minore di 1 anno. Dati archeologici. La sepoltura è priva di corredo. Il sesso archeologico non pertanto è determinabile. Inquadramento cronologico: per l’assenza di materiali di corredo, non è possibile proporre un inquadramento cronologico puntuale, anche se la sovrapposizione rispetto alla tomba 188, di età ellenistica, sembra fornire un possibile terminus post quem per quella in esame. Tomba 137 (Saggio D; Tavv. 6, 10). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare con margini irregolari, orientata in senso sudest/nord-ovest (largh. 26; lungh. 40; prof. 15), localizzata nella porzione orientale del Saggio D. La fossa disturba il riempimento delle tombe 169 e 171 (vedi, 246-248). Dati antropologici. Si recuperano alcuni frammenti di cranio e tre diafisi di ossa lunghe in pessime condizioni di conservazione di un feto. La determinazione dell’età alla morte è limitata alla misura di lunghezza della rocca petrosa (27.22 mm) che indica una età fetale di 32 settimane. Dati archeologici. All’esterno della fossa, presso il lato corto sud-orientale, si rinviene una brocchetta in ceramica a vernice nera (n. 1). Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Età ellenistica. n. 1 (Tav. 33, 1): lagynos a profilo lenticolare in ceramica a vernice nera. Diam. fondo 6.4, alt. max. cons. 5.2. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con scarsissimi inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 7.5YR 8/4. Vernice lucente, con colature nella parte bassa della vasca e sul piede; colore: Munsell 2.5YR 2.5/0. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Mancante di orlo, collo ed ansa; si conserva solo il ventre compresso. Tipo non puntualizzabile. Tomba 138 (Saggio D; Tavv. 6, 10). Sepoltura a incinerazione contenuta in una fossa rettangolare, orientata lungo un asse sud221
Capestrano, I
n. 4 (Tav. 33, 2): olletta in ceramica comune. Diam. orlo 8; alt. 9.6. Impasto duro, poroso con rari vacuoli distribuiti in maniera disomogenea, frattura irregolare, con scarsi inclusi di piccole dimensioni; colore: Munsell 7.5YR 5/0-3/0. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Ricomposta da vari frammenti. Tipo I.50.B.14, varietà b.
secondarie sia morfologiche che metriche come anche la determinazione dell’età risultano inattendibili a causa delle deformazioni dovute al rituale dell’incinerazione. Il peso totale dei resti umani incinerati risulta di 760 gr. Dati archeologici. Nel riempimento superficiale, composto di materiale carbonioso, si rinvengono un chiodo in ferro di grandi dimensioni terminante a uncino (n. 11) e un’olletta in ceramica comune frammentaria (n. 7). Al di sotto dello strato di carbone frammisto a ossa combuste, si rinvengono frammenti di balsamario in vetro (n. 9), un frammento di olletta a pareti sottili (n. 7) e un’olletta in ceramica comune (n. 6). Intorno all’olla, in posizione radiale, si rinvengono altri sei chiodi in ferro (n. 11), probabilmente relativi a un contenitore ligneo per l’olla n. 5. Un piattino in ceramica depurata acroma (n. 3) era coperto dal cinerario. Un altro piattino (n. 4), una perla in pasta vitrea (n. 14), due chiodi angolari in ferro (n. 12), un chiodino in ferro (n. 13) e un frammento di lucerna (n. 8) sono rinvenuti nel corso delle operazioni di scavo in laboratorio dell’olla cineraria. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Fine I secolo a.C.I secolo d.C.
n. 5 (Tav. 33, 3): olletta in ceramica comune. Diam. fondo 3.5; alt. max. cons. 9. Impasto tenero, poroso con rari vacuoli distribuiti in maniera disomogenea, frattura irregolare, con scarsi inclusi di piccole dimensioni; colore: Munsell 2.5YR 3/4. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Manca del labbro e della spalla; ricomposta da vari frammenti. Non è possibile identificarne puntualmente il tipo. n. 6 (Tav. 33, 14): coperchio in ceramica comune. Diam. alla base 17; alt. 4.8. Impasto duro, poroso con rari vacuoli distribuiti in maniera disomogenea, frattura irregolare, con scarsi inclusi di piccole dimensioni; colore Munsell 2.5YR 6/6. Superficie liscia. Realizzato al tornio. Frammentario. Tipo I.300.5. n. 7 (Tav. 33, 7): coppetta globulare in ceramica a pareti sottili. Diam. orlo 5; alt. max. cons. 3.8. Impasto duro, compatto, frattura netta, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR tra 4/1 e 4/2. Superficie liscia. Decorazione “alla barbotine” sulla spalla. Realizzata al tornio. Frammentaria, manca di parte del labbro, del ventre e del fondo. Tipo L.260.2.
n. 1 (Tav. 33, 8): piattino in ceramica depurata acroma, con tracce di vernice. Diam. orlo 9.6; alt. 1.4. . Impasto duro, compatto, frattura netta, privo di inclusi; colore: Munsell 7.5YR 8/4. Superficie polverosa. Superficie polverosa. Vernice evanide; colore: Munsell 2.5YR 4/8. Realizzato al tornio. Ricomposto da vari frammenti. Tipo D.290.1.
n. 8 (Tav. 33, 16): lucerna. Lungh. max. 3. Impasto tenero, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 10YR 3/1-4/2. Superficie liscia. Realizzata a stampo. Frammento di fondo. Tipo non identificabile.
n. 2 (Tav. 33, 9): piattino in ceramica depurata acroma, con tracce di vernice Diam. orlo 8.6; alt. 1.4. . Impasto duro, compatto, frattura netta, privo di inclusi; colore: Munsell 10 YR 4/1-8/3. Superficie polverosa. Vernice evanide; colore: Munsell 2.5YR 4/8. Realizzato al tornio. Ricomposto da vari frammenti. Tipo D.290.1.
n. 9 (Tav. 33, 4): balsamario in vetro. Diam. orlo 1.8; alt. 3.1. Si conserva solo il collo e il labbro. Tipo non puntualizzabile.
n. 3 (Tav. 33, 15): olla ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 17.4; alt. 29.2. Argilla dura, poco depurata; colore: Munsell 10YR 6/26/6. Ricomposta da vari frammenti. Tipo I.40.8.
n. 10 (Tav. 33, 10): balsamario in vetro. Largh. 5. Deformato dal calore. Non è possibile identificarne il tipo di pertinenza. 222
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
Inquadramento cronologico: I secolo d.C.
n. 11 (Tav. 33, 11): sette chiodi in ferro. Lungh. max. 9.5; min. 5; diam. testa max. 3.2; min. 1.6. Superficie corrosa e ossidata. Integri, con estremità piegata. Tipo Q.110.1.
n. 1 (Tav. 33, 17): bicchiere troncoconico in ceramica sigillata italica. Diam. orlo 6; alt. max. cons. 2. Impasto molto duro, compatto, frattura netta, privo di inclusi. Superficie liscia. Mancante del fondo. Tipo K.180.1.
n. 12 (Tav. 33, 13): chiodo in ferro di piccole dimensioni. Lungh. 2; diam. testa 0.2. Superficie corrosa e ossidata. Integro. Tipo Q.110.3.
n. 2 (Tav. 33, 18): piede a disco di forma chiusa (?) in ceramica sigillata italica. Diam. piede 3; alt. max. cons. 1.2. Impasto molto duro, compatto, frattura netta, privo di inclusi. Superficie liscia. Tipo non identificabile.
n. 13 (Tav. 33, 12): due grappe in ferro. Lungh. 7 e 9. Superficie corrosa e ossidata. Privi della testa. Tipo Q.120.1.
n. 3 (Tav. 33, 19): piede a disco di forma chiusa in ceramica comune. Diam. fondo 4.6; alt. max. cons. 2. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 7.5YR 8/2. Superficie polverosa. Evidenti linee del tornio sulla superficie interna. Tipo non identificabile.
n. 14 (Tav. 33, 6): vago in pasta vitrea monocromo. Diam. 0.5. Colore blu. Integro. Tipo S.60.A.2, varietà a. n. 15 (Tav. 33, 5): frammento di coperchio in osso. Diam. 3.5; alt. 0.3. Tipo non puntualizzabile. Tomba 139 (Saggio D; Tav. 6, manca la planimetria di dettaglio). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare orientata in senso ovest/est (lungh. 176; largh. 66; prof. 40), localizzata presso il margine orientale del Saggio D. Al momento dello scavo, la fossa era pesantemente disturbata dall’impianto della più recente tomba 113 (vedi, 207-208). Dati antropologici. Dal riempimento della tomba proviene soltanto un frammento di cavità glenoidea di scapola destra di individuo adulto. Dati archeologici. Non si rinvengono resti del corredo. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Incerto.
n. 4 (Tav. 33, 22): chiodo in ferro. Diam. testa 2.3; lungh. 11.2. Superficie corrosa e ossidata. Integro. Tipo Q.110.1. n. 5 (Tav. 33, 20): chiodo in ferro di piccole dimensioni. Diam. testa 1.1; lungh. 2.3. Superficie corrosa e ossidata. Integro. Tipo Q.110.3. n. 6 (Tav. 33, 21): chiodo in ferro di piccole dimensioni. Diam. testa 1.1; lungh. max. cons. 0.1. Superficie corrosa e ossidata. Mutilo. Tipo Q.110.3. Tomba 141 (Saggio D; Tavv. 6, 11). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso sud-est/nord-ovest (lungh. 165; largh. 43; prof. 20), localizzata nel settore sud-orientale del Saggio D. L’evidenza risulta pesantemente disturbata dall’azione dell’escavatore, che ha compromesso la parte inferiore della deposizione. La terra di riempimento della fossa è caratterizzata dalla presenza di grandi ciottoli e spezzoni litici; questi ultimi si trovano concentrati anche nella porzione nord-occidentale del piano di deposizione, originariamente parte del ripostiglio litico, come attesta il rinvenimento di
Tomba 140 (Saggio D; Tavv. 6, 11). Fossa di forma pressoché ellissoidale contenente una sepoltura a incinerazione (lungh. max. 50; prof. 30), localizzato nella zona meridionale del Saggio D. L’evidenza disturba la tomba 161 (vedi, 238). Dati antropologici e archeologici. Le ceneri erano probabilmente contenute in una piccola custodia lignea, come fanno ipotizzare i tre chiodi in ferro (nn. 4-6) rinvenuti insieme a numerosi frammenti ossei bruciati e frammenti ceramici (nn. 1-3). 223
Capestrano, I
n. 3 (Tav. 33, 23): fibula in ferro ad arco semplice rialzato. Lungh. max. cons. 3.8; alt. 2. Superficie corrosa e ossidata. Mancante della staffa e dell’ago. Tipo S.20.A.1, varietà a.
frammenti ceramici pertinenti a un grande contenitore in impasto. La deposizione è dorsale, primaria e in spazio vuoto. Il cranio, rivolto a est; gli arti superiori e inferiori distesi. Dati antropologici. Lo scheletro, abbastanza completo e discretamente conservato, appartiene a un individuo adulto femminile di circa 35-39 anni. La determinazione del sesso è limitata a una porzione di bacino destro con incisura ischiatica ampia e alla misura del diametro del caput femorale (41.6 mm). Le ossa postcraniali includono arti superiori e inferiori, mani e piedi, cassa toracica e colonna vertebrale e non presentano anomalie. La lunghezza massima del femore destro (389 mm) permette un calcolo della statura in vita di 150 cm. Dati archeologici. Del corredo si conservano due fibule in ferro, rinvenute sulla terza vertebra cervicale e tra la settima e la dodicesima vertebra cervicale (nn. 3-4). Un altro frammento di fibula di ferro, pertinente alla molla, è rinvenuto sul torace (n. 5). Dalla terra di riempimento sono recuperati alcuni frammenti ceramici, che in fase di restauro si sono rivelati pertinenti una tazza e a un’olla in impasto (nn. 1-2). Sulla base della mancanza delle armi nel corredo e dell’inquadramento cronologico proposto, il sesso archeologico è determinabile come femminile. Inquadramento cronologico. Fine VII secolo a.C.
n. 4 (Tav. 33, 24): fibula in ferro ad arco semplice rialzato. Lungh. max. ric. 5; alt. max. cons. 2. Superficie corrosa e ossidata. Frammentaria, si conservano parte dell’arco, della molla e della staffa lunga. Tipo S.20.A.1, varietà b. n. 5 (Tav. 33, 25): frammento di fibula in ferro. Lungh. max. cons. 1.8. Superficie corrosa e ossidata. Tipo nom puntualizzabile. Tomba 142 (Saggio C; Tavv. 5, 11). Sepoltura neonatale sotto coppo orientata in senso nord-nord est/sud-sud ovest (coppo: lungh. max. cons. 27; largh. 21), localizzata presso il limite settentrionale del Saggio C. La sepoltura è delimitata da pietre di piccole e medie dimensioni presso i due lati lunghi e risulta tagliata dal corridoio di accesso della tomba 172 (vedi, 248-250). Dati antropologici. L’inumato è un sub-adulto di età perinatale (feto o neonato), di cui si conservano solo alcuni frammenti degli arti inferiori, in particolare le diafisi dei femori e delle tibie. Dati archeologici. Il corredo è assente. Il sesso archeologico non è comunque determinabile. Inquadramento cronologico: la mancanza del corredo non consente un inquadramento cronologico puntuale; l’unico elemento utile in tal senso è l’anteriorità stratigrafica rispetto alla tomba 172, databile in età ellenistica.
n. 1 (Tav. 33, 27): olletta ovoide in impasto grezzo. Diam. orlo 18.6; alt. max. cons. 4. Impasto duro, poroso con frequenti vacuoli distribuiti in maniera omogenea, frattura frastagliata, con frequenti inclusi di piccole e medie dimensioni; colore: Munsell 7.5YR 6.5/6. Superficie ruvida. Si conservano frammenti del labbro, del collo e della spalla. Tipo A.50.A.3.
Tomba 143 (Saggio C; Tavv. 5, 12). Tomba ipogeica “a grotticella” con corridoio di accesso, localizzata presso il limite sudorientale del Settore C. La camera, con l’asse maggiore orientato in senso nord-est/sud-ovest, presenta forma irregolare e angoli arrotondati: il lato sud-occidentale è rettilineo, quello nordorientale curvilineo (lungh. 195; largh. min 60; largh. max. 90). La volta, parzialmente crollata, si presenta piana e le pareti regolari; il fondo è lievemente inclinato in direzione dell’accesso, con un pulvino scavato per accogliere il capo del defunto. L’accesso alla camera è segnato da
n. 2 (Tav. 33, 26): tazza ovoide in impasto grezzo. Diam. orlo 7.2; alt. 7.2. Impasto tenero, poroso con frequenti vacuoli distribuiti in maniera omogenea, frattura frastagliata, con frequenti inclusi di piccole e medie dimensioni; colore: Munsell 10YR 5.5/6. Superficie liscia. Realizzata a mano, sono visibili sulla superficie interna i segni della steccatura. Parzialmente ricomposta. Tipo A.220.1. 224
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
compatto, frattura regolare, con rari inclusi di piccole dimensioni; colore: Munsell 5YR tra 4.5/6 e 2.5/1, con aloni di cottura. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Ricomposta da vari frammenti. Tipo I.50.B.9, varietà b.
un restringimento dei battenti laterali, con luce di 66 di larghezza e un’altezza di 70. Il corridoio di accesso (lungh. 360; largh. max. 81; largh. min. 66; prof. max. 116; prof. min. 73), orientato in senso sud-est/nord-ovest, presenta il piano di fondo inclinato verso nordovest, con un notevole dislivello antistante la camera. Quest’ultimo doveva essere originariamente chiuso da una tavola lignea alloggiata in corrispondenza dei battenti, come sembra suggerire anche il rinvenimento di frammenti di chiodi in ferro presso l’arto inferiore destro della defunta (n. 6). La deposizione, realizzata direttamente sul piano del vano ipogeo, è dorsale, primaria e nello spazio vuoto, in ottimo stato di conservazione. L’inumata presenta gli arti superiori e inferiori distesi, le mani sul bacino; il cranio orientato a sud-ovest. Dati antropologici. L’inumato era un individuo adulto femminile di circa 35-39 anni. Lo scheletro è completo e ben conservato, sia craniale che postcraniale, non si segnalano anomalie. La determinazione del sesso è possibile osservando la morfologia del cranio e del bacino. Le suture craniche sono ancora ben separate e non presentano fenomeni di ossificazione. L’aspetto della superficie auricolare dell’ileo è compatibile con una età alla morte di 35-39 anni. La misura di lunghezza massima del femore sinistro (435 mm) e destro (436 mm) permette un calcolo della statura in vita di 161.5 cm. Dati archeologici. Il corredo è distribuito prevalentemente a nord-est degli arti inferiori, dove si concentrano i pocula e l’olletta in ceramica comune e il balsamario (nn. 2-5); un’olletta in ceramica comune è deposta sui piedi (n. 1). Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. II secolo a.C.
n. 3 (Tav. 34, 5): poculum in ceramica comune. Diam. orlo 8.4; alt. 7.2. Impasto duro, con rari inclusi di piccole dimensioni; colore: Munsell 10YR 3/2. Superficie polverosa. Realizzato a mano. Integro. Tipo I.190.2, varietà a. n. 4 (Tav. 34, 6): poculum in ceramica comune. Diam. orlo 7.2; alt. 6.8. Impasto tenero, poroso con frequenti vacuoli distribuiti in maniera omogenea, frattura irregolare, con abbondanti inclusi di piccole dimensioni; colore: Munsell 7.5YR 5/6. Superficie liscia. Realizzato a mano. Manca parte dell’orlo. La superficie è parzialmente abrasa. Tipo I.190.2, varietà a. n. 5 (Tav. 34, 1): balsamario ceramico fusiforme. Diam. orlo 3.4; alt. 25.4. Impasto duro, compatto, privo di inclusi; colore: Munsell 7.5YR 6.5/6. Superficie polverosa. Tracce di vernice sul collo, opaca, diluita; colore: Munsell 7.5YR 3.5/0. Realizzato al tornio. Ricomposto da vari frammenti. Tipo N.130.5. n. 6 (Tav. 34, 3, 8): sei chiodi di ferro e due frammenti di teste. Diam. testa max. 3; min. 1.4; lungh. max. 6; min. 5.8; spessore max. spillo 0.9; min. 0.5. Superficie corrosa e ossidata. Si conservano tracce di legno. Tipo Q.110.2. Tomba 144 (Saggio C; Tavv. 5, 11). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso sud-est/nord-ovest (lungh. 170; largh. 78; prof. 196), localizzata a ridosso del margine settentrionale del saggio di scavo. La tomba risulta disturbata nel suo interro superficiale dal corridoio di accesso della tomba 151 (vedi, 231-232). Presenta una nicchia semicircolare aperta lungo il lato meridionale ad un’altezza di 83 dal piano di inumazione (largh. 40; prof. 30) per l’alloggiamento del ripostiglio. Si conservano tracce di un contenitore ligneo sul fondo della fossa, al cui interno si rinviene la deposizione,
n. 1 (Tav. 34, 7): olletta ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 15.2; alt. 20.8. Impasto duro, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 7.5/4. Superficie saponosa. Realizzata al tornio. Integra. Tipo I.50.A.9. n. 2 (Tav. 34, 4): olletta in ceramica comune. Diam. orlo 10.8; alt. 13. Impasto duro, 225
Capestrano, I
comune lungo la tibia destra (n. 8); un coperchio conico in ceramica comune rovesciato al di sopra delle caviglie (n. 9); una coppetta in ceramica a vernice nera (n. 4) presso la caviglia destra e un’altra vicino al piede destro (n. 3), nei pressi di uno skyphos in vernice nera (n. 5), collocato al di sopra di un’olletta biansata in ceramica a bande (n. 1) presso i piedi del defunto. Il ripostiglio è composto da un’olla in ceramica comune (n. 7) contenente uno skyphos in ceramica a vernice nera (n. 6). La composizione del corredo consente di determinare il sesso archeologico come femminile. Inquadramento cronologico. La datazione del contesto ricade nell’ambito del III secolo a.C. La presenza della coppa n. 1 e della coppetta n. 4 sembra orientarne la puntualizzazione alla seconda metà III-inizi II secolo a.C., anche se l’olletta n. 1, che richiama produzioni dell’area frentana della fine del IV-inizi III, non sembra coerente con tale datazione.
in decubito laterale destro, primaria e in ambiente vuoto; il cranio è rivolto a nord, gli arti superiori sono distesi lungo i fianchi; gli arti inferiori distesi con i piedi sovrapposti. Dati antropologici. I resti umani appartengono ad un adulto femminile di età tra 25 e 34 anni. Tutti i distretti scheletrici, craniale e postcraniali, sono rappresentati. Molteplici indicatori sia nel cranio che nel bacino hanno permesso di determinare il sesso, a cui si aggiungono le misurazioni della testa omerale destra e il diametro del caput femorale sinistro compatibili con un individuo femminile. I denti mostrano una usura corrispondente a una età di 25-35 anni. Una anomalia di eruzione dentaria è visibile nel lato destro della mandibola, dove il canino è ruotato medialmente. Dall’osservazione dell’aspetto della superficie auricolare si può stimare una età alla morte di 25-34 anni e, più precisamente, in base alla sinfisi pubica, di circa 30.7 anni (nel range 2339). Per il calcolo della statura sono disponibili la lunghezza massima dell’omero destro (309 mm) e sinistro (298 mm) e risulta di 160 cm. Infine, come può ricorrere nell’ambito della variabilità umana, questo individuo presenta una caratteristica antropologica di tipo discontinuo, rilevata in diversi individui di questa necropoli. Si tratta della presenza nel cranio di ossa soprannumerarie (wormiane) localizzate lungo la sutura lambdoidea, di cui due inferiormente a sinistra (lambdoidee) e una superiormente nel punto di contatto con la sutura sagittale (al lambda). Nella colonna vertebrale invece è visibile una anchilosi, non grave e conforme agli elementi coinvolti, che interessa l’ultima vertebra lombare e il sacro, un fenomeno denominato “sacralizzazione della quinta vertebra lombare” (fig.antr.online 144_01A,B). Dati archeologici. Il corredo si compone di un balsamario ceramico a ovest del cranio (n. 10); una fibula in ferro (n. 12) e una fuseruola in impasto (n. 11) all’altezza del torace; due anelli in argento sono rinvenuti ancora infilati alle dita della defunta, il primo alla mano sinistra, il secondo alla destra (nn. 13-14). Il resto del corredo è posto in corrispondenza della porzione inferiore del corpo: una coppa in ceramica a vernice nera all’altezza del ginocchio destro (n. 2); un poculum in ceramica
n. 1 (Tav. 35, 6): olletta biansata in ceramica a bande. Diam. orlo 8.4; alt. 13.3. Impasto duro, compatto, frattura regolare, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 7.5/2. Superficie liscia. Vernice evanide; colore: Munsell 10YR tra 5/610 e 1/4. Presenta una decorazione a due fasce orizzontali sovradipinte al di sotto delle anse e a tratti verticali in corrispondenza della spalla e delle anse. Realizzata al tornio. Ricomposta da vari frammenti. Tipo E.70.1. n. 2: nella scheda di rinvenimento e nella pianta della sepoltura è segnalata la presenza di una coppa a vernice nera, non individuabile in magazzino. n. 3 (Tav. 35, 7): coppa a profilo distinto in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 10.6; alt. 6.2. Impasto duro, privo di inclusi; colore: Munsell 7.5YR 8/2. Vernice compatta semilucida; colore: Munsell .5Y 2/0; con impronte di immersione sulla parete e sul piede. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.240.C.3. n. 4 (Tav. 35, 11): coppetta a profilo globulare in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 6.8; alt. 3.8. Impasto duro, privo di inclusi; colore: 226
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
Munsell 10YR 8/2. Vernice opaca, evanide; colore: Munsell 2.5YR 2.5/0. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Tipo H.260.A.18.
concentrici sull’orlo, sul collo e sulla spalla; colore vernice: Munsell 7.5YR 3/2. Realizzato al tornio. Integro. Tipo N.130.2.
n. 5 (Tav. 35, 1): skyphos a profilo troncoconico in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 10.4; alt. 10.5. Impasto duro, privo di inclusi; colore: Munsell 10 YR 8/3. Vernice semilucida, evanide, presente su tutta la superficie; colore: Munsell 7.5YR 2/0. Superficie liscia. Realizzato al tornio. Integro. Tipo H.280.7.
n. 11 (Tav. 35, 8): fuseruola biconica in impasto. Diam. 3.2; alt. 2.4. Impasto duro; colore: Munsell 2.5YR 3,5/0. Superficie liscia. Realizzata a mano. Integra. Tipo Q.10.1. n. 12 (Tav. 35, 5): fibula in ferro ad arco semplice. Lungh. max. ric. 7.2. Superficie ossidata e corrosa. Frammentaria. Probabilmente ascrivibile al Tipo S.20.A.4, varietà a.
n. 6 (Tav. 35, 2): skyphos a profilo troncoconico in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 9.4; alt. 10.6. Impasto duro, compatto, frattura netta, privo di inclusi; colore Munsell 7.5YR 7/4. Vernice compatta, semilucida; colore: Munsell 2.5YR 2.5/0, piede e fondo esterno risparmiati, impronte di immersione tra la vasca e il fondo. Superficie liscia. Realizzato al tornio. Mancante di una delle anse. Tipo H.280.7.
n. 13 (Tav. 35, 9): anello in argento con castone a losanga. Diam. 1.8; largh. castone 0.6. Integro. Con castone inciso. Tipo S.40.B.2. n. 14 (Tav. 35, 10): anello in argento con castone a losanga. Diam. 2; largh. castone 0.9. Integro. Castone inciso. Tipo S.40.B.2.
n. 7 (Tav. 35, 13): olla globulare in ceramica comune. Diam. orlo 21.4; alt. 34.7. Impasto duro, poroso con rari vacuoli distribuiti in maniera disomogenea, frattura irregolare, con frequenti inclusi di grandi dimensioni distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 5YR 7/6. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Ricomposta da vari frammenti. Tipo I.40.3.
Tomba 145 (Saggio C; Tavv. 5, 11). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso sud-est/nord-ovest (lungh. 135, largh. 65; prof. max. cons. 160), localizzata nel settore sud-occidentale del Saggio C. Sulla parete sud-orientale, in prossimità dell’angolo occidentale e a circa 70 dal piano di inumazione, è ricavata una piccola nicchia (largh. 15; prof. 25; alt. 30) per l’alloggiamento del ripostiglio. La deposizione è dorsale, primaria e in ambiente chiuso; gli arti superiori e inferiori sono allineati. Dati antropologici. Lo scheletro appartiene a un individuo immaturo (sub-adulto), mal conservato, di età alla morte stimata tra 3 e 5 anni. Sono presenti frammenti di cranio e mandibola, elementi dentari decidui e permanenti il cui stadio di sviluppo corrisponde a una età di 4 anni 12 mesi. La stima dell’età alla morte è confermata dalla valutazione della maturazione del cranio: nel frontale è completa (età maggiore di due anni) mentre nella pars basilaris è incompleta e corrisponde a una età minore di 5-7 anni. Dati archeologici. Il corredo è costituito da un’olletta e un poculum in ceramica comune, presso la diafisi prossimale delle tibie (nn. 6-7; il poculum non è visibile nella pianta); un piatto
n. 8 (Tav. 35, 4): poculum a profilo sinuoso in ceramica comune. Diam. orlo 8.8; alt. 9.2. Impasto duro, con frequenti inclusi di medie dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore Munsell 2.5YR 5.5/8; con aloni di cottura. Superficie ruvida. Realizzato al tornio. Integro. Tipo I.190.3, varietà b. n. 9 (Tav. 35, 3): coperchio globulare in ceramica comune. Diam. alla base 9; alt. 5.2. Impasto duro, con frequenti inclusi di medie dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 2.5/0. Superficie liscia. Realizzato a mano. Integro. Tipo I.300.1. n. 10 (Tav. 35, 12): balsamario ceramico fusiforme. Diam. orlo 16; alt. 14.4. Impasto duro, privo di inclusi; colore: Munsell 7.5YR 6.5/6. Superficie polverosa. Si conservano tracce di decorazione dipinta in cerchi 227
Capestrano, I
più scure sulla superficie esterna dovute a cottura non omogenea. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo I.50.A.11.
e una coppa in ceramica a vernice nera sui piedi (nn. 2 e 4); una coppetta in ceramica a vernice nera nei pressi del femore sinistro (n. 1). Il ripostiglio è composto da un’olla in ceramica comune con uno skyphos in ceramica a vernice nera (nn. 3 e 5). Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Seconda metà IIIprima metà II secolo a.C.
n. 6 (Tav. 36, 1): olletta ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 9.4; alt. 9.8. Impasto duro, con inclusi calcarei di medie dimensioni; colore superficie: Munsell 2.5YR 4/6. Superficie polverosa, con tracce di cottura disomogenea. Realizzata al tornio. Integra. Tipo I.50.B.9, varietà a.
n. 1 (Tav. 36, 5): coppetta a profilo globulare in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 12.2; alt. 5. Impasto tenero, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 8/2. Vernice lucida ed assente in più parti; colore: Munsell 2.5YR 3/0-3/2. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.260.A.8.
n. 7 (Tav. 36, 4): poculum in ceramica comune. Diam. orlo 8.2; alt. 8.6. Impasto duro e compatto, frattura regolare, con abbondanti inclusi di grandezza media distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10YR 3/1-5YR 5/6. Superficie polverosa, con tracce di cottura disomogenea. Realizzato al tornio. Frammentario in corrispondenza dell’orlo Tipo I.190.2, varietà a.
n. 2 (Tav. 36, 6): coppetta a profilo distinto in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 4.4; alt. 4. Impasto duro, privo di inclusi; colore: Munsell 5YR 8/2. Vernice compatta e lucida; colore: Munsell 2.5YR 2.5/0; in corrispondenza del fondo e della vasca impronte di immersione. Sull’esterno della vasca, sono graffiti due segni alfabetici (probabilmente P e O, o A). Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.260.C.1.
Tomba 146 (Saggio D; Tavv. 6, 11). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso sud-est/nord-ovest (lungh. max. cons. 155; largh. 80; prof. 53), localizzata nel settore meridionale del Saggio D. La fossa era tagliata presso l’angolo meridionale dalla tomba 159 (vedi, 236-237) e il riempimento era disturbato dalla tomba neonatale 148 (vedi, 230). La deposizione, profondamente disturbata, sembra delimitata da alcune pietre, di cui una di grandi dimensioni infissa verticalmente sul fondo della fossa. La deposizione è dorsale, primaria e in ambiente vuoto; gli arti inferiori distesi e allineati. Dati antropologici. L’inumato è un individuo sub-adulto con età di circa 12 anni. Di questo individuo non restano che gli arti inferiori in pessimo stato di conservazione. Il femore sinistro misura una lunghezza massima di 380 mm e le epifisi prossimale e distale non sono saldate alla diafisi, quindi è possibile stimare una età alla morte di circa 12 anni. Nella tomba sono stati raccolti anche i resti di adulto femminile di 25-29 anni. Lo stato di conservazione è buono e completo. Sia il cranio che il bacino mostrano morfologia compatibile con caratteri sessuali secondari femminili. L’età può essere stimata a partire dall’aspetto della superficie auricolare dell’ileo che conserva
n. 3 (Tav. 36, 2): skyphos a profilo troncoconico in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 8.8; alt. 10.2. Impasto tenero e privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 8/4. Vernice poco resistente ed opaca; colore: Munsell 2.5YR 3/0. Superficie polverosa. Realizzato al tornio. Integro. Tipo H.280.9. n. 4 (Tav. 36, 3): piatto con vasca troncoconica e labbro svasato in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 17.2; alt. 4.3. Impasto tenero, compatto, frattura regolare, privo di inclusi; colore: Munsell:7.5YR 7.5/4. Vernice opaca ed assente in più punti; colore: Munsell 2.4YR tra 2/5 e 4/6. Superficie polverosa. Realizzato al tornio. Mancante di parte dell’orlo. Tipo H.290.C.6. n. 5 (Tav. 36, 7): olletta ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 15; alt. 21.2. Impasto duro, con frequenti inclusi di medie dimensioni; colore: Munsell 2.5YR 5/6; si conservano tracce 228
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
per l’alloggiamento del ripostiglio. Nella terra di riempimento della fossa, a circa 25 dal margine superiore, si rinviene una grande pietra posizionata in corrispondenza del bacino dell’inumato. Si rinvengono i resti della cassa lignea sul fondo, meglio conservata in corrispondenza della testa e dei piedi. La deposizione, al suo interno, è dorsale, primaria e in ambiente vuoto, con gli arti superiori e inferiori distesi. Il cranio è rivolto a nord; le mani poste sul bacino e gli arti inferiori distesi. Dati antropologici. Il materiale antropologico appartiene a un individuo adulto probabilmente maschile di età matura. Tutte le regioni scheletriche sono presenti, ma lo stato di conservazione è pessimo e frammentario, per questa ragione non sono disponibili indicatori per delineare un profilo biologico. L’unica osservazione possibile riguarda la morfologia della mandibola che è robusta e il processo mastoideo abbastanza verticalizzato. Probabilmente la morte è avvenuta in età matura considerando alcuni elementi dentari in avanzato stato di usura e con episodi di grave carie. In questo contesto tombale sono stati raccolti e denominati “Frammenti ossei estranei”: un frammento di cranio frontale e una decina di denti. Dati archeologici. Il corredo si dispone all’interno della cassa lignea e si compone di una fibula in ferro sull’emitorace destro (n. 7); uno strigile in ferro presso la mano destra (n. 8); un piatto in ceramica a vernice nera sul bacino (n. 5); due coppe in ceramica a vernice nera sui femori, su una delle quali è adagiata una coppetta della stessa classe (nn. 1-3); in corrispondenza del piede sinistro si trovano elementi in ferro identificabili come resti di calzari (n. 9). Il ripostiglio è composto di un’olla in ceramica d’impasto, a fianco della quale è deposto uno skyphos in ceramica a vernice nera (nn. 4 e 6). La presenza dello strigile conferma l’attribuzione a un individuo maschile adulto. Inquadramento cronologico. Prima metà II secolo a.C.
tracce di crestoline parallele (billowing) e alcune strie corrispondente a età tra 25 e 29 anni. La giovane età è confermata dalla lieve usura dentaria compatibile con una età tra 18 e 22 anni. Il calcolo della statura in vita risulta di 159 cm, sulla base della lunghezza massima del femore sinistro (426 mm) e della tibia destra (337 mm). Dati archeologici. Il corredo si compone di una fibula in ferro, rinvenuta in condizioni frammentarie sul piano della sepoltura al di sopra del bacino (n. 2) e di una tazza in ceramica d’impasto deposta presso i piedi (n. 1). È possibile che un’armilla in verga di bronzo a sezione circolare (n. 3), rinvenuta all’interno della vicina tomba 159, databile in età ellenistica, possa essere riferita all’evidenza in esame. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. VI secolo a.C. (?). n. 1 (Tav. 36, 8): scodella monoansata in impasto grezzo. Diam. orlo 8.8; alt. max. 5.5. Impasto tenero, poroso con rari vacuoli distribuiti in maniera omogenea, frattura frastagliata, con abbondanti inclusi di piccole e medie dimensioni; colore: Munsell 10YR da 4/3 a 2/1. Superficie liscia, irregolare, con impressioni di elementi vegetali. Realizzata a mano. Mancante dell’ansa. Tipo A.230.B.1. n. 2 (Tav. 36, 10): fibula in ferro con arco semplice a tutto sesto. Lungh. max. ric. 6; alt. max. cons. 1.8. Superficie corrosa e ossidata. Frammentaria; si conservano la molla, gli attacchi dell’arco e la staffa allungata. Tipo S.20.A.3. n. 3 (Tav. 36, 9): armilla in bronzo con capi aperti sovrapposti. Diam. 6; largh. 1.5; spessore verga 0.3. Patina verde in superficie. Ricomposta da alcuni frammenti. Tipo S.30.A.1. Tomba 147 (Saggio D; Tavv. 6, 13). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso sud-est/nord-ovest (lungh. 240; largh. 75; prof. 145), localizzata nel settore centrale del Saggio D. Nella parete sudorientale della fossa, è ricavata una nicchia a 70 dal piano di deposizione (largh. 60; prof. 25),
n. 1 (Tav. 36, 15): coppa in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 19; alt. 7.4. Impasto duro, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 8/2. Vernice quasi totalmente assente sull’intera 229
Capestrano, I
7.8; alt. max. ric. 3.6. Superficie corrosa e ossidata. Frammentaria. Lembi di tessuto si conservano sulla molla. Tipo S.20.A.4, varietà a.
superficie sia interna che esterna; colore: Munsell 10YR 4/1. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.240.A.3. n. 2 (Tav. 36, 14): coppa a profilo globulare in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 19.6; alt. 6.4. Impasto duro, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 2/0. Vernice lucente e compatta; colore: Munsell 7.5YR 2/0. Tracce di rotellatura si conservano lungo almeno tre fasce sovrapposte della superficie esterna. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.240.A.13.
n. 8 (Tav. 36, 13): strigile in ferro. Largh. max. ligula 3.4; lungh. 25.5; lungh. manico 9.7. Superficie corrosa e ossidata. Parzialmente ricomposto. Tipo R.30.1. n. 9 (Tav. 36, 16): sei frammenti in ferro riferibili probabilmente ai ramponi e alle fascette laterali di calzari. Lungh. max. ric. 18; lungh. max. ramponi 6.6; min. 5.2. Superficie corrosa e ossidata.
n. 3 (Tav. 36, 17): coppetta miniaturistica a profilo globulare in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 4.2; alt. 2.8. Impasto tenero, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 7/2. Vernice pressoché assente. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.260.A.13.
Tomba 148 (Saggio D; Tavv. 6, 13). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso sud-est/nord-ovest (lungh. 50; largh. 26; prof. 35), localizzata nella zona sudoccidentale del Saggio D. Disturba la tomba 146 (vedi, 228-229). La deposizione risulta delimitata lateralmente da due allineamenti di pietre di piccole dimensioni ed è dorsale, primaria e in ambiente pieno, con gli arti superiori e inferiori distesi. Dati antropologici. I resti umani appartengono ad un sub-adulto perinatale il cui scheletro è completo ed in discreto stato di conservazione. Le misure di lunghezza massima della pars petrosa (32 mm), dell’omero (57.1 mm), del femore (71.8 mm) indicano una età alla morte alla 36a-38a settimana di gestazione. Dati archeologici. Il corredo è costituito da una fibula in ferro posta sul lato destro del bacino (n. 1). Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Gen. età arcaica?
n. 4 (Tav. 36, 18): skyphos a profilo troncoconico in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 12; alt. 14.2. Impasto duro privo di inclusi; colore: Munsell 7.5YR 7.5/4. Vernice lucente, uniforme con impronte di immersione in prossimità del piede e tracce di colatura sul fondo: colore: Munsell 7.5YR 2/0. Superficie liscia.Realizzato al tornio. Integro. Tipo H.280.5. n. 5 (Tav. 36, 11): piatto con vasca troncoconica e labbro svasato in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 18; alt. 4.7. Impasto duro e compatto, frattura regolare, priva di inclusi; colore: Munsell 10YR 7/4. Vernice compatta e opaca; colore: Munsell 2.5YR 2/0; tracce di immersione in prossimità del fondo e tracce del tornio anche esternamente. Realizzato al tornio. Frattura netta sull’orlo. Parzialmente ricomposto. Tipo H.290.C.7.
n. 1 (Tav. 37, 1): fibula in ferro con arco semplice a tutto sesto. Lungh. 5.9; alt. 3. Superficie corrosa e ossidata. Ricomposta da vari frammenti. Tipo S.20.A.3.
n. 6 (Tav. 36, 19): olla ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 14; alt. 28.4. Impasto duro, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 7.5YR 6.5/8. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Integra. Tipo I.40.2.
Tomba 149 (Saggio D; Tav. 6, manca la planimetria di dettaglio). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso est/ovest (lungh. max. ric. 118; largh. max. ric. 58; prof. 30), localizzata lungo il margine orientale del Saggio D. Rinvenuta profondamente disturbata
n. 7 (Tav. 36, 12): fibula in ferro con piccolo arco semplice a tutto sesto. Lungh. ric. dell’ago 230
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
in senso nord-est/sud-ovest (lungh. max. cons. 260; largh. max. 115; prof. 85) e il suo piano di calpestio presenta una leggera inclinazione in direzione della camera, cui si accede tramite una soglia. La deposizione, realizzata direttamente sul piano della camera, è dorsale, primaria e in spazio vuoto; l’inumato giaceva in posizione supina con l’arto superiore flesso e quello sinistro lievemente flesso sul bacino, con il cranio orientato a est. Dati antropologici. L’inumato è un individuo adulto femminile di età alla morte tra 35 e 56 anni. Lo scheletro è completo e ben conservato. Le caratteristiche sessuali secondarie femminili sono ben distinguibili nel cranio e nella mandibola e nella morfologia del bacino e del sacro. L’età alla morte può essere stimata in base all’aspetto della sinfisi pubica destra tra 35 e 56 anni (media di 45.6 anni). Il grado di ossificazione delle suture craniche è molto avanzato, risultano completamente obliterate sia la sutura sagittale che coronale e lambdoidea. Anche lo stadio di usura dei denti conferma una età avanzata, così come altri segni di degenerazione scheletrica correlati all’età e genericamente attribuibili a osteoartrosi: sul dente dell’epistrofeo, sul manubrio e sulla porzione sternale della prima costa, sull’epifisi distale dei femori. Inoltre le rotule destra e sinistra presentano anteriormente una proliferazione di tessuto osseo lieve in corrispondenza dell’inserzione tendinea del quadricipite (entesopatia), il muscolo responsabile del movimento di flessione ed estensione del ginocchio (fig.antr.online 151_01). La lunghezza massima del femore sinistro (426 mm) permette il calcolo della statura che risulta di159 cm. Dati archeologici. Il corredo si compone di una lagynos in ceramica comune e un balsamario deposti presso la parete nord-occidentale del vano ipogeo (nn. 1 e 9); tra l’inumato e l’accesso alla camera, si concentrano una lucerna in ceramica a vernice nera (n. 8) deposta all’interno di un piatto in ceramica a vernice nera (n. 6); una coppa biansata; una coppetta, una coppa della stessa classe e una olletta in ceramica comune al di sotto (nn. 2-5, 7). Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Seconda metà/fine
dall’impianto della tomba 178 (vedi, 254). Tomba 150 (Saggio D; Tavv. 6, 13). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso est/ovest (lungh. max. ric. 50; largh. max. ric. 35; prof. 25), localizzata nell’area sud-orientale del Saggio D. La fossa taglia la tomba 178 e risulta pesantemente danneggiata dall’impianto delle tombe 152 e 177 (vedi, 232-233, 253-254). Sul piano di deposizione si conservano due spezzoni litici di medie dimensioni, addossati al lato meridionale. La deposizione si presenta in pessimo stato di conservazione. Dati antropologici. I resti umani appartengono a un sub-adulto perinatale, la morfologia delle coste e dell’arco vertebrale conservati sono compatibili con un feto di cui non è possibile stimare con attendibilità l’età alla morte. Dati archeologici. Si rinviene una fibula in bronzo (n. 1), probabilmente originariamente deposta sul torace. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Fine VI secolo a.C. n. 1 (Tav. 37, 2): fibula in bronzo con arco a doppia ondulazione. Lungh. 6.5; alt. 2.2. Patina verde in superficie. Integra. L’arco è decorato da due fasci di trattini orizzontali incisi e dal motivo a croce di S. Andrea sulla parte superiore. Tipo S.20.B.1. Tomba 151 (Saggio C; Tavv. 5, 14). Tomba ipogeica “a grotticella” con corridoio di accesso semplice, localizzata presso il limite nord-orientale del Saggio C. Il suo impianto disturba le tombe 144 e 173 (vedi 225-227, 250-251). La camera ha pianta trapezoidale, orientata in senso nord-ovest/sud-est (lungh. max. cons. 200; largh. nella porzione centrale 115; si restringe a est fino a 98 e a ovest fino a 85; alt. 110). La volta risulta crollata in antico e si conserva solo nel punto di innesto delle pareti. Il piano di deposizione è orizzontale. L’accesso è rivolto a nord-est, con una luce di 100 ca. A ridosso dello stipite sud-orientale, si rinviene uno spezzone di calcare di grandi dimensioni, con la probabile funzione di sostenere e bloccare l’originaria chiusura lignea della camera. Il corridoio di accesso è orientato 231
Capestrano, I
Diam. orlo 21.2; alt. 4.4. Impasto duro, con rarissimi inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 10YR 7/4. Vernice conservata in modo disomogeneo; colore: Munsell 2.5Y 2/0; tracce d’immersione sul fondo. Superficie saponosa. Realizzato al tornio. Integro. Tipo H.290.B.2.
II secolo a.C. n. 1 (Tav. 37, 3): lagynos in ceramica depurata acroma. Diam. orlo 5.6; alt. 20.2. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10YR 7.5/4. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Mancante di parte del labbro. Tipo D.120.3.
n. 7 (Tav. 37, 11): olletta ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 10.6; alt. 11.9. Impasto duro, con frequenti inclusi di piccole dimensioni; colore: Munsell 5YR 2.5/1. Superficie ruvida. Realizzata al tornio. Integra. Tipo I.50.B.9, varietà b.
n. 2 (Tav. 37, 6): lagynos a profilo cilindrico in ceramica a vernice nera. Diam. fondo 12.4; alt. 7.4. Impasto duro, compatto, frattura netta, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 7/4. Vernice distribuita in modo omogeneo e fondo parzialmente verniciato con incisione; colore: Munsell 7.5YR 2/0. Superficie liscia. Al di sotto del fondo reca un probabile segno alfabetico graffito (H?). Realizzata al tornio. Mancante di parte dell’orlo. Tipo H.120.3.
n. 8 (Tav. 37, 7): lucerna con serbatoio globulare in ceramica a vernice nera. Diam. vasca 4.8; lungh. becco 2.6; alt. 2.5. Impasto duro, con rarissimi inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 5YR 6.5/6. Vernice totalmente assente. Superficie saponosa. Realizzata al tornio. Integra. Tipo M.A.1.
n. 3 (Tav. 37, 4): coppa a profilo distinto in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 16.8; alt. 5.8. Impasto tenero, compatto, frattura regolare, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 8/3. Vernice conservata parzialmente sulla superficie e in corrispondenza del fondo; colore: Munsell 2.5YR 3/0. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Ricomposta da vari frammenti. Tipo H.240.C.10.
n. 9 (Tav. 37, 9): balsamario ceramico fusiforme. Diam. orlo 3.2; alt. 25.9. Impasto duro, con rarissimi inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR da 7/4 a 6/6. Tracce di vernice; colore: Munsell 5YR tra 4/3 e 3/1. Superficie polverosa. Realizzato al tornio. Integro. Tipo N.130.5.
n. 4 (Tav. 37, 8): coppa biansata in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 14.6; alt. 6.6. Impasto duro, privo di inclusi; colore: Munsell 7.5YR 8/4. Vernice non conservata su tutta la superficie e parzialmente sul fondo; colore: Munsell 7.5YR 2/0. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.250.1.
Tomba 152 (Saggio D; Tavv. 6, 13) Sepoltura a inumazione in fossa pressoché rettangolare, orientata lungo l’asse nordovest/sud-est (lungh. 110; largh. 75; prof. 57); localizzata nella porzione meridionale del saggio di scavo. Taglia a sud-est la tomba 150 e a nord-ovest è tagliata dalla 165 (vedi 231, 240-241). Il piano di inumazione è segnato da un allineamento di tre pietre di media grandezza poste di taglio, con andamento est-ovest. Dati antropologici. La sepoltura risulta priva di resti antropologici. Dati archeologici. Al centro del piano di deposizione, si recupera una fibula frammentaria in pessimo stato di conservazione (non documentata). Inquadramento cronologico: lo stato di conservazione dei materiali non consente un
n. 5 (Tav. 37, 10): coppetta a profilo distinto in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 10.6; alt. 5.4. Impasto duro, con rarissimi inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 10YR 7.5/4. Vernice parzialmente conservata sulla superficie e tracce di vernice sul fondo; colore: Munsell 2.4YR tra 3 e 2.5/0. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.260.C.7. n. 6 (Tav. 37, 5): piatto con vasca troncoconica e labbro rientrante in ceramica a vernice nera. 232
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
inquadramento cronologico puntuale; a tale proposito, la sua posizione rispetto alla tomba 150, di età tardo-arcaica e alla 166, di età ellenistica, consente solo un inquadramento generico tra questi due periodi. Tomba 153 (Saggio D; Tavv. 6, 13). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso nord-ovest/sud-est (lungh. 240; largh. 85; prof. non registrata in corso di scavo), localizzata nell’area centrale del saggio di scavo. L’evidenza disturba pesantemente la più antica tomba 154, ed è disturbata dalla tomba 128 (vedi scheda seguente e 215). Lungo il lato nord-orientale della fossa si apre una nicchia (largh. 63; prof. 25) all’interno della quale sono deposti materiali ceramici, chiusa da spezzoni litici alloggiati nel riempimento; sul lato opposto, si apre un’altra nicchia (largh. 60; prof. 30), per la quale però non è sicura l’attribuzione alla tomba in esame o alla 154. Sul piano di fondo della fossa sono evidenti le tracce nerastre di una cassa lignea, all’interno della quale si rinviene la deposizione dorsale, primaria e nello spazio vuoto, con il cranio ruotato a ovest e gli arti superiori convergenti sul bacino; gli arti inferiori sono distesi e i piedi sovrapposti. Dati antropologici. Lo scheletro appartiene a un adulto femminile di età tra 35 e 45 anni. Tutti i distretti scheletrici, craniale e postcraniali, sono rappresentati. La determinazione del sesso femminile è basata sulla morfologia della mandibola e del cranio (processo mastoideo, profilo della glabella, margine sovraorbitario). L’età, valutata in base all’usura dentaria, è stimata tra 35 e 45 anni. Tra i denti raccolti singolarmente, si segnala la presenza di apposizioni di tartaro sul lato buccale di due incisivi mandibolari. Una lieve proliferazione di 2 mm è localizzata sul dente dell’epistrofeo, correlabile a osteoartrosi del tratto cervicale della colonna vertebrale. Un’altra anomalia correlata a osteoartrosi è localizzata nel gomito. In particolare si osserva sull’epifisi prossimale delle ulne destra e sinistra una proliferazione del tessuto osseo (fig.antr.online 153_01A,B,C), come anche lungo la circonferenza del capitello radiale bilateralmente (fig.antr.online 153_02A,B). Infine questo individuo presenta presso l’aspetto mediale della metafisi distale 233
dell’omero sinistro una ulteriore proliferazione di tessuto osseo compatibile per forma e dimensioni con uno “spur sopracondilare”, cioè un carattere antropologico epigenetico ereditario. Tuttavia, considerando lo stato di conservazione delle ossa, non si esclude la possibilità che in questo caso l’anomalia abbia una origine occupazionale o conseguenza di un trauma dei tessuti molli (fig.antr.online 153_03A,B). Dati archeologici. Il corredo, concentrato prevalentemente nella cassa lignea, era composto da una fuseruola in impasto sull’emitorace destro (n. 7); un anello in ferro all’anulare destro (n. 8); una scodella in ceramica comune sulla tibia sinistra (n. 6); a sud-ovest dei piedi una coppa in ceramica a vernice nera, ed al suo interno un poculum in ceramica comune (nn. 2 e 5). Nella nicchia a est dell’inumato, si rinvengono una brocchetta in ceramica depurata acroma e una coppa in ceramica a vernice nera (nn. 1 e 3); in quella a ovest, un’olla in ceramica comune (n. 4). La presenza della fuseruola e dell’anello suggerisce una identificazione come individuo femminile. Inquadramento cronologico. II secolo a.C. n. 1 (Tav. 38, 1): lagynos in ceramica depurata acroma. Diam. orlo 4; alt. 14.9. Impasto duro, con inclusi molto rari di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell tra 7.5YR 7/6 e 6/6. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Integra. Tipo D.120.2. n. 2 (Tav. 38, 3): coppa a profilo globulare in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 18.6; alt. 7. Impasto tenero, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 8/4. Vernice conservata solo parzialmente; colore: Munsell 5YR 2.5/2. Superficie saponosa. Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.240.A.12. n. 3 (Tav. 38, 7): coppetta a profilo distinto in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 13.4; alt. 4.7. Impasto duro, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 8/4. Vernice disomogenea, lacunosa almeno in un quarto della ciotola, sono presenti sul fondo alcune sbavature; colore: Munsell 2.5YR 4/8. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.260.C.3.
Capestrano, I
ne suggeriscono l’attribuzione a un individuo infantile. Inquadramento cronologico. Età tardo-arcaica.
n. 4 (Tav. 38, 8): olletta globulare in ceramica comune. Diam. orlo 19.3; alt. 22. Impasto duro, poroso con rari vacuoli distribuiti in maniera disomogenea, frattura frastagliata, con frequenti inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 2.5YR 4/8. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Ricomposta da vari frammenti. Tipo I.50.A.1.
n. 1 (Tav. 38, 9): fibula in ferro con arco semplice a tutto sesto. Lungh. 5.2; alt. 3.5. Superficie corrosa e ossidata. Ricomposta da vari frammenti. Seconda metà/fine VI secolo a.C.
n. 5 (Tav. 38, 6): poculum a profilo cilindrico in ceramica comune. Diam. orlo 8; alt. 9. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con frequenti inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell tra 2.5YR 3/4 e a 10YR 4/3. Realizzato a mano. Superficie liscia. Ricomposto da vari frammenti. Tipo I.190.2, varietà b.
Tomba 155 (Saggio C; Tavv. 5, 143). Sepoltura a inumazione in fossa di forma pressoché ovale, orientata in senso nord-sud (lungh. 50; largh. 30; prof. 21; prof. 53), localizzata nella porzione occidentale del Saggio C. La tomba sembra essere stata originariamente segnalata in superficie da una lastra litica di forma pressoché rettangolare. La deposizione è in decubito laterale sinistro, con gli arti inferiori rannicchiati. Mancano elementi di corredo. Dati antropologici. Si recuperano i resti di un feto il cui scheletro è discretamente conservato e abbastanza completo. Alcuni dati metrici permettono di determinarne l’età alla morte alla 38a-40a settimana di gestazione. Dati archeologici. Non si recuperano materiali di corredo. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Incerto.
n. 6 (Tav. 38, 2): scodella a profilo globulare in ceramica comune. Diam. orlo 20; alt. 9.5-7.7. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con frequenti inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 2.5YR 3/0. Superficie scabra, fortemente danneggiata. Realizzata a mano. Integra. Tipo I.230.2. n. 7 (Tav. 38, 5): fuseruola biconica in impasto. Diam. 3.1; alt. 2.7. Impasto duro; colore: Munsell 5YR 3/1. Superficie liscia e steccata. Realizzata a mano. Integra. Tipo Q.10.1.
Tomba 156 (Saggio C; Tavv. 5, 14). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso nord-ovest/sud-est (lungh. 186; largh. 57; prof. 232), localizzata presso il margine sud-occidentale del Saggio C. La deposizione è dorsale e primaria, in spazio vuoto; il cranio è volto a sud-ovest; gli arti superiori e inferiori distesi; di questi ultimi mancano le tibie e le ossa dei piedi e, in corrispondenza di tali lacune, si registra la presenza di alcune pietre di medie dimensioni. Dati antropologici. I resti umani appartengono ad un individuo adulto di sesso femminile e di età compresa tra 34 e 63 anni. Lo stato di conservazione è pessimo, tuttavia sono presenti elementi del cranio e del postcranio incluse le estremità degli arti. La mandibola ha morfologia dalle caratteristiche femminili, così come le porzioni di cranio con processo mastoideo e margini sovraorbitali. I denti
n. 8 (Tav. 38, 4): anello in ferro con castone a losanga. Diam. 2.5; largh. castone 2.4. Superficie corrosa e ossidata. Ricomposto da vari frammenti. Tipo S.40.B.2. Tomba 154 (Saggio D; Tavv. 6, 13). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso nord-ovest/sud-est (lungh. 85; largh. 60; prof. non puntualizzabile), localizzata nella porzione centrale del Saggio D. La fossa è disturbata dalla tomba 153. Sul piano di deposizione sono allineate tre pietre disposte di taglio. Dati antropologici. La sepoltura risulta priva di resti antropologici. Dati archeologici. Il corredo è composto da un’unica fibula in ferro, rinvenuta lungo il lato orientale (n. 1). Il sesso archeologico non è determinabile; le dimensioni ridotte della fossa 234
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
Due fori paralleli sul punto di massima espansione. Tipo H.120.6.
mostrano una usura grave compatibile con una età tra 35 e 45 anni. In particolare gli incisivi mandibolari del lato destro mostrano una anomala usura. Considerando l’aspetto della superficie auricolare dell’ileo, è possibile stimare una età di 50-59 anni, confermata dalla valutazione della sinfisi pubica sinistra molto degradata corrispondente a età di 48.1 anni (in un range tra 34 e 63 anni). La colonna vertebrale mostra segni di osteoartrosi localizzata nel tratto cervicale, dove i corpi delle vertebre C1, C3, C4, C5, C7 presentano una proliferazione osteofitica (becco) anteriormente. Una anomalia colpisce anche la clavicola destra (la sinistra non è disponibile per l’analisi paleopatologica) ben visibile sia in visione superiore che ventrale (fig.antr.online 156_01A,B). Si tratta della traccia di un grave fenomeno erosivo associato ad intensa attività osteoblastica (metaplasia ossea) presso la fossa romboidale, nel punto di inserzione del legamento costo-clavicolare, esito probabilmente di una prolungata attività di sovraccarico o stress occupazionale dell’arto superiore. Tale anomalia è più precisamente una sindesmopatia del legamento costo clavicolare che si altera per stress occupazionali ed infatti può essere simmetrica o asimmetrica a seconda dell’uso di entrambi gli arti o sovraccarico monolaterale. Dati archeologici. Il corredo si compone di una fibula in ferro sul torace (n. 5); un anello in bronzo alla mano sinistra (n. 6); una lagynos in ceramica a vernice nera nello spazio tra le ginocchia (n. 1); una coppa della stessa classe e due pocula in ceramica comune in corrispondenza degli arti inferiori (nn. 2-4). La presenza dell’anello sembra confermare l’identificazione del sesso archeologico come femminile. Inquadramento cronologico. Fine III-prima metà II secolo a.C.
n. 2 (Tav. 38, 13): coppetta a profilo globulare in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 12; alt. 5.3. Impasto duro, compatto, frattura regolare, privo di inclusi; colore: Munsell 7.5YR 8/3. Vernice compatta; colore Munsell 2.5YR; sono presenti imperfezioni nella verniciatura in prossimità del piede sulla superficie esterna, sull’orlo la vernice è evanide sia all’interno che all’esterno. Superficie liscia. Realizzato al tornio. Mancante di parte dell’orlo. Tipo H.260.A.5. n. 3 (Tav. 38, 12): poculum a profilo cilindrico in ceramica comune. Diam. orlo 8.4; alt. 9.8. Impasto tenero, compatto, frattura frastagliata, con frequenti inclusi di piccole e medie dimensioni distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 5YR tra 6/6 e 3/1. Superficie polverosa. Realizzato al tornio. Manca parte dell’orlo. Tipo I.190.1. n. 4 (Tav. 38, 14): poculum a profilo cilindrico in ceramica comune. Diam. orlo 7.4; alt. 7.2. Impasto tenero, compatto, frattura frastagliata, con frequenti inclusi di piccole e medie dimensioni distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 10YR 7.5/3. Superficie liscia. Realizzato al tornio. Presenta piccole lacune in corrispondenza del labbro. Tipo I.190.2, varietà a. n. 5 (Tav. 38, 10): fibula in ferro con arco semplice, a tutto sesto ampio e assottigliato. Lungh. max. ric. 6; alt. max. ric. 3. Superficie corrosa e ossidata. Frammentaria (tre frammenti), mancante dell’ago. Tracce di tessuto sulla molla. Tipo S.20.A.4, varietà b. n. 6 (Tav. 38, 11): anello in bronzo con castone a losanga. Diam. 2; largh. castone 2.1. Patina verde sulla superficie. Integro. Tipo S.40.B.2.
n. 1 (Tav. 38, 15): lagynos a profilo ovoide in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 4.2; alt. 18.7. Impasto duro, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 8/3. Vernice compatta e opaca; colore: Munsell 5Y 2.5/1; il fondo è risparmiato e presenta delle colature all’esterno. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra.
Tomba 157 (Saggio C; Tavv. 5, 15). Tomba ipogeica “a grotticella” con corridoio di accesso semplice, di cui non è stata scavata completamente la camera, trovandosi l’emergenza in corrispondenza del limite meridionale del Saggio C. La camera presenta 235
Capestrano, I
ceramica a vernice nera. Diam. orlo 12.2; alt. 5.3. Impasto duro, privo di inclusi; colore: Munsell 7.5YR tra 7.5 e 7. Vernice lucente con colature nella parte bassa della vasca e sul piede; colore: Munsell 2.5YR 2.5/0. Superficie liscia. Sulla parte bassa della vasca sono graffiti due segni alfabetici (I ed N o M?). Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.260.A.8.
pianta rettangolare, orientata in senso nordovest/sud-est; gli angoli della parete di fondo sono arrotondati e il piano è orizzontale (lungh. 150; largh. max. cons. 70; prof. 214). L’accesso al corridoio di accesso, più alto di 14 rispetto alla soglia, si apre sul lato sud-orientale, con una luce di 65. Al suo interno non si rinvengono resti antropologici, ma solo i materiali di corredo. Il mancato scavo in estensione della camera impedisce di puntualizzare se il defunto fosse posto lungo la parete di fondo (eventualmente, con una banchina laterale) o meno. Il corridoio è orientato in senso nordest/sud-ovest (lungh. 185; largh. max. 70; largh. min. 46; prof. 202). Dati antropologici. La sepoltura risulta priva di resti antropologici. Dati archeologici. Il corredo si trova deposto nella porzione occidentale della camera, a ridosso di due blocchi di pietra calcarea, e si compone di una brocchetta in ceramica a vernice nera (n. 2); un poculum in ceramica depurata acroma (n. 1); una coppetta ed un piatto in ceramica a vernice nera (nn. 3-4). Nella terra di riempimento della camera si rinvengono frammenti di un’olla in impasto (n. 5), forse da una sepoltura più antica sconvolta. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Prima metà-metà II secolo a.C.
n. 4 (Tav. 39, 2): piatto con vasca troncoconica e labbro rientrante in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 20.4; alt. 4.9. Impasto duro, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 7/4. Vernice opaca, disomogenea; colore: Munsell 5YR 3/1. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Mancante di parte dell’orlo. Tipo H.290.B.6. Dalla terra di riempimento del corridoio di accesso: n. 5 (Tav. 39, 5): olla in ceramica d’impasto. Diam. orlo 23; alt. max. cons. 6.6. Impasto duro, poroso con frequenti vacuoli distribuiti in manirea omogenea, frattura frastagliata, con frequenti inclusi di piccole e medie dimensioni; colore: Munsell 2.5YR 3/6. Superficie liscia. Frammentaria. Tipo A.40.B.12. Tomba 158 (Saggio C; Tav. 5, manca la planimetria di dettaglio). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso est-ovest (lungh. 200; largh. 85). L’evidenza si estende in buona parte oltre il limite occidentale del Saggio C e non è stata pertanto scavata.
n. 1 (Tav. 39, 3): poculum in ceramica depurata acroma. Diam. orlo 8.1; alt. 7.3. Impasto tenero, compatto, frattura irregolare, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti n maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 7/4. Probabilmente il vaso era verniciato con un pigmento molto diluito, come attestano tracce molto labili. Superficie polverosa. Realizzato al tornio. Ricomposto da vari frammenti. Tipo D.190.1.
Tomba 159 (Saggio D; Tavv. 6, 14). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso sud-est/nord-ovest (lungh. 160; largh. 48; prof. 78), tagliata dalla tomba 146 in corrispondenza del suo angolo nordoccidentale (vedi, 228-229). Presenta sul lato lungo sud-occidentale una nicchia di forma trapezoidale, ricavata a circa 70 dal piano di deposizione, nella quale è alloggiato il ripostiglio (largh. 38; prof. 15). Lungo il lato occidentale sono allineate alcune pietre di medie dimensioni. La deposizione è in pessimo stato di conservazione. Dati antropologici. L’inumato è un sub-adulto di circa 2-3 anni. Sono conservati frammenti di
n. 2 (Tav. 39, 1): brocchetta piriforme in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 4.8; alt. 12.2. Impasto duro, privo di inclusi; colore: Munsell 7.5YR 8/4. Vernice opaca con colature al fondo del vaso e sul piede; colore: Munsell 2.5YR 2.5/0. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.110.1. n. 3 (Tav. 39, 4): coppetta a profilo globulare in 236
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
S.30.A.1.
cranio, denti decidui e permanenti in formazione, elementi della colonna vertebrale, e una diafisi di clavicola. Dati archeologici. Il corredo si compone di una fibula in bronzo rinvenuta al centro della fossa (n. 4); di un’armilla in bronzo (n. 5) e una coppetta in ceramica a vernice nera (n. 1) poste in corrispondenza del lato di fondo settentrionale della fossa. Il ripostiglio è composto da un’olla in ceramica comune, contenente uno skyphos in ceramica a vernice nera (nn. 2-3). Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Fine IV-prima metà III secolo a.C.
Tomba 160 (Saggio D; Tavv. 6, 143). Sepoltura ad incinerazione realizzata in una fossa di forma irregolarmente rettangolare, orientata in senso nord-est/sud-ovest (lungh. 190; largh. 95; prof. media 39), localizzata nel settore sud-occidentale del Saggio D. È tagliata nella terra di riempimento del corridoio di accesso della tomba 190 e taglia la tomba 162 (vedi, 238, 263-266). L’evidenza al momento dello scavo risultava pesantemente danneggiata da interventi post-deposizionali. Nel riempimento si rinvengono pochi frammenti di ossa umane con evidenti tracce di combustione. Dati antropologici. I resti dell’individuo della tomba in esame non risultano presenti in deposito quindi non disponibili all’analisi. Dati archeologici. Presso il suo margine meridionale si rinvengono un coperchio (n. 3), un’olletta (n. 2) e un’anforetta (n. 1) in ceramica comune. Nel riempimento si recuperano frammenti di un balsamario e di una lucerna (non documentati) e sette i in ferro (n. 4). La presenza del coperchio ha fatto ipotizzare l’originaria presenza di un’olla destinata ad accogliere le ceneri del defunto, forse danneggiata dai lavori agricoli. Al contrario, è possibile che i chiodi in ferro siano da riferire a una cassetta lignea destinata a contenere i materiali del corredo. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. I secolo d.C.
n. 1 (Tav. 39, 7): coppetta a profilo globulare in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 13.4; alt. 5.8. Impasto duro, compatto, frattura regolare, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 8/3. Vernice solo parzialmente conservata; colore: Munsell 2.5YR 2.5/0. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Manca di parte dell’orlo. Tipo H.260.A.2. n. 2 (Tav. 39, 6): skyphos a profilo sinuoso in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 9.6; alt. 11.5. Impasto duro, compatto, frattura regolare, privo di inclsusi; Munsell 5YR 7/6. Vernice omogenea e lucente; colore: Munsell 2.5YR 2.5/0. Superficie liscia. Realizzato al tornio. Mancante di un’ansa. Tipo H.280.3. n. 3 (Tav. 39, 10): olletta globulare in ceramica comune. Diam. orlo 13.6; alt. 21. Impasto tenero, poroso con rari vacuoli distribuiti in maniera omogenea, con frequenti inclusi di piccole dimensioni; colore: Munsell 10R 5/8. Superficie ruvida. Realizzata al tornio. Ricomposta da vari frammenti. Tipo I.50.A.2.
n. 1 (Tav. 39, 13): anforetta ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 7; alt. 18. Impasto duro, compatto, frattura regolare, privo di inclusi; colore: Munsell 5YR 6/8. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Ricomposta da vari frammenti. Tipo I.20.3. n. 2 (Tav. 39, 12): olletta ovoide/piriforme in ceramica comune. Diam. orlo 5.5; alt. 9. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con abbondanti inclusi di piccole e medie dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell:10YR 4/1. Superficie ruvida. Realizzata al tornio. Parzialmente ricomposta da vari frammenti. Tipo I.50.B.15, varietà c.
n. 4 (Tav. 39, 9): fibula in bronzo con arco a losanga e molla bilaterale. Lungh. max. cons. 4; alt. 2.2. Patina verde sulla superficie. Mancante di parte dell’arco e della staffa. Tipo S.A.20.9. n. 5 (Tav. 39, 8): armilla in bronzo a capi sovrapposti. Diam. 5.4; spessore verga 0.9. Patina verde sulla superficie. Integra. Sulle estremità si conserva una decorazione a solcature oblique e longitudinali incisa. Tipo
n. 3 (Tav. 39, 11): coperchio in ceramica 237
Capestrano, I
doppia ondulazione. Lungh. max. cons. 3.3; alt. max. cons. 6.2. Superficie corrosa e ossidata. Si conservano l’arco e parte dell’ago. Sull’arco è presente un’ageminatura in bronzo. Tipo S.20.B.2.
comune. Diam. orlo 17.6; alt. 5.5. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con abbondanti inclusi di piccole e medie dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell:tra 5YR 5/6-8 e 2.5YR 3/0. Superficie ruvida. Tracce scure di cottura sull’intera superficie. Realizzato a mano. Ricomposto da vari frammenti. Tipo I.300.5.
Tomba 162 (Saggio D; Tav. 6, manca la planimetria di dettaglio). Sepoltura a inumazione in fossa di forma rettangolare, orientata lungo l’asse nord-est/sudovest (lungh. max. cons. 80; largh. 30), localizzata nel settore sud-occidentale del Saggio D. È disturbata profondamente nella sua porzione meridionale dall’impianto della tomba 160 e taglia il riempimento del corridoio di accesso della 190 (vedi, 237-238, 263-266). Dati antropologici. Si recuperano pochi frammenti di cranio e di ossa, la maggior parte non determinabili. Alcuni elementi dentari decidui e permanenti in formazione permettono di capire che l’inumato era un sub-adulto morto all’età di circa 9 mesi. Dati archeologici. All’interno della tomba si rinvengono solo tre anelli in oro pertinenti probabilmente al corredo (nn. 1-2). Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico: l’unico elemento utilizzabile al fine di una datazione è l’anteriorità della sepoltura rispetto alla tomba 160.
n. 4 (Tav. 39, 14): sette chiodi in ferro. Diam. testa max. 3; min. 1.4; lungh. max. 4.6; min. 3.6. Superficie corrosa e ossidata. Quasi tutti gli esemplari sono frammentari. Tipo Q.110.2. Tomba 161 (Saggio D; Tavv. 6, 15). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata secondo l’asse sud-nord (lungh. 156; largh. 70; prof. 95), localizzata nella zona sudorientale del Saggio D. La fossa è disturbata parzialmente dalla tomba a incinerazione 140 e taglia a sud la tomba 166 (vedi 223, 241-242). Il piano di inumazione è lievemente inclinato da ovest a est e vi si conservano tracce di una piccola cassa lignea (lungh. 85; largh. 30), delimitata da pietre di medie e grandi dimensioni. Al momento dello scavo, si rinvenivano solo frammenti di ossa lunghe. Dati antropologici. Gli scarsissimi resti ossei conservati non consentono di proporre considerazioni sui caratteri biologici dell’inumato. Dati archeologici. Il corredo è composto da frammenti di due fibule in ferro (nn. 1-2), rinvenuti all’interno del contenitore ligneo. Il sesso archeologico non è definibile. Inquadramento cronologico: il rapporto di posteriorità rispetto alla tomba 166, ascrivibile al periodo tardo-arcaico e di anteriorità rispetto alla tomba 140 di età imperiale, indica una datazione ampia per l’evidenza in esame, pur se la presenza della fibula n. 1 sembra restringere tale arco cronologico all’età ellenistica.
n. 1 (Tav. 40, 3): due anelli in oro con verga sottile, capo avvolto a cappio e fissato da un bottoncino. Diam. 1.2; spessore 0.1. Integri. Tipo S.40.A.2. n. 2 (Tav. 40, 4): anello in oro a fascia e forma rettangolare. Diam. 1.2; larg. 0.4. Integro. Presenta applicato sulla superficie un motivo plastico rappresentante un fallo Tipo S.40.A.5. Tomba 163 (Saggio C; Tavv. 6, 16). Tomba ipogeica “a grotticella” con corridoio d’accesso semplice, localizzata presso il margine sud-occidentale del Saggio C. L’accesso al corridoio e l’angolo occidentale della camera non sono stati indagati, trovandosi al di sotto del limite del saggio di scavo. La struttura taglia la tomba 107: nella terra di riempimento del corridoio, infatti, si rinvengono frammenti di cranio di infante, provenienti
n. 1 (Tav. 40, 1): fibula in ferro ad arco semplice. Lungh. max. cons. 5.9; alt. max. cons. 1.8. Superficie corrosa e ossidata. Si conservano tre frammenti, tra cui la staffa e parte della molla. Probabilmente ascrivibile al Tipo S.20.A.4, varietà a. n. 2 (Tav. 40, 2): fibula in ferro con arco a 238
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
pessime condizioni di conservazione (n. 4, non documentata). Nell’area antistante l’accesso alla camera, si rinviene un’olla in ceramica comune (n. 3), contenente uno skyphos in ceramica a vernice nera (n. 2). Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Seconda metà IIIprima metà II secolo a.C.
plausibilmente da tale evidenza (vedi, 205). La camera funeraria, orientata in senso ovest-est, presenta pianta pressoché rettangolare (lungh. max. 176; largh. 125); la volta e parte delle pareti risultano crollate al momento dello scavo e il suo margine nord-occidentale è in parte asportato da una trincea realizzata in corso scavo. Si conserva una banchina di deposizione ricavata nel banco geologico (lungh. 176; largh. 83; prof. 67), sulla quale sono deposti il defunto e parte del corredo. L’area antistante l’ingresso del corridoio di accesso, risulta complanare a quest’ultimo. L’accesso è segnato da un restringimento di circa 55 di larghezza, segnato da stipiti laterali. A ridosso di quello occidentale, si rinvengono due pietre di grandi dimensioni allineate in senso est-ovest, probabilmente utilizzate per addossarvi la tavola di chiusura della camera. Contrariamente alle altre tombe dello stesso tipo rinvenute nell’area, mancano resti di decomposizione di tali elementi e i chiodi in ferro utilizzati per il fissaggio. Il corridoio di accesso, orientato in senso nord-sud (lungh. max. cons. 150; largh. max. 72; largh. min. 67; prof. max. 115; prof. min. 104) è caratterizzato da un piano inclinato continuo e sembra aver subito rifacimenti in seguito all’asporto di buona parte dei lati occidentale e meridionale. La deposizione è dorsale, primaria e nello spazio vuoto, con il cranio orientato a nord-ovest e gli arti superiori e inferiori distesi. Sulla base della rotazione laterale di 180° del cranio, è possibile ipotizzare l’originaria presenza di un supporto sottostante in materiale deperibile, decomposto nel corso del tempo. Dati antropologici. L’inumato è un adulto di sesso maschile anziano di oltre 45 anni. La determinazione del sesso è basata sull’osservazione dei caratteri sessuali secondari del cranio. Una porzione di calotta cranica mostra la completa ossificazione della sutura sagittale. La diffusa edentulia dei denti giugali sia nel lato destro che sinistro della mandibola lascia ipotizzare si tratti un individuo anziano di oltre 45 anni. Dati archeologici. Il corredo è composto da una fibula in ferro frammentaria posta sullo sterno (n. 5); una coppetta in ceramica a vernice nera, tra le diafisi prossimali delle tibie (n. 1); un’olletta in ceramica comune tra i piedi, in
n. 1 (Tav. 40, 7): coppetta a profilo globulare in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 11; alt. 4.8. Impasto duro, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 8/2-8/4. Vernice poco conservata opaca; colore: Munsell 10YR tra 4/1 e 2/1. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.260.A.8. n. 2 (Tav. 40, 5): skyphos a profilo troncoconico in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 12.8; alt. 14.4. Impasto duro, privo di inclusi; colore: Munsell 5YR 7/3. Vernice parzialmente abrasa; colore Munsell 2.5YR 3/0. Superficie polverosa. Il fondo reca una X impressa nella parte centrale. Realizzato al tornio. Integro. Tipo H.280.5. n. 3 (Tav. 40, 8): olla globulare in ceramica comune. Diam. orlo 14.4; alt. 27. Impasto duro, con abbondandti inclusi di piccole e medie dimensioni; colore: Munsell 7.5YR 6/6. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo I.40.3. n. 4: frammenti di parete attribuibili a un’olletta in ceramica comune. Impasto duro, compatto, frattura frastagliata; con abbondanti inclusi di piccole e medie dimensioni. Tipo non puntualizzabile. n. 5 (Tav. 40, 6): fibula in ferro con arco semplice a tutto sesto, ampio e assottigliato. Lungh. 6.6; alt. 3.4. Superficie corrosa e ossidata. Parzialmente ricomposta da vari frammenti. Tipo S.20.A.4, varietà b. Tomba 164 (Saggio D; Tavv. 6, 15). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso sud-est/nord-ovest (lungh. 150; largh. 52; prof. 60), localizzata nell’area nord-orientale del Saggio D. Presenta una nicchia semicircolare ricavata lungo il lato 239
Capestrano, I
I.60.1.
meridionale (largh. 53; prof. 36), funzionale all’alloggiamento del ripostiglio. Il piano di inumazione è caratterizzato da un dislivello centrale di forma rettangolare delimitato da pietre di piccole dimensioni, all’interno del quale è realizzata la deposizione. Dati antropologici. In corso di scavo sono segnalati solo minuti frammenti del cranio, non raccolti. Dati archeologici. Il corredo, contenuto all’interno del dislivello centrale, è composto da un poculum in ceramica comune (n. 4); una coppetta e una pisside in ceramica a vernice nera (nn. 1-2), concentrati presso il margine nord-occidentale. Il ripostiglio è composto da un’olla in ceramica comune (n. 3), all’interno della quale è deposto un altro poculum della stessa classe (n. 5). Il sesso archeologico non è determinabile; le dimensioni della fossa ne suggeriscono l’attribuzione a un individuo infantile. Inquadramento cronologico. Seconda metà III secolo a.C.
n. 4 (Tav. 40, 10): poculum in ceramica comune. Diam. orlo 8.4; alt. 9.7. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con frequenti inclusi di piccole e medie dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10YR 7/4. Superficie ruvida. Realizzato al tornio. Ricomposto da vari frammenti. Tipo I.190.2, varietà a. n. 5 (Tav. 40, 13): poculum in ceramica comune. Diam. orlo 6.2; alt. 7.5. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con frequenti inclusi di piccole e medie dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10YR 7/4. Superficie ruvida. Realizzato al tornio. Mancante di parte del labbro. Tipo I.190.2, varietà a. Tomba 165 (Saggio D; Tavv. 6, 15). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso sud-est/nord-ovest (lungh. 98; largh. 40; prof. 121), nella porzione sudorientale del Saggio D; taglia le tombe 152 e 166 (vedi, 232-233, 241-242). Lungo il lato meridionale della fossa è ricavata una nicchia di forma semicircolare scavata a circa 60 dal piano di deposizione nel lato lungo meridionale (largh. 34; prof. 18), funzionale all’alloggiamento del ripostiglio. Della deposizione, riferibile a un individuo subadulto, si conservano solo pochi frammenti ossei, delimitati a nord-est da un accumulo di spezzoni litici di grandi dimensioni. Dati antropologici. Gli scarsissimi resti ossei conservati non consentono di proporre considerazioni sui caratteri biologici dell’inumato. Dati archeologici. Il corredo è composto da una coppetta in ceramica a vernice nera, posta al centro del piano di deposizione (n. 1). Il ripostiglio è composto da un’olletta biansata (n. 2) contenente un kantharos (n. 3), ambedue in ceramica comune. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Fine IV-primi decenni III secolo a.C.
n. 1 (Tav. 40, 11): coppetta a profilo globulare in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 11.2; alt. 5. Impasto tenero, poroso con radi vacuoli distribuiti in maniera omogenea, frattura irregolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 10YR 8/3. Vernice semilucida; colore: Munsell 2.5YR 2.5/0; mancante sul piede. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Manca di parte dell’orlo. Tipo H.260.A.9. n. 2 (Tav. 40, 12): coppetta miniaturistica a profilo globulare in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 2.6; alt. 2.8. Impasto duro, privo di inclusi; colore: Munsell 7.5YR 8/2. Vernice opaca e disomogenea; colore: Munsell 7.5YR tra 3.5 e 2.5; presente solo fino all’orlo. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integro. Tipo H.260.A.14. n. 3 (Tav. 40, 9): olla biansata globulare in ceramica comune. Diam. orlo 14.8; alt. 24.5. Impasto duro, compatto, frattura frastagliata, con frequenti inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10YR 7/6. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Ricomposta da vari frammenti. Tipo
n. 1 (Tav. 41, 1): coppetta a profilo globulare in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 7.8; alt. 4.2. 240
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
punta di lancia a est del cranio e all’esterno della cassa lignea, deposta con la punta rivolta verso l’alto (n. 6); all’interno della cassa, due spiedi in condizioni frammentarie sono allineati lungo il fianco destro del defunto (n. 3); frammenti di ferro probabilmente pertinenti a una fibula si trovano presso il fianco sinistro; una fibula si trova presso il femore sinistro (n. 5) e un’olletta in impasto in corrispondenza dei piedi (n. 2), nei pressi è stata rilevata la presenza di semi. Il ripostiglio è composto da un’olla in impasto (n. 1) contenente elementi frammentari in lamina di bronzo, forse pertinenti a un cinturone (n. 4). Il corredo consente una determinazione del sesso archeologico come maschile. Inquadramento cronologico. Ultimo quarto VIprima metà V secolo a.C.
Impasto tenero, compatto, frattura regolare, privo di inclusi; colore: Munsell 5YR 8/3. Vernice opaca, evanide; colore: Munsell 5YR 2.5/1. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Frammentario in corrispondenza dell’orlo. Tipo H.260.A.10. n. 2 (Tav. 41, 3): olletta biansata globulare in ceramica comune. Diam. orlo 11.6; alt. 18.2. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con frequenti inclusi di piccole e medie dimensioni; colore: Munsell 5YR tra 5/8 e 8/2. Superficie ruvida. Deformata a causa di difetti nell’esecuzione e di cottura. Realizzata a mano. Frammentaria in corrispondenza di una delle due anse. Tipo I.70.1. n. 3 (Tav. 41, 2): kantharos miniaturistico a profilo globulare in ceramica comune. Diam. orlo 6; alt. 5.4. Impasto duro; colore: Munsell 5YR tra 7/1 e 5/8. Superficie liscia, con aloni di cottura. Realizzato al tornio. Integro. Tipo I.210.1.
n. 1 (Tav. 41, 9): olla globulare in impasto grezzo. Diam. orlo 23.8; alt. 39.2. Impasto duro, con frequenti inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 5YR tra 5.5/8 e 5YR 5/6. Superficie liscia. Realizzato a mano. Integro. Tipo A.40.B.11.
Tomba 166 (Saggio D; Tavv. 6, 15). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso sud-est/nord-ovest (lungh. 273; largh. 100; prof. 286), localizzata nell’area sud-orientale del Saggio D. L’evidenza è disturbata dalle tombe 161 e 165 (vedi, 238, 240-241). Sul fondo della fossa si registrano tracce di decomposizione riferibili a una cassa lignea; presso l’angolo settentrionale della fossa, è deposto il ripostiglio, protetto da pietre di medie dimensioni. La deposizione, all’interno della cassa, è dorsale, primaria e nello spazio vuoto, con gli arti distesi e il cranio orientato a sud-est. Ai piedi del defunto si rinvengono due denti appartenenti ad un altro individuo, forse provenienti dallo sconvolgimento di una tomba più antica. Dati antropologici. Alcuni frammenti di cranio e le diafisi degli arti superiori e inferiori appartengono a un individuo adulto. Limitatamente alla osservazione di un frammento di osso craniale frontale con glabella marcata e dello stato avanzato di ossificazione delle suture craniali, è possibile ipotizzare che l’inumato fosse un individuo maschile di età matura. Dati archeologici. Il corredo si compone di una
n. 2 (Tav. 41, 8): olletta globulare in impasto grezzo. Diam. orlo 18; alt. 20.4. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con frequenti inclusi di medie e grandi dimensioni; colore: Munsell 2.5YR 4/8. Superficie liscia. Realizzata a mano, si conservano tracce di steccatura. Lacunosa in corrispondenza del fondo. Tipo A.50.B.1. n. 3 (Tav. 41, 4): frammenti appartenenti ad almeno due spiedi in ferro con testa a ricciolo. Lungh. 46 e 4.7; 24.4 e 16.9; spessore stelo 1.2. Superfici corrose e ossidate. Tipo Q.60.1. n. 4 (Tav. 41, 7): elemento in lamina di bronzo probabilmente identificabile come una placca di cinturone ripiegata, con due chiodini in bronzo inseriti in fori passanti. Largh. 2.8; lungh. 3. Patina verde in superficie. Frammentario. Tipo S.10.3. n. 5 (Tav. 41, 6): fibula in ferro con arco semplice a tutto sesto. Lungh. max. ric. 7; alt. 3. Superficie corrosa e ossidata; si conserva un 241
Capestrano, I
meridionale, si rinviene una coppetta in ceramica a vernice nera (n. 2); una coppa in ceramica a vernice nera e un’olletta in ceramica comune si trovano nell’angolo occidentale della fossa (nn. 1 e 5). Il ripostiglio si compone di un’olla in ceramica comune, contenente uno skyphos in ceramica a vernice nera (nn. 3-4). Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Prima metà II secolo a.C.
lembo di tessuto sull’arco, mineralizzato per effetto dell’ossidazione. Parzialmente ricomposta. Tipo S.20.A.3. n. 6 (Tav. 41, 5): punta di lancia in ferro. Lungh. 30; Lama: largh. max. 3.5; spessore max. 0.56; cannone: lungh. 14; diam. 2.3. Superficie corrosa e ossidata. Integra. Tipo T.40.5. Tomba 167 (Saggio D; Tavv. 6, 16). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso sud-est/nord-ovest (lungh. 260; largh. 85; prof. 191), localizzata nell’area centrale del Saggio D. Sul lato lungo meridionale, a circa 70 dal piano di deposizione, è ricavata una nicchia semicircolare (largh. 65; prof. 32) nella quale è alloggiato il ripostiglio. Sul piano di fondo della fossa si conservano tracce della cassa lignea. Al suo interno, la deposizione è dorsale, primaria e in spazio vuoto, con gli arti superiori e inferiori distesi e il capo a sud-est, l’arto superiore destro è rivolto verso il bacino. Dati antropologici. I resti umani appartengono a un individuo adulto femminile di 25-29 anni. Lo stato di conservazione è discreto e sono presenti i distretti scheletrici principali: colonna vertebrale e coste, diafisi degli arti superiori e inferiori, mani. La determinazione del sesso è basata sull’osservazione dei caratteri sessuali secondari di cranio e bacino. L’età alla morte può essere stimata a partire dall’osservazione dell’aspetto della superficie auricolare dell’ileo che corrisponde a età giovane-adulta di 25-29 anni, come conferma anche una usura limitata degli elementi dentari (17-25 anni) e l’assenza di ossificazione delle suture craniche. Inoltre questo individuo presenta, nell’ambito della normale variabilità umana, una caratteristica antropologica di tipo discontinuo, già rilevata in diversi casi in questa necropoli. Si tratta della presenza nel cranio di ossa soprannumerarie (wormiane) localizzate lungo la sutura lambdoidea, di cui in questo caso due inferiormente a sinistra e quattro inferiormente a destra (lambdoidee). Dati archeologici. Il corredo è composto da un’armilla in bronzo infilata all’arto superiore destro (n. 7); una fibula in ferro posta all’altezza del torace (n. 6); lungo il lato
n. 1 (Tav. 42, 4): coppa a profilo globulare in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 18; alt. 6.9. Impasto tenero, compatto, frattura regolare, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR tra 8/3 e 8/4. Vernice opaca, quasi completamente evanide; colore: Munsell 10YR 4/1. Superficie polverosa. Impronte d’immersione in prossimità del piede. Realizzata al tornio. Ricomposta da vari frammenti. Tipo H.240.A.12. n. 2 (Tav. 42, 5): coppetta a profilo globulare in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 11; alt. 5.4. Impasto duro, privo di inclusi; colore: Munsell 7.5YR 8/4. Vernice lucida, omogenea; colore: Munsell 7.5YR 3/0. Superficie liscia. Impronte d’immersione sul piede. Realizzata al tornio. Piccola frattura sull’orlo. Integro. Tipo H.260.A.9. n. 3 (Tav. 42, 1): skyphos a profilo troncoconico in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 11.4; alt. 13.8. Impasto duro, compattp, frattura netta, privo di inclusi; colore: Munsell 7.5YR 6/6. Vernice lucida, omogenea; colore: Munsell 7.5YR. Superficie liscia. Impronte d’immersione tra il piede e la vasca. Realizzata al tornio. Presenta una lacuna in corrispondenza dell’orlo. Tipo H.280.6. n. 4 (Tav. 42, 7): olla globulare in ceramica comune. Diam. orlo 17.4; alt. 34.6. Impasto duro, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 5YR tra 7/6 e 2.5YR 5/6. Presenta una deformazione all’attaccatura della spalla verificatasi durante la cottura. Realizzata al tornio. Integra. Tipo I.40.5. n. 5 (Tav. 42, 6): olletta ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 8.5; alt. 9. Impasto duro, 242
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
Dati antropologici. I resti umani appartengono a un individuo adulto maschile di 40-44 anni. Lo scheletro è in buono stato di conservazione e integralmente conservato. Il cranio e il bacino presentano caratteristiche morfologiche maschili. L’età alla morte può essere stimata a partire dalla osservazione dell’aspetto della sinfisi pubica, corrispondente a una età alla morte in media di 45.6 anni in un range tra 35 e 56, a cui si aggiunge la valutazione della superficie auricolare dell’ileo compatibile con una età tra 40 - 44 anni. L’età matura è confermata anche dalla perdita antemortem del primo molare destro mandibolare (fig.antr.online 168_01) e del primo e secondo molari sinistri mascellari i cui alveoli sono in avanzato stato di riassorbimento osseo e dalla grave usura degli altri denti molari. Questo individuo presenta una serie di anomalie scheletriche tra le più significative dell’intera necropoli. La più interessante di queste anomale tracce osteologiche è localizzata nella cassa toracica, su due frammenti di coste del lato destro (fig.antr.online 168_02A,B,C,D,E,F,G). Si individua una area di proliferazione di tessuto osseo circoscritta ad un tratto di 5 cm presso l’angolo costale e principalmente localizzata al margine superiore e inferiore, di cui segue l’andamento, con un lieve coinvolgimento della superficie dorsale. La superficie del tessuto osseo proliferativo in alcune aree è ancora poroso, ma il diffuso aspetto compatto indica che la lesione è consolidata ed in avanzato stadio di rimodellamento. A causa dello stato di conservazione frammentario, la diagnosi è difficile. La localizzazione, la morfologia e le caratteristiche macroscopiche lasciano ipotizzare che la paleopatologia sia conseguenza di un episodio traumatico. Infatti l’andamento di questa metaplasia potrebbe essere correlata agli effetti di un disturbo circolatorio ovvero a un rimodellamento posttraumatico con ossificazione di un ematoma. Al momento sono da escludersi patologie infettive o neoplastiche, varianti anatomiche, manifestazioni carenziali. Non ci sono manifestazioni paleopatologiche su sterno o su altri elementi della cassa toracica. Ulteriori anomalie appartenenti alla categoria denominata “entesopatie/sindesmopatie” sono
con rari inclusi di medie dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 5YR tra 3/1e 6/6. Realizzata al tornio. Integra. Tipo I.50.B.9, varietà a. n. 6 (Tav. 42, 2): fibula in ferro con piccolo arco semplice a tutto sesto. Lungh. 5.5; alt. 3.5. Superficie corrosa e ossidata. Integra. Si conservano lembi di tessuto. Tipo S.20.A.4, varietà a. n. 7 (Tav. 42, 3): armilla in bronzo con estrmità aperte e avvolte alla verga da spirale a sei giri. Diam. 7.2; spessore verga 0.3; spessore fascetta 0.15. Patina verde in superficie. Ricomposto. Tipo S.30.A.4. Tomba 168 (Saggio D; Tavv. 6, 18). Tomba ipogeica “a grotticella” con corridoio di accesso a scalini, localizzata nella porzione nord-occidentale del Saggio D. La camera, orientata in senso sud-est/nord-ovest, presenta pianta irregolarmente rettangolare (largh. 160; lungh. 220; prof. 179), con pareti verticali e volta piana, parzialmente crollata, prive di soluzioni nette di continuità. Il piano della camera è orizzontale e lievemente più profondo rispetto all’accesso, orientato a sud-ovest e segnato dal restringimento dei due battenti laterali, con una luce di 92. Il corridoio di accesso (lungh. 280; largh. 107; prof. max. 130; prof. min. 35) è orientato in senso nord-est/sudovest ed è caratterizzato da cinque gradini tagliati nel banco geologico al suo ingresso, alti tra 35 e 20; i gradini danno accesso a un tratto piano antistante la camera, solo lievemente inclinato. Non sono presenti tracce di materiale organico decomposto sulla soglia di accesso alla camera, ascrivibili a una chiusura in legno, come si è verificato negli altri casi di tombe ipogeiche attestati nell’area di scavo. La deposizione è dorsale, primaria e nello spazio vuoto ed è realizzata direttamente sul piano di fondo della camera. Il cranio si rinviene a circa 20 dalla sua posizione originaria: tale spostamento è forse dovuto al crollo della volta dopo la deposizione o, anche, alla presenza originaria di un supporto in materiale deperibile sotto la testa; l’arto superiore destro è piegato verso il sinistro che, invece, è disteso lungo il corpo; gli arti inferiori sono distesi. 243
Capestrano, I
localizzate presso l’epifisi prossimale delle clavicole destra e sinistra e sull’epifisi prossimale dell’ulna destra. La prima è di lieve entità ed è riconducibile a sindesmopatia bilaterale del legamento costo clavicolare che si altera per stress occupazionali ed infatti può essere simmetrica, come in questo caso, o asimmetrica, a seconda dell’uso di entrambi gli arti o sovraccarico monolaterale. Invece nel secondo caso si tratta di un entesofita all’olecrano in corrispondenza dell’inserzione del muscolo tricipite brachiale sull’ulna destra (fig.antr.online 168_03A,B), all’origine del quale vi è un sovraccarico e una ripetuta attività impegnativa con l’utilizzo del braccio con un ripetuto movimento di flessione-estensione, per esempio nell’attività di taglialegna o fabbro. Una addizionale traccia di sofferenza dell’arto superiore destro è osservabile nell’andamento anomalo della diafisi del radio che si può ipotizzare sia stata causata da un evento traumatico il cui esito sia una frattura composta che, dall’analisi macroscopica, è della tipologia detta “frattura incompleta a legno verde” (fig.antr.online 168_04A,B,C,D,E). Infine, a completamento del quadro paleopatologico, osservando la colonna vertebrale si rilevano i segni di anomalie scheletriche imputabili a osteoartrosi. Questi sono localizzati sulla seconda vertebra cervicale, in particolare dove l’area di articolazione del dente dell’epistrofeo presenta una proliferazione della lunghezza di circa 3 mm (fig.antr.online 168_05), sulle vertebre toraciche con lievi becchi osteofitici e noduli di Schmorl, in particolare la T12 (fig.antr.online 168_06), e soprattutto nel tratto lombare dove si segnala la grave anchilosi che coinvolge L1,L2,L3 (fig.antr.online 168_07A,B,C,D). In quest’ultimo caso, si può descrivere come una esostosi marginale alla circonferenza dei corpi vertebrali, in ambito medico definita anche anchilosi per sindesmofitosi, in ambito paleopatologico ricondotta all’ampia categoria dei fenomeni di osteoartrosi. Sul sacro non vi sono anomalie. Da questo contesto provengono almeno 25 elementi dentari singolarmente raccolti e attributi a livelli di “crollo della volta” e, in fase di analisi antropologica, non riconducibili al soggetto principale, ma a individui diversi. 244
Dati archeologici. Il corredo si compone di un piatto in ceramica a vernice nera all’esterno dell’arto superiore sinistro (n. 6); all’altezza del bacino, sul lato opposto, si rinviene il fondo di una forma non identificata in ceramica comune (n. 12). Nell’area compresa tra i piedi del defunto, il lato di fondo della camera e lo stipite occidentale, si distribuiscono un’olla in ceramica comune (n. 8); un piatto (n. 7) e una coppetta in ceramica a vernice nera (n. 3); un vaso tripodato in ceramica comune (n. 11); un’olletta in ceramica comune (n. 9); un chiodo in ferro (n. 14) uno skyphos in ceramica a vernice nera (n. 5); un’olletta in ceramica comune (n. 10); una coppetta in ceramica a vernice nera (n. 4); una coppa in ceramica a vernice nera (n. 2); una coppia di placchette e maglie di catenella in bronzo (n. 16); una lucerna in ceramica vernice nera (n. 13). Sulla soglia della camera, al limite con il corridoio di accesso, a ridosso della parete orientale, si rinvengono un piatto in ceramica a vernice nera (n. 18); nella terra di riempimento, un balsamario ceramico (n. 19) e una coppetta in ceramica a vernice nera (n. 17), ed un frammento di olla. A ridosso della parete orientale della camera si rinviene una lagynos in ceramica depurata acroma (n. 1); a nord-est dell’inumato, un chiodo in ferro (n. 15). Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Decenni finali IIprima metà I secolo a.C. n. 1 (Tav. 43, 1): lagynos in ceramica depurata acroma. Diam. orlo 8.4; alt. 34.2. Impasto duro, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 8/4. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Integra. Tipo D.120.4. n. 2 (Tav. 43, 17): coppa a profilo distinto in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 15.6; alt. 5.2. Impasto tenero, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 8/2. Vernice opaca e fortemente evanide, scarsamente conservata soprattutto sulla parete esterna; colore: Munsell 10YR 3/1. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.240.C.9. n. 3 (Tav. 43, 12): coppetta a profilo distinto in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 11; alt. 5.2. Impasto duro, compatto, frattura regolare, privo
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
integrata. Tipo I.50.B.9, varietà d.
di inclusi; colore: Munsell 10YR 8/4. Vernice opaca, evanide e presente su tutta la superficie; colore: Munsell 10YR 3/1. Realizzata al tornio. Integra, con scheggiatura sull’orlo. Tipo H.260.C.7.
n. 9 (Tav. 43, 6): olletta in ceramica comune. Diam. orlo 13; alt. 12.5. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con inclusi di piccole e medie dimensioni; colore: Munsell 2.5YR 4/2. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Ricomposta da vari frammenti. Tipo I.50.B.14, varietà b.
n. 4 (Tav. 43, 4): coppetta a fondo convesso in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 11; alt. 7. Impasto duro, privo di inclusi; colore: Munsell 7.5YR 8/4; vernice evanide, con ampi aloni di cottura; colore: Munsell 5YR 3/2. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.260.D.1.
n. 10 (Tav. 43, 9): olletta ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 8.6; alt. 9. Impasto duro, con frequenti inclusi di piccole e medie dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 5YR 5/8. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Integra. Tipo I.50.B.9, varietà e.
n. 5 (Tav. 43, 3): skyphos a profilo troncoconico in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 10.9; alt. 13.1. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10YR 8/2. Vernice opaca e fortemente evanide, conservata in minima parte in prossimità della vasca; colore: Munsell 10YR 3/2. Superficie liscia. Realizzato al tornio. Ricomposto. Tipo H.280.5.
n. 11 (Tav. 43, 19): vaso tripodato in ceramica comune. Diam. orlo 13.4; alt. 10.9. Impasto duro, con frequenti inclusi di medie e grandi dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 5YR 5.5/6. Superficie ruvida. Realizzato al tornio. Integro. Tipo I.310.1. n. 12 (Tav. 43, 18): fondo piano indistinto, attribuibile ad una forma chiusa, presumibilmente un’olletta, in ceramica comune. Diam. fondo 7; alt. 6. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con frequenti inclusi di piccole e medie dimensioni; colore: Munsell 5YR 4/4. Superficie ruvida. Tipo non puntualizzabile.
n. 6 (Tav. 43, 14): piatto a vasca troncoconica e labbro rientrante in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 16.7; alt. 3.6. Impasto duro, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 8/4. Vernice abbastanza omogenea presente su tutta la superficie, con impronte di immersione tra la vasca e il piede; colore: Munsell 7.5YR 2/0. Superficie liscia. Realizzato al tornio. Integro. Tipo H.290.B.10.
n. 13 (Tav. 43, 7): lucerna con serbatoio cilindrico in ceramica a vernice nera. Diam. vasca 5; alt. 3.7. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 7.5YR 6/6; vernice completamente assente. Superficie polverosa. Integro, con scheggiatura sull’orlo. Tipo M.A.2.
n. 7 (Tav. 43, 15): piatto a vasca troncoconica e labbro rientrante in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 19.8; alt. 4.4. Impasto duro, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 8/6. Vernice ben conservata, il fondo è risparmiato ma presenta tracce di colatura di vernice; colore: Munsell 5YR 2.5/1. Superficie liscia. Realizzato al tornio. Integro. Tipo H.290.B.4.
n. 14 (Tav. 43, 2): chiodo in ferro. Diam. testa 3.9; lungh. 8. Superficie corrosa e ossidata. Integro. Evidenti tracce di materiale organico (legno), probabilmente pertinente alla cassa lignea in cui era deposto il defunto. Tipo Q.110.1.
n. 8 (Tav. 43, 13): olletta ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 15.4; alt. 18.6. Impasto duro, poroso con radi vacuoli distribuiti in maniera omogenea, frattura frastagliata, con inclusi di medie e grandi dimensioni; colore: Munsell 5YR 4/6. Superficie ruvida. Realizzata al tornio. Ricomposta da vari frammenti e
n. 15 (Tav. 43, 11): chiodo in ferro. Diam. testa 245
Capestrano, I
137 (vedi, 221, 247-248, 253-254). Lungo il lato nord-orientale della fossa, a circa 30 dal piano di deposizione, è ricavata una nicchia scavata (largh. 65; prof. 30; alt. 35), nella quale è alloggiato il ripostiglio. Sul piano della fossa si conservano resti di una cassa lignea. La deposizione, all’interno della cassa, è dorsale, primaria e nello spazio vuoto; il cranio è rivolto a nord-ovest; gli arti superiori distesi lungo il torace e quelli inferiori distesi e allineati. Dati antropologici. Si conservano solo pochi frammenti di cranio, tra cui una porzione di occipitale e di temporale dalle caratteristiche femminili, con suture ancora ben visibili e pochi denti anteriori molto usurati. Allo stesso individuo adulto, probabilmente, possono forse essere attribuiti altri resti umani denominati “T 169 riempimento” che consistono in due frammenti di coste, schegge di ossa lunghe e diafisi degli arti superiori e inferiori. Dati archeologici. Il corredo, contenuto all’interno della cassa lignea, è composto da una coppa in ceramica a vernice nera deposta ai piedi dell’inumato (n. 1). Il ripostiglio è composto da un’olla in ceramica comune (n. 3), contenente a sua volta uno skyphos in ceramica a vernice nera (n. 2). Nella terra di riempimento si rinvengono una punta di lancia in ferro frammentaria (n. 4), due frammenti di ferro ed un frammento in bronzo, probabilmente provenienti dallo sconvolgimento di tombe più antiche. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Prima metà II secolo a.C.
3.9; lungh. 9.4. Superficie corrosa e ossidata. Evidenti tracce di materiale organico (tessuto e legno), probabilmente pertinente al sudario e alla cassa lignea in cui era deposto il defunto. Tipo Q.110.1. n. 16 (Tav. 43, 10): placchette e catenella in bronzo. Largh. max. placchetta conservata meglio 1.1; lungh.. della placchetta conservata meglio 3.9; lungh. max. della catenella 4.6. Patina verde sulla superficie. Reperti provenienti dal corridoio di accesso: n. 17 (Tav. 43, 5): coppetta a profilo distinto in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 5.5; alt. 5.2. Impasto tenero, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di piccole dimensioni; colore: Munsell 10 YR 8/3. Vernice evanide, opaca; colore: Munsell 2.5Y 4/0. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Mancante del piede. Tipo H.260.C.7. n. 18 (Tav. 43, 16): piatto in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 20.8; alt. 4.4. Impasto tenero, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di piccole dimensioni; colore: Munsell 10YR 8/3. Vernice evanide presente su tutta la superficie; colore: Munsell 7.5YR 3/0. Superficie polverosa Realizzato al tornio. Parzialmente ricomposto da vari frammenti. Sul fondo, presenta un’iscrizione graffita (presumibilmente CB). Tipo H.290.B.6. n. 19 (Tav. 43, 8): balsamario ceramico fusiforme. Diam. orlo 2.4; alt. 12.9. Impasto tenero, compatto, frattura regolare, privo di inclusi; colore: Munsell 7.5YR 7/6; labili tracce di vernice opaca sul collo; colore: Munsell 5YR 5/6. Superficie polverosa. Realizzato al tornio. Parzialmente ricomposto. Tipo N.130.1.
n. 1 (Tav. 44, 2): coppa a profilo distinto in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 18.8; alt. 6.7. Impasto duro, con sporadici inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10YR 8.5/4. Vernice mal conservata nel fondo interno e in parte della superficie esterna; colore: Munsell tra 10YR 8/1 e 5YR 5/8. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.240.C.2.
Tomba 169 (Saggio D; Tavv. 6, 16). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare orientata in senso nord-ovest/sud-est (lungh. 210 m; largh. 70; prof. 50), localizzata a ridosso del limite sud-orientale del Saggio D. Taglia il lato meridionale della tomba 170, quello orientale della 171, quello settentrionale della 178 e in parte l’angolo settentrionale della tomba 177; è inoltre disturbata dalla tomba
n. 2 (Tav. 44, 1): skyphos a profilo troncoconico in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 10.2; alt. 10.4. Impasto duro, privo di inclusi; colore: Munsell 7.5YR 8/4. Vernice poco compatta; colore: Munsell 7.5YR 3/2. Superficie liscia. 246
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
Inquadramento cronologico. metà/ltimo quarto VI secolo a.C.
Realizzato al tornio. Integro. Tipo H.280.5. n. 3 (Tav. 44, 3): olla globulare in ceramica comune. Diam. orlo 18.5; alt. 37. Impasto duro, con frequenti inclusi di piccole e medie dimensioni; colore: Munsell 5YR 6/6. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo I.40.3.
Seconda
n. 1 (Tav. 45, 6): dolio globulare in impasto grezzo. Diam. orlo 36; alt. 60. Impasto duro, poroso con frequenti vacuoli distribuiti in maniera omogenea, frattura frastagliata, con abbondanti inclusi di medie e grandi dimensioni; colore: Munsell: 2.5YR 4.5/6. Superficie liscia. Realizzato a mano. Ricomposto da vari frammenti. Tipo A.80.3.
n. 4 (Tav. 44, 4): punta di lancia in ferro (pilum). Lungh. max. cons. 37; largh. max. 4; spessore max. 0.8; diam. cannone 2.5. Superficie corrosa e ossidata. Lacunosa in corrispondenza delle due estremità. Tipo T.40.8.
n. 2 (Tav. 45, 1): oinochoe trilobata in impasto buccheroide. Diam. orlo 5.8; alt. 7. Impasto tenero, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell: 2.5YR 3.5/0. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Ricomposta da vari frammenti. Tipo B.100.2.
Tomba 170 (Saggio D; Tavv. 6, 17). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso sud-est/nord-ovest (lungh. 280; largh. 110; prof. 114), localizzata a ridosso del limite orientale del Saggio D. L’evidenza è disturbata dal taglio delle tombe 169 e 171 sul lato lungo occidentale e dalla tomba a camera 180 lungo quello opposto (vedi, 246-248, 255256). Sul piano di deposizione si conservano le tracce della decomposizione di una cassa lignea, delimitata a nord da un allineamento irregolare di pietre di medie dimensioni. La porzione esterna alla cassa, a ridosso del lato corto settentrionale, è occupata dal ripostiglio, protetto da un consistente accumulo di spezzoni litici. Dati antropologici. Lo scheletro è pessimo in stato di conservazione ed estremamente frammentario. Si tratta probabilmente di un individuo adulto di cui restano il primo e il secondo molare mascellare permanenti con usura limitata allo smalto e frammenti di epifisi distale di tibia con tracce di colore verde da contatto con oggetti metallici ossidati. Dati archeologici. Il corredo è composto da due fibule in ferro deposte probabilmente all’altezza del torace (nn. 5-6) e un’altra lungo il fianco destro (n. 4); un bacile in lamina bronzea è rinvenuto in corrispondenza dei piedi del defunto (n. 3). Il ripostiglio è composto da un’olla in impasto contenente una oinochoe in impasto buccheroide (nn. 1-2). Sulla base della mancanza delle armi e dell’inquadramento cronologico proposto, il sesso archeologico può essere determinato come femminile.
n. 3 (Tav. 45, 4): bacile a orlo perlinato con vasca a profilo svasato in lamina di bronzo. Diam. orlo 22 m; alt. 4.2. Patina verde in superficie. Parzialmente ricomposto. Tipo O.330.A.6. n. 4 (Tav. 45, 2): fibula in ferro ad arco semplice rialzato. Lungh. 6.5; alt. 2.8. Superficie corrosa e ossidata. Ricomponibile da tre frammenti. Tipo S.20.A.1, varietà a. n. 5 (Tav. 45, 3): fibula in ferro con arco a tripla ondulazione. Lungh. max. ric. 9.5; alt. max. ric. 5.4. Superficie corrosa e ossidata. Mancante di parte dell’arco e dell’ago. Probabilmente ascrivibile al Tipo S.20.B.4. n. 6 (Tav. 45, 5): fibula in ferro con arco a tripla ondulazione. Lungh. max. cons. 7.4; alt. 4. Superficie corrosa e ossidata. Mancante di parte della staffa. Probabilmente ascrivibile al Tipo S.20.B.4. Tomba 171 (Saggio D; Tavv. 6, 17). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso sud-est/nord-ovest (lungh. 230 ca; largh. 80 ca, prof. max. cons. 125), localizzata nel settore sud-orientale del Saggio D. Taglia la più antica tomba 170 ed è disturbata dalla sovrapposizione delle tombe 137 e 169 (vedi schede precedenti e, 221). La 247
Capestrano, I
conservano tracce steccatura. Integra. Tipo A.50.A.1.
cassa lignea utilizzata per contenere la deposizione si conserva addossata alla parete sud-occidentale; nell’angolo occidentale, si rinviene il ripostiglio protetto da pietre. La deposizione è dorsale, primaria e nello spazio vuoto, con l’arto superiore destro flesso sul bacino e quello sinistro disteso; gli arti inferiori sono distesi e i piedi uniti. Dati antropologici. L’inumato è un individuo adulto femminile di età tra 40 e 44 anni. Si conserva la parte superiore destra dello scheletro e l’intera parte inferiore, incluse le estremità degli arti. Lo stato di conservazione è molto frammentario e permette di rilevare caratteristiche sessuali femminili limitatamente all’incisura ischiatica del bacino e di determinare l’età dall’aspetto della superficie auricolare dell’ileo (40-44 anni) e della sinfisi pubica (38.2 nel range 27-49 anni). La statura può essere calcolata a partire dalla lunghezza massima della tibia destra (336 mm) e sinistra (337 mm) e risulta di 159 cm. Dati archeologici. Il corredo è composto da un’olletta in impasto deposta presso la tibia sinistra (n. 2); una fibula frammentaria in ferro (n. 4) si rinviene nella terra di riempimento della fossa, in corrispondenza dell’arto superiore sinistro. Il ripostiglio è costituito da un’olla in impasto, contenente una tazza carenata della stessa classe (nn. 1 e 3). Sulla base della mancanza delle armi e dell’inquadramento cronologico proposto, il sesso archeologico sembra individuabile come femminile. Inquadramento cronologico. VI secolo a.C.
n. 3 (Tav. 46, 1): tazza carenata in impasto grezzo. Diam. orlo 11.6; alt. 8.3. Impasto duro, con frequenti inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell: 5YR 3.5/1. Superficie liscia. Realizzata a mano, si conservano tracce di steccatura sulla superficie esterna. Integra. Tipo A.220.2. n. 4 (Tav. 46, 2): fibula in ferro con arco a tripla ondulazione. Lungh. max. cons. 5.4; alt. max. cons. 2.1. Superficie corrosa e ossidata. Mancante dell’ago e della staffa. Probabilmente ascrivibile al Tipo S.20.B.4. Tomba 172 (Saggio C; Tavv. 5, 19). Tomba ipogeica “a grotticella” con corridoio di accesso semplice, localizzata nell’angolo orientale del Saggio C. In corrispondenza del corridoio, taglia la tomba 142 (vedi, 224). La camera, orientata in senso nord-ovest/sud-est, presenta pianta rettangolare con angoli arrotondati (lungh. 205; largh. 80; prof. 183); la volta, parzialmente crollata e con andamento curvilineo, è senza soluzione di continuità rispetto alla parete. Il fondo è regolare e posto a circa 20 al di sopra del piano di accesso al corridoio, il quale risulta quindi distinto da un netto dislivello. L’ingresso, lungo il lato orientale della camera, con una luce di 103, è delimitato da due stipiti di circa 15 di larghezza. Il corridoio di accesso, orientato in senso nordest/sud-ovest, presenta piano continuo, leggermente inclinato e privo di gradoni (lungh. max. indagata 227; largh. 128; prof. max. 183; prof. min. 177). Al suo interno, a ridosso dell’apertura si rinvengono tre blocchi calcarei di grandi dimensioni la cui funzione è plausibilmente quella di chiudere una porta lignea, di cui si conservano i resti decomposti. Il gradino di accesso alla camera e il blocco calcareo più vicino all’ingresso sono caratterizzati da tracce di colore rosso, forse resti di un pigmento che poteva rivestire la parete interna della porta lignea. La deposizione è dorsale, primaria e nello spazio vuoto, con gli arti distesi e il cranio orientato a est. All’altezza del ventre, nel cinto pelvico della defunta, sono
n. 1 (Tav. 46, 4): olla globulare in impasto grezzo. Diam. orlo 22.1; alt. 35.2. Impasto duro, poroso con frequenti vacuoli distribuiti in maniera omogenea, frattura frastagliata, con inclusi di piccole e medie dimensioni; colore: Munsell 7.5YR 7.5/6. Superficie liscia. Realizzata a mano. Ricomposta da vari frammenti. Tipo A.40.B.16. n. 2 (Tav. 46, 3): olletta ovoide in impasto grezzo. Diam. orlo 13.8; alt. 19.7 Impasto duro, con frequenti inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell da 7.5YR 6.5/6 a 7.5YR 3.5/2. Superifcie liscia. Realizzata a mano, si 248
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
alcuni punti risultano quasi obliterati indicando un avanzato rimodellamento. Solitamente interpretati come prova di infezioni “nonspecifiche” la cui eziologia è varia e complessa ed include eventi traumatici, disturbi circolatori, patologie articolari, malattie ematologiche, displasie scheletriche, malattie infettive (micosi, sifilide, lebbra, ostemielite, tubercolosi), patologie metaboliche e neoplasie. Sebbene da interpretare con estrema attenzione e cautela, soprattutto in assenza di altre anomalie scheletriche correlabili a questa, in ogni caso la periostite è segno di una risposta infiammatoria in questo caso cronica. Inoltre questa donna presenta, nell’ambito della normale variabilità umana, alcune caratteristiche antropologiche di tipo discontinuo. Si tratta della presenza nel cranio di ossa soprannumerarie (wormiane) di cui due presenti lungo la sutura lambdoidea a destra (lambdoidee), e altre due lungo la sutura coronale bilateralmente a destra e a sinistra (coronali). A cui si aggiunge la doppia faccetta dell’articolazione astragalo-calcaneale anteriore visibile sul calcagno, una variabile non metrica di origine genetica (fig.antr.online 172_03). La statura risulta di 164.5 cm, calcolata dalla misura di lunghezza massima del femore sinistro (447 mm). All’interno del cinto pelvico della donna era presente lo scheletro integro e ben conservato di un sub-adulto perinatale, probabilmente neonato. L’analisi dell’amelogenesi dentaria e la misurazione della lunghezza sia degli arti superiori che inferiori permettono di determinare l’età alla 40a settimana di gestazione. La morfologia dell’ileo immaturo sembra maschile. Tra le ossa del cranio, lo sfenoide e la pars basilaris sono caratterizzati da una porosità anormale, consistente in piccoli fori (minori di 1 mm di diametro) che penetrano la superficie compatta accompagnati da piccole spicole di nuova formazione ossea (fig.antr.online 172feto_01,02,03). Si tratta di una anomalia scheletrica non specifica riconducibile a una patologia sistemica tra le cui cause vi può essere una condizione di anemia, carenza metabolica (scorbuto, rachitismo) o una infezione. Dati archeologici. Il corredo è composto da un’olletta in ceramica comune deposta tra la parete di fondo e l’arto superiore destro del
stati rinvenuti i resti di un feto. Infatti, come documentato in fase di scavo e confermato dai dati antropologici, la causa di morte è dovuta a complicazioni al termine della gravidanza, in particolare è molto probabile che sia avvenuta durante il parto o immediatamente dopo. Inoltre si rinvengono anche i resti di un animale, identificato come Sus domesticus Erxleben, sezionato in due porzioni e sepolto presso gli arti inferiori della defunta: il cranio con la parte anteriore del corpo a sud-est dell’inumato, parte degli arti inferiori a sud-ovest. Alcuni elementi vertebrali del suino recano traccia di segni di macellazione in senso sagittale. Dati antropologici. Lo scheletro dell’inumato è completo e ben conservato, il cranio è integro (fig.antr.online 172_01). I resti umani appartengono a un giovane individuo adulto femminile di 30-34 anni. La determinazione del sesso è confermata dall’osservazione dei caratteri sessuali secondari sia del cranio che del bacino, in quest’ultimo è ben marcato il solco preauricolare. L’età alla morte è giovane, infatti le suture craniche sono ben separate, la superficie auricolare mostra vestigia di billowing sostituite da strie (30-34 anni), le clavicole presentano estremità prossimali con maturazione scheletrica completa (oltre 30 anni). L’analisi paleopatologica rileva una importante anomalia nell’arto superiore sinistro presso la metafisi prossimale dell’omero (fig.antr.online 172_02A,B,C,D,E). Si tratta di una lieve deviazione di angolazione della testa dell’omero. Tale deformazione potrebbe avere una origine traumatica, a seguito di compressione (impattazione) oppure di lesione del collo omerale con conseguente accorciamento. Non sono presenti altre anomalie su questo elemento osseo. Gli arti inferiori non presentano anomalie, eccetto per la presenza sulla diafisi delle tibie e delle fibule di fini striature, cioè fini linee parallele dai margini netti di circa 1 mm di profondità parallele all’andamento assiale e compatibili con solchi vascolari di tessuto osseo neoformato. Si tratta di una anomalia superficiale della corticale priva di valore diagnostico specifico, denominata “periostite”. Questi fitti solchi hanno margini poco netti indicativi di una reazione non più attiva e in 249
Capestrano, I
n. 6 (Tav. 46, 9): balsamario ceramico fusiforme. Diam. orlo 2.4; alt. 24.4. Impasto duro, privo di inclusi; colore: Munsell 7.5YR tra 7/4 e 6/6. Superficie ruvida. Reca tracce di vernice distribuite in modo disomogeneo; colore: Munsell 5YR da 4/3 a 3/1. Realizzato al tornio. Integro. Tipo N.130.4.
defunto (n. 3); un esemplare simile è deposto in corrispondenza della soglia (n. 5); una coppa in ceramica a vernice nera contenente un’olletta in ceramica comune si trova vicino al piede sinistro (nn. 1 e 4); un’olla in ceramica comune e un balsamario ceramico sono collocati in corrispondenza dell’angolo sud-orientale (nn. 2 e 6). Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Metà II secolo a.C.
Tomba 173 (Saggio C; Tavv. 5, 17). Sepoltura a inumazione in fossa di forma trapezoidale, orientata in senso sud-est/nordovest (largh. max. 120; lungh. max. 270; prof. 184), localizzata nella porzione settentrionale del Saggio C. È tagliata in corrispondenza dell’angolo settentrionale dalla tomba a camera 151 (vedi, 231-232). Sul fondo, a contatto con il lato meridionale, si rinvengono resti della cassa lignea, che contiene la deposizione del defunto e del corredo; alloggiato nell’angolo nordoccidentale della fossa, il ripostiglio è protetto da numerosi spezzoni litici di grandi e medie dimensioni. Si conservano scarsissimi resti ossei. Dati antropologici. I resti ossei non consentono di proporre considerazioni sui caratteri biologici dell’inumato. Dati archeologici. Il corredo è composto da una punta di lancia e il relativo sauroter in ferro, disposti in posizione funzionale: la punta si trova presso il lato corto meridionale, il sauroter pressoché al centro della fossa, nella posizione corrispondente agli arti inferiori del defunto (nn. 6-7); una spada in ferro è deposta lungo il margine sud-occidentale, probabilmente in corrispondenza del fianco sinistro del defunto (n. 5), ad essa risulta saldato un frammento di spiedo con testa a ricciolo (n. 4). Nella posizione occupata originariamente dal torace, si rinvengono vari frammenti di spiedi in ferro (n. 4). Un bacile in lamina bronzea si trova in corrispondenza del cranio (n. 3). La posizione dei piedi è segnalata dalla presenza di calzari in ferro e legno (n. 8) e, a breve distanza, si rinviene un calderone in lamina bronzea contenente un frammento di spiedo in ferro (n. 2). Il ripostiglio è composto da una grande olla in impasto (n. 1). Il sesso archeologico è definibile come maschile. Inquadramento cronologico. Seconda metà/fine VI secolo a.C.
n. 1 (Tav. 46, 6): coppa a profilo distinto in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 17.2; alt. 6.8. Impasto duro, privo di inclusi; colore: Munsell 5YR 4.5/6. Vernice omogenea; colore: Munsell 7.5YR 3.5/0. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Sul fondo presenta un’iscrizione incisa prima della cottura; vedi Volume II di questo lavoro). Tipo H.240.C.7. n. 2 (Tav. 46, 10): olletta ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 17.8; alt. 22.4. Impasto duro, con frequenti inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 2.5YR 6.5/8. Superificie ruvida. Realizzata al tornio. Integra. Tipo I.50.A.11. n. 3 (Tav. 46, 7): olletta ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 11.2; alt. 11. Impasto duro, con frequenti inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell tra 2.5YR 3.5/0 e 2.5YR 4.5/6. Superficie ruvida- Realizzata al tornio. Integra. Tipo I.50.B.9, varietà a. n. 4 (Tav. 46, 8): olletta ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 12; alt. 12.2. Impasto duro, con frequenti inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 4.5/6. Superficie ruvida. Realizzata al tornio. Ricomposta da vari frammenti. Tipo I.50.B.9, varietà d. n. 5 (Tav. 46, 5): olletta ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 13.4; alt. 14.5. Impasto duro, con frequenti inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 2.5YR 2.5/4. Superficie ruvida. Realizzata al tornio. Integra. Tipo I.50.B.9, varietà b. 250
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
frammenti.
n. 1 (Tav. 48, 1): olla globulare in impasto grezzo. Diam. orlo 27.6; alt. 53.5. Impasto tenero, poroso con frequenti vacuoli distribuiti in maniera omogenea, frattura frastagliata, con abbondanti inclusi di medie e grandi dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 2.5YR 3/2. Superficie ruvida. Realizzata a mano. Ricomposta da vari frammenti. Tipo A.40.B.5.
Tomba 174 (Saggio C; Tavv. 5, 20). Tomba ipogeica “a grotticella” con corridoio di accesso semplice, localizzata a ridosso del limite orientale del Saggio C. Taglia la tomba 186 (vedi, 259-261). La camera, orientata in senso nord-est/sud-ovest (lungh. 200; largh. 100; prof. 80) presenta forma ovale con margini irregolari. La volta, a profilo curvilineo, risulta crollata e le pareti sono prive di continuità rispetto al fondo e alla volta stessa; presentano anch’esse andamento irregolare; il fondo è piano. L’accesso, aperto sul lato orientale con una luce di 115, non presenta stipiti ed è delimitato da una chiusura realizzata con pietre di medie dimensioni sovrapposte a secco per un’altezza di circa 50. Il rinvenimento sul piano di inumazione della camera di tre chiodi in ferro (n. 4), suggerisce l’originaria presenza di una tavola lignea come chiusura della camera. Il corridoio di accesso non è stato interamente indagato (lungh. scavata 145; largh. max. 115; largh. min. 89; prof. max. 70; prof. min. 50) essendo parzialmente coperto dal limite di scavo; è caratterizzato da un piano inclinato liscio. Si conservano solo scarsi resti della deposizione localizzati nella parte settentrionale della camera. Dati antropologici. Gli scarsissimi resti ossei conservati non consentono di proporre considerazioni sui caratteri biologici dell’inumato. Dati archeologici. Il corredo è costituito da un piatto in ceramica a vernice nera (n. 2), rinvenuto al centro della camera; un’olla in ceramica comune (n. 3) e una coppa biansata in ceramica a vernice nera (n. 1) nella porzione meridionale della stessa. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. II secolo a.C.
n. 2 (Tav. 47, 1): calderone con fondo concavo in lamina bronzea, con manico mobile in ferro. Diam. orlo 21.2; alt. max. cons. 10. Patina verde sulla superficie. Mancante di parte del fondo. Su una delle placche e sul manico in ferro sono presenti tracce di tessuto. Tipo O.320.1. n. 3 (Tav. 48, 2): bacile in lamina di bronzo con breve orlo a tesa. Diam. orlo 17.4; alt. 4.7. Patina verde sulla superficie. Integro. Tipo O.330.B.3. n. 4 (Tav. 47, 4): frammenti di tre spiedi in ferro con testa a ricciolo, di cui uno saldato alla spada n. 5. Lungh. max. cons. 39.3, 36,3 e 30; spessore stelo 0.9; diam. testa 2. Superficie corrosa e ossidata. Uno di essi risulta saldato. Tipo Q.60.1. n. 5 (Tav. 47, 3): spada in ferro. Lungh. 65.5; lama: lungh. 54.6, largh. max. 4.2, largh. min. 3.6, spessore 1; impugnatura: largh. max. 3.8; spessore max. cons. 1 . Superficie corrosa e ossidata. Manca parte dell’elsa. La lama presenta un ingrossamento a circa 1/3 della lungh. complessiva. Tipo T.20.1. n. 6 (Tav. 47, 6): punta di lancia in ferro. Lungh. 32.2; lama: largh. max. 4.3, spessore 0.7; cannone: lungh. 7.6, diam. 2. Superficie corrosa e ossidata. Integra. Si conservano tracce di legno nell’immanicatura. Tipo T.40.3.
n. 1 (Tav. 49, 1): coppa biansata in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 13.8; alt. 6.7. Impasto duro, compatto, privo di inclusi; colore: Munsell 7.5YR 7/4. Vernice compatta, opaca; colore: Munsell 2.5YR 3/0. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Mancante di una delle anse. Tipo H.250.2.
n. 7 (Tav. 47, 5): sauroter in ferro. Lungh. 9.7; diam. 2. Superficie corrosa e ossidata. Mutilo. Tipo T.60.1. n. 8 (Tav. 47, 2): calzari in legno, ferro e bronzo. Lungh. max. ric. 24; larg. max. ric. 10. Superficie corrosa e ossidata. Si conservano in
n. 2 (Tav. 49, 2): piatto con vasca troncoconica 251
Capestrano, I
rileva la coronale parzialmente obliterata e la lambdoidea e sagittale completamente ossificate. Le uniche anomalie riscontrate sono di natura osteoartrosica e sono visibili presso l’estremità sternale della prima costa, bilateralmente, e soprattutto ai margini del corpo vertebrale nel tratto cervicale e lombare dello scheletro assiale. In particolare C4, C5, C6, C7, T1, L3, L4 mostrano una proliferazione di tessuto osseo compatibile con osteofiti di media e grave severità (fig.antr.online 175_01,02A,B). Si può infine tentare di calcolare la statura a partire dalla lunghezza massima dell’omero (320 mm) e risulta di 169 cm. Dati archeologici. Il corredo, che probabilmente era deposto in corrispondenza della metà inferiore della deposizione, è stato completamente asportato dagli interventi post deposizionali sopra ricordati. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico: pur mancando completamente materiali di corredo, la tipologia funeraria orienta la datazione della tomba nel corso dell’età ellenistica.
bassa e labbro distinto in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 19.4; alt. 3.6. Impasto duro, compatto, privo di inclusi; colore: Munsell 7.5YR 7/4. Vernice compatta, opaca; colore: Munsell 10YR 7/3. Superficie liscia. Realizzato al tornio. Integro. Tipo H.290.B.10. n. 3 (Tav. 49, 4): olla globulare in ceramica comune. Diam. orlo 15.6; alt. 26. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di piccole e medie dimensioni disposti in maniera omogenea; colore: Munsell 10YR 7/4. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Ricomposta da vari frammenti. Tipo I.40.7. n. 4 (Tav. 49, 3): tre chiodi di ferro. Diam. max. testa 3; min. 0.8; lungh. max. 5.1; min, 3. Superficie corrosa e ossidata. Integri. Si conservano tracce di legno. Tipo Q.110.2. Tomba 175 (Saggio C; Tavv. 5, 20). Tomba ipogeica “a grotticella” con corridoio di accesso. Taglia la tomba 176, di età arcaica. La camera e il corridoio risultano disturbati profondamente dall’impianto di un muro di età moderna (US 241) e il corridoio a sua volta taglia la tomba 182 a fossa (vedi, 256-257). La camera, orientata in senso nord-nord ovest/sudsud est (lungh. max. cons. 110; largh. max. cons. 95; prof. media del piano di deposizione 187), si conserva solo nella parte occidentale; anche la volta risulta crollata. Il corridoio di accesso (lungh. max. cons. 192; largh. max. cons. 82), orientato in senso nord-est/sud-ovest, non è stato scavato. La deposizione si conserva solo nella parte superiore, è dorsale, primaria e nello spazio vuoto. Il cranio è stato rinvenuto a circa 20 dalla sua posizione originaria, forse a causa del crollo della volta o, anche, per la presenza di un supporto in materiale deperibile originariamente posto sotto la testa. Dati antropologici. Lo scheletro appartiene a un individuo adulto maschile di età avanzata. Lo stato si conservazione è parziale e molto frammentario. La determinazione del sesso è possibile osservando il profilo della mandibola e la stima dell’età può essere generalmente indicata come matura-avanzata poiché è limitata alla valutazione dell’usura dentaria che corrisponde a 25-35 anni e allo stadio di fusione delle suture craniche che, nelle parti disponibili,
Tomba 176 (Saggio C; Tavv. 5, 21). Sepoltura a inumazione in fossa pressoché rettangolare orientata in senso sud-est/nordovest (lungh. 290; largh. 110; prof. 280), localizzata nell’area settentrionale del Saggio C. Risulta disturbata dall’impianto del muro US 241 di età moderna e dall’impianto della tomba 175 (vedi scheda precedente). Tracce di materiale organico decomposto individuate sul fondo della fossa segnalano l’originaria presenza di una cassa lignea. La mancanza completa di resti scheletrici e l’attribuzione del corredo a un individuo maschio adulto, suggerisce di interpretare l’evidenza come un cenotafio. Dati archeologici. Durante l’indagine archeologica non sono stati rinvenuti resti antropologici. Dati archeologici. Il corredo è composto da una spada in ferro (n. 8) rinvenuta nella porzione mediana della fossa, con la punta compresa dai resti dei due calzari in ferro (n. 10). Nella porzione orientale della fossa, presso il lato corto, sono deposti una brocca (n. 2) e un bacile (n. 4) in lamina bronzea; una coppia di alari in 252
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
pressi, un rasoio in ferro (n. 7); nella terra di riempimento, una punta di lancia e una di giavellotto in ferro (nn. 9-10); una brocca in ceramica depurata acroma (n. 2); una fibula ad arco serpeggiante in ferro posta sui piedi (n. 4); frammenti di anellini in ferro a sezione circolare (n. 6). Il ripostiglio è composto da un’olla in impasto (n. 1). Il sesso archeologico è definibile come maschile. Inquadramento cronologico. Seconda metà VI secolo a.C.
ferro (nn. 6-7), sui quali erano deposti tre spiedi in ferro (n. 5). Gli spiedi e gli alari sembrano coprire un possibile sostegno ligneo decomposto; a ridosso degli alari, si rinviene la lancia in ferro (n. 9). Il ripostiglio, complanare al piano di inumazione e posto a ridosso del lato corto occidentale della fossa, è formato da blocchi calcarei di medie e grandi dimensioni, posti a protezione di una grande olla in impasto (n. 1) e di un calderone bronzeo (n. 3). Il sesso archeologico è definibile come maschile. Inquadramento cronologico: età arcaica.
n. 1 (Tav. 49, 5): olla in impasto. Diam. fondo 31; alt. max. cons. 33. Impasto duro, poroso con frequenti vacuoli disposti in maniera omogenea, frattura frastagliata, con numerosi inclusi di medie e grandi dimensioni; colore: Munsell 2.5YR 4/6. Superficie liscia. Realizzata a mano. Mancante dell’orlo. Tipo non puntualizzabile.
I materiali della tomba 176 risultano in corso di analisi e restauro presso il laboratorio del Museo delle Paludi di Celano. Tomba 177 (Saggio D; Tavv. 6, 22). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso sud-est/nord-ovest (lungh. max. cons. 260; largh. 90; prof. 126), localizzata presso il limite sud-orientale del Saggio D e tagliata a nord-est dalla tomba 169 (vedi, 246-247); a est, taglia le tombe 150 e 178 (vedi, 231 e scheda seguente); la tomba non è stata scavata completamente in corrispondenza del lato corto meridionale, coperto dal limite di scavo. In una nicchia ricavata nell’angolo nordoccidentale di fondo della fossa, il ripostiglio è protetto da pietre di medie e grandi dimensioni. L’inumato è deposto in posizione dorsale all’interno di una cassa lignea, addossata alla parete occidentale della fossa. La deposizione è dorsale, primaria e in spazio vuoto; si rinvengono scarsi resti del cranio, delle ossa lunghe degli arti superiori, distese lungo il torace, e degli arti inferiori, distesi e allineati. Dati antropologici. Si recuperano pochi frammenti ossei, tra cui otto denti, tre vertebre toraciche appartenenti a un adulto. Il numero minimo di individui è di due, poiché sono conservate tre diafisi di tibia denominate “ritrovamento sporadico presso T 177”. A posteriori è possibile ipotizzare che uno di questi elementi dell’arto inferiore appartenesse all’individuo della T 169. Dati archeologici. Il corredo è composto da un sauroter in ferro a est del cranio (n. 11); una spada in ferro deposta a ovest della tibia (n. 8); un gancio a doppia spirale sulle ginocchia (n. 5); un bacile di bronzo sui piedi (n. 3) e, nei
n. 2 (Tav. 50, 6): brocca in argilla depurata. Diam. orlo 7.6; alt. 15. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 2.5YR 2.5/1. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Ricomposta da vari frammenti ed integrata. Tipo D.110.2. n. 3 (Tav. 50, 7): bacile a orlo perlinato con vasca a profilo diritto in lamina di bronzo. Diam. orlo 25; alt. 5. Patina verde sulla superficie. Mancante di parte dell’orlo. Tipo O.330.A.3. n. 4 (Tav. 50, 4): fibula in ferro con arco a tripla ondulazione. Lungh. 8. Superficie corrosa e ossidata. Parzialmente ricomposta; si conservano evidenti tracce di tessuto, in particolare sull’ago. Tipo S.20.B.4. n. 5 (Tav. 50, 2): gancio di cintura/cinturone a doppia spirale. Largh. 6; spessore filo 0.2. Patina verde in superficie. Integro. Tipo S.10.4. n. 6 (registrati in corso di scavo ma non documentati puntualmente): frammenti di anelli in ferro con frammenti di chiodini in ferro concrezionati. Diam. da 1 a 3. Superficie corrosa e ossidata. n. 7 (Tav. 50, 3): rasoio semilunato in ferro. 253
Capestrano, I
impasto grezzo. Diam. orlo 18; alt. 30.4. Impasto duro, poroso con rari vacuoli distribuiti in maniera disomogenea, frattura irregolare, con inclusi di dimensioni medie e piccole; colore: Munsell tra 10YR 2/1 e 10YR 4/2. Superficie liscia. Realizzato a mano. Ricomposto da vari frammenti; mancante di parte del ventre. Tipo A.30.3.
Lungh. 9.5; largh. 3.3, spessore 0.3. Superficie corrosa e ossidata. Mutilo. Si conservano sulla superficie lembi di tessuto. Tipo R.50.1. n. 8 (Tav. 50, 1): spada in ferro. Lungh. max cons. 66; lama: lungh. 54, largh. max. 5.5, largh. min. 3.6, spessore max. 0.8; elsa: lungh. 11.6, largh. max. cons. 8.8; spessore 0.3. Superficie corrosa e ossidata. Ricomposta da più frammenti. Si conservano parte della lamina in ferro e del legno dell’elsa (con i chiodini di giuntura). Tipo T.20.1, varietà b.
n. 2 (Tav. 51, 2): brocchetta globulare in impasto grezzo. Diam. orlo 5; alt. 7.9. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con frequenti inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera disomogenea: colore: Munsell 5YR 4/6. Superficie liscia. Realizzata a mano; sono visibili tracce di steccatura sia internamente che esternamente. Ricomposta da vari frammenti. Tipo A.110.1.
n. 9 (Tav. 50, 10): punta di lancia in ferro. Lungh. 26; lama: largh. max. 4.6, spessore max. 0.9; cannone: lungh. 8.1, diam. 2.2. Superficie corrosa e ossidata. Integra. Tipo T.40.2. n. 10 (Tav. 50, 8): punta di giavellotto in ferro. Lungh. max. cons. 13.5; lama: largh. 3.4, spessore 0.6; cannone: 5.3, diam. 1.7. Superficie corrosa e ossidata. Mutila. Tipo T.50.2.
Tomba 179 (Saggio D; Tavv. 6, 21). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare orientata in senso sud-est/nord-ovest (lungh. max. cons. 80; largh. 60; prof. 120), localizzata nella porzione centrale del Saggio D. È tagliata per più di metà della sua lunghezza dall’impianto della tomba 180 (vedi scheda successiva). Nella parete nord-orientale, a 10 dal piano di deposizione, è ricavata una nicchia (largh. 50; prof. 20) funzionale all’alloggiamento del ripostiglio. Si conserva parte della cassa lignea contenente scarsissimi resti antropologici. Dati antropologici. Lo stato di conservazione dei resti osteologici è pessimo e non restano che pochi frammenti di vertebra, diafisi di femori e ossa tarsali di un individuo adulto. Dati archeologici. Nella cassa lignea si rinviene una coppetta in ceramica a vernice nera (n. 1). Il ripostiglio è composto da un’olletta biansata (n. 2). Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Fine IV-prima metà III secolo a.C.
n. 11 (Tav. 50, 9): sauroter in ferro. Lungh. 10.5; diam. immanicatura 2.1. Superficie corrosa e ossidata. Integro. Tipo T.60.1. Tomba 178 (Saggio D; Tavv. 6, 21). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso est-ovest (lungh. max. cons. 70; largh. 85; prof. 55), localizzata nel settore orientale del Saggio D. Disturba la tomba 149 e risulta distrutta e sconvolta per oltre la metà della sua lunghezza dall’impianto della tomba 177 (vedi scheda precedente e 230-231). Il ripostiglio, nell’angolo settentrionale della fossa, è protetto da spezzoni litici infissi nel piano di deposizione. Dati antropologici. La sepoltura risulta priva di resti antropologici. Dati archeologici. Il ripostiglio è composto da un vaso a collo in impasto (n. 1), affiancato da una brocchetta della stessa classe (n. 2). Il sesso archeologico non è determinabile; le dimensioni della fossa ne suggeriscono l’attribuzione a un individuo di età infantile. Inquadramento cronologico. Prima metà VI secolo a.C.
n. 1 (Tav. 51, 4): coppetta a profilo globulare in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 12.2; alt. 5.2. Impasto duro, compatto, frattura regolare, privo di inclusi; colore: Munsell 7.5YR 7/6. Vernice lucente, omogenea, con sbavature sulla vasca in prossimità del piede; colore: Munsell 2.5YR 2.5/0. Superficie liscia. Realizzata al
n. 1 (Tav. 51, 1): vaso a collo tetransato in 254
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
ischiatica. La superficie auricolare presenta un aspetto corrispondente a una età alla morte tra 40 e 44 anni. Il cranio è completo e premette la stima dell’età in base al grado di chiusura delle suture craniche che risulta corrispondere a 45.2 anni (in un range 31-65) e 45.5 anni (35-57 anni). L’usura dei denti è limitata allo smalto, tuttavia osservando nel complesso la dentatura mandibolare è evidente una usura maggiore dei denti anteriori rispetto ai giugali (fig.antr.online 180_01). Tra i denti raccolti singolarmente, sul primo molare mascellare si documenta la presenza del tubercolo di Carabelli. L’analisi paleopatologica ha individuato nella colonna vertebrale segni di osteoartrosi e nella tibia sinistra le vestigia di una lesione traumatica. Per quanto riguarda le vertebre, si tratta di perdite di tessuto osseo localizzate sulla superficie del corpo vertebrale di toraciche e di L1 compatibili con noduli di Schmorl non gravi. L’atlante (C1) presenta una anomalia di dimensioni, per cui risulta inspessito il tubercolo anteriore (fig.antr.online 180_02A,B). Nel caso della tibia sinistra, si osserva lungo il margine anteriore, all’incirca a metà diafisi, una area di tessuto osseo circoscritto molto compatto di forma ovale (lunghezza 27.5 mm e larghezza 16.3 mm). Si tratta molto probabilmente di un callo osseo in avanzato stato di riassorbimento esito di una frattura ricomposta di origine traumatica che ha coinvolto solo la tibia sinistra poiché sulla controlaterale destra non vi è traccia di anomalie (fig.antr.online 180_03A,B). Si segnala anche in questo caso il ricorrere di un carattere discontinuo craniale: la presenza di un osso soprannumerario (wormiano) al lambda. È possibile tentare di calcolare la statura in vita dalla misura di lunghezza dell’omero destro (338 mm) e sinistro (324) e risulta di circa 172 cm. Dati archeologici. Il corredo si compone di un piatto (n. 4) e una pisside (n. 1) in ceramica a vernice nera, un’olletta (n. 6) e un’olla (n. 5) in ceramica comune, sulla quale si rinviene una coppa biansata in ceramica a vernice nera (n. 3), posti in corrispondenza dell’ingresso. Nell’angolo meridionale della camera, si rinvengono una coppa in ceramica a vernice nera (n. 2) e tre chiodi in ferro (n. 7), relativi probabilmente ad un contenitore o sostegno
tornio. Ricomposta da vari frammenti. Tipo H.260.A.3. n. 2 (Tav. 51, 3): olletta biansata globulare in ceramica comune. Diam. orlo 12.6; alt. 22.3. Impasto duro con frequenti inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell tra 2.5YR 3/0 e 2.5 YR 5/6. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Integra. Tipo I.70.2. Tomba 180 (Saggio D; Tavv. 6, 23). Tomba ipogeica “a grotticella”, con corridoio di accesso a gradoni, localizzata presso il limite sud-orientale del Saggio D. Taglia le tombe 170 e 179 (vedi, 247 e scheda precedente). La camera presenta pianta pressoché rettangolare, con pareti verticali (lungh. 222; largh. 125; prof. piano di deposizione 211). La volta è completamente crollata e nel riempimento della camera si rinvengono le due deposizioni neonatali tombe 181 e 184 (vedi scheda seguente e 258). Il piano di inumazione presenta un andamento orizzontale, con un dislivello di 15 rispetto al piano del corridoio di accesso. Il vano d’ingresso, aperto ad est con una luce di 105, doveva essere originariamente chiuso da un elemento ligneo. Il corridoio di accesso, orientato lungo l’asse nord-ovest/sudest, presenta forma trapezoidale e pareti leggermente inclinate e convergenti verso l’accesso (lungh. 260; largh. 147; largh. min. 93; prof. max. 165; prof. min. 40). L’accesso al corridoio è lavorato a gradoni di altezza variabile dai 15 ai 30. Sul fondo della camera si rinviene la deposizione, orientata in senso nordest/sud-ovest, in ottimo stato di conservazione, in posizione dorsale, primaria e nello spazio vuoto. L’inumato presenta l’arto superiore destro flesso, con la mano sull’omero sinistro ed il cranio, leggermente sollevato, rivolto a nord-ovest. Dati antropologici. I resti umani appartengono a un individuo maschio adulto di età media intorno ai 45 anni, in buono stato di conservazione e conservato integralmente. Sia la morfologia del cranio che del bacino presentano caratteristiche maschili, ben osservabili nella cresta nucale, nei processi mastoidei, nel frontale, nei margini sovraorbitari, nella mandibola, nell’incisura 255
Capestrano, I
5YR 5/8. Superficie ruvida. Realizzata al tornio. Parzialmente ricomposto da vari frammenti. Tipo I.50.B.9, varietà a.
ligneo. Nella terra di riempimento della camera si rinvengono due pendenti in bronzo (n. 8) e un vago di collana in pasta vitrea di colore blu (n. 9). Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Seconda metà II secolo a.C.
n. 7 (Tav. 52, 6): tre chiodi in ferro. Diam. testa max. 3; min. 1; lungh. max. 12.6, 6.6, 3.5. Superficie corrosa e ossidata. Uno si conserva integro, gli altri due sono frammentari. Uno del Tipo Q.110.1; due del tipo Q.110.2.
n. 1 (Tav. 52, 4): pisside cilindrica in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 8.4; alt. 6.3. Impasto duro, prico di inclusi; colore: Munsell 5 YR 6/8. Vernice omogenea, lucente; colore: Munsell 2.5YR 2.5/0. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.140.1.
n. 8 (Tav. 52, 7): due pendenti lanceolati in lamina di bronzo. Largh. 1.4; lungh. max. cons. 4.5. Patina verde in superficie. Ambedue sono mutili. Tipo S.50.2.
n. 2 (Tav. 52, 8): coppa a profilo distinto in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 16; alt. 5.9. Impasto duro, privo di inclusi; colore: Munsell tra 7.5YR 8/4. Vernice lucente, non uniforme con coloriture sulla parete esterna e interna; colore: Munsell 7.5YR 2/0. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.240.C.11.
n. 9 (Tav. 52, 9): vago di collana in pasta vitrea a occhi (diam. max. cons. 1; spessore 0.3). Mutilo. Tipo S.60.A.2, varietà b3. Tomba 181 (Saggio D; Tavv. 6, 23). Sepoltura neonatale a inumazione rinvenuta all’interno della camera della tomba 180, al di sopra del crollo della volta di quest’ultima (vedi scheda precedente). La deposizione era alloggiata all’interno di due coppi contrapposti (lungh. 63; largh. media 17). Il coppo di copertura era disturbato e spezzato nel mezzo. Non è stata realizzata una planimetria di dettaglio per tale sepoltura. Dati antropologici. L’inumato è un sub-adulto perinatale di età compresa tra 34a-36a settimana di gestazione e la nascita. Non è possibile determinare con maggiore precisione l’età alla morte a causa dello stato di conservazione pessimo. Infatti lo scheletro include soltanto alcuni frammenti di cranio, coste e vertebre. Dati archeologici. Il corredo è assente. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico: il rinvenimento all’interno della tomba 180 suggerisce una datazione in età ellenistica.
n. 3 (Tav. 52, 1): coppa biansata in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 14; alt. 6.8. Impasto tenero, compatto, frattura regolare, privo di inclusi; colore: Munsell 7.5YR 8/6. Vernice opaca non uniforme; colore: Munsell tra 7.5YR 2/0YR e 2.5YR 3/0. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Mancante di parte delle anse. Tipo H.250.1. n. 4 (Tav. 52, 3): piatto con vasca troncoconica e labbro rientrante in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 22.8; alt. 4.4. Impasto duro, compatto, frattura netta, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 7/4. Vernice non uniforme e opaca; colore: Munsell tra 2.5Y 2/0 e 5YR 3/3. Superficie liscia. Realizzato al tornio. Ricomposto da vari frammenti. Tipo H.290.B.3. n. 5 (Tav. 52, 2): olla globulare in ceramica comune. Diam. orlo 14.6; alt. 25. Impasto tenero, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di piccole dimensioni; colore: Munsell 7.5YR 8/4. Superficie polverosa. Ricomposta da vari frammenti. Tipo I.40.4.
Tomba 182 (Saggio C; Tavv. 5, 22). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso sud-est/nord-ovest (lungh. 170; largh. 55; prof. 78), localizzata nell’area nord-occidentale del Saggio C. È disturbata presso il suo lato meridionale dal corridoio di accesso della tomba 175 (vedi, 252) e, presso quello orientale, dal muro di età moderna US 241. La deposizione è primaria, dorsale e in
n. 6 (Tav. 52, 5): olletta ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 11.6; alt. 12.6. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con inclusi di dimensioni medie e grandi; colore: Munsell 256
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
S.20.A.1, varietà a.
ambiente vuoto; il cranio è orientato a sud-est; l’arto superiore destro è allineato lungo il torace, quello sinistro è piegato con la mano sulle ossa pelviche; l’arto inferiore sinistro è disteso, mentre le ossa di quello destro sembrano essere state disturbate in fase postdeposizionale. Dati antropologici. Si conservano pochi frammenti attribuibili a un individuo adulto femminile forse di 25-35 anni. Sono presenti resti di cranio, mandibola e denti, diafisi degli arti superiori e inferiori. Dati archeologici. Il corredo si compone di una fibula in ferro sul torace (n. 2); un anello in bronzo (n. 4) probabilmente indossato alla mano sinistra; una fibula in ferro (n. 3) rinvenuta tra gli arti inferiori; una scodella in impasto (n. 1) deposta presso i piedi, in corrispondenza dell’angolo settentrionale della fossa. Un elemento non identificabile in ferro (n. 5) si rinviene nella terra di riempimento. Sulla base della mancanza delle armi e dell’inquadramento cronologico proposto, il sesso archeologico è definibile come femminile. Inquadramento cronologico. Fine VI-prima metà V secolo a.C.
n. 4 (Tav. 52, 13): anello in bronzo con verga sottile. Diam. 2; spessore 0.1. Patina verde sulla superficie. Integro. Tipo S.40.A.1. n. 4 (Tav. 52, 12): elemento in ferro. Lungh. 5.5. Superficie corrosa e ossidata. Frammentario. Lo stato di conservazione non permette un’identificazione certa del reperto. Tomba 183 (Saggio D; Tavv. 6, 22). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso nord-ovest/sud-est (lungh. 124; largh. 58; prof. 68), localizzata nella porzione sud-occidentale del Saggio D. Sul piano di deposizione si rinvengono i resti di una cassa lignea, contenuta da pietre di grandi e medie dimensioni, la cui presenza è confermata dal rinvenimento di chiodi in ferro lungo i suoi margini (n. 4). Dati antropologici. I resti umani appartengono a un sub-adulto in pessimo stato di conservazione e molto frammentario. Dallo stadio di formazione degli elementi dentari decidui è possibile stimare l’età alla morte che corrisponde a 6 mesi ± 2 mesi. Dati archeologici. Al di sopra di una delle pietre di delimitazione della cassa si rinvengono i frammenti di un’olletta in ceramica comune (n. 1) e una lucerna (n. 2), probabilmente posti in origine al di fuori del contenitore ligneo. Nei pressi dell’angolo orientale di fondo, si rinviene un calderone in bronzo (n. 3), probabilmente pertinente ad una deposizione precedente e già sconvolta in antico, presumibilmente in seguito alla costruzione della tomba a camera 190 (vedi, 263-266; il calderone è visibile alla Tav. 53). Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. I secolo d.C.
n. 1 (Tav. 52, 14): scodella con vasca a calotta in impasto grezzo. Diam. orlo 10; alt. 6. Impasto duro, poroso con rari vacuoli distribuiti in maniera omogenea, frattura irregolare, con inclusi di piccole e medie dimensioni distribuiti in maniera omogenea: colore: Munsell 5YR tra 4.5/2 e 5.5/8. Superficie liscia. Realizzata a mano; si conservano tracce di steccatura sulla superficie. Mancante di parte del labbro. Tipo A.230.A.1. n. 2 (Tav. 52, 10): fibula in ferro ad arco semplice a sezione quadrata e borchia conica applicata sull’arco. Lungh. 12; alt. 5.2. Superficie corrosa e ossidata. Ricomponibile da vari frammenti. Una lamina di ferro sembra essere stata applicata in antico sulla staffa. Tracce di tessuto sulla molla, sull’ago e sulla staffa. Tipo S.20.A.6.
n. 1 (Tav. 52, 16): olletta ovoide/piriforme in ceramica comune. Diam. orlo 6; alt. 8.5. Impasto tenero, con abbondanri inclusi di medie dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 2.5YR tra 3/6 e 4/8. Superficie ruvida. Realizzata al tornio. Integra. Tipo I.50.B.15, varietà c.
n. 3 (Tav. 52, 11): fibula in ferro ad arco semplice rialzato. Lungh. 4.5; alt. 5. Superficie corrosa e ossidata. Ricomponibile da vari frammenti. Tracce di tessuto sulla molla. Tipo
n. 2 (Tav. 52, 15): lucerna a disco. Diam. vasca 8.1; lungh. becco 2.9; alt. 4. Impasto tenero, 257
Capestrano, I
deposizione, lievemente inclinato da nord verso sud, presenta un allineamento di pietre di medie dimensioni lungo il lato minore sudoccidentale. Dati antropologici. Dell’inumato si conserva solo un omero sinistro di adulto. Dati archeologici. Il corredo si compone di un bacile in bronzo (n. 1) contenente un rasoio in ferro (n. 2), nella posizione originariamente occupata dai piedi; in prossimità e al di sotto del bacile si trovano frammenti di due calzari in ferro (n. 9) e due chiodi dello stesso materiale (n. 10). In corrispondenza della posizione degli arti inferiori, si rinvengono diciannove ribattini in lamina di bronzo, sui quali si conservavano ancora tracce di tessuto (n. 11). Due punte di lancia in ferro si trovano in prossimità dell’angolo nord-orientale della fossa (nn. 7-8); un coltello in ferro (n. 6) in prossimità del lato maggiore occidentale; tre fibule in ferro frammentarie (nn. 3-5), in corrispondenza della originaria posizione del torace del defunto. Sono probabilmente da ascrivere a questa sepoltura anche alcuni frammenti in impasto buccheroide rinvenuti nella terra di riempimento della tomba 125, uno stamnos in lamina bronzea (n. 12) e tre fibule in bronzo (nn. 13-15) rinvenuti nel corridoio di accesso della tomba 190 (vedi, 263-266). Il sesso archeologico è determinabile come maschile. Inquadramento cronologico. Fine VI-inizi V secolo a.C.
compatto, frattura regolare, privo di inclusi; colore: Munsell 7.5YR 7/2. Reca tracce di vernice; colore: Munsell 2.5YR 4/8. Superficie polverosa. Realizzata a stampo. Ricomposta; il becco è scheggiato. Tipo M.E.1. n. 3 (Tav. 53, 13): calderone con labbro rientrante in bronzo. Diam. 26; alt. max. cons. 7.8. Patina verde sulla superficie. Si conserva parte del labbro e della vasca; manca il manico, del quale si conserva l’innesto in corrispondenza del labbro. Tipo O.320.1 (dubitativamente). n. 4 (Tav. 52, 17): otto chiodi in ferro. Diam. testa 3.1 a 2.7; lungh. da 9.5 a 6.5. Superficie corrosa e ossidata. Integri. Conservano tracce di legno. Tipo Q.110.1. Tomba 184 (Saggio D; Tavv. 6, 23). Deposizione di un individuo neonatale, rinvenuta nell’angolo settentrionale della tomba 180 (vedi, 255-256), nel suo riempimento. Si conservano solo frammenti ossei in pessimo stato di conservazione. Non è stata realizzata una planimetria specifica per tale sepoltura. Dati antropologici. Gli scarsissimi resti ossei conservati non consentono di proporre considerazioni sui caratteri biologici dell’inumato. Dati archeologici. La deposizione non è accompagnata da corredo. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico: sulla base della posizione all’interno della camera della tomba 180 già riempita del crollo della volta, la sepoltura va probabilmente ascritta alla fine dell’età repubblicana/inizi dell’età imperiale.
n. 1 (Tav. 53, 8): bacile a orlo perlinato con vasca a profilo lievemente rientrante e fondo piano in lamina di bronzo. Diam. orlo 27.8; alt. 6. Patina verde sulla superficie. Integro. Tipo O.330.A.2. n. 2 (Tav. 53, 5): rasoio semilunato in ferro. Lungh. max. cons. 8.2; larg. max. cons. 6.6; spessore 0.1. Superficie corrosa e ossidata. Mutilo della punta. Tracce di tessuto sul codolo. Tipo R.50.1.
Tomba 185 (Saggio D; Tavv. 6, 22). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso sud-ovest/nord-est (lungh. 190; largh. 70; prof. 63), localizzata nel settore sud-occidentale del Saggio D. È pesantemente disturbata dall’impianto delle tombe 125 e 190 (vedi 214, 263-266). Date le condizioni di giacitura, non è possibile definirne puntualmente i margini superiori e anche l’interno risulta sconvolto, soprattutto nella porzione riservata al ripostiglio. Il piano di
n. 3 (Tav. 53, 11): fibula in ferro con arco a tripla ondulazione. Lungh. max. ric. 5.1; alt. max. ric. 5. Superficie corrosa e ossidata. Frammentaria. Tipo S.20.B.4. n. 4 (Tav. 53, 15): fibula in ferro con arco a 258
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
n. 12 (Tav. 53, 16): stamnos in bronzo. Diam. orlo 10.2; alt. 10.4. Patina verde sulla superficie. Mancante di parte del fondo. Tipo O.340.1.
tripla ondulazione. Lungh. max. ric. 7.8; alt. max. ric. 6. Superficie corrosa e ossidata. Si conserva parte dell’arco, presumibilmente serpeggiante a più ondulazioni, con agemina in filo di bronzo conservata almeno in un punto. Probabilmente ascrivibile al Tipo S.20.B.4.
n. 13 (Tav. 53, 1): fibula in bronzo con arco a doppia ondulazione. Lungh. 7; alt. 2.9. Patina verde sulla superficie. Mancante dell’ago. Tipo S.20.B.1.
n. 5 (Tav. 53, 12): fibula in ferro. Superficie corrosa e ossidata. Si conservano parte della molla e della staffa. Non è possibile definire il tipo di appartenenza.
n. 14 (Tav. 53, 2): fibula in bronzo con arco a doppia ondulazione. Lungh. 6.6; alt. 3. Patina verde sulla superficie. Sulla parte superiore dell’arco, si conserva la decorazione a tratti incisi. Tipo S.20.B.1.
n. 6 (Tav. 53, 10): coltello affila-lama in ferro. Lungh. max. cons. 24; lama: largh. max 3.1, spessore max. 0.9. Superficie corrosa e ossidata. Mutilo. Tipo T.30.1.
n. 15 (Tav. 53, 3): fibula in bronzo con arco a doppia ondulazione. Lungh. 8.1; alt. con ago 2.8. Patina verde sulla superficie. Integra. Tipo S.20.B.1.
n. 7 (Tav. 53, 4): punta di lancia in ferro. Lungh. max. ric. 36; lama: largh. max. 4.8, spessore 0.8; cannone: lungh. 7.6, diam. 2.6. Superficie corrosa e ossidata. Mutila. Tipo T.40.2.
n. 16 (Tav. 53, 6): spada in ferro. Lungh. max. ric. 46; spessore max. lama 0.9. Superficie corrosa e ossidata. Si conserva solo la lama in frammenti. Probabilmente Tipo T.20.1.
n. 8 (Tav. 53, 14): punta di giavellotto in ferro. Lungh. max. cons. 20.5; lama: larg. max. 3.6, spessore 0.6; cannone: lungh. 8.2, diam. 2.1. Superficie corrosa e ossidata. Manca dell’estremità superiore. Tipo T.50.1.
Tomba 186 (Saggio C; Tavv. 6, 24). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso sud-ovest/nord-est (lungh. 259; largh. 90; prof. 157), localizzata lungo il limite orientale del Saggio C. È tagliata dalla tomba a camera 174 in corrispondenza del suo lato corto settentrionale. Nella terra di riempimento della tomba, a circa 60 di profondità dai margini superiori, si individua un livello di pietre di medie e grandi dimensioni, maggiormente concentrate nella porzione settentrionale della fossa, probabilmente a segnare la posizione del ripostiglio, deposto presso l’angolo nord-occidentale. A 110 di profondità dai margini superiori e al centro della fossa, si individua una situla in lamina bronzea (n. 3), verosimilmente deposta al di sopra del contenitore ligneo, i cui resti sono delimitati a est da un allineamento di pietre di medie dimensioni poste di taglio. Dati antropologici. Il materiale osteologico appartiene a un sub-adulto di età adolescenziale. A causa dell’estrema frammentazione del cranio e all’assenza di elementi postcraniali, non è possibile ulteriormente approfondire il profilo
n. 9 (Tav. 53, 17): calzare in ferro e legno. Lungh. max. ric. 24.3; largh. max. ric. 10.8. Superficie corrosa e ossidata. Si conserva la parte posteriore e una lamina presumibilmente laterale. n. 10 (Tav. 53, 7): due chiodi in ferro. Diam. testa 1.1 e 2.4; lungh. 4.6 e 9.3. Superficie corrosa e ossidata. Integri. Uno del Tipo Q.110.1 e uno del Tipo Q.110.2. n. 11 (Tav. 53, 9): 19 ribattini in bronzo. Diam. 1 ca. Diciannove ribattini di forma circolare in lamina di bronzo, accompagnati da due laminette rettangolari in lamina di bronzo, pertinenti probabilmente ad un reperto in materiale deperibile. Patina verde sulla superficie. Su alcuni ribattini si conservano tracce di tessuto. Reperti provenienti dal corridoio di accesso della tomba 190: 259
Capestrano, I
n. 4 (Tav. 54, 12): olpe con ampia imboccatura in lamina bronzea. Diam. orlo 10; alt. ricostruibile 13. Patina verde sulla superficie. Si conservano solo parti del labbro, del fondo e l’ansa. Tipo O.110.2. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 128, fig. 9.
biologico. Molto probabilmente si tratta di un adolescente considerando che tra gli elementi dentari è presente un terzo molare mascellare in uno stadio di formazione di circa 15 anni ± 30 mesi. Dati archeologici. Il corredo si compone di una collana in ambra (n. 18) e una di vaghi in pasta vitrea (n. 17) all’altezza del collo; sette fibule in ferro deposte sul torace (nn. 7-13); due anelli in argento, portati alla mano destra (n. 16); un bacile in lamina bronzea in corrispondenza del bacino (n. 5), posto a coprire una grattugia in bronzo (n. 6), un’armilla in bronzo (n. 15) e una fibula in ferro (n. 14); una scodella biansata in impasto (n. 2) è deposta a ridosso del bacile. Il ripostiglio è composto da un’olla in impasto (n. 1), contenente un’olpe in lamina bronzea (n. 4). Al di sotto delle pietre del ripostiglio, si rinvengono alcune cerniere in ferro (n. 19). Il sesso archeologico è determinabile come maschile. Inquadramento cronologico. Prima metà V secolo a.C.
n. 5 (Tav. 54, 2): bacile a orlo perlinato con vasca a profilo svasato in lamina bronzea. Diam. orlo 26.5; alt. 4. Patina verde sulla superficie. Mutilo. Tipo O.330.A.5. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 128, fig. 9. n. 6 (Tav. 54, 4): grattugia in bronzo. Lungh. max. cons. 13.5; largh. max. cons. 5.4. Patina verde sulla superficie. Frammentaria. Probabilmente, Tipo Q.70.1. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 128, fig. 9. n. 7 (Tav. 54, 6): fibula in ferro con arco a tripla ondulazione in ferro con catenella. Lungh. max. cons. 4.3; alt. max. cons. 3.6. Superficie corrosa e ossidata. Si conserva parte dell’arco e dell’ago. Probabilmente ascrivibile al Tipo S.20.B.4. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 128, fig. 9.
n. 1 (Tav. 55, 1): olla globulare in impasto grezzo. Diam. orlo 30; alt. 40. Impasto duro, poroso con frequenti vacuoli distribuiti in maniera omogenea, frattura frastagliata, con inclusi di piccole e medie dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 2.5YR 4.5/6. Superficie liscia. Realizzata a mano. Ricomposta da vari frammenti. Tipo A.40.B.10. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 128, fig. 9.
n. 8 (Tav. 54, 7): fibula in ferro con arco a tripla ondulazione in ferro. Lungh. max. 9.5; alt. max. 3.6. Superficie corrosa e ossidata. Frammentaria, manca parte dell’ago dell’arco; lembi di tessuto si conservano sulla molla e sulla staffa. Si conservano resti di una catenella in ferro inserita nell’ago. Tipo S.20.B.4. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 128, fig. 9.
n. 2 (Tav. 54, 1): scodella biansata in impasto buccheroide. Diam. orlo 13.6; alt. 6.4. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con frequenti inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10YR 3/1. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Ricomposta da vari frammenti Tipo B.230.C.3. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 128, fig. 9.
n. 9 (Tav. 54, 8): fibula in ferro con arco a tripla ondulazione in ferro con catenella. Lungh. max. 5; alt. 3.6. Superficie corrosa e ossidata. Frammentaria, manca parte dell’ago e della staffa. Lembi di tessuto si conservano sull’arco. Probabilmente ascrivibile al Tipo S.20.B.4. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 128, fig. 9. n. 10 (Tav. 54, 14): fibula in ferro con arco a tripla ondulazione. Lungh. max. cons. 2.8; alt. max. ric. 3.5. Superficie corrosa e ossidata. Frammentaria, manca la staffa, parte dell’arco e dell’ago Probabilmente ascrivibile al Tipo S.20.B.4. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 128, fig. 9.
n. 3 (Tav. 54, 18): situla stamnoide in lamina bronzea con manico in ferro. Diam. orlo 18.8; alt. max. cons. 18.5. Patina verde sulla superficie. Mancante di parte del fondo. Tipo O.90.1. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 128, fig. 9.
260
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
n. 11 (Tav. 54, 11): fibula in ferro. Lungh. max. cons. 3.4; alt. max. ric. 3.9. Superficie corrosa e ossidata. Frammentaria; si conservano parte dell’arco e dell’ago. Tipo non puntualizzabile. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 128, fig. 9.
1.8; spessore 0.6); 1 vago discoidale a margini frastagliati del Tipo S.60.B.8. (diam. 1.5; spessore 0.8). Integri; superficie parzialmente abrase. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 128, fig. 9.
n. 12 (Tav. 54, 15): fibula in ferro. Lungh. max. cons. 6.5. Superficie corrosa e ossidata. Frammentaria, si conservano soltanto parte dell’ago a sezione circolare e della staffa, insieme a lembi di tessuto. Tipo non identificabile. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 128, fig. 9.
n. 19 (Tav. 54, 16): coppia di cerniere in ferro pertinenti a ramponi di calzari. Lungh. lamina 6; lungh. chiodi da 1.1 a 3.5. Superficie corrosa e ossidata. Integre. Si conserva una lamina di ferro in cui sono inseriti all’estremità due chiodini a testa circolare. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 128, fig. 9.
n. 13 (Tav. 54, 13): fibula in ferro. Lungh. ago e staffa cons. 9.9. Superficie corrosa e ossidata. Frammentaria, si conservano solo parte dell’ago a sezione circolare e della staffa, insieme a lembi di tessuto. Tipo non identificabile. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 128, fig. 9.
Tomba 187 (Saggio D; Tavv. 6, 24). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso nord-ovest/sud-est (lungh. 200; largh. 50; prof. 98), localizzata lungo il margine nord-orientale del Saggio D. A circa 50 dai margini superiori della fossa si rinviene una pietra di medie dimensioni posta all’altezza del cranio del defunto; altre due sono in corrispondenza del bacino ed un grande blocco squadrato in corrispondenza degli arti inferiori. La deposizione è primaria, in decubito laterale sinistro con gli arti inferiori piegati, in spazio vuoto. Dati antropologici. I resti umani appartengono a un individuo adulto maschile di 17-25 anni. Il suo scheletro è conservato abbastanza integralmente e, nonostante l’elevata frammentarietà, include sia il cranio che il postcranio. Le caratteristiche sessuali secondarie sono osservabili nella morfologia del cranio e del bacino. L’usura dei denti, limitata allo smalto del primo molare, indicherebbe una età alla morte giovane, tra 17 e 25 anni, così come le suture craniche ben separate e prive di segni di ossificazione. Nessuna anomalia viene rilevata, eccetto una lieve proliferazione (becco osteofitico) non significativa al margine superiore della prima vertebra del sacro. Il sesso archeologico non è determinabile. Dati archeologici. La sepoltura è priva di corredo. Inquadramento cronologico. Incerto.
n. 14 (Tav. 54, 10): fibula in ferro. Lungh. ago 3.2. Superficie corrosa e ossidata. Frammentaria, si conserva solo parte della staffa, insieme a lembi di tessuto. Tipo non identificabile. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 128, fig. 9. n. 15 (Tav. 54, 5): armilla in bronzo con capi aperti sovrapposti. Diam. 3.2; spessore verga 0.2. Patina verde sulla superficie. Integra. Tipo S.30.A.1. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 128, fig. 9. n. 16 (Tav. 54, 9): due anelli in argento con verga sottile. Diam. 2; spessore verga 0.1. Uno è integro, l’altro ricomposto. Tipo S.40.A.1. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 128, fig. 9. n. 17 (Tav. 54, 17): collana di 5 vaghi in pasta vitrea monocromi del Tipo S.60.A.1, varietà a; 4 a occhi del Tipo S.60.A.2, varietà b3; 10 del Tipo S.60.A.2, varietà b4; 3 del Tipo S.60.A.2, varietà b5; 6 del Tipo S.60.A.2, varietà b9; 1 del Tipo S.60.A.2, varietà c1 (diam. 0.6-1.3; spessore. 0.6-1.4). Integri. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 128, fig. 9.
Tomba 188 (Saggio D; Tavv. 6, 24). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso nord-ovest/sud-est (lungh. 200; largh. 91; prof. 200), localizzata nella
n. 18 (Tav. 54, 3): collana di 14 vaghi in ambra cilindrici del Tipo S.60.B.4 (diam. 0.7, lungh. 2); 6 vaghi discoidali del Tipo S.60.B.7 (diam. 261
Capestrano, I
(bilateralmente le cavità glenoidee mostrano una proliferazione marginale), il ginocchio destro (la superficie del piatto tibiale è caratterizzato da un significativo orlo osteofitico), le estremità degli arti (mano destra e piedi). Per quanto riguarda la mano destra, dal confronto con le ossa dell’estremità sinistra, è evidente la proliferazione dei margini dell’articolazione distale dei metacarpi dovuta alla degenerazione osteoartrosica, che non coinvolge le ossa carpali, ma colpisce tutti i metacarpi e le falangi, in maniera più grave il primo dito, pollice (fig.antr.online 188_03A,B,C,D). Nei piedi la lesione è invece di tipologia osteolitica e limitata al primo dito, infatti ha determinato una area di perdita di tessuto osseo puntiforme sulla superficie dell’articolazione prossimale della prima falange (fig.antr.online 188_04). Anche questa donna presenta, nell’ambito della normale variabilità umana, una caratteristica antropologica di tipo discontinuo, già rilevata in diversi casi in questa necropoli: un osso soprannumerario craniale (wormiano) localizzato al bregma. La lunghezza massima del femore destro (402 mm) e la lunghezza massima della tibia sinistra (328 mm) permettono di calcolare una statura in vita di circa 155 cm. Dati archeologici. Il corredo è composto da una coppa in ceramica a vernice nera (n. 2), contenuta da piccole pietre e alloggiata sui piedi del defunto; un’armilla in bronzo (n. 5) infilata all’avambraccio destro; alcuni vaghi di collana rinvenuti nella regione craniale (n. 7); frammenti di fibule sull’emitorace destro (nn. 3-4); un anello infilato alle dita della mano sinistra (n. 6). Il ripostiglio è composto da un’olla in ceramica comune (n. 1). Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Seconda metà IIIinizi II secolo a.C.
porzione sud-occidentale del Saggio D. È tagliata dalla sepoltura neonatale 136 e in parte dalla tomba a incinerazione 189; il lato corto occidentale e parte del lato lungo sudoccidentale sono tagliati dal corridoio di accesso della tomba a camera 190 (vedi, 220221, 263-266). Lungo il lato nord-orientale della fossa, a circa 110 di profondità dai suoi margini superiori, è ricavata una nicchia (largh. 63; prof. 37) funzionale all’alloggiamento del ripostiglio. Il piano di inumazione è ricavato in un dislivello del fondo della fossa. La deposizione è dorsale, primaria e nello spazio vuoto; l’inumato presenta il cranio volto a sud, gli arti superiori piegati e le mani giunte sul bacino, con gli arti inferiori distesi e paralleli. Nella terra di riempimento della fossa si rinvengono frammenti di cranio, probabilmente da una sepoltura sconvolta, pertinenti a un individuo femminile. Dati antropologici. Si raccolgono i resti umani di un individuo adulto femminile di circa 60 anni. La determinazione del sesso è limitata all’osservazione della morfologia del cranio e alla misurazione del capitello della testa omerale sinistra (40 mm) del caput femorale destro (42.3 mm). Per la stima dell’età alla morte è possibile osservare la superficie auricolare dell’ileo destro e sinistro corrispondenti a una età di oltre 60 anni, e l’aspetto della sinfisi pubica che indica una età in media di 60 anni (tra 48 e 72 anni). Si conferma che la morte sia avvenuta in età matura-avanzata poiché i frammenti di cranio mostrano una completa obliterazione delle suture e alcuni elementi dentari mascellari (P1 e P2 lato destro) e mandibolari (M1 e M2 lato sinistro) sono stati persi in vita (fig.antr.online 188_01A,B). L’analisi paleopatologica ha individuato una serie di anomalie scheletriche imputabili a osteoartrosi e localizzate sul tratto lombare della colonna vertebrale, all’epifisi prossimale della tibia destra, nelle mani e nei piedi. In particolare, sono tutte manifestazioni scheletriche di malattie articolari o artropatie secondo la terminologia archeo-antropologica. Nel caso della colonna vertebrale sono visibili becchi osteofitici di grave entità soltanto su L3, L4, L5, il resto dello scheletro assiale non presenta anomalie (fig.antr.online 188_02A,B). Le altre articolazioni colpite sono le spalle
n. 1 (Tav. 55, 8): olla globulare in impasto grezzo. Diam. orlo 28; alt. 32.2. Impasto duro, compatto, poroso con rari vacuoli distribuiti in maniera omogenea, frattura irregolare, con di dimensioni grandi; colore: Munsell 5YR tra 6/4 e 6/6. Superficie ruvida. Realizzata a mano. Ricomposta da vari frammenti. Tipo A.40.B.28. 262
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
scheda precedente). La sepoltura risulta profondamente disturbata, al punto che non è possibile identificare il tipo di cinerario utilizzato. Al suo interno si rinvengono numerosi frammenti ossei, con diverso grado di combustione. Sono inoltre presenti frammenti ceramici riconducibili probabilmente a due vasetti miniaturistici. Inquadramento cronologico. Prima età imperiale.
n. 2 (Tav. 55, 7): coppa a profilo globulare in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 20; alt. 8.6. Impasto tenero, poroso con rari vacuoli distribuiti in maniera disomogenea, frattura laminare, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 8/3. Vernice nera evanide, presente solo sull’orlo e sulla parete; colore: Munsell tra 10YR 3/4 e 2.5YR 4/4, le tracce sono presenti solo sull’orlo e sulla parete di una piccola porzione del vaso. Superficie polverosa. Ricomposta da vari frammenti. Tipo H.240.A.9.
Tomba 190 (Saggio D; Tavv. 6, 25). Tomba ipogeica “a grotticella” con corridoio di accesso a gradoni, localizzata in prossimità del margine occidentale del Saggio D; è tagliata dalle tombe 160, 162 e 191 e taglia le tombe 130, 125, 185 e 188 (vedi, 214, 216-217, 237238, 258-259, 262-263, 266). La camera presenta forma rettangolare con angoli arrotondati ed orientamento in senso est-ovest (lungh. 240; largh. 135; alt. della camera fino alla volta 150; prof. 224) e si apre sul corridoio di accesso a sud con un restringimento dell’accesso, con luce di 130, in corrispondenza del quale doveva essere alloggiato un elemento ligneo di chiusura, la cui presenza è attestata dal rinvenimento di chiodi in ferro (n. 15). Lungo le pareti della camera è sbozzata una risega che diviene più profonda in corrispondenza dei lati corti. Il corridoio di accesso (lungh. 260; largh. max. cons. 155; largh. min. 130; prof. 57 al primo gradino e 160 al piano d’accesso) è orientato lungo l’asse sud-nord e presenta quattro gradini nella sua porzione meridionale. La deposizione, dorsale, primaria e nello spazio vuoto. Il cranio al momento dello scavo risultava ruotato di 180° rispetto alla sua posizione originaria, probabilmente a seguito di un collasso dovuto all’originario posizionamento su un supporto in materiale deperibile; anche gli arti superiori erano leggermente obliqui rispetto al torace; gli arti inferiori distesi e allineati. Dati antropologici. L’individuo è un adulto femminile di circa 45-49 anni. Lo stato di conservazione è discreto. Lo scheletro include frammenti di cranio e ossa postcraniali dello scheletro assiale, arti superiori e inferiori incluse le estremità. Il cranio e il bacino presentano caratteristiche morfologiche femminili. La misura del diametro del capitello
n. 3 (Tav. 55, 3): fibula in ferro con arco semplice, a tutto sesto ampio e assottigliato. Lungh. max. ric. 3.6; alt. max. ric. 3.3. Superficie corrosa e ossidata. Frammentaria, mancante dell’ago. Tipo S.20.A.4, varietà b. n. 4 (Tav. 55, 4): fibula in ferro con arco semplice a tutto sesto, ampio e assottigliato. Lungh. max. ric. 4.8; alt. max. ric. 3.3. Superficie corrosa e ossidata. Frammentaria, mancante della molla. Tipo S.20.A.4, varietà b. n. 5 (Tav. 55, 2): armilla in bronzo con estremità aperte distinte e a fascia. Patina verde sulla superficie. Diam. 9; spessore verga 0.6. Integra. Tipo S.30.A.3. n. 6 (Tav. 55, 5): anello digitale in argento con verga sottile. Diam. 2.1; spessore verga 0.1. Ricomposto. Tipo S.40.A.1. n. 7 (Tav. 55, 6): collana composta da 2 vaghi in ambra a profilo compresso (diam. 0.7; spessore 0.4) del Tipo S.60.B.2; 4 vaghi in pasta vitrea monocromi (diam. 0.3-0.4; spessore 0.2-0.3) del Tipo S.60.A.2, varietà a, e 1 in bronzo del Tipo S.60.C.1 (diam. 0.2; spessore 0.8). Integri. n. 8: frammento in ferro con tracce di tessuto. Lungh. 2.6; spessore 0.6. Superficie corrosa e ossidata. Tipo e classe non puntualizzabili. Tomba 189 (Saggio D; Tavv. 6, 24). Tomba a incinerazione realizzata in una piccola fossa rettangolare orientata in senso nord-sud, con angoli arrotondati (lungh. 60; largh. 50; prof. non registrata), localizzata nel settore meridionale del Saggio D. Taglia in parte l’angolo meridionale della tomba 188 (vedi 263
Capestrano, I
radiale (21.11 mm) e del caput femorale destro (43.39 mm) rientrano nella variabilità femminile. La valutazione dell’usura dei denti indica una età tra 25 e 35 anni, a cui si aggiunge la considerazione che la maturazione scheletrica delle clavicole è completa e corrisponde a una età di oltre 30 anni. L’aspetto della superficie auricolare dell’ileo è compatibile con una età tra 45 e 49 anni. Una osservazione tafonomica riguarda la colorazione verde della tibia destra dovuta a contatto con oggetti di metallo ossidati. Infine dal “Riempimento corridoio 190” provengono altri resti umani di adulto: frammenti di diafisi di ossa lunghe degli arti superiori tra cui una ulna destra. Dati archeologici. Tra la deposizione e l’accesso alla camera, si rinvengono una lagynos in ceramica depurata acroma (n. 2) e un’olletta in ceramica comune (n. 12) frammentarie; un’altra lagynos in ceramica depurata acroma (n. 1); due piatti in ceramica a vernice nera (nn. 10-11); una coppa biansata della stessa classe (n. 6); una lucerna (n. 14) adagiata in una coppetta (n. 7); tre coppe e un piatto a vernice nera (nn. 3, 8-9). Nei pressi dell’angolo sud-occidentale della camera si rinvengono un’olletta in ceramica comune (n. 13), una coppa in ceramica a vernice nera (n. 5) ed una lagynos in ceramica a vernice nera frammentaria (n. 4). Uno specchio frammentario in bronzo (nn. 16) si rinviene adagiato sulla tibia sinistra. Alcuni reperti ritrovati all’interno della camera e nel corridoio di accesso sono pertinenti ad altre sepolture più antiche (per la tomba 185, vedi, 258-259). Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Seconda metà IIinizi I secolo a.C.
di inclusi; colore: Munsell 10YR 8/3. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Parzialmente ricomposta, mancante dell’orlo. Tipo D.190.2. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 121, fig. 16.
n. 1 (Tav. 56, 1): lagynos in ceramica depurata acroma. Diam. orlo 4.8; alt. 15. 3. Impasto duro, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 8/4. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Integra. Tipo D.120.1. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 121, fig. 16.
n. 6 (Tav. 56, 3): coppa a fondo convesso in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 11; alt. 6.1. Impasto duro, compatto, privo di inclusi; colore: Munsell 7.5YR 8/6. Vernice opaca, omogenea, evanide in prossimità dell’orlo; colore: Munsell 10YR 3/3. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Parzialmente ricomposta, mancante di parte dell’orlo. Tipo H.240.D.1. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 121, fig. 16.
n. 3 (Tav. 56, 2): coppa in ceramica depurata acroma. Diam. orlo 13; alt. max. cons. 4.5. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 2.5YR 3.5/0. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Parzialmente ricomposta. Il piede non è conservato. Tipo D.240.1. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 121, fig. 16. n. 4 (Tav. 56, 5): lagynos a profilo cilindrico in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 2.4; alt. 10.9. Impasto tenero, compatto, frattura regolare, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 8/4. Vernice di buona fattura, si presenta conservata solo su metà della superficie; colore: Munsell 7.5YR 2/. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Mancante di parte ventre e dell’ansa. Tipo H.120.4. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 121, fig. 16. n. 5 (Tav. 56, 11): coppa a profilo distinto in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 16.6; alt. 6.4. Impasto duro, compatto, frattura regolare, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 8/4. Vernice opaca non omogenea, evanide; colore: Munsell 5YR 2.5/1. Piede verniciato. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Ricomposta da cinque frammenti. Tipo H.240.C.4. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 121, fig. 16.
n. 2 (Tav. 56, 4): lagynos in ceramica depurata acroma. Diam. fondo 9.6; alt. max. cons. 22. Impasto duro, compatto, frattura regolare, privo 264
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
n. 12 (manca documentazione di dettaglio): olletta in ceramica comune. Diam. orlo 12.8; alt. 13.6. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con abbondanti inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR tra 55/6 e 3.5/0. Superficie ruvida. Realizzata al tornio. Ricomposta da vari frammenti. Presenta deformazione dovuta a manifattura grossolana e a difetti verificatisi durante la cottura. Tipo non puntualizzabile. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 121, fig. 16.
n. 7 (Tav. 56, 8): coppa biansata in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 13.8; alt. 6.7. Impasto duro, privo di inclusi; colore: Munsell 7.5YR 2/0. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.250.1. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 121, fig. 16. n. 8 (Tav. 56, 14): coppetta a profilo distinto in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 9.2; alt. 5.3. Impasto tenero, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 8/4. Vernice opaca, evanide; colore: Munsell 2.5YR 5/8. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.260.C.7. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 121, fig. 16.
n. 13 (Tav. 56, 13): olletta cilindrica in ceramica comune. Diam. orlo 9.2; alt. 8.6. Impasto duro, con inclusi di piccole e medie dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 5YR 6/8. Superficie ruvida. Realizzata al tornio. Integra. Tipo I.50.B.11. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 121, fig. 16.
n. 9 (Tav. 56, 10): piatto con vasca troncoconica e labbro rientrante in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 16.2; alt. 4.3. Impasto duro, privo di inclusi; colore: Munsell 7.5YR 8/4. Vernice distribuita su tutta la superficie, con colorazione diversa nella parte interna; colore: Munsell 5YR 6/8 e 5YR 2.5/1. Superficie liscia. Realizzato al tornio. Integro. Tipo H.290.B.1. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 121, fig. 16.
n. 14 (Tav. 56, 6): lucerna con serbatoio cilindrico in ceramica a vernice nera. Diam. vasca 4.2; lungh. becco 3; alt. 3.7. Impasto duro, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 5/8. Manca completamente la vernice. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Integra. Tracce di combustione sul becco Tipo M.A.2. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 121, fig. 16.
n. 10 (Tav. 56, 12): piatto con vasca troncoconica e labbro diritto in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 23; alt. 4.2. Impasto tenero, compatto, frattura regolare, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 8/4. Vernice lucida, omogenea; colore: Munsell 7.5YR 2/0. Superficie polverosa. Realizzato al tornio. Parzialmente ricomposto da numerosi frammenti. Tipo H.290.B.9. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 121, fig. 16.
n. 15 (Tav. 56, 16): sei chiodi in ferro. Diam. testa da 1.5 a 3; lungh. da 3.4 a 9.8. Superficie corrosa e ossidata. Integri, mutili, frammentari; superficie ossidata e corrosa. Quattordici del Tipo Q.110.1; uno del Tipo Q.110.2. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 121, fig. 16.
n. 11 (Tav. 56, 9): piatto con vasca troncoconica e labbro diritto in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 21.4; alt. 3.6. Impasto duro, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 8/4. Vernice opaca ed evanide: colore: Munsell 5YR 6/8. Superficie liscia. Realizzato al tornio. Ricomposto da vari frammenti. Tipo H.290.B.11. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 121, fig. 16.
n. 16 (Tav. 56, 7 e 15): specchio in bronzo. Diam. 8; spessore 0.2-0.3. Patina verde sulla superficie. Parzialmente ricomposto da cinque frammenti; superficie coperta di patina verde azzurra. Tipo R.40.1, varietà a. Bibliografia: d’Ercole e Cella 2007b, 121, fig. 16.
265
Capestrano, I
Tomba 191 (Saggio D; Tav. 6, manca planimetria di dettaglio). La sepoltura, venuta alla luce solo alla fine della campagna di scavo, non è stata interamente scavata, pertanto ne è stato evidenziato solo l’angolo nord-occidentale, il quale taglia il primo scalino del corridoio di accesso della tomba 190. Il resto della fossa presenta un andamento sud-est. Dimensioni dell’angolo posto in luce: lungh. (lato nord) 56; largh. (lato nord-ovest) 60; prof. 12. Dati antropologici. Sono disponibili per l’analisi antropologica solo alcuni frammenti di cranio, tra cui un processo mastoideo dalla morfologia femminile, e le prime due vertebre cervicali prive di anomalie. Dati archeologici. Non sono stati recuperati elementi del corredo. Inquadramento cronologico. Incerto.
III.2. FOSSASCOPANA: LA CAMPAGNA 2007 (TOMBE 194-258) (Federica Properzio; Deneb Cesana per le analisi antropologiche)4. Come nel caso dello scavo del 2003, il saggio aperto nel 2007 (il cui scavo è proseguito nel 2008) a est della strada antica, che si sovrapponeva in minima parte alla porzione meridionale del Saggio D (vedi, Tavv. 57-58), ha restituito prevalentemente tombe a fossa databili tra la fine del VII secolo a.C. e l’età ellenistica avanzata. Solo una sepoltura è del tipo “a grotticella” (tomba 214), mentre si registra un numero più consistente di tombe a incinerazione della prima età imperiale rispetto alle indagini del 2003 (tombe 194-196, 201, 203, 213, 218, 225-226, 253, 256). La tomba 248, di datazione incerta, presenta una deposizione solo parzialmente in connessione anatomica, all’interno di una fossa di forma irregolare, e non è pertanto chiaro se si tratti di una sepoltura di età diversa dal resto della necropoli o dell’esito dello sconvolgimento di sepolture circostanti. Nell’area si registra la presenza di alcuni addensamenti di sepolture, uno dei quali (nella porzione centrale del saggio, a ridosso del limite occidentale) presenta una forma quadrangolare, e l’altro sembra disporsi intorno a un’area circolare vuota (nella porzione meridionale).
Tomba 192 (Saggio D; Tav. 6, manca planimetria di dettaglio). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso ovest/est, originariamente numerata come 113bis (lungh. 116; largh. 53; prof. 33), localizzata nella porzione centrale del Saggio D. La fossa taglia la tomba 133 (vedi, 219). Dati antropologici. Il materiale antropologico appartiene ad un giovane individuo adulto di sesso femminile. Anche in questo caso il pessimo stato di conservazione, permette la determinazione del sesso e la stima dell’età alla morte in base a pochi indicatori: la morfologia dell’ileo, il diametro del caput femorale sinistro (36 mm). I denti, singolarmente conservati, non presentano usura. Il postcranio include frammenti di diafisi di arti superiori e inferiori, mani e piedi, e il tratto toracico della colonna vertebrale. Dati archeologici. Nella terra di riempimento si rinvengono frammenti di due chiodi in ferro. Mancano elementi di corredo. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Incerto.
Tomba 194 (Campagna 2007; Tav. 58, manca planimetria di dettaglio)5. Sepoltura a incinerazione realizzata in una piccola fossa pressoché rettangolare, orientata in senso est/ovest (lungh. 120; largh. 60; prof. 10), localizzata nei pressi del limite nordoccidentale del saggio di scavo. Nel riempimento si rinvengono le ceneri probabilmente appartenenti al defunto e scarsi resti ossei. 4 La schedatura e la documentazione grafica delle sepolture rinvenute nel corso del 2007 e dei rispettivi corredi è frutto del lavoro di tesi di laurea specialistica in Etruscologia e Antichità Italiche di Federica Properzio presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. Le analisi antropologiche sono a cura di Deneb Cesana. 5 Il numero 193, continuativo rispetto alla numerazione del 2003, non è stato assegnato all’inizio della campagna del 2007.
266
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
Inquadramento cronologico. Sulla base del rituale adottato, è plausibile ipotizzare una datazione nella prima età imperiale.
Dati antropologici. I resti dell’individuo della tomba in esame non risultano presenti in deposito quindi non disponibili all’analisi. Dati archeologici. Si rinvengono frammenti non diagnostici di un balsamario ceramico, un’olletta in ceramica comune e una lucerna, probabilmente sottoposti a combustione con le spoglie del defunto. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Sulla base del rituale adottato, è plausibile ipotizzare un inquadramento cronologico nella prima età imperiale.
Tomba 197 (Campagna 2007; Tavv. 58,59). Sepoltura a inumazione in fossa di forma rettangolare, orientata in senso sud-ovest/nordest (lungh. 190; largh. 80; prof. 8), localizzata nella porzione nord-occidentale del saggio di scavo. Taglia le tombe 222 e 246 (vedi, 285286 e 295-296). Nell’angolo settentrionale della fossa, si conserva il ripostiglio. Dell’individuo, probabilmente un adulto di sesso antropologico non identificato, si conservano pochi frammenti scheletrici, riferibili alle ossa lunghe degli arti superiori e inferiori. Dati antropologici. I resti dell’individuo della tomba in esame non risultano presenti in deposito quindi non disponibili all’analisi. Dati archeologici. Il corredo si compone di una fibula in ferro sulla clavicola sinistra (n. 4); una scodella in impasto buccheroide gli arti inferiori (n. 3). Il ripostiglio è composto da un’olla in impasto (n. 1), contenente una brocchetta in impasto buccheroide (n. 2). Sulla base della mancanza di armi nel corredo e della cronologia del contesto, il sesso archeologico potrebbe essere individuato come femminile; le dimensioni della fossa ne suggeriscono l’attribuzione a un individuo adulto. Inquadramento cronologico. Fine VI-V secolo a.C.
Tomba 195 (Campagna 2007; Tav. 58; manca la planimetria di dettaglio). Sepoltura a incinerazione realizzata in una piccola fossa quadrangolare, orientata in senso est/ovest (lungh. 77; largh. 70; prof. 15), localizzata nei pressi del limite nord-occidentale del saggio di scavo. Nel riempimento si rinvengono le ceneri probabilmente appartenenti al defunto e scarsi resti ossei. Dati antropologici. I resti dell’individuo della tomba in esame non risultano presenti in deposito quindi non disponibili all’analisi. Dati archeologici. Mancano completamente resti del corredo. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Sulla base del rituale adottato, è plausibile ipotizzare una datazione nella prima età imperiale.
n. 1 (Tav. 69, 4): olla in impasto. Diam. fondo: 13.5; alt. max. cons. 12.8. Impasto duro, poroso con rari vacuoli disposti in maniera disomogenea, frattura irregolare, con scarsi inclusi di piccole dimensioni; colore: Munsell 2.5YR 4/4. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Mancante della parte superiore. Tipo non identificabile.
Tomba 196 (Campagna 2007; Tav. 58, manca la planimetria di dettaglio). Sepoltura a incinerazione realizzata in una piccola fossa pressoché rettangolare, orientata in senso est/ovest (lungh. 120; largh. 50; prof. 15), localizzata nei pressi del limite nordoccidentale del saggio di scavo. Nel riempimento si rinvengono le ceneri probabilmente appartenenti al defunto e scarsi resti ossei. Dati antropologici. I resti dell’individuo della tomba in esame non risultano presenti in deposito quindi non disponibili all’analisi. Dati archeologici. Si rinvengono alcuni frammenti ceramici in impasto, non diagnostici, sottoposti anch’essi a combustione con le spoglie del defunto. Il sesso archeologico non è determinabile.
n. 2 (Tav. 69, 1): brocchetta globulare in impasto buccheroide. Diam. piede: 2.5; alt. 7.8. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con scarsi inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore Munsell 5YR 4/1. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Mancante di parte del collo, dell’orlo e dell’ansa. Probabilmente Tipo B.110.4
267
Capestrano, I
Munsell 2.5YR 3/4. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Mancante di gran parte della parete e dell’orlo. Tipo non identificabile.
n. 3 (Tav. 69, 2) coppa con vasca a calotta emisferica in impasto buccheroide. Diam. orlo 14; alt. 6.9. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 5Y 2.5/1. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Mancante di parte della parete. Tipo B.240.1.
n. 2 (Tav. 69, 5): brocchetta in impasto buccheroide. Diam. orlo 7; alt. 12.5. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con scarsi inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 5Y 2.5/1. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Mancante di parte della parete e delle anse. Tipo B.110.4.
n. 4 (Tav. 69, 3): frammento di fibula in ferro. Lungh. max. cons. 2.5; alt. max. cons. 0.8. Superficie corrosa e ossidata. Mancante dell’arco e della molla; si conserva solo la staffa con terminazione a ricciolo. Tipo non identificabile.
n. 3 (Tav. 69, 9): bacile in lamina di bronzo, con labbro ripiegato su una verga in ferro. Diam. orlo 21.6; alt. max. cons. 4. Patina verde sulla superficie. Mancante del fondo. Tipo O.330.B.2.
Tomba 198 (Campagna 2007; Tavv. 58, 59). Sepoltura a inumazione in fossa di forma rettangolare, orientata in senso nord-ovest/sudest (lungh. 290; largh. 90; prof. 10), localizzata nella porzione centrale del saggio di scavo. Deposizione dorsale e primaria, in pessime condizioni. Presso il lato corto sud-occidentale della fossa si conserva il ripostiglio. Al momento dello scavo si rinvengono solo due frammenti dei femori. Dati antropologici. Gli scarsissimi resti ossei conservati non consentono di proporre considerazioni sui caratteri biologici dell’inumato. Dati archeologici. Il corredo è composto da frammenti di fibule in ferro nella posizione del torace (nn. 4-6); un bacile in bronzo nella posizione usualmente occupata dai piedi (n. 3). Il ripostiglio è composto da un’olla in impasto (n. 1), contenente una brocchetta in impasto buccheroide (n. 2). Sulla base della mancanza di armi nel corredo e della cronologia del contesto, il sesso archeologico potrebbe essere identificato come femminile; le dimensioni della fossa ne suggeriscono l’attribuzione a un individuo adulto. Inquadramento cronologico. Seconda metà VI secolo a.C.
n. 4 (Tav. 69, 8): fibula in ferro con arco semplice rialzato. Lungh. max. ric. 3.5; alt. max. ric. 2.7. Superficie corrosa e ossidata. Mancante della molla. Tipo S.20.A.1, varietà a. n. 5 (Tav. 69, 7): fibula in ferro con arco a doppia (?) ondulazione. Lungh. max cons. 7; alt. max. ric. 4.8. Superficie corrosa e ossidata. Mancante di parte della staffa, dell’ago e della molla. Probabilmente ascrivibile al Tipo S.20.B.1. n. 6 (Tav. 69, 6) fibula in ferro con arco a doppia o tripla ondulazione. Lungh. max ric. 5; alt. max. ric. 4.8. Superficie corrosa e ossidata. Si conservano solo frammenti dell’ago, dell’arco e della molla. Tipo non identificabile. Tomba 199 (Campagna 2007; Tavv. 58, 59). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare orientata in senso sud-ovest/nord-est (lungh. 250; largh. 80; prof. 180), localizzata nell’angolo sud-orientale del saggio di scavo. Deposizione dorsale, primaria e in ambiente vuoto; il cranio è rivolto verso nord; gli arti superiori sono aderenti ai fianchi con le mani sulle ossa pelviche; gli arti inferiori allineati e i piedi sovrapposti. Dati antropologici. I resti scheletrici appartengono ad un individuo adulto forse maschile di età matura avanzata. Lo stato di conservazione è molto frammentario. Nel cranio, le morfologie della cresta nucale, del frontale, del margine sovraorbitale e della
n. 1 (Tav. 69, 10): olla ovoide in impasto con corpo ovoide e fondo piano. Diam. piede 21.6; alt. 14. Impasto duro, poroso con rari vacuoli distribuiti in maniera omogenea, frattura frastagliata, con inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: 268
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
Diam. orlo 3.3; alt. 2.5. Impasto duro, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; Munsell 5YR 8/2. Vernice scrostata, opaca e con imperfezioni di cottura; colore: Munsell 5R 2.5/1; l’interno e il fondo del piede sono risparmiati. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.260.A.12.
mandibola hanno caratteristiche maschili. Considerando che alcuni frammenti di cranio mostrano le suture coronale e sagittale quasi obliterate, si può ipotizzare una età adulta matura avanzata. Dati archeologici. Il corredo è composto da una fibula in ferro vicino all’arto superiore sinistro (n. 8); una coppa in ceramica a vernice nera (n. 2) e uno strigile in ferro tra gli arti inferiori (n. 7); una coppa e due coppette (nn. 1-3); un piatto (n. 5) in ceramica a vernice nera e un’olletta in ceramica comune presso i piedi (n. 6). Il sesso archeologico è determinabile come maschile. Inquadramento cronologico. Prima metà II secolo a.C.
n. 5 (Tav. 69, 15): piatto a vernice nera. Diam. orlo 19; alt. 4.2. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con scarsi inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 10YR 8/3. Vernice diluita, scrostata e opaca; colore: Munsell 7.5 YR 2.5/1, applicata per immersione su tutta la superficie tranne il fondo del piede. Superficie liscia. Realizzato al tornio. Ricomposto da più frammenti. Tipo H.290.C.7.
n. 1 (Tav. 69, 11): coppa a profilo globulare in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 20.6; alt. 7.2. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 5YR 8/2. Vernice consistente con riflessi metallici applicata per immersione su tutta la superficie tranne il fondo del piede; colore: Munsell 5YR 2.5/1. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Ricomposta da più frammenti. Tipo H.240.A.5.
n. 6 (Tav. 69, 16): olletta ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 8.7; alt. 9. Impasto duro, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10R 4/3. Superficie liscia. Realizzato al tornio. Integro. Tipo I.50.B.9, varietà f. n. 7 (Tav. 69, 17): strigile in ferro. Lungh. 40; largh. 3; spessore 0.4-0.8. Superficie corrosa e ossidata. Ricomposto da più frammenti. Tipo R.30.1.
n. 2 (Tav. 69, 12): coppa a profilo globulare in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 19; alt. 6.5. Impasto duro, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 5YR 8/2. Vernice coprente e opaca applicata per immersione su tutta la superficie tranne il fondo del piede; colore: Munsell 5YR 2.5/1. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.240.A.10.
n. 8 (Tav. 69, 18) fibula in ferro con piccolo arco semplice a tutto sesto. Lungh. max. ric. 6; alt. max. ric. 3.5. Superficie corrosa e ossidata. Mancante di parte della staffa e dell’arco. Tipo S.20.A.4, varietà a.
n. 3 (Tav. 69, 13): coppetta a profilo globulare in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 12.4; alt. 5. Impasto duro, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 2.5YR 5/3. Vernice coprente, scrostata e opaca applicata per immersione su tutta la superficie tranne il fondo del piede; colore: Munsell 5R 2.5/1. Superficie liscia, con aloni di cottura. Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.260.A.5.
Tomba 200 (Campagna 2007; Tavv. 58, 59). Sepoltura a inumazione in fossa di forma rettangolare, orientata in senso sud-ovest/nordest (lungh. 250; largh. 100; prof. 50), localizzata nella porzione nord-occidentale del saggio di scavo. Presso il lato corto nord-occidentale della fossa si conserva il ripostiglio. Deposizione dorsale, primaria, in pessimo stato di conservazione. Dati antropologici. I resti scheletrici sono limitati alle diafisi di ulna e radio e a frammenti indeterminabili.
n. 4 (Tav. 69, 14): coppetta miniaturistica a profilo globulare in ceramica a vernice nera. 269
Capestrano, I
sud-ovest/nord-est (lungh. 95; largh. 50; prof. 15), localizzata nella porzione nord-occidentale del saggio di scavo. Nel riempimento si rinvengono le ceneri probabilmente appartenenti al defunto e scarsi resti ossei. Dati antropologici. I resti dell’individuo della tomba in esame non risultano presenti in deposito quindi non disponibili all’analisi. Dati archeologici. Nella terra di riempimento si rinvengono frammenti ceramici pertinenti ad un’olletta in ceramica comune (n. 1) e ad una lucerna (n. 2), probabilmente sottoposti a combustione con le spoglie del defunto. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. I secolo d.C.
Dati archeologici. Il corredo si compone di due scodelle in impasto buccheroide rinvenute in corrispondenza dei piedi (nn. 3-4). Il ripostiglio è composto da un’olla in impasto (n. 1), contenente una brocchetta in impasto buccheroide, (n. 2). Sulla base della mancanza di armi nel corredo e della cronologia del contesto, il sesso archeologico potrebbe essere femminile; le dimensioni della fossa ne suggeriscono l’attribuzione a un individuo adulto. Inquadramento cronologico. Fine VI-prima metà V secolo a.C. n. 1 (Tav. 70, 4): olla globulare in impasto grezzo. Diam. orlo 21.6; alt. 14. Impasto duro, compatto, frattura frastagliata, con frequenti inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 2.5YR 3/2. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Mancante di parte della parete e del fondo. Tipo A.40.B.15.
n. 1 (Tav. 70, 5): olletta ovoide/piriforme in ceramica comune. Diam. orlo 6.4; alt. 9.3. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con abbondanti inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5R 4/4. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Mancante di parte della parete. Tipo I.50.B.15, varietà c.
n. 2 (Tav. 70, 1): brocchetta globulare miniaturistica in impasto buccheroide. Diam. orlo 5.2; alt. 7.5. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con scarsi inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 7.5R 4/1. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Mancante del fondo. Tipo B.110.5. n. 3 (Tav. 70, 2): scodella carenata in impasto buccheroide. Diam. orlo 16; alt. 6.5. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con scarsi inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 7.5R 4/1. Superficie lisciata. Realizzata al tornio. Integra. Tipo B.230.A.7. n. 4 (Tav. 70, 3): scodella carenata in impasto buccheroide. Diam. orlo 18; alt. max. cons. 5 Impasto duro, compatto, frattura regolare, con scarsi inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 7.5R 4/1. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Mancante del fondo. Tipo B.230.A.6. Tomba 201 (Campagna 2007; Tavv. 58, 59). Sepoltura a incinerazione realizzata in una piccola fossa rettangolare orientata in senso 270
n. 2 (Tav. 70, 6): lucerna a volute. Diam. disco 6.3; lungh. becco 3.4; alt. 1.7. Impasto duro, compatto, frattura netta, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 7.5YR 8/1. Realizzata a matrice. Superficie liscia. Mancante di parte del disco, della spalla e del fondo. Tipo non puntualizzabile. Tomba 202 (Campagna 2007; Tavv. 58, 59). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare orientata in senso nord-est/sud-ovest (lungh. 160; largh. 40; prof. 50), localizzata nella porzione settentrionale del saggio di scavo. Deposizione dorsale, primaria e in ambiente vuoto; il cranio è rivolto verso a sud; gli arti superiori sono aderenti ai fianchi e quelli inferiori allineati. Dati antropologici. Lo scheletro appartiene a un giovane individuo adulto forse maschile di 2025 anni. Lo stato di conservazione è frammentario e sono presenti i seguenti distretti scheletrici: cranio, arti superiori, arti inferiori. La giovane età è ipotizzata in base all’osservazione dell’usura dentaria che è
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
praticamente assente e quindi compatibile con una età alla morte tra 17 e 25 anni. Dati archeologici. Nel riempimento della fossa si rinvengono tre chiodi in ferro (n. 1) all’altezza del cranio e frammenti non diagnostici di un’olletta in ceramica comune nei pressi dei piedi. I primi sono probabilmente relativi a una cassa lignea all’interno della quale poteva essere deposto il defunto, i secondi al corredo sconvolto per un’azione di disturbo post-deposizionale. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico: data la mancanza di materiali di corredo, non è possibile proporre un inquadramento cronologico puntuale.
Tomba 204 (Campagna 2007; Tavv. 58, 60). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare orientata in senso sud-ovest/nord-est (lungh. 280; largh. 100; prof. 10), localizzata nell’area centrale del saggio di scavo. In corrispondenza dell’angolo settentrionale della fossa si conserva il ripostiglio. Deposizione dorsale, primaria e in ambiente vuoto; gli arti inferiori sono allineati e distesi. Dati antropologici. Lo stato di conservazione non permette di delineare il profilo biologico dell’individuo sepolto. I resti umani consistono in tre elementi dentari, molari, di adulto, diafisi di femore sinistro, frammento di tibia. Dati archeologici. Il corredo si compone di un sauroter in ferro all’altezza del cranio (n. 5); una fibula in ferro sullo sterno (n. 3); un pugnale a stami e il relativo fodero in ferro presso l’arto inferiore sinistro (n. 4); un bacile in lamina di bronzo sui piedi (n. 2). Il ripostiglio è composto da un’olla in impasto in pessimo stato di conservazione (non documentabile) e da una forma chiusa non identificabile in impasto buccheroide (n. 1). Il sesso archeologico è determinabile come maschile; le dimensioni della fossa ne confermano l’attribuzione a un individuo adulto. Inquadramento cronologico. Fine VII-prima metà VI secolo a.C.
n. 1 (Tav. 70, 7); tre chiodi in ferro. Diam. testa 2, 2, 1.6; lungh. 3.6, 5.1, 4.8. Superfici corrose e ossidate. Due integri, uno mancante della punta. Tipo Q.110.2. Tomba 203 (Campagna 2007; Tav. 58, manca la planimetria di dettaglio). Sepoltura a incinerazione realizzata in una fossa quadrangolare (lungh. 40; largh. 40; prof. 10), localizzata nella porzione settentrionale del saggio di scavo. Nel riempimento si rinvengono le ceneri probabilmente appartenenti al defunto e scarsi resti ossei. Dati antropologici. I resti dell’individuo della tomba in esame non risultano presenti in deposito quindi non disponibili all’analisi. Dati archeologici. Si rinvengono frammenti di un’olletta in ceramica comune (n. 1) e frammenti di una lucerna, probabilmente sottoposti a combustione con le spoglie del defunto. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Prima età imperiale.
n. 1 (Tav. 70, 9): forma chiusa di piccole dimensioni, con corpo ovoide e piede ad anello (forse una brocchetta o un’anforetta) in impasto buccheroide. Diam. fondo 5; alt. 8. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con scarsi inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore nero colore: Munsell 7.5R 4/1. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Mancante spalla, dell’orlo e dell’ansa. Tipo non identificabile. n. 2 (Tav. 70, 10): bacile a orlo perlinato e fondo concavo in lamina di bronzo. Diam. orlo 21.4; alt. 5. Patina verde sulla superficie. Integro. Tipo O.330.A.1. n. 3 (Tav. 70, 11): fibula a tripla ondulazione in ferro. Lungh. max. ric. 12; alt. 5. Superficie corrosa e ossidata. Mancante di parte della staffa e dell’ago. Probabilmente ascrivibile al Tipo S.20.B.4.
n. 1 (Tav. 70, 8) olletta in ceramica comune. Diam. fondo 3.2; alt. 7. Impasto tenero, compatto, frattura irregolare, con abbondanti inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10R 6/4. Superficie lisciata. Realizzata al tornio. Mancante di parte della parete e dell’orlo. Tipo non identificabile.
271
Capestrano, I
omogenea; colore crema: Munsell 7.5YR 8/4. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Mancante del collo e di parte delle anse. Vicino al Tipo I.20.3.
n. 4 (Tav. 70, 12): pugnale a stami concrezionato nel fodero in ferro, con due anelli da sospensione e frammenti della catena. Pugnale: lungh. max. ric. 37; lama: lungh. max. ric. 26.8, largh. max. 4, spessore 0.8; fodero: largh. max. 4.8, spessore lamina 0.6; anelli da sospensione: diam. 2.8, spessore verga 0.6. Superficie corrosa e ossidata. Il pugnale risulta concrezionato nel fodero e manca di parte del codolo e degli stami. Probabilmente Tipo T.10.1.
n. 2 (Tav. 71, 1): coppetta a profilo carenato in ceramica comune. Diam. orlo 9.2; alt. 3.2. Impasto duro, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 8/3. Vernice diluita, scrostata, opaca; colore: Munsell 5YR 3/1, applicata per immersione su tutta la superficie tranne il fondo del piede. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo I.260.3.
n. 5 (Tav. 70, 13): sauroter in ferro. Lungh. 12.5; diam. 1. 8. Superficie corrosa e ossidata. Integro. Tipo T.60.1.
n. 3 (Tav. 71, 3): olletta ovoide/piriforme in ceramica comune. Diam. orlo 6.5; alt. 9.2. Impasto duro, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 5YR 5/2. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo I.50.B.15, varietà c.
La tomba 205 è stata individuata, numerata nella planimetria alla Tav. 58, ma non è stata scavata. Tomba 206 (Campagna 2007; Tavv. 58, 60). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare orientata in senso sud-ovest/nord-est (lungh. 130; largh. 80; prof. 20), localizzata nell’area sud-occidentale del saggio di scavo. Deposizione dorsale, primaria in pessimo stato di conservazione. Si rinvengono pochi frammenti di ossa umane pertinenti ai femori di un individuo sub-adulto. Dati antropologici. I resti dell’individuo della tomba in esame non risultano presenti in deposito quindi non disponibili all’analisi. Dati archeologici. Il corredo è composto da tre balsamari in vetro (nn. 5-6, il n. 7 si rinviene nella terra di riempimento); un’olletta in ceramica comune (n. 3); una coppetta in ceramica a vernice nera (n. 2) e una moneta in bronzo (n. 9) presso la testa; una lucerna (n. 4) e un’anforetta in ceramica comune (n. 1) presso i piedi. Si rinvengono numerosi chiodi in ferro (n. 8) lungo l’intero perimetro della fossa, verosimilmente pertinenti alla cassa lignea che conteneva l’inumato. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Seconda metà II secolo d.C.
n. 4 (Tav. 71, 4): frammento di lucerna a volute con spalla decorata da due solchi concentrici. Diam. disco 9; lungh. 8.8; alt. 1. Impasto duro, compatto, frattura netta, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 5YR 8/2. Superficie liscia. Realizzata a matrice. Tipo non identificabile. n. 5 (Tav. 71, 5) balsamario piriforme in vetro. Diam. orlo 2.5; alt. 14.5. Vetro trasparente con patina iridea. Ricomposto da più frammenti. Tipo P.130.9. n. 6 (Tav. 71, 6): balsamario piriforme in vetro. Diam. orlo 2; alt. 9.3. Vetro trasparente, colore tendente al blu. Ricomposto da più frammenti. Tipo P.130.9. n. 7 (Tav. 71, 7): balsamario piriforme in vetro. Diam. fondo 3.2; alt. 3. Vetro opaco, colore tendente al verde. Mancante del collo. Tipo P.130.9. n. 8 (Tav. 71, 8): dodici chiodi in ferro. Diam. testa 1.6; lungh. max. 9, min. 8. Superfici corrose e ossidate. Frammentari. Tipo Q.110.1.
n. 1 (Tav. 71, 2): anforetta in ceramica comune. Diam. piede 5.8; alt. 18.5. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera
n. 9 (Tav. 71, 9) Moneta in bronzo. 272
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
Superficie lisciata e ingobbiata; colore ingobbio: Munsell 5YR 4/4. Realizzata al tornio. Ricomposta da più frammenti. Tipo L.260.1.
Cronologia 119-121 d.C. Identificazione e attribuzione Zecca: Roma Autorità emittente: Adriano Descrizione fisica Metallo: AE Modulo: 25.00 mm Peso: 14.00 gr. Asse: 6 Nominale: Dupondio Conservazione: mediocre Descrizione del tipo D/ Busto radiato e drappeggiato di Adriano volto a d. A s., [IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS] AVG [P M TR P COS III] (). R/ Aeternitas stante drappeggiata, testa volta a s.; regge nella mano d., la testa del sole; nella mano s., la testa della luna. A s., [AET]ER[N]IT[AS AVGVSTI] (); al centro, S C. Bibliografia: RIC II Hadrian 597 D; BMC 1219 Cfr.: ANS 1944.100.45634
n. 12 (Tav. 71, 11): balsamario ceramico. Diam. fondo 3; alt. 5.5. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni; color: Munsell 7.5YR 8/3. Realizzato al tornio. Mancante del collo e di parte del ventre. Tipo non identificabile.
La scheda scientifica adotta i campi della scheda NU (Numismatica), i cui parametri sono stati fissati dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD).6
Nei pressi della tomba 206 si rinvengono alcuni materiali sporadici, provenienti probabilmente dallo sconvolgimento di tombe vicine: n. 10 (Tav. 71, 12): scodella con vasca a calotta in impasto grezzo. Diam. orlo 14; alt. max. cons. 2.5. Impasto tenero, poroso con frequenti vacuoli distribuiti in maniera omogenea, frattura irregolare, con scarsi inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 2.5YR 3/2. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Mancante del fondo. Tipo A.230.A.2. n. 11 (Tav. 71, 10): coppetta carenata in ceramica a pareti sottili. Diam. orlo 8; alt. 5.5. Impasto duro, compatto, frattura netta, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea, colore: Munsell 5YR 6/6. 6
Vedi appendice numismatica in questo Volume a pag.497 a cura della dott.ssa Stefania Montanaro. 273
Tomba 207 (Campagna 2007; Tavv. 58, 60). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare orientata in senso nord-est/sud-ovest (lungh. 260; largh. 100; prof. 50), localizzata nell’area sud-orientale del saggio di scavo. È tagliata dalla tomba 228 in corrispondenza del suo lato nord-orientale (vedi, 289). Presso l’angolo settentrionale della fossa, si conserva il ripostiglio. Deposizione dorsale, primaria e in ambiente vuoto, in buono stato di conservazione; il cranio è in posizione frontale; gli arti superiori sono piegati con le mani sulle ossa pelviche; quelli inferiori distesi e allineati. Dati antropologici. L’inumato è un individuo adulto maschile di 30-34 anni. Lo stato di conservazione è frammentario e lacunoso, ma tutti i distretti scheletrici sono rappresentati (cranio, colonna vertebrale e cassa toracica, arti superiori, arti inferiori, mani e piedi). Per la determinazione del sesso sono osservabili la morfologia del cranio e della mandibola, dell’incisura ischiatica destra molto stretta. La stima dell’età può essere valutata osservando l’aspetto della superficie auricolare corrispondente a 30-34 anni. L’articolazione del dente dell’epistrofeo mostra una lieve proliferazione di tessuto osseo riconducibile in generale a osteoartrosi, non significativa. L’unica anomalia rilevante riguarda l’usura dentaria, apparentemente più marcata nei denti anteriori che in quelli giugali (fig.antr.online 207_01). La statura in vita è calcolata a partire dalla lunghezza massima della tibia destra (373 mm) e risulta di 172.5 cm. Dati archeologici. Il corredo si compone di due spiedi in ferro posti uno a destra e l’altro a sinistra degli arti inferiori (nn. 3-4), una spada in ferro (n. 6) sopra la quale è deposto un coltello-cote in ferro (n. 7); un bacile in lamina di bronzo (n. 2) contenente un rasoio in bronzo
Capestrano, I
Superficie corrosa e ossidata. Mancante del manico; si conservano tracce di tessuto. Tipo T.30.1.
(n. 5). Il ripostiglio è composto da un’olla in impasto, scarsamente conservata (n. 1). Il sesso archeologico è determinabile come maschile. Inquadramento cronologico. Metà VI secolo a.C. n. 1 (Tav. 72, 1): olla in impasto. Diam. fondo 19; alt. max. cons. 7.4. Impasto tenero, poroso con frequenti vacuoli distribuiti in maniera omogenea, frattura frastagliata, con abbondanti inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10R 5/6. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Si conserva solo parte del fondo piano e del ventre, probabilmente cilindro-ovoide. Tipo non identificabile. n. 2 (Tav. 72, 2): bacile a orlo perlinato e fondo concavo in lamina di bronzo. Diam. orlo 25; alt. 6.5. Patina verde sulla superficie. Mancante del fondo. Tipo O.330.A.1. n. 3 (Tav. 72, 6): spiedo in ferro. Lungh. max. cons. 76; spessore stelo 1.1. Superficie corrosa e ossidata. Lacunoso della testa; si conservano tracce di tessuto sulla superficie. Tipo non identificabile. n. 4 (Tav. 72, 7): spiedo in ferro. Lungh. 35; spessore stelo 1.2. Superficie corrosa e ossidata. Lacunoso della testa e di parte del corpo; si conservano tracce di tessuto sulla superficie. Tipo non identificabile. n. 5 (Tav. 72, 3): rasoio semilunato in bronzo. Lungh. 7; largh. 3.2; spessore lama 0.1. Patina verde in superficie. Si conservano tre forellini forse per il fissaggio di un rivestimento in materiale deperibile. Tipo R.50.2.
La tomba 208 è stata localizzata a ridosso del limite sud-occidentale del saggio di scavo e posizionata nella planimetria visibile alla Tav. 58, ma risultava completamente sconvolta. Essa risulta tagliata dall’impianto delle tombe 256257 e taglia la tomba 209. Dati antropologici. I resti umani raccolti in questo contesto tombale appartengono ad un individuo adulto in condizioni di conservazione pessime. Tutti i distretti scheletrici sono presenti, incluse le estremità degli arti, ma non integri. La morfologia del cranio presenta caratteristiche femminili sia nel frontale che nell’occipitale. A confermare la determinazione del sesso anche la misura del caput femorale destro (44.39 mm) e sinistro (43.30 mm). L’andamento dell’incisura ischiatica è compatibile con un individuo femminile. La stima dell’età è possibile soltanto considerando la completa maturazione scheletrica della clavicola che indica una età matura di oltre 30 anni circa. Confermato dalla valutazione del grado di ossificazione delle suture ectocraniche che risulta nel range 31-65 (con una media di 45.2 anni). A confermare questa stima di età matura avanzata si rileva anche la presenza di osteoartrosi, localizzata nella seconda vertebra cervicale (epistrofeo) che sul dente presenta una proliferazione di lieve entità misurabile in 2 mm. Tomba 209 (Campagna 2007; Tavv. 58, 60). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare orientata in senso nord-ovest/sud-est (lungh. 160; largh. 85; prof. 10), localizzata nei pressi del limite sud-occidentale del saggio di scavo, disturbata dalle tombe 208 e 257 (vedi scheda precedente e 303-304). La sepoltura risulta completamente asportata nella sua porzione superiore; dell’inumato, in posizione dorsale e primaria; gli arti inferiori sono allineati e distesi. Dati antropologici. Si conservano pochi resti ossei determinabili: un frammento di ileo con incisura ischiatica maschile, una testa femorale e due diafisi di femori di adulto.
n. 6 (Tav. 72, 5): spada in ferro con la lama concrezionata nel fodero in ferro e legno. Lungh. 79; lama: lungh. 62.4; spessore 0.8; elsa: lungh. 16, spessore lamina 0.8; fodero: max. espansione 4.8. Superficie corrosa e ossidata. Mancante di parte dell’elsa. Tipo T.20.1. n. 7 (Tav. 72, 4): coltello affila lama in ferro. Lungh. max. cons. 32.5; largh. 2, spessore 0.4. 274
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
Dati archeologici. Il corredo risulta profondamente disturbato; direttamente a sud della sepoltura, si rinviene un frammento di brocchetta di impasto buccheroide (n. 1), che potrebbe in via altamente ipotetica esservi ascritto. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico: sulla base delle relazioni stratigrafiche sopra descritte, è possibile che la tomba 209 sia la più antica del piccolo gruppo di cui fa parte e, sulla base dell’ansa in impasto buccheroide n. 1, potrebbe essere attribuita al periodo arcaico.
un’olla in impasto (n. 1). La composizione del corredo sembra confermare l’attribuzione a un individuo di sesso archeologico femminile. Inquadramento cronologico. VI secolo a.C.
n. 1 (Tav. 71, 13): frammento di ansa di brocchetta in impasto buccheroide. Spessore 3; alt. 11. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 10R 4/1. Superficie liscia. Tipo non identificabile.
n. 2 (Tav. 72, 15): fibula in ferro con arco a tripla ondulazione. Lungh. max. cons. 4.5; alt. max. cons. 3. Superficie corrosa e ossidata. Mancante dell’ago e di parte della staffa. Si conserva una catenina in ferro saldata all’arco. Probabilmente ascrivibile al Tipo S.20.B.4.
n. 1 (Tav. 72, 8): olla in impasto. Diam. fondo 15; alt. 8.2. Impasto tenero, poroso con frequenti vacuoli distribuiti in maniera omogenea, frattura frastagliata, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10R 4/3. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Si conserva il fondo. Tipo non identificabile.
n. 3 (Tav. 72, 10): fibula in ferro, con catenina agganciata. Lungh. max. cons. 4; alt. max. cons. 1.5. Superficie corrosa e ossidata. Mancante dell’arco e dell’ago, si conserva solo parte della staffa desinente a ricciolo. Tipo non identificabile.
Tomba 210 (Campagna 2007; Tavv. 58, 60). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso nord-ovest/sud-est (lungh. 230; largh. 80; prof. 10), localizzata presso il margine sud-orientale del saggio di scavo. In corrispondenza dell’angolo meridionale della fossa, si conserva il ripostiglio. Deposizione dorsale, primaria e in ambiente vuoto; il cranio è in posizione frontale e gli arti superiori allineati ai fianchi; mancano gli arti inferiori. Dati antropologici. Lo scheletro appartiene a un individuo adulto probabilmente di sesso femminile e di giovane età (17-25 anni). A causa dello stato di conservazione estremamente frammentario e lacunoso, la determinazione del sesso è basata soltanto sulla morfologia della mandibola e la stima dell’età sull’osservazione dell’usura dentaria. Infatti, eccetto alcuni frammenti di vertebre cervicali e poche diafisi degli arti superiori, il cranio e i denti sono i resti maggiormente disponibili all’analisi. Sul frontale è ben visibile la sutura metopica, un carattere epigenetico del cranio che in questa necropoli compare esclusivamente su questo individuo. Dati archeologici. Il corredo si compone di una collana di vaghi in pasta vitrea, ambra e bulle in bronzo sul collo (n. 8), cinque fibule in ferro sul torace (nn. 2-7). Il ripostiglio è composto da
n. 4 (Tav. 72, 11) fibula in ferro. Lungh. max. cons. 8.5; alt. max. cons. 1. Superficie corrosa e ossidata. Si conserva solo la staffa desinente a ricciolo e parte dell’ago. Tipo non identificabile. n. 5 (Tav. 72, 12): fibula in ferro con catenina agganciata. Lungh. max. cons. 3; alt. max. cons. 5.5. Superficie corrosa e ossidata. Si conserva solo parte della staffa desinente a ricciolo. Tipo non identificabile. n. 6 (Tav. 72, 13): fibula in ferro. Lungh. max. cons. 3.5; alt. 0.8. Superficie corrosa e ossidata. Si conserva solo un frammento di staffa. Tipo non identificabile. n. 7 (Tav. 72, 14): fibula in ferro con catenina agganciata. Lungh. max. cons. 3; alt. max. cons. 1.2. Superficie corrosa e ossidata. Si conserva solo parte della staffa desinente a ricciolo. Tipo non identificabile. n. 8 (Tav. 72, 9): collana composta da 11 pendenti a bulla in bronzo (diam. 1.6; spessore 275
Capestrano, I
n. 4 (Tav. 73, 4): sauroter in ferro. Lungh. 8; diam. 1. Superficie corrosa e ossidata. Ricomposto da più frammenti. Tipo T.60.1.
1) del Tipo S.50.3; 2 vaghi in ambra (diam. 1.11.6; spessore 0.4-0.7) 1 a profilo compresso del Tipo S.60.B.2. e 1 discoidale del Tipo S.60.B.7; 5 vaghi in pasta vitrea a zig-zag del Tipo S.60.A.2, varietà e2; 1 a zig-zag del Tipo S.60.A.2, varietà e3; 4 a zig-zag del Tipo S.60.A.2, varietà e4; 1 a zig-zag 5 vaghi in pasta vitrea a zig-zag del Tipo S.60.A.2, varietà e5 (diam. 1; spessore 0.6). Integri.
Tomba 212 (Campagna 2007; Tavv. 58, 61). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare con orientamento sud-ovest/nord-est (lungh. 200; largh. 90; profondità 5), localizzata nell’area centrale del saggio di scavo. Dati antropologici. La sepoltura risulta priva di resti antropologici. Dati archeologici. Il corredo si compone di un pendaglio in bronzo (n. 7) e due fibule in ferro sul torace (nn. 5-6); un’armilla in ferro (n. 8) e un pugnale a stami con la punta rivolta verso la posizione della testa del defunto, con il fodero in ferro (nn. 9-10) in corrispondenza delle ossa pelviche; quattro vasi in impasto buccheroide (nn. 1-4) frantumati ritualmente ai lati lunghi della fossa e presso i piedi del defunto e un’olla in impasto presso l’angolo sud-occidentale della fossa. I caratteri del corredo suggeriscono una identificazione del sesso archeologico come maschile e, data l’assenza completa di resti antropologici, l’evidenza può essere interpretata come cenotafio, riferibile comunque a un individuo adulto. Inquadramento cronologico. Prima metà VI secolo a.C.
Tomba 211 (Campagna 2007; Tavv. 58, 61). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare orientata in senso sud-ovest/nord-est (lungh. 230; largh. 90; prof. 10), localizzata nella porzione centrale del saggio di scavo e tagliata dalle tombe 227 e 245 (vedi, 288-289 e 295). Presso l’angolo settentrionale della fossa, si conserva il La deposizione è dorsale, primaria, con gli arti inferiori allineati. Dati antropologici. Si conservano solo due diafisi di tibia di un individuo adulto. Dati archeologici. Il corredo si compone di una spada in ferro con la punta volta verso il capo dell’inumato (n. 3); un bacile in lamina di bronzo (n. 1) contenente un rasoio in ferro (n. 2); nel riempimento della fossa si rinviene un sauroter in ferro (n. 4). Il ripostiglio è composto da un’olla in impasto profondamente disturbata dagli interventi post deposizionali (non documentabile). Il sesso archeologico è determinabile come maschile. Inquadramento cronologico. Metà VI secolo a.C.
n. 1 (Tav. 74, 2): anforetta globulare in impasto buccheroide. Diam. orlo 8; alt. 13. Impasto tenero, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5R 3/1. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Ricomposta da più frammenti. Tipo B.20.1.
n. 1 (Tav. 73, 1): bacile con orlo indistinto in lamina di bronzo. Diam. orlo 20; alt. 6. Patina verde in superficie. Integro. Tipo O.330.B.1.
n. 2 (Tav. 74, 1): brocca globulare in impasto buccheroide. Diam. orlo 12; alt. max. cons. 21. Impasto tenero, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 4/1. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Sulla spalla sono incisi motivi riproducenti probabilmente degli scudi, campiti da fiori di loto e superiormente, da una fila di rombi. Mancante del fondo. Tipo B.110.1.
n. 2 (Tav. 73, 2): rasoio in ferro a lama allungata. Lungh. max. cons. 8.2; largh. max. cons. 2.5; spessore 0.2. Superficie corrosa e ossidata. Mancante del manico e di parte del corpo. Tipo R.50.3. n. 3 (Tav. 73, 3): spada in ferro con elsa rivestita in legno. Lungh. 65.5; lama: lungh. 54; largh. max. espansione 4.5, spessore max. 1.2; elsa: largh. max. espansione 3.6; spessore lamina 0.8; spessore rivestimento 0.2. Superficie corrosa e ossidata. Mancante della punta. Tipo T.20.1.
n. 3 (Tav. 74, 3): forma chiusa di piccole dimensioni (probabilmente un’anforetta) in 276
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
n. 10 (Tav. 74, 9): fodero di pugnale in ferro. Lungh. 29; largh. max. espansione 3.7; spessore lamina 0.1. Superficie corrosa e ossidata. Integro. Tipo T.15.1.
impasto buccheroide. Corpo globulare, piede a disco. Diam. piede 5.9; alt. max. cons. 5. Impasto tenero, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 4/1. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Mancante della parete e dell’orlo. Tipo non identificabile.
Tomba 213 (Campagna 2007; Tavv. 58, 61). Sepoltura a incinerazione in fossa rettangolare orientata lungo l’asse sud-ovest/nord-est (lungh. 100; largh. 50; prof. non registrata), localizzata nella porzione centrale del saggio di scavo. Dati antropologici. Si raccolgono pochi frammenti di cranio, di un colore bianco compatibile con azione di combustione e incinerazione il cui peso totale risulta di 151.10 gr. Dati archeologici. Si rinvengono frammenti ceramici in ceramica comune, pertinenti ad un’olletta (n. 1); un’anforetta (n. 2) e una coppetta (n. 3); tre chiodi (n. 4) e borchiette (n. 5) in ferro forse pertinenti alla cassa lignea, probabilmente sottoposti a combustione con le spoglie del defunto. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. I secolo d.C.
n. 4 (Tav. 74, 4): forma chiusa di piccole dimensioni (probabilmente un’anforetta) in impasto buccheroide. Piede a disco. Realizzata al tornio. Diam. piede 5; alt. max. cons. 1. Impasto tenero, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 4/1. Superficie liscia. Mancante della parete e dell’orlo. Tipo non identificabile. n. 5 (Tav. 74, 6): fibula in ferro con arco a doppia ondulazione. Lungh. max. cons. 6.9; alt. 4. Superficie corrosa e ossidata. Mancante dell’ago e della staffa. Tipo S.20.B.2. n. 6 (Tav. 74, 5): fibula in ferro con arco a doppia ondulazione. Lungh. max. cons. 6; alt. max. cons. 3.5. Superficie corrosa e ossidata. Mancante di parte dell’arco, dell’ago e della staffa. Probabilmente ascrivibile al Tipo S.20.B.2.
n. 1 (Tav. 73, 6): anforetta in ceramica comune. Diam. orlo 11; alt. max. cons. 6. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 8/2. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Mancante del ventre. Tipo I.20.4.
n. 7 (Tav. 74, 7): armilla in ferro con capi aperti e verga spessa a doppio avvolgimento. Diam. 5.8; larghezza 1.2; spessore verga 0.6. Superficie corrosa e ossidata. Tipo S.30.A.5. n. 8 (Tav. 74, 8): pendente conico in lamina di bronzo con appiccagnolo, cui si conserva agganciato un anello di catenina. Alt. 4.5; spessore. 0.9. Patina verde sulla superficie. Integro. Tipo S.50.1.
n. 2 (Tav. 73, 5): olletta ovoide/piriforme in ceramica comune. Diam. orlo 7; alt. 9.5. Impasto duro, poroso con frequenti vacuoli distribuiti in maniera omogenea, frattura irregolare, con abbondanti inclusi di piccole dimensioni; colore: Munsell 7.5R 7/1. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Ricomposta da più frammenti. Tipo I.50.B.15, varietà b.
n. 9 (Tav. 74, 10): pugnale a stami con un anello da sospensione concrezionato. Lungh. max. cons. 24; lama: lungh. max. 15.2, largh. max. 2.8, spessore max. 0.8; codolo: lungh. max. cons. 8.8, spessore 0.6; anello da sospensione: diam. 2.4, spessore 0.1. Superficie corrosa e ossidata. Mancante della punta e dell’elsa. Probabilmente Tipo T.10.1; fodero Tipo T.15.1.
n. 3 (Tav. 73, 7): coppetta globulare in ceramica comune. Diam. orlo 12; alt max. cons. 1.5. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 5/3. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Mancante di parte della vasca e del fondo. Tipo I.260.1.
277
Capestrano, I
tomba. Nel corridoio di accesso, a ridosso dell’ingresso alla camera, si rinvengono una coppa in ceramica a vernice nera (n. 3) a nordest e un piatto nella stessa classe (n. 6) a sudovest. La presenza dello spillone e della tanagrina sembrano orientare l’identificazione del sesso archeologico come femminile. Inquadramento cronologico. Seconda metà II secolo a.C.
n. 4 (Tav. 73, 8): tre chiodi in ferro. Diam. testa 1, 1.6, 1; lungh. 8.4, 8, 5.6. Superfici corrose e ossidate. Due del Tipo Q.110.1; uno del Tipo Q.110.2. n. 5 (Tav. 73, 9): quattro chiodi in ferro di piccole dimensioni. Diam. testa 0.8; lungh. 2. Superfici corrose e ossidate. Tipo Q.110.3. Tomba 214 (Campagna 2007; Tavv. 58, 62). Tomba ipogeica “a grotticella” con corridoio di accesso (lungh. 135; largh. max. 177; alt. 114), localizzata nella porzione nord-orientale del saggio di scavo. La camera presenta pianta irregolarmente trapezoidale orientata in senso sud-est/nord-ovest. L’accesso alla camera è segnato da un restringimento in corrispondenza di due stipiti (con una luce di 100 ca); il corridoio di accesso (lungh. 230; largh. max. 130; largh. min. 100; alt. max.; alt. max. 115; alt. min. 50) è orientato in senso sudovest/nord-est e presenta un solo gradino (a 137 ca dall’accesso alla camera; alt. 20 ca.). La deposizione è dorsale, primaria e in ambiente vuoto; è probabile che fosse originariamente realizzata su un supporto in materiale deperibile, vista la posizione scomposta dei resti: il cranio, infatti, è rivolto a sud-ovest; l’arto superiore destro è piegato verso l’esterno; il torso lievemente ruotato a destra; gli arti inferiori allineati e distesi. Dati antropologici. L’inumato è un subadulto di circa 4-6 anni (d’Ercole e Martellone 2007b), purtroppo i resti umani del defunto sepolto in questa tomba non risultano presenti in deposito quindi non disponibili all’analisi. Dati archeologici. Il corredo è composto da una coppa biansata (n. 4), una coppetta (n. 5), una lagynos (n. 2) in ceramica a vernice nera deposte nell’area antistante l’accesso, a nord-est del defunto; una tanagrina in impasto (n. 14) vicino alla mano destra; due balsamari ceramici (nn. 9-10) sugli arti inferiori; un’olletta in impasto (n. 1) presso il lato di fondo della camera; un’olletta in ceramica comune (n. 7) e uno specchio in bronzo (n. 11) a sud degli arti inferiori; una lucerna (n. 8) e uno spillone in osso a figura femminile (n. 12) ai piedi. Presso il lato orientale della grotticella si rinvengono diversi chiodi in ferro (n. 13), forse pertinenti ad un tavolato di chiusura dell’ingresso della 278
n. 1 (Tav. 75, 1): olletta globulare in impasto grezzo. Diam. orlo 12; alt. 19.5. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con rari inclusi di piccole dimensioni; colore: Munsell 2.5YR 4/8. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Parzialmente ricomposta da più frammenti. Tipo A.50.B.2. n. 2 (Tav. 75, 3): lagynos a profilo lenticolare in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 2.4; alt. 10.5. Impasto duro, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10R 5/6. Vernice coprente, scrostata e con riflessi metallescenti applicata per immersione su tutta la superficie tranne il fondo del piede; colore: Munsell 10YR 3/1. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.120.5. n. 3 (Tav. 75, 4): coppa a profilo distinto in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 16; alt. 5.8. Impasto duro, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10YR 7/2. Vernice diluita, scrostata, opaca applicata per immersione su tutta la superficie tranne il fondo del piede; colore: Munsell 10YR 4/2. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.240.C.5. n. 4 (Tav. 75, 5): coppa biansata in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 14.5; alt. 6.5. Impasto duro, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: 10R 5/6. Vernice coprente, scrostata e opaca, applicata per immersione su tutta la superficie tranne il fondo del piede; imperfezioni di cottura; colore: Munsell 7.5YR 3/1. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Ricomposta da più frammenti. Tipo H.250.1.
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
n. 10 (Tav. 75, 10): balsamario ceramico fusiforme. Diam. orlo 2.4; alt. 14.7. Impasto duro, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10R 4/4. Vernice nera sul collo, diluita, scrostata e opaca; colore: Munsell 5R 4/1. Superficie polverosa. Realizzato al tornio. Integro. Tipo N.130.5.
n. 5 (Tav. 75, 6): coppetta a profilo distinto in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 9.9; diam. inferiore 5; alt. 4.8. Impasto duro, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: 7.5YR 8/2. Vernice coprente, scrostata e opaca applicata per immersione su tutta la superficie tranne il fondo del piede; colore: Munsell 7.5YR 3/1. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.260.C.7.
n. 11 (Tav. 75, 11): specchio in bronzo e anellini in bronzo. Piastra: diam. 8.6; spessore 0.1. Anellini: diam. 2; spessore verga 0.1. Patina verde sulla superficie. La piastra è lacunosa. Tipo R.40.1, varietà b.
n. 6 (Tav. 75, 7): piatto con vasca troncoconica e labbro rientrante in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 20.2; alt. 4.5. Impasto duro, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10R 5/6. Vernice consistente, scrostata e opaca, applicata per immersione su tutta la superficie tranne il fondo del piede; imperfezioni di cottura; colore: Munsell 7.5YR 3/1. Superficie polverosa. Realizzato al tornio. Integro. Tipo H.290.B.7.
n. 12 (Tav. 75, 12): ago crinale in osso. Lungh. 7.5; largh. max. espansione 1; spessore 0.4. Mancante della punta. Tipo S.70.2. n. 13 (Tav. 75, 13): due chiodi in ferro. Diam. testa esemplare integro 2; alt. 10.5, 6.8. Superficie corrosa e ossidata. Frammentari. Tipo Q.110.1.
n. 7 (Tav. 75, 2): olletta ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 11.4; alt. 13. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con abbondanti inclusi di piccole dimensioni; colore: Munsell 7.5YR 4/3. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Ricomposta da più frammenti. Tipo I.50.B.9, varietà b.
n. 14 (Tav. 75, 14): tanagrina in terracotta. Alt. max. cons. 14; diam. corpo 6.2. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con rari inclusi piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 5YR 5/8. Superficie liscia. Realizzata a matrice. Mancante della testa. Sul retro, liscio, si apre un foro di sfiato. Rappresenta una figura femminile panneggiata con il braccio destro piegato sul torace. Vedi, S. Buono, Carpineto Sinello (CH), area sacra di Fonte San NicolaFaustoferri 1997, 101, n. 5 (esemplare datato al III secolo a.C.).
n. 8 (Tav. 75, 8) lucerna. Diam. ric. disco 5.6; lungh. max. cons. 5; alt. 2.8. Impasto duro, compatto, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 5Y 8/2. Superficie lisciata. Realizzata a matrice. Lacunosa del becco. Spalla decorata da due solchi concentrici di dimensioni differenti, quello esterno risulta più grande e decorato da bugne quadrangolari a cui se ne affianco due di dimensioni minori. Tipo non identificabile.
Tomba 215 (Campagna 2007; Tavv. 58, 61). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare orientata in senso sud-est\nord-ovest (lungh. 210; largh. 60; prof. 50), localizzata nell’area nord-orientale del saggio di scavo. La deposizione è dorsale e primaria; il cranio è rivolto a ovest, gli arti superiori aderenti ai fianchi con le mani sul bacino; gli arti inferiori distesi e allineati. Dati antropologici. I resti dell’individuo della tomba in esame non sono presenti in deposito quindi non disponibili all’analisi. Dati archeologici. Il corredo si compone di un balsamario in vetro presso il cranio (n. 7); una
n. 9 (Tav. 75, 9): balsamario ceramico fusiforme. Diam. orlo 2.5; alt. 14.8. Impasto duro, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 2.5YR 5/6. Si conservano tracce di vernice nera sul collo, diluita, scrostata e opaca; colore: Munsell 5R 4/1. Superficie polverosa. Realizzato al tornio. Integro. Tipo N.130.5.
279
Capestrano, I
n. 6 (Tav. 74, 16): balsamario piriforme in vetro. Diam. orlo 2.9; alt. 12.5. Colore trasparente con patina iridea. Integro. Tipo P.130.9.
lagynos in ceramica comune lungo l’arto superiore destro (n. 3); un balsamario in vetro sul torace (n. 5) e altri tre lungo l’arto inferiore destro (nn. 6-7, 9); una lucerna (n. 4) e due ollette in ceramica comune (nn. 1-2) presso i piedi. Ai quattro angoli della fossa si rinvengono otto chiodi in ferro, di cui sono stati recuperati quattro esemplari (n. 10), pertinenti probabilmente alla cassa lignea che originariamente conteneva il defunto. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Prima metà del II secolo d.C.
n. 7 (Tav. 74, 17): balsamario piriforme in vetro. Diam. orlo 2.2; alt. 13. Colore trasparente con patina iridea. Integro. Tipo P.130.9. n. 8 (Tav. 74, 18) balsamario piriforme in vetro. Diam. fondo 3.2; alt. max. cons. 6. Colore trasparente con patina iridea. Mancante di parte del collo. Tipo P.130.9. n. 9 (Tav. 74, 19) balsamario piriforme in vetro. Diam. fondo 2.8; alt. max. cons. 2.4. Colore trasparente con patina iridea. Mancante del collo e dell’orlo. Tipo P.130.9.
n. 1 (Tav. 74, 13): olletta ovoide/piriforme in ceramica comune. Diam. orlo 7; alt. 9. Impasto duro, con abbondanti inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore bruno-rossiccio: Munsell 10R 5/4. Superficie ruvida. Realizzata al tornio. Integra. Tipo I.50.B.15, varietà b.
n. 10 (Tav. 74, 20): quattro chiodi in ferro. Superficie corrosa e ossidata. Due esemplari mancanti delle punte. Diam. testa 1.2; lungh. 10, 9.6, i 2 esemplari mutili, 6.4, 4.4. Tipo Q.110.1.
n. 2 (Tav. 74, 12): olletta ovoide/piriforme in ceramica comune. Diam. orlo 9; alt. 12.5. Impasto duro, con abbondanti inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10R 5/4. Superficie ruvida. Realizzata al tornio. Integra. Tipo I.50.B.15, varietà b.
Tomba 216 (Campagna 2007: Tavv. 58, 61). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare orientata in senso sud-ovest/nord-est (lungh. 200; largh. 110; prof. non registrata) localizzata nell’area nord-occidentale del saggio di scavo. La fossa presenta una nicchia di forma rettangolare aperta lungo il lato settentrionale (largh. 150; lungh. 50). La deposizione è dorsale, primaria e in ambiente vuoto; il cranio è rivolto a sud-est, gli arti superiori aderenti ai fianchi con le mani sul bacino; gli arti inferiori distesi e allineati. Dati antropologici. L’inumato è un individuo sub-adulto adolescente di 16-20 anni, probabilmente di sesso maschile. Lo stato di conservazione è molto buono e lo scheletro è quasi completo. L’età è stata stimata in base allo stato di maturazione scheletrica: nel radio sinistro si può osservare la linea di fusione ancora ben visibile (fig.antr.online 216_01A,B) mentre nel radio destro l’epifisi distale non è ancora saldata alla diafisi; i metacarpi invece hanno completato la saldatura delle epifisi distali; l’epifisi distale del femore a destra è saldata alla diafisi mentre la sinistra non ancora (fig.antr.online 216_02). Sebbene si tratti di un sub-adulto, le caratteristiche secondarie
n. 3 (Tav. 74, 11): lagynos cilindrica in ceramica comune. Diam. orlo 3.4; alt. 16.4. Impasto tenero, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10R 4/6. Superficie lisciata e lucidata. Realizzata al tornio. Ricomposta da più frammenti. Tipo I.120.5. n. 4 (Tav. 74, 14): lucerna a canale. Diam. disco 6.7; lungh. becco 3.8; alt. 3. Impasto con scarsi inclusi micacei e calcarei di piccole dimensioni; colore: Munsell 10R 5/6. Superficie lisciata e ingobbiata; colore ingobbio: Munsell 7.5R 4/6. Realizzata a matrice. Integra. Tipo M.D.2. n. 5 (Tav. 74, 15): balsamariopiriforme in vetro. Diam. fondo 3; alt. 13. Colore trasparente con patina iridea. Mancante di parte dell’orlo. Tipo P.130.9.
280
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
n. 4 (Tav. 76, 3) piatto con vasca troncoconica e labbro svasato in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 12.5; alt. 4. duro, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 7.5YR 8/2. Vernice diluita, scrostata e opaca, applicata per immersione su tutta la superficie tranne il fondo del piede; colore: Munsell 10R 4/1; imperfezioni di cottura con focature rossicce. Superficie liscia. Realizzato al tornio. Ricomposto da più frammenti. Tipo H.290.C.2.
maschili sono già visibili sia nel cranio che nel bacino. Dati archeologici. Il corredo si compone di un elemento in ferro (n. 15) e un coltello in ferro (n. 10) sul torace; un ago crinale in osso (n. 13) e uno skyphos in ceramica a vernice nera (n. 3) presso l’arto superiore sinistro; una coppetta in ceramica a vernice nera (n. 2), un balsamario ceramico (n. 9), uno strigile in ferro (n. 14) e una kreagra (n. 11) presso il bacino; un piatto in ceramica a vernice nera (n. 4) e tre ollette in ceramica comune (nn. 6-8) presso l’arto inferiore destro; un’altra olletta (n. 5) e un’olla in impasto presso i piedi (n. 1). Il sesso archeologico è determinabile come maschile. Inquadramento cronologico. Prima metà II secolo a.C.
n. 5 (Tav. 76, 5): olletta ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 11.4; alt. 16.3. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con abbondanti inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10YR 6/2. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Ricomposta da più frammenti. Tipo I.50.B.9, varietà c.
n. 1 (Tav. 76, 4): olletta globulare in impasto grezzo. Diam. orlo 13.4; alt. 23. Impasto duro, poroso con rari vacuoli distribuiti in maniera omogenea; frattura frastagliata, con abbondanti inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5R 7/1. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Ricomposta da più frammenti. Tipo A.50.B.3.
n. 6 (Tav. 76, 6): olletta ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 10.8; alt. 14. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con abbondanti inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10YR 6/2. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Ricomposta da più frammenti. Tipo I.50.B.9, varietà c.
n. 2 (Tav. 76, 1): coppetta a profilo globulare in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 12; alt. 5.5. Impasto duro, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 7.5R 8/3. Vernice coprente, scrostata su gran parte della parete e opaca, applicata per immersione su tutta la superficie tranne il fondo del piede; colore 7.5R 3/1; con imperfezioni di cottura (disco di “empilement” di colore rossiccio). Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.260.A.6.
n. 7 (Tav. 76, 7): olletta ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 10; alt. 13.5. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con abbondanti inclusi di piccole e medie dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10YR 6/2. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Ricomposta da più frammenti Tipo I.50.B.9, varietà c. n. 8 (Tav. 76, 8): olletta ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 10.6; alt. 12.3. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con abbondanti inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10YR 6/2. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Presenta tracce di esposizione al calore e un segno X inciso sul ventre. Ricomposta da più frammenti. Tipo I.50.B.9, varietà c.
n. 3 (Tav. 76, 2): skyphos a profilo sinuoso in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 12.5; alt. 13.4. Impasto duro, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 7.5YR 8/2. Vernice coprente, scrostata e opaca, applicata per immersione su tutta la superficie tranne il fondo del piede; colore: Munsell 10R 4/2; imperfezioni di cottura. Superficie liscia. Realizzato al tornio. Integro. Tipo H.280.2.
281
Capestrano, I
Dati antropologici. Si conservano alcuni frammenti di cranio di adulto tra cui un processo mastoideo ridotto e una sinfisi mentoniera forse femminile, alcuni denti anteriori con segni di degradazione diagenetica, una diafisi di omero, due diafisi di femore. Dati archeologici. Il corredo si compone di una forma chiusa in ceramica comune (n. 2) e un balsamario in vetro frammentario presso la testa (n. 5); un altro balsamario in vetro (n. 4) sull’omero sinistro; sedici chiodi in ferro (n. 7) all’altezza degli arti inferiori; un’olletta in ceramica comune (n. 1) e una lucerna (n. 3) presso i piedi. Si rinvengono quattro chiodi in ferro (n. 6) sia all’altezza del cranio che dei piedi, probabilmente riferibili alla cassa lignea in cui era alloggiato il defunto. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Inizi II secolo d.C.
n. 9 (Tav. 76, 9): balsamario ceramico fusiforme. Diam. orlo 3.1; alt. 21. Impasto duro, con rarissimi inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10R 4/3. Superficie polverosa. Realizzato al tornio. Integro. Tipo N.130.3. n. 10 (Tav. 76, 11): coltello in ferro a lama allungata. Lungh. max. cons. 11; lama: lungh. max. cons. 9.2, largh. max. espansione 2, spessore 0.4; codolo: lungh. max. cons. 1.8; spessore 0.4. Superficie corrosa e ossidata. Mancante della punta e di parte del codolo; si conservano tracce di stoffa sul codolo. Tipo Q.80.1. n. 11 (Tav. 76, 10): kreagra in ferro. Lungh. 23.5; spessore stelo 1.5; diam. placca 4.4. Superficie corrosa e ossidata. Integra. Tipo Q.90.1.
n. 1 (Tav. 75, 16): olletta ovoide/piriforme in ceramica comune. Diam. orlo 7.2; alt. 9.5. Impasto duro, con abbondanti inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 4/2. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Integra. Tipo I.50.B.15, varietà a.
n. 12 (Tav. 76, 12): anello in ferro con verga sottile. Diam. 2.4; spessore verga 0.4. I Superficie corrosa e ossidata. Integro. Tipo S.40.A.1. n. 13 (Tav. 76, 13): ago crinale in osso. Lungh. 12.4; diam. stelo 0.7. Integro. Tipo S.70.1.
n. 2 (Tav. 75, 15): forma chiusa in ceramica comune (olla? olletta?). Diam. piede 5.4; alt. 7.5. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR/4.1. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Lacunosa di parte del ventre, della spalla e del collo. Corpo ovoide, piede ad anello. Tipo non identificabile.
n. 14 (Tav. 76, 14): strigile in ferro. Lungh. 15.5; largh. max. espansione 2; spessore lamina 0.4. Superficie corrosa e ossidata. Mancante di parte dell’impugnatura. Tipo R.30.1. n. 15 (Tav. 76, 15): elemento in ferro, forse una fibbia. Si compone di un elemento con arco semicircolare a cui è saldato una verga a sezione circolare con terminazione a globetto. Stelo: lungh. max. cons. 16, spessore 0.5; alt. 4; elemento arcuato: lungh. max. cons. 10.8, spessore 0.4. Superficie corrosa e ossidata. Tipo non identificabile.
n. 3 (Tav. 75, 17) lucerna a disco. Diam. disco 6.5; lungh. becco 4; alt. 2.5. Impasto duro, compatto, frattura netta, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera disomogenea; colore: colore: Munsell 7.5YR 4/2. Superficie liscia e ingobbiata; colore ingobbio: Munsell 10R 4/8. Realizzata a matrice. Mancante di parte del disco e del becco. Tipo M.E.2.
Tomba 217 (Campagna 2007; Tavv. 58, 61). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare orientata in senso nord-est/sud-ovest (lungh. 210; largh. 150; prof. 10), localizzata nella porzione nord-orientale del saggio di scavo. Taglia la tomba 279 (vedi, 314-315). La deposizione è dorsale, primaria e in ambiente vuoto; il cranio è volto a est; gli arti superiori sono piegati; gli arti inferiori distesi.
n. 4 (Tav. 75, 18): balsamario in vetro. Diam. fondo 6; alt. 3. Colore trasparente. Mancante del collo. Tipo non identificabile. 282
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
n. 5 (Tav. 75, 19): balsamario in vetro. Diam. fondo 3.4; alt. 2. Colore trasparente. Mancante del collo. Tipo non identificabile. n. 6 (Tav. 75, 20): quattro chiodi in ferro. Diam. testa 1.2; lungh. 8. Superficie corrosa e ossidata. Tipo Q.110.1. n. 7 (Tav. 75, 21): sedici chiodi in ferro di piccole dimensioni. Diam. testa 0.8; lungh. 1.5. Superficie corrosa e ossidata. Tipo Q.110.3. Tomba 218 (Campagna 2007; Tavv. 58, 63). Sepoltura a incinerazione realizzata in una piccola fossa rettangolare, orientata in senso nord-est/sud-ovest (lungh. 100; largh. 70; prof. 7), localizzata nell’area centrale del saggio di scavo. Taglia la tomba 268 (vedi, 308-309). Nel riempimento si rinvengono le ceneri probabilmente appartenenti al defunto e scarsi resti ossei. Dati antropologici. I resti dell’individuo della tomba in esame non risultano presenti in deposito quindi non disponibili all’analisi. Dati archeologici. Si rinvengono frammenti ceramici in impasto e vetro, non diagnostici, due chiodi (n. 1) e frammenti di grappe (n. 2) in ferro, da riferire probabilmente a un contenitore ligneo e sottoposti a combustione con le spoglie del defunto. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Sulla base del rituale funerario, è plausibile che si tratti di una sepoltura della prima età imperiale. n. 1 (Tav. 77, 1): due chiodi in ferro. Diam. testa esemplare integro 1; lungh. 8.3; lungh. es. mutilo 3.8. Uno dei due esemplari manca della testa e della punta. Superficie corrosa e ossidata. Mutili. Tipo Q.110.1. n. 2 (Tav. 77, 2): frammento di grappa in ferro. Testa piatta con due alette con terminazione triangolare, spillone a sezione rettangolare. Alt. 7.8; largh. 0.5. Lacunosa. Superficie corrosa e ossidata. Tomba 219 (Campagna 2007; Tavv. 58, 63). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare orientata in senso sud-ovest/nord-est (lungh. 220; largh. 90; prof. 70), localizzata nell’area centrale del saggio di scavo. Taglia la tomba
243 (vedi, 294). In corrispondenza dell’angolo nord-occidentale della fossa, si conserva il ripostiglio, protetto da spezzoni litici. La deposizione è dorsale, primaria; gli arti superiori e inferiori sono allineati e distesi. Dati antropologici. Dell’individuo sepolto si conservano pochi piccoli frammenti ossei tra cui si identificano le diafisi delle tibie riferibili a un adulto. Dati archeologici. Il corredo si compone di una fibula con pinzetta in ferro sullo sterno (n. 3); uno spiedo in ferro lungo l’arto inferiore sinistro (n. 4). Il ripostiglio è composto da un’olla in impasto (n. 1) all’interno della quale si rinviene una tazza in impasto buccheroide (n. 2). Sulla base della mancanza delle armi e dell’inquadramento cronologico proposto, il sesso archeologico sembra essere femminile; le dimensioni della fossa confermano l’attribuzione a un individuo adulto. Inquadramento cronologico. Ultimi decenni VIinizi V secolo a.C. n. 1 (Tav. 77, 4): olla ovoide in impasto grezzo. Diam. orlo 21; alt. 32. Impasto tenero, con abbondanti inclusi di piccole e medie dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10R 4/3. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo A.40.A.7. n. 2 (Tav. 77, 3): tazza carenata in impasto buccheroide. Diam. orlo 11.6; alt. 9. Impasto duro, con rarissimi inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 7/2. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo B.220.1. n. 3 (Tav. 77, 5): fibula in ferro con pinzetta agganciata. Fibula: lungh. max. cons. 5; alt. max. cons. 1. Superficie corrosa e ossidata. Frammentaria. Tipo non identificabile. Pinzetta: lungh. 4.6; alt. 0.4. Frammentaria. Superficie corrosa e ossidata. Tipo non identificabile. n. 4 (Tav. 77, 6): spiedo in ferro con testa ad occhiello. Lungh. 100; diam. testa 2; spessore. stelo 1. Superficie corrosa e ossidata. Integro. Tipo Q.60.2. La tomba 220 è stata identificata e numerata, ma non scavata (vedi, Tav. 58).
283
Capestrano, I
n. 4 (Tav. 78, 4): frammento di forma chiusa in impasto buccheroide. Largh. max. cons. 5.5; alt. max. cons. 5. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogena; colore: Munsell 10R 5/1. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Decorazione a fasce; dall’alto: una fascia con teoria di cavalli stilizzati rivolti verso destra, ottenuti con la tecnica del cilindretto; la fascia sottostante presenta motivi a stampiglio rettangolare con croce di Sant’Andrea campiti da puntini; l’ultima è decorata a cerchielli concentrici ottenuti a impressione. Tipo non identificabile.
Tomba 221 (Campagna 2007; Tavv. 58, 63). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare tagliata orientata in senso sud-ovest/nord-est (lungh. 220; largh. 100; prof. 60), localizzata lungo il limite nord-occidentale del saggio di scavo. Tagliata dalla tomba 250. In corrispondenza dell’angolo occidentale, si conserva il ripostiglio. La deposizione, per quanto leggibile, è dorsale e primaria. Dati antropologici. I resti dell’individuo della tomba in esame non risultano presenti in deposito quindi non disponibili all’analisi. Dati archeologici. Il corredo si compone di una fibula in ferro (n. 7) sulla clavicola destra; uno spiedo in ferro (n. 8) e frammenti di impasto buccheroide (nn. 2-6) lungo l’arto inferiore destro. Il ripostiglio è composto da un’olla in impasto (n. 1) contenente una grappetta in bronzo (n. 9). Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Pieno VI secolo a.C.
n. 5 (Tav. 78, 5): frammento di forma chiusa in impasto buccheroide. Largh. max. cons. 8.8; alt. 5.8. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogena; colore: Munsell 10R 5/1. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Decorazione a fasce; dall’alto, una fascia con teoria di cavalli stilizzati rivolti verso destra, ottenuti con la tecnica del cilindretto; la fascia sottostante presenta motivi a stampiglio rettangolare con croce di Sant’Andrea campiti da puntini; l’ultima è decorata a cerchielli concentrici ottenuti a impressione. Probabilmente pertinente allo stesso esemplare del n. 4. Tipo non identificabile.
n. 1 (Tav. 78, 1): olla globulare in impasto grezzo. Diam. orlo 25; alt. 39.5. Impasto duro, poroso con frequenti vacuoli distribuiti in maniera omogenea, frattura frastagliata, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 7/2. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Ricomposta da più frammenti. Tipo A.40.B.9.
n. 6 (Tav. 78, 6): frammento di forma chiusa di grandi dimensioni in impasto buccheroide. Largh. max. cons. 5; alt. max. cons. 5.5. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogena; colore: Munsell 7.5YR 5/1. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Decorazione di due linee incise e una cordonatura. Tipo non identificabile.
n. 2 (Tav. 78, 2): forma chiusa di piccole dimensioni (probabilmente un’anforetta) in impasto buccheroide. Diam. piede 4; alt. 2. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogena; colore nero: Munsell 10R 3/1. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Si conserva solo il piede a disco e parte del ventre ovoide. Tipo non identificabile.
n. 7 (Tav. 78, 7): fibula ad arco semplice in ferro. Lungh. max. cons. 4; alt. max. cons. 4. Superficie corrosa e ossidata. Mancante della molla, della staffa e della terminazione. Arco probabilmente semplice rialzato a sezione circolare. Tipo non identificabile.
n. 3 (Tav. 78, 3): forma chiusa di piccole dimensioni (probabilmente un’anforetta) in impasto buccheroide. Diam. piede 5; alt. 1.7. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogena; colore: Munsell 10R 4/1. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Si conservano solo il piede a disco e parte del ventre ovoide. Tipo non identificabile.
n. 8 (Tav. 78, 9): spiedo in ferro. Lungh. max. cons. 35; spessore stelo 1. Superficie corrosa e
284
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
ossidata. Mancante della testa. L’estremità è ripiegata. Tipo non identificabile. n. 9 (Tav. 78, 8): borchietta in bronzo. Diam. testa 1.2; alt. 1.4. Patina verde sulla superficie. Tomba 222 (Campagna 2007; Tavv. 58, 63). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare con orientamento sud-ovest/nord-est (lungh. 260; largh. 70; prof. 60), localizzata nella porzione centrale del saggio di scavo. Tagliata dalle tombe 197 e 246 (vedi, 267-268, 295-296). In corrispondenza dell’angolo settentrionale della fossa, si conserva il ripostiglio, protetto da spezzoni litici. La deposizione è dorsale e primaria e in ambiente vuoto; il cranio si presenta in posizione frontale; gli arti superiori e inferiori sono distesi e allineati. Dati antropologici. Lo scheletro appartiene ad un adulto maschile ed è in pessime condizioni di conservazione. Sono presenti frammenti di cranio, la mandibola, tutti i denti, le diafisi di arti superiori e inferiori, qualche falange delle mani. La determinazione del sesso è limitata alla analisi della morfologia della mandibola, del frontale e alla misura del caput femorale destro (47.9 mm). La stima dell’età non è attendibile poiché l’avanzata usura dei denti indicherebbe una età tra 35-45 anni mentre alcuni frammenti di cranio mostrano le suture craniche ancora ben separate. Le diafisi delle tibie destra e sinistra mostrano una colorazione verde dovuta al contatto con oggetti metallici ossidati. Dati archeologici. Il corredo si compone di un poculum in impasto (n. 2) e una forma chiusa di piccole dimensioni (forse una brocchetta) in impasto buccheroide (n. 3) deposti presso la testa; una fibula e una pinzetta in ferro (nn. 7, 10) sul torace; una spada (n. 8) e uno spiedo in ferro (n. 6) lungo l’arto superiore destro; un bacile in lamina di bronzo (n. 5) tra gli arti inferiori; una punta di lancia in ferro (n. 9). Il ripostiglio è composto da un’olla in impasto (n. 1) contenente una brocchetta in impasto buccheroide (n. 4). Il sesso archeologico è definibile come maschile. Inquadramento cronologico. Seconda metà VI secolo a.C.
285
n. 1 (Tav. 79, 1): olla ovoide in impasto grezzo. Diam. orlo 25; alt. max. cons. 4.6. Impasto tenero, poroso con frequenti vacuoli distribuiti in maniera disomogenea, frattura irregolare; con abbondanti inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 4/3. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Si conservano solo il labbro e parte del collo. Tipo A.40.A.7. n. 2 (Tav. 79, 2): poculum globulare in impasto grezzo. Diam. orlo 9.4; alt. 9.7. Impasto duro, con frequenti inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 4/4. Superficie liscia. Realizzato a mano. Integro. Tipo A.190.1. n. 3 (Tav. 79, 3): forma chiusa di piccole dimensioni in impasto buccheroide (probabilmente una brocchetta). Diam. piede 4; alt. max. cons. 2.5. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10YR 3/1. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Si conserva solo il basso piede ad anello. Tipo non identificabile. n. 4 (Tav. 79, 4): forma chiusa di piccole dimensioni in impasto buccheroide (probabilmente brocchetta). Diam. piede 5.6; alt. 2.8. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10YR 3/1. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Si conserva solo il basso piede ad anello. Tipo non identificabile. n. 5 (Tav. 79, 5): bacile con orlo ribattuto verso l’interno in lamina di bronzo. Diam. orlo 20; alt. max. cons. 5. Patina verde sulla superficie. Mancante del fondo. Tipo O.330.B.4. n. 6 (Tav. 79, 10): spiedo in ferro con testa a ricciolo. Lungh. 93; diam. testa 2.8; spessore stelo 1. Superficie corrosa e ossidata. Integro. Tipo Q.60.1. n. 7 (Tav. 79, 7) fibula in ferro con arco semplice. Lungh. max. cons. 3.7; alt. max. cons. 2.2. Superficie corrosa e ossidata. Mancante dell’ago e della staffa. Tipo non identificabile.
Capestrano, I
distribuiti in maniera omogenea; frattura frastagliata, con abbondanti inclusi di piccole e medie dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore Munsell 10YR 4/3. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Si conservano solo l’orlo e il collo. A.40.B.13.
n. 8 (Tav. 79, 8): spada in ferro. Lungh. 78; lama: lungh. 64, largh. max. 4, spessore max. 0.8; elsa: largh. max. 4, spessore placca in ferro 1; spessore rivestimento in legno 0.4. Superficie corrosa e ossidata. L’elsa è lacunosa e conserva tracce del rivestimento in legno; si conserva parte dell’anello inserito sull’elsa. Tipo T.20.1. n. 9 (Tav. 79, 9): punta di lancia in ferro. Lungh. max. cons. 14; lama: lungh. max. cons. 4, largh. max. 2.4; diam. max. cons. cannone 1.5. Superficie corrosa e ossidata. Mancante della punta e del cannone. Tipo non identificabile.
n. 2 (Tav. 80, 3): calderone con fondo concavo in lamina bronzea, con manico mobile in ferro. Diam. orlo 33.6; alt. 10.3; manico: spessore verga 0.8. Patina verde in superficie. Mancante di parte della vasca. Tipo O.320.1 (dubitativamente). n. 3 (Tav. 80, 2): stamnos in lamina di bronzo. Diam. orlo 11.6; alt. 11.3. Patina verde in superficie. Ricomposto da più frammenti. Restauro antico del fondo ottenuto con due lamine di bronzo unite con ribattini ovali fissati con chiodini. Tipo O.340.1.
n. 10 (Tav. 79, 6): pinzetta in ferro. Lungh. 4.5; largh. 2; spessore verga 0.6. Superficie corrosa e ossidata. Integra. Tipo R.10.1. Tomba 223 (Campagna 2007; Tavv. 58, 63). Sepoltura a inumazione in fossa di forma rettangolare orientata in senso ovest-est (lungh. 225; largh. 90; prof. 50), localizzata nella porzione centrale del saggio di scavo. Taglia la tomba 230 presso il suo limite settentrionale e la 271 lungo quello meridionale (vedi, 289-290, 310-311). In corrispondenza dell’angolo settentrionale della fossa, si conserva il ripostiglio. Dati antropologici. I resti dell’individuo della tomba in esame non risultano presenti in deposito quindi non disponibili all’analisi. Dati archeologici. Il corredo è composto da una spada in ferro (n. 5) deposta probabilmente lungo l’arto inferiore sinistro, con la punta rivolta verso la posizione originaria del cranio; un calderone in lamina di bronzo con manico mobile in ferro (n. 2); uno spiedo in ferro (n. 4) e uno stamnos in lamina di bronzo (n. 3); una punta di lancia in ferro (n. 6) in corrispondenza degli arti inferiori; un paio di calzari in ferro (n. 7) ai piedi. Il ripostiglio è composto da un’olla in impasto (n. 1). Il sesso archeologico è determinabile come maschile e le dimensioni della fossa ne suggeriscono l’attribuzione a un individuo adulto. Inquadramento cronologico. Fine VI-inizi V secolo a.C.
n. 4 (Tav. 80, 5): spiedo in ferro. Lungh. 64.5; spessore stelo 1. Superficie corrosa e ossidata. Mancante della testa. Verga di ferro a sezione quadrangolare. Tipo non identificabile. n. 5 (Tav. 80, 4): spada in ferro. Lungh. max. cons. 70; lama: lung. 58, largh. max. 4, spessore max. 1.2; elsa: largh. max. cons. 2.8; spessore placca in ferro, spessore rivestimento in legno 1.1. Si conservano tracce del rivestimento in legno dell’elsa e del fodero. Superficie corrosa e ossidata. Mancante di parte dell’elsa. Tipo T.20.1. n. 6 (Tav. 80, 7): punta di lancia in ferro. Lungh. max. cons. 31; lama: lungh. max. cons. 24.2, largh. max. 4.5; cannone: diam. 2.4. Superficie corrosa e ossidata. Mancante della punta. Tipo T.40.2. n. 7 (Tav. 80, 6): undici frammenti di ramponi, pertinenti a due calzari in ferro e legno. La larghezza max. ric. è di 6.8; lo spessore dei vari elementi varia da 0.7 a 1.2. Superficie corrosa e ossidata. Tomba 224 (Campagna 2007; Tavv. 58, 64). Sepoltura a inumazione in fossa di forma rettangolare, orientata in senso sud-ovest/nordest (lungh. 200; largh. 80; prof. non rilevata), localizzata nella porzione settentrionale del
n. 1 (Tav. 80, 1): olla globulare (?) in impasto grezzo. Diam. orlo 22; alt. max. cons. 11.5. Impasto tenero, poroso con frequenti vacuoli 286
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
saggio di scavo. La deposizione risulta coperta nella porzione superiore dai frammenti di due coppi adiacenti. Deposizione in decubito laterale sinistro in posizione rannicchiata; gli arti superiori e inferiori sono piegati. Dati antropologici. L’inumato è un individuo adulto femminile, ma lo stato di conservazione è molto frammentario e gli elementi identificabili consistono in parti di cranio, tre denti e una diafisi di omero. Dai frammenti di cranio si osserva una morfologia dell’occipitale e del frontale femminile e le suture craniche ben separate. Dati archeologici. Il corredo risulta assente. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Incerto.
10R 4/6. Superficie liscia. Realizzato al tornio. Ricomposto da più frammenti. Tipo K.290.1.
Tomba 225 (Campagna 2007; Tavv. 58, 64). Piccola fossa di forma rettangolare orientata in senso ovest-est (lungh. 75; largh. 50; prof. 20) e localizzata nella porzione settentrionale del saggio di scavo. Si rinviene coperta da frammenti di coppi e sconvolta probabilmente da lavori agricoli. Non essendo segnalato nella scheda di sepoltura il rinvenimento di resti antropologici combusti o di cenere, non è chiaro il tipo di rituale funerario utilizzato: si potrebbe trattare di una incinerazione o, data la presenza della copertura in coppi, della sepoltura di un individuo infantile. Dati antropologici. La sepoltura risulta priva di resti antropologici. Dati archeologici. Del corredo, profondamente disturbato, si conservano uno strigile in ferro (n. 7); un balsamario ceramico (n. 2) e un piatto in ceramica sigillata italica (n. 1) nella parte settentrionale della fossa; due frammenti di balsamari ceramici (nn. 3-4), una lucerna (n. 5), una pedina da gioco in osso (n. 9), un bottone in bronzo (n. 8) e una forbicina in ferro (n. 6) nella parte meridionale. Sulla base della presenza dello strigile, il sesso archeologico può essere definito come maschile. Inquadramento cronologico. Ultimi decenni del I secolo a.C. (età augustea).
n. 4 (Tav. 78, 12): balsamario ceramico. Diam. fondo 2; alt. 1.7. Impasto duro, compatto, frattura regolare, privo di inclusi; colore: Munsell 10R 4/4. Superficie polverosa. Realizzato al tornio. Si conserva solo parte del fondo piano e del ventre globulare. Tipo non identificabile.
n. 2 (Tav. 78, 14): balsamario ceramico piriforme. Diam. orlo 2.8; alt. 14. Impasto duro, privo di inclusi; colore: Munsell 10R 5/8. Superficie polverosa. Realizzato al tornio. Integro. Tipo N.130.7, varietà b. n. 3 (Tav. 78, 11): balsamario ceramico. Diam. fondo 3.4; alt. 3.5. Impasto duro, compatto, frattura regolare, privo di inclusi; colore: Munsell 10R 4/4. Superficie polverosa. Realizzato al tornio. Si conserva solo parte del fondo piano e del ventre globulare. Tipo non identificabile.
n. 5 (Tav. 78, 13): lucerna. Lungh. max. cons. 5.3; alt. max. cons. 2.5. Impasto duro, compatto, frattura regolare, privo di inclusi; colore: Munsell 10R 4/4. Superficie liscia; ingobbio rosso; colore: Munsell 7.5YR 4/8. Realizzata a matrice. Si conserva solo parte del disco decorato a baccellature e del becco. Tipo non identificabile. n. 6 (Tav. 78, 15): piccola forbice in ferro. Lungh. 7; largh. 1. Superficie corrosa e ossidata. Le due lame risultano profondamente concrezionate. Tipo non puntualizzabile. n. 7 (Tav. 78, 16): strigile in ferro. Lungh. 20; largh. max. lama 4; spessore lama 1. Superficie corrosa e ossidata. Integro. Tipo R.30.1. n. 8 (Tav. 78, 18): bottone in bronzo. Diam. 2.5; spessore 0.2. Patina verde sulla superficie. Integro.
1 (Tav. 78, 10): piatto a profilo troncoconico in ceramica sigillata italica. Diam. orlo 24; alt. 3.5. Impasto duro, compatto, frattura netta, privo di inclusi; colore: Munsell 10R 6/6. Ingobbio rosso diluito, scrostato e opaco; colore: Munsell
n. 9 (Tav. 78, 17): pedina in osso di forma circolare. Diam. 1.7; spessore 0.3. Integra. Tomba 226 (Campagna 2007; Tavv. 58, 64). 287
Capestrano, I
rilevata. La lunghezza massima del femore destro (418 mm) permette di calcolare la statura in vita di 157 cm. A parte sono stati raccolti e denominati “resti ossei del riempimento forse pertinenti in data 18.06.2007” e consistono in una sola diafisi di omero. Dati archeologici. Il corredo si compone di cinque fibule in ferro presso il torace (nn. 2-6) e una coppa in ceramica a vernice nera (n. 1) sui piedi. Il sesso archeologico non è determinabile. Nel riempimento si rinvengono frammenti non diagnostici pertinenti a un’olla in impasto, probabilmente provenienti dal disturbo della vicina tomba 245. Inquadramento cronologico. Inizi III secolo a.C.
Sepoltura a incinerazione realizzata in una piccola fossa di forma pressoché ovale (lungh. 40; largh. 30; prof. 10), localizzata nella porzione settentrionale dell’area di scavo. Nel riempimento si rinvengono le ceneri probabilmente appartenenti al defunto e scarsi resti ossei. Dati antropologici. I resti dell’individuo della tomba in esame non risultano presenti in deposito quindi non disponibili all’analisi. Dati archeologici. Il corredo è assente. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Sulla base del rituale adottato, è plausibile che si tratti di una sepoltura della prima età imperiale. Tomba 227 (Campagna 2007; Tavv. 58, 64). Sepoltura a inumazione in fossa di forma rettangolare orientata in senso sud-ovest/nordest (lungh. 210; largh. 80; prof. 120) localizzata nella porzione centrale del saggio di scavo. Taglia le tombe 211 e 245 (vedi, 276, 295). La deposizione è dorsale, primaria e in ambiente vuoto; il cranio è in posizione frontale; gli arti superiori sono aderenti ai fianchi con la mano sinistra sulle ossa pelviche; gli arti inferiori distesi e allineati. Dati antropologici. I resti umani appartengono a un individuo adulto femminile di 45-49 anni. Il cranio è quasi completo e ben conservato e mostra le caratteristiche sessuali secondarie femminili. Anche la morfologia del bacino, soprattutto la presenza di un marcato solco preauricolare su entrambe le ossa dell’ileo, conferma la determinazione. L’età alla morte doveva essere avanzata, considerando l’usura dentaria e la perdita antemortem del primo e secondo molare mascellare del lato destro e del primo molare mascellare del lato sinistro. I frammenti di cranio disponibili all’analisi, mostrano un avanzato stadio di ossificazione delle suture craniche, in particolare la coronale è quasi obliterata. A questo si aggiunge la stima dell’età in base alla superficie auricolare dell’ileo che corrisponde a 45-49 anni e della sinfisi pubica che indica una media di 48.1 anni (nel range 34-63 anni). Una lieve apposizione di tartaro è visibile sul lato labiale dei denti anteriori. Il postcranio include colonna vertebrale, coste, arti superiori e arti inferiori, mani e piedi, e nessuna ulteriore anomalia è
n. 1 (Tav. 81, 1): coppa a profilo globulare in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 19; alt. 8,5. Impasto duro, privo di inclusi; colore: Munsell 7.5YR 7/3. Vernice consistente con riflessi metallici; colore: Munsell 10R 2.5/1 applicata per immersione su tutta la superficie tranne il fondo del piede. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.240.A.2. n. 2 (Tav. 81, 4): fibula in ferro con arco semplice. Lungh. max. cons. 4.5; alt. max. cons. 3.5. Superficie corrosa e ossidata. Mancante dell’ago e della staffa. Si conservano tracce di tessuto sull’arco. Probabilmente ascrivibile al Tipo S.20.A.4, varietà a. n. 3 (Tav. 81, 5): fibula in ferro con arco semplice. Lungh. max. cons. 4.5; alt. max. cons. 3. Superficie corrosa e ossidata. Mancante dell’ago e della staffa. Si conservano resti di tessuto. Probabilmente ascrivibile al Tipo S.20.A.4, varietà a. n. 4 (Tav. 81, 6): fibula in ferro cin arco semplice. Lungh. max. cons. 4.5; alt. 3.7. Superficie corrosa e ossidata. Mancante dell’ago e della staffa. Si conservano resti di tessuto. Probabilmente ascrivibile al Tipo S.20.A.4, varietà a. n. 5 (Tav. 81, 2): fibula in ferro cob arco semplice. Lungh. max. ric. 2.5; alt. max. ric. 4. Superficie corrosa e ossidata. Si conservano solo frammenti dell’arco e dell’ago. Si
288
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
su tutta la superficie tranne il fondo del piede; colore: Munsell 7.5YR. Superficie liscia. Realizzato al tornio. Integro. Tipo Tipo H.280.3.
conservano resti di tessuto. Probabilmente ascrivibile al Tipo S.20.A.4, varietà a. n. 6 (Tav. 81, 3): fibula in ferro con arco semplice. Lungh. max. ric. 3; alt. max. ric. 2.5. Superficie corrosa e ossidata. Si conservano solo frammenti dell’arco e dell’ago. Si conservano resti di tessuto. Probabilmente ascrivibile al Tipo S.20.A.4, varietà a.
Tomba 229 (Campagna 2007; Tavv. 58, 65). Sepoltura neonatale orientata in senso nordest/sud-ovest (lungh. 100; largh. 60; prof. non rilevata), localizzata nella porzione sudoccidentale del saggio di scavo. Taglia la tomba 272. La deposizione, realizzata in un coppo rovesciato, è dorsale, primaria, con scarsa parte dei resti antropologici conservati; il cranio è in posizione frontale. Dati antropologici. Si tratta di un sub-adulto di cui si sono conservati soltanto i denti. Lo studio dello sviluppo dentario dei denti decidui e permanenti permette di stimarne l’età alla morte all’incirca a 18 mesi ± 6 mesi. Dati archeologici. Il corredo è assente. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Incerto.
Tomba 228 (Campagna 2007; Tavv. 58, 64). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare orientata in senso sud-est/nord-ovest (lungh. 200; largh. 70; prof. 30), localizzata nella zona meridionale del saggio di scavo. Taglia dalla tomba 207 in corrispondenza del suo lato nordorientale (vedi, 273-274). Il ripostiglio è alloggiato in una piccola nicchia ricavata nell’angolo sud-occidentale della fossa. La deposizione è dorsale, primaria e in ambiente vuoto; i resti antropologici sono conservati in minima parte: il cranio è volto verso ovest, gli arti superiori aderenti ai fianchi. Dati antropologici. Lo scheletro è in pessimo stato di conservazione per cui non è possibile delineare il profilo biologico dell’inumato, un adulto di sesso forse femminile ed età indeterminabile. Tra le ossa identificabili: frammenti di cranio e vertebre, una porzione di mandibola con mento femminile, denti anteriori, una diafisi di omero. Dati archeologici. Il ripostiglio è composto da un’olla in impasto (n. 1) contenente uno skyphos in ceramica a vernice nera privato intenzionalmente di un’ansa (n. 2). Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. III secolo a.C. n. 1 (Tav. 81, 7): olla globulare in impasto grezzo. Diam. orlo 19; alt. 35.5. Impasto tenero, con abbondanti inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10R 4/3. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo A.40.B.25. n. 2 (Tav. 81, 8): skyphos a profilo sinuoso in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 10.4; alt. 11. Impasto duro, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10YR 8/3. Vernice coprente e con riflessi metallici applicata per immersione 289
Tomba 230 (Campagna 2007; Tavv. 58, 65). Sepoltura a inumazione in fossa di forma rettangolare, orientata in senso sud-ovest/nordest (lungh. 310; largh. 90; prof. 40), localizzata nella porzione centrale del saggio di scavo. Tagliata dalla tomba 223 (vedi, 286-287). In corrispondenza dell’angolo settentrionale della fossa, si conserva il ripostiglio coperto da un accumulo consistente di spezzoni litici. La deposizione è dorsale, primaria e in pessimo stato di conservazione; gli arti arti superiori e inferiori sono allineati e distesi. Dati antropologici. Dell’individuo adulto sono conservate solo le ossa lunghe degli arti inferiori (diafisi di femori e di tibie). Dati archeologici. Il corredo si compone di due sauroteres in ferro (n. 13) presso il lato destro della testa; un fascio di quattro spiedi in ferro (nn. 5-8) presso l’arto superiore sinistro; un alare in ferro integro e uno frammentario (nn. 3-4), un paio di calzari (n. 14) e un pugnale a stami con il fodero in ferro (n. 10) tra gli arti inferiori; due punte di lancia in ferro (nn. 1112) lungo l’arto inferiore destro e un calderone in lamina di bronzo (n. 2) contenente un rasoio in ferro (n. 9) sui piedi. Il ripostiglio è composto da un’olla in impasto (n. 1). Il sesso archeologico è determinabile come maschile.
Capestrano, I
Inquadramento cronologico. Prima metà VI secolo a.C.
spessore 0.3. Superficie corrosa e ossidata. Mancante della punta. Tipo R.50.3.
n. 1 (Tav. 82, 1): olla globulare (?) in impasto grezzo. Diam. orlo 22; alt. max. cons. 6.5. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con abbondanti inclusi di piccole e medie dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore grigiastro: Munsell 7.5YR 4/1. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Si conservano l’orlo, il collo e la spalla. Tipo A.40.B.13.
n. 10 (Tav. 83, 1): pugnale a stami inserito e concrezionato all’interno di un fodero in ferro. Lungh. max. cons. 37; lungh. codolo e stami 11.2; fodero: lungh. 32, largh. max. 4. Superficie corrosa e ossidata. Mancante di parte degli stami. Tipo T.10.1; fodero tipo T.15.1. n. 11 (Tav. 83, 2): punta di lancia in ferro. Lungh. 26.5; lama: lungh. 20.5, largh. max. 4.5, spessore max. 1.6; cannone: diam. 2.4. Superficie corrosa e ossidata. Integra. Tipo T.40.2.
n. 2 (Tav. 82, 2): calderone con vasca emisferica e fondo piano in lamina di bronzo, con manico mobile in ferro. Diam. orlo 21; alt. 10; spessore manico 0.8. Patina verde in superficie. Integro. Tipo O.320.2.
n. 12 (Tav. 83, 3): punta di lancia in ferro. Lungh. 32; lama: lungh. 28, largh. max. 5, spessore max. 0.9; cannone: diam. 2.4. Superficie corrosa e ossidata. Integra. Tipo T.40.2.
n. 3 (Tav. 82, 7): alare in ferro. Lungh. 75.5; largh. piedini 18; alt. piedini. 16; spessore verga 1-2. Mancante di parte dei piedini. Tipo Q.50.1.
n. 13 (Tav. 83, 4): due sauroteres in ferro. Dimensioni: lungh. 8; diam. 1.5. Superficie corrosa e ossidata. Mancanti delle punte, si rinvengono concrezionati. Tipo T.60.1.
n. 4 (Tav. 82, 8): frammento di piedino di alare in ferro. Largh. max. cons. 18; alt. max. cons. 5.2. Superficie corrosa e ossidata. Si conserva solo un piedino. Pertinente all’esemplare precedente. n. 5 (Tav. 82, 3): spiedo in ferro con testa a ricciolo. Lungh. max. cons. 70; diam. testa 0.9; spessore stelo 1.5. Superficie corrosa e ossidata. Integro. Tipo Q.60.1.
n. 14 (Tav. 83, 5): frammenti di calzari in ferro. Lungh. max. ric. 25.2; largh. max. ric. 10.8; spessore verga 1.4. Superficie corrosa e ossidata. Si conservano tracce del legno. La tomba 231 è stata individuata nel 2007 ma scavata nel 2009 con il numero di tomba 267 (vedi, 308) (Tav.58); le tombe 232-234 sono state individuate, numerate nella planimetria generale (vedi Tav. 58), ma non scavate.
n. 6 (Tav. 82, 4): spiedo in ferro con testa a ricciolo. Lungh. max. cons. 32; diam. testa 1.6; spessore stelo 1. Superficie corrosa e ossidata. Mancante di parte dello stelo. Tipo Q.60.1. n. 7 (Tav. 82, 5): spiedo in ferro con testa a ricciolo. Lungh. max. cons. 50; diam. testa 1.6; spessore stelo 1. Superficie corrosa e ossidata. Mancante di parte dello stelo. Tipo Q.60.1.
Tomba 235 (Campagna 2007; Tavv. 58, 65). Fossa di forma rettangolare orientata in senso nord-ovest/sud-est (lungh. 180; largh. 60; prof. 10), localizzata nell’area nord-occidentale del saggio di scavo. Tagliata dalla tomba 239. Il riempimento risulta coperto da frammenti di coppi, sconvolti da disturbi post-deposizionali di età non definibile. Al suo interno non si rinvengono né resti antropologici né resti del corredo. Inquadramento cronologico: vedi tomba 224.
n. 8 (Tav. 82, 6): spiedo in ferro con testa a ricciolo. Lungh. 64.5; spessore stelo 1. Superficie corrosa e ossidata. Mancante di parte dello stelo e della testa. Tipo Q.60.1. n. 9 (Tav. 82, 9): rasoio a lama allungata in ferro. Lungh. max. cons. 13; lama: largh. max. espansione 3, spessore 0.2; codolo: lungh. 2.8, 290
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
n. 3 (Tav. 83, 6): skyphos a profilo sinuoso in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 19; alt. 8.5. Impasto duro, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 8/3. Vernice coprente, scrostata e opaca applicata per immersione su tutta la superficie tranne il fondo del piede; colore: Munsell 10R 3/1. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.280.4.
Le tombe 236-238 sono state individuate, numerate nella planimetria generale (vedi, Tav. 58), ma non scavate. Tomba 239 (Campagna 2007; Tavv. 58, 65). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso sud-ovest/nord-est (lungh. 200; largh. 80; prof. 70), localizzata nell’area nord-occidentale del saggio di scavo. Taglia in corrispondenza del suo angolo nord-orientale la tomba 235, a est la 255 e a sud la 240 (vedi, scheda successiva, 291 e 302). Sul lato lungo meridionale, a circa 40 rispetto al piano di inumazione è ricavata una nicchia (largh. 44; prof. 16) per l’alloggiamento del ripostiglio. La deposizione è dorsale e primaria; gli arti superiori distesi e aderenti ai fianchi; quelli inferiori distesi e allineati. Dati antropologici. I resti osteologici conservati consistono in poche schegge di ossa lunghe di arti superiori e inferiori, non ulteriormente determinabili. Dati archeologici. Il corredo si compone di una fibula in ferro (n. 4) sul torace; una punta di lancia in ferro (n. 5) presso l’arto superiore sinistro; una coppa in ceramica a vernice nera (n. 2) sui piedi. Il ripostiglio è composto da un’olla in impasto (n. 1) contente uno skyphos in ceramica a vernice nera (n. 3). Il sesso archeologico è determinabile come maschile e le dimensioni della fossa ne suggeriscono l’attribuzione a un individuo adulto. Inquadramento cronologico. Fine IV-prima metà III secolo a.C.
n. 4 (Tav. 83, 10): fibula in ferro con piccolo arco semplice a tutto sesto. Lungh. 4.7; alt. 3. Superficie corrosa e ossidata. Mancante dell’ago. Tipo S.20.A.4, varietà a. n. 5 (Tav. 83, 9): punta di giavellotto in ferro. Lungh. 21.5; largh. max. lama 2.5; diam. cannone 2.4. Superficie corrosa e ossidata. Integra. Tipo T.50.6. Tomba 240 (Campagna 2007; Tavv. 58, 65). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare orientata in senso nordd-ovest/sud-est (lungh. 250; largh. 100; prof. non rilevata), localizzata presso il margine meridionale del saggio di scavo, tagliata dalla tomba 239 (vedi scheda precedente). In corrispondenza dell’angolo settentrionale della fossa, è deposto il ripostiglio, protetto da spezzoni litici di medie dimensioni. Dati antropologici. La sepoltura risulta priva di resti antropologici. Dati archeologici. Il corredo si compone di un’anforetta in impasto buccheroide (n. 1), due fibule a doppia ondulazione in bronzo (nn. 6-7) e una fusaiola in impasto (n. 4) nella posizione originaria del cranio; uno spiedo in ferro (n. 5) lungo il lato destro della fossa; un’olpe in lamina di bronzo (n. 2), di cui rimane solo l’ansa, e un bacile in lamina di bronzo (n. 3) presso i piedi. Il ripostiglio è composto da un’olla in impasto non recuperata in magazzino. Sulla base del corredo e dell’inquadramento cronologico, il sesso archeologico è determinabile come femminile e le dimensioni della fossa ne suggeriscono l’attribuzione a un individuo adulto. Inquadramento cronologico. Fine del VI-prima metà del V secolo a.C.
n. 1 (Tav. 83, 7): olla globulare in impasto grezzo. Diam. orlo 21.6; alt. 34. Impasto duro, con abbondanti inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10R 4/3. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo A.40.B.27. n. 2 (Tav. 83, 8): coppa a profilo distinto in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 20.8; alt. 6. Impasto duro, privo di inclusi; colore: Munsell 7.5YR 8/3. Vernice coprente e opaca applicata per immersione su tutta la superficie tranne il fondo del piede; colore: Munsell 10R 3/1. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.240.C.13.
n. 1 (Tav. 84, 1): vaso a collo in impasto buccheroide. Diam. orlo 9; alt. 19. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di 291
Capestrano, I
settentrionale della fossa, si conserva il ripostiglio. La deposizione è dorsale, primaria e in pessimo stato di conservazione ed era delimitata da un accumulo di spezzoni litici di grandi e medie dimensioni disposti lungo il lato meridionale della fossa. Dati antropologici. I resti dell’individuo della tomba in esame non risultano presenti in deposito quindi non disponibili all’analisi. Dati archeologici. Il corredo si compone di uno stamnos (n. 6), un’oinochoe frammentaria del tipo “Schnabelkanne” (n. 3), un’olpe in lamina di bronzo (n. 4) e una fibula in bronzo (n. 13) deposti presso il cranio; quattro fibule in bronzo sul torace (nn. 9-12); uno spiedo in ferro lungo l’arto superiore sinistro e altri due lungo quello destro, di cui uno disperso (nn. 7-8); un calderone in lamina di bronzo (n. 5) sul bacino; una coppetta su alto piede in ceramica a bande (n. 2) tra gli arti inferiori e un’olla/anfora in impasto (n. 1) presso i piedi. Il ripostiglio è composto da un’olla in impasto non recuperata in magazzino. Sulla base della mancanza delle armi e dell’inquadramento cronologico, il sesso archeologico può essere identificato come femminile; le dimensioni della fossa ne suggeriscono l’attribuzione a un individuo adulto. Inquadramento cronologico. Primo quarto V secolo a.C.
minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10R 3/1. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Ricomposta da più frammenti. Tipo B.30.1. n. 2 (Tav. 84, 2): ansa di olpe in bronzo. Lungh. 13.6; spessore 0.6. Patina verde sulla superficie. Si conserva solo l’ansa fusa piena a sezione quadrangolare con terminazione inferiore circolare con foro centrale per il fissaggio tramite un chiodino e superiore a placchetta rettangolare con due fori per il fissaggio. Tipo non identificabile. n. 3 (Tav. 84, 3): bacile con orlo ribattuto verso l’interno in lamina di bronzo. Diam. orlo 22; alt. 6. Patina verde sulla superficie. Ricomposto da più frammenti. Tipo O.330.B.4. n. 4 (Tav. 84, 6): fuseruola a profilo piriforme in impasto. Diam. 2.2; alt. 2.4. Impasto duro, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10R 3/2. Superficie liscia. Realizzata a mano. Integra. Tipo Q.10.4. n. 5 (Tav. 84, 7): spiedo in ferro con testa a ricciolo. Lungh. 49.5; diam. testa 2.4; spessore stelo 1.5. Superficie corrosa e ossidata. Mancante della punta. Tipo Q.60.1.
n. 1 (Tav. 85, 2): anfora (?) in impasto. Diam. orlo 18; alt. max. cons. 9. Impasto tenero, poroso con rari vacuoli distribuiti in maniera omogenea, frattura frastagliata, con rari inclusi di piccole e medie dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 5YR 7/6. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Si conserva solo l’orlo e il collo. Tipo G.1.
n. 6 (Tav. 84, 4): fibula in bronzo con arco a doppia ondulazione. Lungh. 8.4; alt. 3. Patina verde sulla superficie. Integra. L’arco è decorato da un motivo a due spine di pesce contrapposte. Si conserva parte di una catenella in ferro infilata nella staffa. Tipo S.20.B.1. n. 7 (Tav. 84, 5): fibula in bronzo con arco a doppia ondulazione. Lungh. 8.5; alt. 3. Patina verde sulla superficie. Integra. L’arco è decorato da un motivo a due spine di pesce contrapposte. Si conserva parte di una catenella in ferro infilata nella staffa. Tipo S.20.B.1.
n. 2 (Tav. 85, 1) coppetta in ceramica depurata di imitazione attica (?). Diam. orlo 8.4; alt. 3.6. Impasto tenero, con rarissimi inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea: colore: Munsell 10R 6/6. Decorata a fasce di vernice rossa sull’orlo interno ed esterno, sul corpo e sul piede; colore: Munsell 7.5R 4/4. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Mancante della base del piede. Tipo F.260.1.
Tomba 241 (Campagna 2007; Tavv. 58, 65). Sepoltura a inumazione in fossa di forma rettangolare, orientata in senso sud-ovest/nordest (lungh. 260; largh. 100; prof. 56), localizzata presso il margine nord-occidentale del saggio di scavo. In corrispondenza dell’angolo 292
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
la staffa da motivi a denti di lupo. Tipo S.20.B.1.
n. 3 (Tav. 85, 4): oinochoe di tipo “Schnabelkanne” in lamina di bronzo. Diam. orlo 13.2; alt. max. cons. 5.4. Patina verde sulla superficie. Si conservano solo il becco, il collo e l’ansa.Fibule Tipo O.100.1.
n. 12 (Tav. 85, 9): fibula in bronzo con arco a doppia ondulazione. Lungh. 7; alt. 2.9. Patina verde sulla superficie. Integra. La staffa è decorata da motivi a denti di lupo. Tipo S.20.B.1.
n. 4 (Tav. 85, 3): olpe con spalla rilevata in lamina di bronzo. Diam. orlo 8.6; alt. 13.5. Patina verde sulla superficie. Integra. Tipo O.110.1.
n. 13 (Tav. 85, 11): fibula in bronzo con arco a tripla ondulazione. Lungh. 7; alt. 2.9. Patina verde sulla superficie. Integra. La staffa è decorata con motivi a zig-zag incisi. Tipo S.20.B.3.
n. 5 (Tav. 85, 6): calderone con labbro rientrante e fondo piano in lamina di bronzo, con manico mobile in ferro. Diam. orlo 26; alt. 13; spessore manico 1.6. Patina verde sulla superficie. Integro. Tipo O.320.3.
Tomba 242 (Campagna 2007; Tavv. 58, 66). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare orientata in senso est-ovest (lungh. 220; largh. 80; prof. 10), localizzata presso il margine occidentale del saggio di scavo. Tagliata presso il suo lato occidentale dalla tomba 252 (vedi, 300-301). Nell’angolo nord-occidentale della fossa si conserva il ripostiglio, protetto da un consistente accumulo di pietre. Dati antropologici. I resti dell’individuo della tomba in esame non risultano presenti in deposito quindi non disponibili all’analisi. Dati archeologici. Il corredo si compone di vaghi di collana in pasta vitrea e ambra (n. 5) e due fibule in ferro (nn. 3-4) all’altezza del collo; un bacile in lamina di bronzo (n. 2) in corrispondenza dei piedi. Il ripostiglio è composto da un’olla in impasto, pesantemente disturbata da interventi post-deposizionali (n. 1). Sulla base della mancanza delle armi e dell’inquadramento cronologico, il sesso archeologico può essere identificato come femminile; le dimensioni della fossa ne suggeriscono l’attribuzione a un individuo adulto. Inquadramento cronologico. Seconda metà VIinizi V secolo a.C.
n. 6 (Tav. 85, 5): stamnos in lamina di bronzo. Diam. orlo 12; alt. 11.2. Patina verde sulla superficie. Integro. Tipo O.340.1. n. 7 (Tav. 85, 12): spiedo in ferro con testa ad occhiello. Lungh. 87; diam. testa 1.6; spessore stelo. 1.5. Superficie corrosa e ossidata. Integro. Tipo Q.60.2. n. 8 (Tav. 85, 13): spiedo in ferro con testa ad occhiello. Lungh. 87.5; diam. testa 1.2; spessore stelo 1.5. Superficie corrosa e ossidata. Tipo Q.60.2. n. 9 (Tav. 85, 7): fibula in bronzo con arco a doppia ondulazione. Lungh. 7.6; alt. 2. Patina verde sulla superficie. Integra. L’arco è decorato da un motivo composto da tratti incisi campiti da due croci di S. Andrea; la staffa da motivi a denti di lupo. Tipo S.20.B.1. n. 10 (Tav. 85, 10): fibula in bronzo con arco a doppia ondulazione. Lungh. max. cons. 6.4; alt. 2. Patina verde sulla superficie. Mancante di parte della staffa. L’arco è decorato da un motivo composto da tratti incisi campiti da due croci di S. Andrea; la staffa da motivi a denti di lupo. Tipo S.20.B.1.
n. 1 (Tav. 81, 9): olla in impasto. Diam. orlo 22; alt max. cons. 2.2. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con frequenti inclusi di piccole e medie dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 5YR 4/1. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Si conserva solo parte dell’orlo e del fondo. Tipo A.40.A.4.
n. 11 (Tav. 85, 8): fibula in bronzo con arco a doppia ondulazione. Lungh. 7; alt. 2.4. Patina verde sulla superficie. Integra. L’arco è decorato da due fasci di tratti orizzontali incisi;
293
Capestrano, I
Superficie liscia. Realizzata al tornio. Mancante della spalla, frammentaria. Tipo B.10.1.
n. 2 (Tav. 81, 10): bacile con orlo ribattuto verso l’interno in lamina di bronzo. Diam. orlo 20.4; alt. 5.8. Patina verde sulla superficie. Integro. Tipo O.330.B.4.
n. 2 (Tav. 84, 9): kantharos miniaturistico in impasto buccheroide. Diam. orlo 7.2; alt. 4. Impasto duro, con ferquenti inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 4/1. Superficie liscia. Realizzato a mano. Integro. Tipo B.210.1.
n. 3 (Tav. 81, 11): fibula in ferro con arco semplice a tutto sesto. Lungh. max. cons. 4; alt. 3. Superficie corrosa e ossidata. Mancante di parte dell’ago e della staffa. Tipo S.20.A.3. n. 4 (Tav. 81, 12): fibula in ferro con arco a doppia ondulazione. Lungh. max. ric. 8.5; alt. 3.5. Superficie corrosa e ossidata. Frammentaria, mancante di parte dell’ago e della staffa. Presenta una catenella di anellini in bronzo agganciata. Tipo S.20.B.2. n. 5 (Tav. 81, 13): collana di 3 vaghi in ambra cilindrici del Tipo S.60.B.4; 2 troncoconici del Tipo S.60.B.5; 4 discoidali del Tipo S.60.B.7 (diam. 1.2-0.8; spessore 1.6-2.4); 4 in pasta vitrea a occhi del Tipo S.60.A.2, varietà b5; 3 del Tipo S.60.A.2, varietà b9 (diam. 0.8; spessore 0.5). Integri. Tomba 243 (Campagna 2007; Tavv. 58, 66). Sepoltura a inumazione in fossa di forma rettangolare, orientata in senso sud-ovest/nordest (lungh. 150; largh. 60; prof. 30), localizzata nella porzione centrale del saggio di scavo. Tagliata lungo il suo lato nord-orientale dalla tomba 219 (vedi, 283-284). Presso l’angolo sud-occidentale della fossa, il ripostiglio è protetto da un accumulo di pietre. Dati antropologici. La sepoltura risulta priva di resti antropologici. Dati archeologici. Il ripostiglio è composto da un’anforetta in impasto buccheroide (n. 1) contenente un kantharos miniaturistico della stessa classe (n. 2). Il sesso archeologico non è determinabile; le dimensioni della fossa ne suggeriscono l’attribuzione a un individuo subadulto. Inquadramento cronologico. Fine VI-inizi V secolo a.C.
Tomba 244 (Campagna 2007; Tavv. 58, 66). Sepoltura a inumazione in fossa di forma rettangolare, orientata in senso sud-ovest/nordest (lungh. 260; largh. 130; prof. non rilevata), localizzata nella porzione centrale del saggio di scavo. Non si conservano resti antropologici; è pertanto possibile che si tratti di un cenotafio. Dati antropologici. La sepoltura risulta priva di resti antropologici. Dati archeologici. Il corredo si compone di una spada in ferro (n. 6), un fascio di tre spiedi in ferro (nn. 3-5) e un calzare in legno e ferro (n. 7) deposti lungo il lato sinistro della fossa, insieme ad un calderone in lamina di bronzo con manico mobile in ferro (n. 1); uno stamnos in lamina di bronzo (n. 2) si rinviene presso l’angolo sud-orientale della fossa. Sulla base del corredo, il sesso archeologico può essere identificato come maschile e le dimensioni della fossa ne suggeriscono l’attribuzione a un individuo adulto. Inquadramento cronologico. Fine VI-inizi V secolo a.C. n. 1 (Tav. 86, 2): calderone con labbro rientante e fondo piano in lamina di bronzo, con manico mobile in ferro. Diam. orlo 28.6; alt. 14; spessore manico 1.6. Patina verde sulla superficie. Integro. Tipo O.320.3 n. 2 (Tav. 86, 1): stamnos in lamina di bronzo. Diam. orlo 12.8; alt. 12. Patina verde sulla superficie. Integro. Tipo O.340.1.
n. 1 (Tav. 84, 8): anfora in impasto buccheroide. Diam. orlo 11; diam. fondo 9.4. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 4/1. 294
n. 3 (Tav. 86, 5): spiedo in ferro con testa a ricciolo. Lungh. max. cons. 60.5; diam. testa 1.6; spessore stelo 1. Superficie corrosa e ossidata. Mancante della punta. Tipo Q.60.1. n. 4 (Tav. 86, 6): spiedo in ferro con testa a ricciolo. Lungh. max. cons. 58; diam. testa 1.6;
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
n. 1 (Tav. 87, 2): olletta biansata in impasto grezzo. Diam. orlo 20.8; alt. 21.4. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 8/4. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Manca la spalla e parte del collo e del labbro. Tipo A.70.2.
spessore stelo 1. Superficie corrosa e ossidata. Mancante della punta. Tipo Q.60.1. n. 5 (Tav. 86, 7): spiedo in ferro con testa a ricciolo. Lungh. 79; diam. testa 1.6, spessore stelo 1. Superficie corrosa e ossidata. Integro. Tipo Q.60.1.
n. 2 (Tav. 87, 1): brocchetta in ceramica depurata acroma. Diam. orlo 4; alt. 7. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10YR 8/3. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Mancante dell’ansa. Tipo D.110.3.
n. 6 (Tav. 86, 4): spada in ferro concrezionata all’interno di un fodero in ferro, bronzo e legno. Lungh. max. cons. 69.5; lama: largh. max. visibile 4.6; elsa: lungh. max. 10; spessore placca in ferro 0.8, spessore rivestimento in legno 0.2; fodero: lungh. 56, largh. max. 4.5; puntale: lungh. 4, largh. max. volute 4.8. Superficie corrosa e ossidata. Si conservano tracce del rivestimento in legno dell’elsa e resti dell’anello originariamente innestato sull’impugnatura. Tipo T.20.1; fodero Tipo T.25.1.
Tomba 246 (Campagna 2007; Tavv. 58, 66). Sepoltura in fossa rettangolare orientata in senso sud-ovest/nord-est (lungh. 220; largh. 65; prof. 90), localizzata a ridosso del margine meridionale del saggio di scavo. È tagliata dalla tomba 197 in corrispondenza del suo angolo nord-orientale, taglia la tomba 222 lungo il lato orientale e la 249 lungo quello occidentale (vedi, 267-268, 285-286 e 297). I resti antropologici, probabilmente ascrivibili a un individuo adulto, si rinvengono privi di connessione anatomica, raccolti nella porzione orientale della fossa: non è chiaro se tali condizioni di giacitura siano il risultato di azioni di disturbo post-deposizionale o se siano intenzionali. Dati antropologici. I resti dell’individuo della tomba in esame non risultano presenti in deposito quindi non disponibili all’analisi. Dati archeologici. Il corredo si compone di una coppa in ceramica a vernice nera (n. 2) e una verga in ferro (n. 5) nel settore che doveva essere occupato precedentemente dal bacino; un elemento in ferro presso il cranio (n. 4). Da assegnare al corredo sono anche alcuni frammenti di olla in impasto (n. 1) e uno skyphos in ceramica a vernice nera (n. 3), registrati al momento del rinvenimento come recuperati “tra le tombe 246 e 249”. Provengono probabilmente dallo sconvolgimento della tomba 222 (vedi, 285286) i nn. 2 e 3 del catalogo seguente. Il sesso archeologico non è determinabile; le dimensioni della fossa ne suggeriscono l’attribuzione a un individuo adulto.
n. 7 (Tav. 86, 3): un frammento di calzare in ferro. Largh. dei due elementi in ferro che lo compongono 12, 8; lungh. 6.5, 4. Superficie corrosa e ossidata. Si rinvengono tracce di legno e di tessuto concrezionate. Tomba 245 (Campagna 2007; Tavv. 58, 66). Sepoltura a inumazione in fossa di forma rettangolare, orientata in senso sud-ovest/nordest (lungh. 230; largh. 70; prof. non rilevata), localizzata nella porzione centrale del saggio di scavo. È profondamente disturbata dall’impianto della tomba 227 e taglia la 211 (vedi, 276, 288-289). Non si rinvengono resti antropologici, probabilmente asportati dall’impianto della tomba più recente. Dati antropologici. La sepoltura risulta priva di resti antropologici. Dati archeologici. Del corredo si conservano un’olla in impasto (n. 1) contenente una brocchetta in ceramica depurata acroma (n. 2), deposte al centro del piano di deposizione. Il sesso archeologico non è determinabile; le dimensioni della fossa ne suggeriscono l’attribuzione a un individuo adulto. Inquadramento cronologico. Fine VI-inizi V secolo a.C.
295
Capestrano, I
pessimo stato di conservazione, contenente due placchette in bronzo (n. 1). Inquadramento cronologico. Incerto.
Inquadramento cronologico. Seconda metà IIIinizi II secolo a.C. n. 1 (Tav. 81, 16): olla in impasto. Diam. orlo 15; alt. max. cons. 5. Impasto tenero, poroso con frequenti vacuoli distribuiti in maniera omogenea, frattura frastagliata, con scarsi inclusi di piccole e medie dimensioni; colore: Munsell 10YR 5/1. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Si conservano solo parte dell’orlo e della spalla. Tipo A.40.B.26.
n. 1 (Tav. 87, 3): tre placchette in lamina di bronzo, con fori passanti (rispettivamente tre, uno e uno). Lungh. 5.4, 4.8, 4; largh. 1.6; spessore 0.2. Patina verde sulla superficie. Lacunose. Tomba 248 (Campagna 2007; Tavv. 58, 66). Sepoltura a inumazione realizzata in una fossa di forma irregolare, contenente la riduzione dei resti antropologici di individuo adulto (lungh. max. 85; largh. max. 65; prof. 60), localizzata nella zona centrale del saggio di scavo. I resti antropologici si rinvengono privi di connessione anatomica, ad esclusione della porzione superiore, in decubito laterale sinistro. Dati antropologici. I resti umani appartengono a un individuo adulto femminile maggiore di 30 anni. Lo scheletro è estremamente frammentario, ma tutti i distretti scheletrici sono rappresentati. Una porzione di bacino ben conservata permette di determinarne il sesso poiché l’incisura ischiatica è molto ampia, ma anche l’età, considerando la superficie auricolare dell’ileo, potrebbe corrispondere a 40-44 anni. La statura in vita risulta di 154.5 cm dal calcolo a partire dalla lunghezza massima del femore sinistro (406 mm). Dati archeologici. Nel riempimento si rinvengono solo frammenti di ceramica d’impasto non diagnostici. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Incerto.
n. 2 (Tav. 81, 14): coppa a profilo globuare in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 20; alt. 7.5. Impasto duro, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 8/3. Vernice coprente e opaca applicata per immersione su tutta la superficie tranne il fondo del piede; colore: Munsell 10R 3/1. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.240.A.9. n. 3 (Tav. 81, 15): skyphos a profilo troncoconico in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 9.7; alt. 10.8. Impasto duro, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 8/3. Vernice coprente, scrostata e semi-lucida applicata per immersione su tutta la superficie tranne il fondo del piede; colore: Munsell 7.5YR 2.5/1. Superficie liscia. Realizzato al tornio. Integro. Tipo H.280.7. n. 4 (Tav. 81, 17): frammento in ferro a sezione rettangolare convessa, da riferire probabilmente alla spada della tomba 222. Lungh. max. cons. 1.5; largh. max. cons. 1,8. Superficie corrosa e ossidata. n. 5 (Tav. 81, 18): Frammento in ferro a sezione quadrangolare, da riferire probabilmente allo spiedo della tomba 222. Lungh. max. cons. 5.7; spessore. 1. Superficie corrosa e ossidata. Tomba 247 (Campagna 2007; Tavv. 58, 66). Si numera come tomba 247 il resto di una possibile inumazione in fossa rettangolare, di cui non è stato possibile definire puntualmente i limiti, per quanto essi sembrino orientati in senso sud-est/nord-ovest, individuata in prossimità delle tombe 205 e 206, nella zona meridionale del saggio di scavo (vedi, 272-273). Non vi si rinvengono resti antropologici e del corredo si recuperano solo un’olla in impasto in 296
Tomba 249 (Campagna 2007; Tavv. 58, 67). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso sud-ovest/nord-est (lungh. 290; largh. 120; prof. 90), localizzata nella porzione centrale del saggio di scavo. Tagliata lungo il suo lato orientale dalla tomba 246 (vedi, 295-296). In corrispondenza dell’angolo nord-occidentale della fossa, si conserva il ripostiglio protetto da un consistente accumulo di spezzoni litici di grandi e medie dimensioni. Si rinvengono scarsi resti antropologici in pessimo stato di conservazione relativi al cranio e alle tibie, che suggeriscono una deposizione dorsale e primaria.
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
fodero in legno concrezionati. Tipo T.20.1, varietà a.
Dati antropologici. I resti dell’individuo della tomba in esame non risultano presenti in deposito quindi non disponibili all’analisi. Dati archeologici. Il corredo è composto da una punta di lancia in ferro (n. 6) presso il lato sinistro del cranio; una coppa in impasto buccheroide su alto piede (n. 2) alla destra; una spada (n. 5) e uno spiedo in ferro (n. 4) lungo il lato sinistro della fossa; un calderone in lamina di bronzo con manico mobile in ferro (n. 3) presso i piedi. Il ripostiglio è composto da un’olla in impasto (n. 1). Il sesso archeologico è definibile come maschile e sulla base delle dimensioni della fossa, la sepoltura può essere attribuita ad un individuo adulto. Inquadramento cronologico. Metà VI secolo a.C.
n. 6 (Tav. 88, 5): punta di lancia in ferro. Lungh. 46; lama: lungh. 36, largh. max. 4, spessore max. 1.6; cannone: diam. 2.4. Integra. Superficie corrosa e ossidata. Si conserva parte dell’asta in legno. Tipo T.40.2. Tomba 250 (Campagna 2007; Tavv. 58, 67). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso sud-ovest/nord-est (lungh. 230; largh. 70; prof. 100), localizzata presso il margine nord-occidentale del saggio di scavo. Taglia lungo il suo lato orientale la tomba 221 (vedi, 284-285). Lungo il lato meridionale della fossa è scavata una piccola nicchia posta ad una quota superiore (30) rispetto al piano di inumazione (largh. 33; prof. 40), funzionale all’alloggiamento del ripostiglio. I pochi resti antropologici rinvenuti suggeriscono una deposizione dorsale e primaria. Si conservano un frammento di cranio e un piccolo frammento di diafisi di femore di un individuo adulto. Dati antropologici. Gli scarsissimi resti ossei conservati non consentono di proporre considerazioni sui caratteri biologici dell’inumato Dati archeologici. Il corredo è composto da due anellini in bronzo (nn. 4-5) presso il femore destro; una coppa in ceramica a vernice nera (n. 2) nella posizione occupata originariamente dai piedi. Il ripostiglio è composto da un’olla in impasto (n. 1) contenente uno skyphos a vernice nera (n. 3). Il sesso archeologico non è determinabile e sulla base delle dimensioni della fossa, la sepoltura può essere attribuita ad un individuo adulto. Inquadramento cronologico. Fine IV-prima metà III secolo a.C.
n. 1 (Tav. 88, 1): olla globulare in impasto grezzo. Diam. orlo 29; alt. 44. Impasto duro, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10R 4/2. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo A.40.B.3. n. 2 (Tav. 88, 2): coppetta globulare in impasto buccheroide. Diam. orlo 6.4; alt. 7. Impasto duro, con rarissimi inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 5/1. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo B.260.2. n. 3 (Tav. 88, 3): calderone con labbro rientrante e fondo piano in lamina di bronzo, con manico mobile in ferro. Diam. orlo 23; alt. 11.2; spessore manico 0.8. Patina verde sulla superficie. Integro. Manico in frammenti. Tipo O.320.3. n. 4 (Tav. 88, 6): spiedo in ferro. Lungh. max. cons. 71.5; spessore stelo 1. Superficie corrosa e ossidata. Mancante della testa. Tipo non identificabile.
n. 1 (Tav. 87, 6): olla globulare in impasto grezzo. Diam. orlo 18; alt. max. cons. 8.5. Impasto tenero, poroso con rari vacuoli distribuiti in maniera omogenea, frattura frastagliata, con inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5R 5/6. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Si conservano il collo e il labbro. Tipo A.40.B.29.
n. 5 (Tav. 88, 4): spada in ferro. Lungh. max. cons. 69.5; lama: lungh. 56; larghezza max. 3.5; spessore max. 1.2; elsa: largh. max. espansione 3.2, spessore placca in ferro 0.8. Superficie corrosa e ossidata. L’elsa manca della parte superiore; sulla lama si conservano resti del
297
Capestrano, I
tripla ondulazione (n. 22), una scodella in impasto buccheroide (n. 21), un frammento di parete con prese a bugna in impasto (n. 20) e un frammento di ansa in ceramica a vernice nera. Il sesso archeologico non è determinabile anche se, sulla base delle dimensioni della fossa, la deposizione è attribuibile a un individuo subadulto. Inquadramento cronologico. Fine I secolo a.C. (età augustea).
n. 2 (Tav. 87, 4): coppa a profilo distinto in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 21; alt. 6.5. Impasto duro, privo di inclusi; colore: Munsell 7.5YR 8/3. Vernice coprente e opaca applicata per immersione su tutta la superficie tranne il fondo del piede; colore: Munsell 7.5R 3/1. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.240.C.13. n. 3 (Tav. 87, 5): skyphos a profilo troncoconico in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 11; alt. 12. Impasto duro, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omgenea; colore: Munsell 7.5YR 8/3. Vernice diluita, scrostata e opaca applicata per immersione su tutta la superficie tranne il fondo del piede; colore: Munsell 7.5R 3/1. Superficie liscia. Realizzato al tornio. Integra. Tipo H.280.10.
n. 1 (Tav. 89, 1): lagynos piriforme in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 3.5; alt. 9.2. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 8/2. Vernice diluita, scrostata e opaca applicata per immersione su tutta la superficie tranne il fondo del piede; colore: Munsell 7.5YR 3/1. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Ricomposta da più frammenti. Tipo H.120.2.
nn. 4-5 (Tav. 87, 7-8): due anelli in bronzo con verga sottile. Diam. 2; spessore verga 0.1. Patina verde in superficie. Il n. 5 è frammentario. Tipo S.40.A.1.
n. 2 (Tav. 89, 2): coppetta a profilo distinto in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 14; alt. 5 Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10R 5/6. Vernice diluita, scrostata, opaca applicata per immersione su tutta la superficie tranne il fondo del piede; colore: Munsell 7.5YR 2.5/1. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Ricomposta da più frammenti. Tipo H.260.C.4.
Tomba 251 (Campagna 2007; Tavv. 58, 67). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso sud-ovest/nord-est (lungh. 150; largh. 70; prof. 20), localizzata nell’area sud-occidentale del saggio di scavo. La deposizione è dorsale e primaria; il cranio è rivolto verso sinistra; gli arti superiori inferiori distesi e allineati. Dati antropologici. I resti dell’individuo della tomba in esame non risultano presenti in deposito quindi non disponibili all’analisi. Dati archeologici. Il corredo si compone di un bicchiere in ceramica a pareti sottili (n. 5), un’olletta in ceramica comune (n. 3), un balsamario ceramico (n. 8), una brocca in ceramica comune (n. 4) e una coppa in ceramica a vernice nera (n. 2) nei pressi del cranio; nove balsamari ceramici presso il bacino (nn. 9-17); una lagynos in ceramica a vernice nera (n. 1), due lucerne (nn. 6-7) e gusci di conchiglie bivalve (n. 19) lungo il lato sinistro della fossa. Si rinvengono inoltre undici chiodi in ferro (n. 18) lungo il perimetro della fossa, pertinenti a una cassa lignea che conteneva originariamente il defunto. Nel riempimento della fossa si rinvengono una fibula in bronzo a
n. 3 (Tav. 89, 4): olletta ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 10.4; alt. 10.5. Impasto compatto, con abbondanti inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 4/2. Superficie liscia, con aloni di cottura. Realizzata al tornio. Integra. Tipo I.50.B.9, varietà b. n. 4 (Tav. 89, 3): brocca globulare in ceramica comune. Diam. orlo 11; alt. 14.8. Impasto duro, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10YR 8/4. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo I.110.2. n. 5 (Tav. 89, 5): bicchiere troncoconico in ceramica a pareti sottili. Diam. orlo 10; alt. 10.5. Impasto duro, compatto, frattura netta, privo di 298
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
inclusi; colore: Munsell 10R 5/6. Superficie ruvida; si conservano tracce di un rivestimento; colore rivestimento: Munsell 7.5YR 6/1. Realizzato al tornio. Frammentario. Tipo L.180.1.
distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 2.5YR 5/8. Fascia di vernice in corrispondenza del labbro e del collo; colore: Munsell 5YR 4/1. Superficie liscia. Realizzato al tornio. Integro. Tipo N.130.7, varietà b.
n. 6 (Tav. 89, 6): lucerna tipo “Vogelkopflampen”. Diam. disco 7; lungh. becco 5.4; alt. 4.5. Impasto duro, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 10R 4/6. Superficie lisciata e ingobbiata; colore dell’ingobbio: Munsell 7.5R 4/8. Realizzata a matrice. Integra. Tipo M.B.1.
n. 12 (Tav. 89, 12) balsamario ceramico piriforme. Diam. orlo 2.2; alt. 7.1 Impasto duro, con rarissimi inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 2.5YR 5/8. Fascia di vernice in corrispondenza del labbro e del collo; colore: Munsell 5YR 4/1. Superficie liscia. Realizzato al tornio. Integro. Tipo N.130.7, varietà b.
n. 7 (Tav. 89, 7): lucerna a volute di piccole dimensioni. Diam. disco 3.5; lungh. becco 4.9; alt. 3.5. Impasto duro, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10R 4/3. Superficie liscia e ingobbiata; colore dell’ingobbio: Munsell 2.5YR 4/4. Realizzata a matrice. Integra. Tipo M.C.3.
n. 13 (Tav. 89 13): balsamario ceramico piriforme. Diam. orlo 2.8; alt. 10 Impasto duro, con rarissimi inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 2.5YR 5/8. Fascia di vernice in corrispondenza del labbro e del collo; colore: Munsell 5YR 4/1. Superficie liscia. Realizzato al tornio. Integro. Tipo N.130.7, varietà b.
n. 8 (Tav. 89, 8): balsamario ceramico globulare. Diam. piede 1.8; alt. max. cons. 7.8. Impasto duro, compatto, frattura netta, privo di inclusi; colore: Munsell 7.5R 4/6. Superficie ruvida. Realizzato al tornio. Mancante del collo. Tipo N.130.8. n. 9 (Tav. 89, 9): balsamario ceramico piriforme. Diam. orlo 2.4; alt. 9.6. Impasto duro, con rarissimi inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 2.5YR 5/8. Fascia di vernice in corrispondenza del labbro e del collo; colore: Munsell 5YR 4/1. Superficie liscia. Realizzato al tornio. Integro. Tipo N.130.7, varietà b.
n. 14 (Tav. 89, 14): balsamario ceramico piriforme. Diam. orlo 2.4; alt. 7.6 Impasto duro, con rarissimi inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 2.5YR 5/8. Fascia di vernice in corrispondenza del labbro e del collo; colore: Munsell 5YR 4/1. Superficie liscia. Realizzato al tornio. Integro. Tipo N.130.7, varietà b.
n. 10 (Tav. 89, 10): balsamario ceramico piriforme. Diam. orlo 2.2; alt. 7. Impasto duro, con rarissimi inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 2.5YR 5/8. Fascia di vernice in corrispondenza del labbro e del collo; colore: Munsell 5YR 4/1. Superficie liscia. Realizzato al tornio. Integro. Tipo N.130.7, varietà b. n. 11 (Tav. 89, 11): balsamario ceramico piriforme. Diam. orlo 2.2; alt. 8.6. Impasto duro, con rarissimi inclusi di minute dimensioni 299
n. 15 (Tav. 89, 15): balsamario ceramico piriforme. Diam. orlo 2.2; alt. 8.8. Impasto duro, con rarissimi inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 2.5YR 5/8. Fascia di vernice in corrispondenza del labbro e del collo; colore: Munsell 5YR 4/1. Superficie liscia. Realizzato al tornio. Integro. Tipo N.130.7, varietà b. n. 16 (Tav. 89, 16): balsamario ceramico piriforme. Diam. orlo 2.6; alt. 9.5 Impasto duro, con rarissimi inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 2.5YR 5/8. Fascia di vernice in corrispondenza del labbro e del collo; colore: Munsell 5YR 4/1. Superficie liscia. Realizzato al tornio. Integro. Tipo N.130.7, varietà b.
Capestrano, I
n. 17 (Tav. 89, 17): balsamario ceramico piriforme. Diam. orlo 2.2; alt. 7.7. Impasto duro, con rarissimi inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 2.5YR 5/8. Fascia di vernice in corrispondenza del labbro e del collo; colore: Munsell 5YR 4/1. Superficie liscia. Realizzato al tornio. Integro. Tipo N.130.7, varietà b. n. 18 (Tav. 89, 18): undici chiodi in ferro. Diam. testa 1; alt. 12-4. Superfici corrose e ossidate. Quattro sono lacunosi. Tipo Q.110.1. n. 19 (Tav. 89, 19): quattro gusci di conchiglie bivalve. Diam. 4. Alcuni sono frammentari. Provengono dal riempimento della fossa i seguenti materiali: n. 20 (Tav. 89, 21): olletta troncoconica in impasto grezzo. Diam. orlo 20.8; alt. 9.5. Impasto tenero, poroso con frequenti vacuoli distribuiti in maniera disomogenea; frattura frastagliata, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 2.5YR 4/1. Superficie liscia. Realizzata a mano. Si conservano solo il labbro e la spalla. Tipo A.50.C.1. n. 21 (Tav. 89, 20): scodella carenata in impasto buccheroide. Diam. orlo 12.2; alt. 6.6. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 5YR 3/1. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Ricomposta da più frammenti. Tipo B.230.A.4. n. 22 (Tav. 89, 22): fibula in bronzo con arco a tripla ondulazione, di piccole dimensioni. Lungh. 4; alt. 1.7. Patina verde sulla superficie. Integra. Tipo S.20.B.3, variante a. Tomba 252 (Campagna 2007; Tavv. 58, 67). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso sud-ovest/nord-est (lungh. 210; largh. 80; prof. 50), localizzata presso il margine occidentale del saggio di scavo. Taglia la tomba 242 (vedi, 293-294). La deposizione è dorsale, primaria e in ambiente vuoto; il cranio è in posizione frontale; gli arti superiori aderenti
ai fianchi con le mani sulla zona pelvica; quelli inferiori distesi e allineati. Dati antropologici. L’inumato principale è un individuo adulto femminile di oltre 35 anni. Tutti i distretti scheletrici sono presenti, ma lo stato di conservazione è estremamente frammentario. Nel cranio e nella mandibola si osservano le caratteristiche sessuali secondarie femminili. Si può stimare una età matura, considerando lo stato di ossificazione delle suture coronale e sagittale e valutando il grado di usura dentaria. Oltre all’individuo principale, si segnala la presenza di un altro individuo rappresentato da due omeri (destro e sinistro). Alcuni resti umani sono raccolti in una vaschetta denominata “Capestrano Capo d’Acqua 252, resti ossei” e consistono in frammenti di cranio con cresta nucale molto evidente e processo mastoideo maschile. In questo contesto tombale sono stati raccolti separatamente con indicazione “dal riempimento T 252” frammenti di ileo con incisura ischiatica molto ampia e di radio e clavicola che potrebbero appartenere all’individuo femminile. Infine, sempre provenienti dal “riempimento della tomba 252” si documenta la presenza di calotta cranica ed elementi dentari, prima costa, diafisi di tibia. Considerando lo sviluppo dei denti, in particolare è visibile il terzo molare mascellare sotto la linea di eruzione, la stima dell’età alla morte è di circa 15 anni. Dati archeologici. Il corredo si compone di una punta di lancia in ferro (n. 6) presso il lato destro del cranio; una fibula in ferro (n. 5) sul torace; un piatto (n. 3), una coppa (n. 1) e una coppetta (n. 2) in ceramica a vernice nera e un poculum in ceramica comune (n. 4) sui piedi. Il sesso archeologico è determinabile come maschile. Inquadramento cronologico. (Fine IV)inizi/prima metà III secolo a.C. n. 1 (Tav. 90, 1): coppa a profilo globulare in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 19.8; alt. 6.5. Impasto duro, con rarissimi inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 8/3. Vernice consistente con riflessi metallici applicata per immersione su tutta la superficie tranne il fondo
300
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
inclusi di piccole e medie dimensioni; colore: Munsell 5YR 5/2. Superficie liscia. Realizzata a mano. Si conserva solo il fondo piano e parte del ventre ovoide. Tipo non identificabile.
del piede; colore: Munsell 7.5YR 3/1. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.240.A.6. n. 2 (Tav. 90, 2): coppetta a profilo globulare in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 4.4; alt. 2.5 Impasto duro, con rarissimi inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 8/3. Vernice coprente scrostata e opaca applicata per immersione su tutta la superficie tranne il fondo del piede; colore: Munsell 7.5YR 3/1. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.260.A.11.
n. 8 (Tav. 90, 8) fibula in ferro a doppia ondulazione. Lungh. max. cons. 4; alt. max. cons. 1.5. Superficie corrosa e ossidata. Si conserva solo parte dell’arco. Tipo non identificabile.
n. 3 (Tav. 90, 3): piatto a vasca troncoconica e labbro svasato in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 15.2; alt. 3.5. Impasto duro, con rarissimi inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 8/2. Vernice coprente e tendente al lucente applicata per immersione su tutta la superficie tranne il fondo del piede; colore: Munsell 5YR 3/2. Superficie liscia. Realizzato al tornio. Integro. Tipo H290.C.4. n. 4 (Tav. 90, 4): poculum in ceramica comune. Diam. orlo 9.2; alt. 9. Impasto tenero, con abbondanti inclusi di piccole e medie dimensioni; colore: Munsell 2.5YR 4/2. Superficie liscia. Realizzato al tornio. Integro. Tipo I.190.3, varietà b. n. 5 (Tav. 90, 5): fibula in ferro con arco semplice. Lungh. max. cons. 3.5; alt. 3.5. Superficie corrosa e ossidata. Mancante di parte dell’arco, dell’ago e della staffa. Probabilmente ascrivibile al Tipo S.20.A.4, varietà a. n. 6 (Tav. 90, 6): punta di lancia in ferro. Lungh. max. cons. 30; lama: lungh. max. cons. 20, largh. max. 3.5; spessore max.1: cannone: diam. 2.4. Superficie corrosa e ossidata. Mancante della punta. Tipo T.40.2. Provengono materiali:
dal
riempimento
i
seguenti
n. 7 (Tav. 90, 7): olletta in ceramica comune. Diam. fondo 7; alt. max. cons. 4. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con frequenti 301
Tomba 253 (Campagna 2007; Tav. 58, manca la planimetria di dettaglio). Sepoltura a incinerazione realizzata in una fossa di forma rettangolare, orientata in senso sudest\nord-ovest (lungh. 80; largh. 60; prof. 15), localizzata presso l’angolo sud-occidentale del saggio di scavo. Dati antropologici. Si rinvengono pochi frammenti ossei umani con traccia di azione del fuoco, infatti hanno aspetto di colore calcinato bianco e deformazioni evidenti della corticale. Tra questi, si possono determinare soltanto un frammento di vertebra e di bacino attribuibili ad un individuo adulto. Il peso totale risulta di 536.25 gr. Dati archeologici. All’interno dello strato superficiale, che copre uno strato di argilla concotta, a sua volta impostato su un livello di carboni, si rinvengono i resti combusti di un individuo, insieme a numerosi frammenti fittili relativi forme vascolari in ceramica in impasto (nn. 1-2) e un elemento in ferro (n. 3) sottoposti a combustione. Questi materiali non sembrano però coerenti con la datazione proposta dell’evidenza, sulla base del rituale, attestato nel resto della necropoli in esame solo per l’età imperiale. Inquadramento cronologico. Prima età imperiale (?). n. 1 (Tav. 90, 10): olla in impasto. Diam. orlo 28; alt. max. cons. 3.2. Impasto tenero, poroso con frequenti vacuoli distribuiti in maniera omogenea, frattura frastagliata, con abbondanti inclusi di piccole e medie dimensioni; colore: Munsell 10R 4/3. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Si conserva solo il labbro, lievemente svasato con orlo ingrossato e distinto, a sezione quadrangolare. Tipo non puntualizzabile.
Capestrano, I
(vedi, 291). Mancano completamente i resti antropologici e non è pertanto possibile ipotizzare né il genere né l’età del defunto; è invece possibile suggerire una interpretazione dell’evidenza come cenotafio. Il corredo risulta anch’esso sconvolto e si conservano solo pochi frammenti di forme chiuse di impasto buccheroide (nn. 1-2). Inquadramento cronologico. Età arcaica.
n. 2 (Tav. 90, 9): scodella carenata in impasto buccheroide. Diam. orlo 16; alt. max. cons. 3. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 7.5YR 3/1. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Si conserva solo il labbro e parte della vasca. Tipo non puntualizzabile. n. 3 (Tav. 90, 11): elemento (ago? Spillone?) in ferro. Lungh. max. cons. 15.5; spessore stelo 0.4. Superficie corrosa e ossidata. Si conserva parte della verga a sezione rettangolare con terminazione a punta a sezione circolare. Tipo non identificabile.
n. 1 (Tav. 90, 12): olla in impasto buccheroide. Alt. max. cons. 8.2. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 4/1. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Si conserva solo parte della spalla e del collo. Tipo non identificabile.
Tomba 254 (Campagna 2007; Tavv. 58, 68). Sepoltura a inumazione in fossa orientata in senso nord-est/sud-ovest (lungh. max. cons. 180; largh. max. cons. 100; prof. 20), localizzata a ridosso del margine nordoccidentale del saggio di scavo; è profondamente disturbata da interventi postdeposizionali. Della deposizione, si rinvengono nella posizione originaria solo i femori allineati. Dati antropologici. I resti dell’individuo della tomba in esame non risultano presenti in deposito quindi non disponibili all’analisi. Dati archeologici. Il corredo si compone di un bacile in lamina bronzea (n. 1) e uno spiedo in ferro (n. 2), deposti lungo gli arti inferiori. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Fine VI-prima metà V secolo a.C.
n. 2 (Tav. 90, 13): frammenti di impasto buccheroide attribuibili a forme chiuse decorate con fasci di linee e triangoli incisi (vedi tomba 212, nn. 1-3). Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 3/1. Superficie liscia. Realizzati al tornio. Tipo non identificabile. Tomba 256 (Campagna 2007; Tavv. 58, 68). Sepoltura a incinerazione realizzata in una piccola fossa pressoché quadrangolare (lungh. 60; largh. 50; prof. 20), localizzata presso il margine sud-occidentale del saggio di scavo. Taglia la tomba 208 (vedi, 274). Dati antropologici. Dell’individuo si conservano soltanto tre piccoli frammenti di ossa lunghe combuste per un totale di soli 3 gr. di peso. Dati archeologici. Tra le ceneri si rinviene un’olletta in ceramica comune (n. 1). Inquadramento cronologico. I secolo d.C.
n. 1 (Tav. 91, 1): bacile con orlo ribattuto verso l’interno in lamina di bronzo. Diam. orlo 17; alt. max. cons. 5. Patina verde sulla superficie. Integro. Tipo O.330.B.4. n. 2 (Tav. 91, 2): spiedo in ferro con testa a ricciolo. Lungh. 52.5; diam. testa 1.6; spessore stelo. 1. Superficie corrosa e ossidata. Tipo Q.60.1.
n. 1 (Tav. 90, 14): olletta ovoide/piriforme in ceramica comune. Diam. orlo 7.8; alt. 9.4. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con abbondanti inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 6/2. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Ricomposta da più frammenti. Tipo I.50.B.15, varietà b.
Tomba 255 (Campagna 2007; Tavv. 58, 68). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare orientata in senso sud-est/nord-ovest (lungh. max. cons. 170; largh. max. cons. 40; prof. 20), localizzata presso il margine nord-occidentale del saggio di scavo. Tagliata dalla tomba 239
Tomba 257 (Campagna 2007; Tavv. 58, 68). 302
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso sud-est/nord-ovest (lungh. 230; largh. 100; prof. 30), localizzata a ridosso del margine sud-occidentale del saggio di scavo. Taglia le tombe 208 e 209 (vedi, 274-275). In corrispondenza dell’angolo occidentale della fossa, il ripostiglio è protetto da un accumulo di spezzoni litici di grandi e medie dimensioni. La deposizione è dorsale e primaria e in ambiente vuoto; il cranio risulta rivolto verso nord; gli arti superiori sono aderenti ai fianchi con le mani sulle ossa pelviche; gli arti inferiori distesi e allineati. Dati antropologici. L’inumato è un adulto maschile di 25-35 anni. Lo stato di conservazione è frammentario e lacunoso. La determinazione del sesso si basa sull’osservazione dei caratteri sessuali secondari del frontale e del processo mastoideo del cranio e dell’incisura ischiatica dell’ileo. Molto probabilmente la morte è avvenuta in giovane età, considerando l’assenza di tracce di ossificazione delle suture craniche e l’usura dentaria limitata allo smalto. Si rileva la presenza di assenza di tessuto osseo di forma puntiforme (cribra orbitalia) di lieve entità nel tetto di entrambe le orbite (fig.antr.online 257_01). La presenza di cribra orbitalia, sebbene si tratti di una anomalia paleopatologica non-specifica, resta un importante indicatore riconducibile ad un problema ematico, la cui eziologia può essere varia, ma soprattutto vi possono concorrere diversi fattori ambientali, tra cui una alimentazione carente. In questo caso non sono documentate altre manifestazioni scheletriche che permettano una diagnosi differenziale. Dati archeologici. Il corredo si compone di uno spiedo (n. 3) e una spada in ferro (n. 4) lungo l’arto inferiore destro; una scodella in impasto buccheroide (n. 2) presso quello sinistro; una punta di lancia in ferro (n. 5) sul piede sinistro. Il ripostiglio è composto da un’olla in impasto (n. 1). Il sesso archeologico è determinabile come maschile. Inquadramento cronologico. Fine del VI-prima metà del V secolo a.C. n. 1 (Tav. 91, 4): olla globulare in impasto grezzo. Diam. orlo 22; alt. 31.5. Impasto tenero, compatto, frattura irregolare, con rari inclusi di 303
piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 6/2. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Ricomposta da più frammenti. Tipo A.40.B.18. n. 2 (Tav. 91, 3): scodella carenata in impasto buccheroide. Diam. orlo 17; alt. 6.9. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni; colore: Munsell 7.5YR 4/1. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Ricomposta da più frammenti. Tipo B.230.A.6. n. 3 (Tav. 91, 7) spiedo in ferro con testa ad occhiello. Lungh. 73; diam. testa 2; spessore stelo. 1. Superficie corrosa e ossidata. Frammentario e mancante di parte dello stelo. Tipo Q.60.2. n. 4 (Tav. 91, 5): spada in ferro. Lungh. max. cons. 73; lama: lungh. max. cons. 60.8, largh. max. 3.5, spessore max. 1.2; elsa: largh. max., spessore placca in ferro 1.2. Superficie corrosa e ossidata. Mancante di parte dell’elsa e della punta. Tipo T.20.1. n. 5 (Tav. 91, 6): punta di lancia in ferro. Lungh. 24.5; lama: lungh. 16.1; largh. max. 3.2, spessore max. 1.2; cannone: diam. 2.4. Superficie corrosa e ossidata. Integra. Tipo T.40.1. Tomba 258 (Campagna 2007; Tav. 58, manca la planimetria di dettaglio). Sepoltura a inumazione in fossa di forma rettangolare (lungh. 175; largh. 86; prof. non rilevata) localizzata presso il limite meridionale del saggio di scavo e orientata in senso sudest/nord-ovest. Manca la documentazione circa i resti antropologici e i materiali rinvenuti al suo interno, ad eccezione di un frammento di olla in impasto (n. 1). Inquadramento cronologico. Fine VI-prima metà V secolo a.C. (?). n. 1 (Tav. 90, 15): olla globulare in impasto grezzo. Diam. orlo 21; alt. max. cons. 7.5. Impasto duro, poroso con rari vacuoli distribuiti in maniera disomogenea, frattura irregolare, con abbondanti inclusi di piccole dimensioni; colore: Munsell 7.5YR 4/1. Superficie liscia.
Capestrano, I
Realizzata al tornio. Si conservano solo il labbro e la spalla. Tipo A.40.B.17.
attingitoio (n. 2). Un peso da telaio si rinviene nel riempimento (n. 3). Sulla base della mancanza delle armi e dell’inquadramento cronologico, il sesso archeologico può essere identificato come femminile. Inquadramento cronologico. VI secolo a.C.
III.3. FOSSASCOPANA: LA CAMPAGNA 2008 (TOMBE 259-284) (Francesca Delle Grazie; Deneb Cesana per le analisi antropologiche)7.
n. 1 (Tav. 97, 1): olla ovoide in impasto. Alt. max. cons. framm. di labbro 3.4; alt. max. cons. frammento di fondo 7.5. Impasto duro con rari vacuoli, frattura irregolare, con frequenti inclusi di piccole e medie dimensioni distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 2.5YR 4/4. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Si conservano due frammenti del labbro e del fondo. Tipo A.40.A.7.
Nel 2008 è proseguita l’indagine del saggio avviato nel corso del 2007, con una breve campagna di scavo che ha portato alla luce esclusivamente tombe a inumazione in fossa, coerenti cronologicamente con quelle già rinvenute. Tomba 259 (Campagna 2008; Tavv. 58, 92). Sepoltura a inumazione in fossa di forma rettangolare, orientata in senso sud-ovest/nordest (lungh. 215; largh. 50; prof. 27), localizzata nella porzione sud-occidentale del saggio di scavo. La fossa taglia la più antica tomba 274 (vedi, 312). Sul lato lungo settentrionale, in corrispondenza dell’angolo nord-orientale, è ricavata una nicchia per l’alloggiamento del ripostiglio (largh. 45; prof. 25). Deposizione dorsale, primaria e probabilmente in uno spazio vuoto; il cranio è volto a sud. Dati antropologici. Lo scheletro è in pessimo stato di conservazione e molto frammentario. Si conservano alcuni frammenti di cranio, singoli elementi dentari e poche diafisi delle ossa lunghe degli arti inferiori. Dalla morfologia dell’incisura ischiatica i resti umani potrebbero appartenere ad un individuo adulto femminile, la cui età alla morte può essere indicativamente stimata tra 25-35 anni. Dati archeologici. Il corredo è composto da cinque vaghi di collana in pasta vitrea in corrispondenza del collo (n. 5); un anello digitale in bronzo alla mano sinistra (n. 4). Nella nicchia del ripostiglio si recuperano due frammenti di olla in impasto (n. 1) e un frammento di ansa appartenente ad un
n. 2 (Tav. 97, 2): frammento di ansa di oinochoe in impasto buccheroide. Lungh. max. cons. 2.1. Impasto duro con vacuoli molto rari, frattura regolare, con inclusi molto rari di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 5Y 2.5/1. Superficie liscia. Senza tipo di riferimento. n. 3 (Tav. 97, 3): peso da telaio troncopiramidale in impasto. Alt. 4.4; largh. base 2.7. Impasto tenero con abbondanti vacuoli, frattura irregolare, con frequenti inclusi di piccole e medie dimensioni distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 7.5YR 4/2. Superficie irregolare e abrasa. Realizzato a mano. Lacunoso di parte della base. Tipo Q.20.1. n. 4 (Tav. 97, 5): anello semplice in bronzo. Diam. 2; spessore verga 0.2. Spezzato in un punto. Tipo S.40.A.1. n. 5 (Tav. 97, 4): 5 vaghi in pasta vitrea a occhi (diam. 1; spessore 0.4-0.5). Integri. 1 del Tipo S.60.A.2, varietà b2; 4 del Tipo S.60.A.2, varietà b8. Tomba 260 (Campagna 2008; Tavv. 58, 92). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso sud-ovest/nord-est (lungh. 218; largh. 63; prof. 25), localizzata nella porzione sud-occidentale del saggio di scavo. Si conservano tracce di una cassa lignea. Sul lato lungo settentrionale, in corrispondenza
7
La schedatura e la documentazione grafica delle sepolture rinvenute nel corso del 2008 e dei rispettivi corredi sono frutto del lavoro di tesi di laurea triennale in Archeologia Classica di Francesca delle Grazie presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di ChietiPescara. L’analisi antropologica è a cura di Deneb Cesana. 304
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
n. 4 (Tav. 97, 8): sauroter in ferro. Lungh. 9; diam. 1.7. Superficie ossidata e corrosa. Integro. T.60.1.
dell’angolo nord-orientale, è ricavata una nicchia per l’alloggiamento del ripostiglio (largh. 68; prof. 22). Deposizione dorsale, primaria, in ambiente vuoto; si conservano resti del cranio, probabilmente rivolto a sud. Dati antropologici. Dell’inumato si conservano solo pochi elementi dentari e frammenti di cranio e postcraniali (diafisi di tibie). L’unica osservazione diagnostica riguarda l’usura dentaria che corrisponde ad una età tra 25 e 35 anni. Dati archeologici. Il corredo è composto da una lancia deposta lungo il fianco destro dell’inumato, di cui la punta in ferro (n. 3) si rinviene presso il cranio e il puntale presso i piedi (n. 4); una spada in ferro in frammenti deposta lungo il fianco sinistro (n. 2). Il ripostiglio è composto da un’olla in impasto frammentaria (n. 1). Il sesso archeologico è determinabile come maschile. Inquadramento cronologico. Fine VI-prima metà V secolo a.C.
Tomba 261 (Campagna 2008; Tavv. 58, 92). Sepoltura a inumazione in fossa di forma rettangolare, orientata in senso sud-ovest/nordest (lungh. 220; larg. 100; prof. 90). Risulta profondamente disturbata da radici e, probabilmente, da interventi di spoliazione moderni. Si conservano sporadiche tracce della cassa lignea. Presso l’angolo meridionale si conserva il ripostiglio. Dati antropologici. La sepoltura risulta priva di resti antropologici. Dati archeologici. Si conserva solo l’olla in impasto del ripostiglio (n. 1), contenente un attingitoio in impasto (n. 2). Il sesso archeologico non è determinabile; le dimensioni della fossa ne suggeriscono l’attribuzione a un individuo adulto. Inquadramento cronologico. Fine VI-inizi V secolo a.C.
n. 1 (Tav. 97, 6): olla globulare in impasto grezzo. Diam. orlo 15.5; alt. 25.5. Impasto duro con rari vacuoli, frattura netta, con abbondanti inclusi di piccole dimentioni distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 5YR 5/6. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Mancante di parte del ventre e del labbro. Tipo A.40.B.21.
n. 1 (Tav. 98, 1): olla ovoide in impasto grezzo. Diam. orlo 19; alt. 33. Impasto duro con rari vacuoli, frattura a scaglie, con frequenti inclusi di piccole e medie dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 5YR 4/4. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Ricomposto da più frammenti, mancante di parte del labbro. Tipo A.40.A.5.
n. 2 (Tav. 97, 9): spada in ferro. Lungh. 75; lama: lungh. 60, largh. max. 4, spessore max. 1; elsa: largh. max. 3, spessore placca in ferro 0.5, spessore rivestimento in ferro 0.4. La lama si presenta consumata nel senso della larghezza; dell’elsa si conservano le due guance in ferro che rivestivano l’immanicatura lignea, non conservata, ed il rivestimento del pomo cilindrico. Superficie ossidata e corrosa. Tipo T.20.1, varietà b.
n. 2 (Tav. 98, 2): attingitoio globulare in impasto grezzo. Diam. orlo 7.5; alt. 9.5. Impasto tenero con vacuoli molto rari, con scarsi inclusi di minute dimensioni, distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 5YR 5/6. Superficie liscia; si conservano tracce di steccatura. Realizzato a mano. Integro. Tipo A.160.1. Tomba 262 (Campagna 2008; Tavv. 58, 92). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso sud-ovest/nord-est (lungh. 275, largh. 79; prof. 87), localizzata nella porzione sud-occidentale del saggio di scavo. Sul piano di deposizione si rinvengono tracce della cassa lignea. La deposizione è dorsale, primaria e in ambiente vuoto; il cranio è rivolto verso nord-est; gli arti superiori sono aderenti al
n. 3 (Tav. 97, 7): punta di giavellotto in ferro. Lungh. 19.6; lama: lungh. 12.8, largh. max. 2.6, spessore max. 0.8; cannone: diam. 1.9. Superficie ossidata e corrosa. Integra. Tipo T.50.1.
305
Capestrano, I
torace e le mani sovrapposte sul bacino; gli arti inferiori distesi. Si rileva la presenza di reperti osteologici faunistici, tra cui una mandibola sinistra di suino con tre molari che mostrano esposizione della dentina per usura masticatoria e alcuni denti mascellari della stessa specie. Dati antropologici. I resti umani appartengono ad un individuo adulto maschile di circa 45 anni. Lo stato di conservazione è discreto e tutti i distretti scheletrici sono rappresentati, incluse le estremità degli arti superiori e inferiori. La morfologia del cranio, in particolare la cresta nucale, e della mandibola presentano caratteristiche sessuali secondarie maschili, come confermerebbero anche le caratteristiche metriche del radio (22,74 mm) e del femore destro (50,24 mm), mentre una porzione di temporale conserva un processo mastoideo intermedio. La stima dell’età alla morte è limitata all’osservazione dello stato di avanzato di saldatura delle suture ectocraniche della volta e all’usura dei denti e si può collocare tra 31 e 65 anni (media 45.2 anni). A partire dalla lunghezza massima del femore destro è possibile calcolare la statura in vita che risulta di 169.5 cm. Dati archeologici. Il corredo è composto da una coppa in vernice nera (n. 1), un balsamario in ceramica depurata (n. 5) e un’olletta in ceramica comune (n. 2) deposti tra il cranio e il lato corto occidentale della fossa; un’olletta in ceramica depurata frammentaria a ovest del bacino (n. 3); un’olletta in ceramica comune (n. 4) e frammenti di calzari in ferro (n. 6) ai piedi. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Prima metà/metà II secolo a.C. n. 1 (Tav. 98, 3): coppa a profilo distinto in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 17.5; alt. 8. Impasto duro compatto, frattura regolare, con inclusi molto rari di minute dimensioni, distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 2.5Y 2.5/1. Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.240.C.8. n. 2 (Tav. 98, 4): olletta ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 11.4, alt. 12.5. Impasto duro, compatto, con inclusi molto rari di minute dimensioni, distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 4/3. Superficie 306
polverosa. Presenta due profonde solcature in corrispondenza del ventre. Realizzata al tornio. Integra. Tipo I.50.B.9, varietà a. n. 3 (Tav. 98, 5): olletta ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 9.8; alt. 11.7. Impasto duro, compatto, con inclusi molto rari di minute dimensioni, distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 3/2. Superficie lisciata. Realizzata al tornio. Integra. Tipo I.50.B.9, varietà c. n. 4 (Tav. 98, 6): olletta globulare in ceramica comune. Diam. orlo 10.5; alt. 11.5. Impasto duro, con rari vacuoli, con frequenti inclusi di piccole dimensioni, distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 7/6. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo I.50.B.13. n. 5 (Tav. 98, 7): balsamario ceramico fusiforme. Diam. fondo 3.6; alt. max. cons. 19.5. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni disposti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 6/6. Superficie ruvida. Realizzato al tornio. Mancante del labbro. Tipo N.130.4. n. 6 (Tav. 98, 8): due frammenti di ramponi di calzari in ferro. Lungh. max. cons. 10, 8; spessore 0.9. Superfici corrose e ossidate. Tipo non puntualizzabile. Tomba 263 (Campagna 2008; Tavv. 58, 92). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso nord-est/sud-ovest (lungh. 130; largh. 110; prof. 25), localizzata nella porzione sud-occidentale del saggio di scavo. Taglia la tomba 280 (vedi, 315). Deposizione in decubito laterale destro, in posizione fetale e in uno spazio vuoto. Dati antropologici. L’inumato era un individuo adulto probabilmente maschile di età matura tra 25 e 45 anni. Lo stato di conservazione dei resti umani è frammentario e si può documentare la presenza di alcuni distretti scheletrici principali: cranio, ossa lunghe degli arti superiori, elementi delle mani, coste e vertebre, ossa lunghe degli arti inferiori. Osservando la morfologia della mandibola, del profilo della glabella e del margine sovraorbitario è possibile determinare
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
dimensioni distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 5YR 6/8. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Ricomposto da più frammenti; mancante del labbro e di gran parte della spalla e del ventre. Tipo non puntualizzabile.
la compatibilità con un individuo maschile. L’età è stimata soltanto a partire dalla valutazione dell’usura dentaria che risulta piuttosto avanzata. Dati archeologici. Il corredo è composto da un’olletta in ceramica comune frammentaria a sud del bacino (n. 1). Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. II secolo a.C. (?). n. 1 (Tav. 98, 9): olletta ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 12; alt. 13. Impasto duro, con rari vacuoli, frattura irregolare, con scarsi inclusi di piccole dimensioni, distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 5YR 5/6. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Ricomposta da vari frammenti; mancante di parte del labbro. Tipo I.50.B.9, varietà e. La tomba 264 (Tav. 58, manca la planimetria di dettaglio), a fossa di forma rettangolare, localizzata nella porzione sud-occidentale dell’area di scavo e disturbata pesantemente dall’impianto della tomba 266 (vedi, 307-308), si conservava per una lungh. max. di 78 e una largh. max. di 52. Al suo interno non si conservavano resti del corredo, ma si raccolgono soltanto pochi frammenti osteologici e quattro denti molari appartenenti ad un individuo adulto. Tomba 265 (Campagna 2008; Tav. 58, manca la planimetria di dettaglio). Sepoltura a inumazione, in fossa rettangolare, orientata in senso est-ovest (lungh. max. cons. 75 largh. 75; prof. 48 localizzata nella porzione sud-occidentale del saggio di scavo. La fossa è tagliata dall’impianto della tomba 280 (vedi, 315). Dati antropologici. La sepoltura risulta priva di resti antropologici. Dati archeologici. Del corredo si recuperano frammenti di un’olla in impasto (n. 1). Il sesso archeologico non è determinabile; sulla base delle dimensioni della fossa, se ne suggerisce l’attribuzione a un individuo sub-adulto. Inquadramento cronologico. Età arcaica.
Tomba 266 (Campagna 2008; Tavv. 58, 93). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso sud-est/nord-ovest (lungh. 239; largh. 90; prof. 25), localizzata nella porzione sud-occidentale del saggio di scavo. La fossa è tagliata dalla tomba 280 (vedi, 315) e taglia le tombe 264 e 274 (vedi, 304, 312). Dati antropologici. I resti dell’individuo della tomba in esame non risultano presenti in deposito quindi non disponibili all’analisi. Dati archeologici. Il corredo è composto da una lancia, di cui si conserva la punta in ferro nella posizione originariamente a nord-est del cranio (n. 4); una spada in ferro in frammenti deposta lungo il fianco sinistro (n. 3); una scodella in impasto buccheroide deposta in corrispondenza dei piedi (n. 1), contenente un rasoio in ferro (n. 5) e uno spiedo in ferro (n. 2) presso l’angolo orientale della fossa; nel riempimento della fossa si rinvengono numerosi piccoli frammenti di fibule e spiedi in ferro Il sesso archeologico è determinabile come maschile; i caratteri del corredo e le dimensioni della fossa ne suggeriscono l’attribuzione a un individuo adulto. Inquadramento cronologico. Seconda metà VI secolo a.C. n. 1 (Tav. 99, 1): scodella biansata in impasto buccheroide. Diam. orlo 15; alt. 8. Argilla compatta, con rari inclusi di medie e piccole dimensioni; colore: Munsell 2.5YR 2.5/1. Superficie steccata e lucidata. Realizzata al tornio. Mancante di parte del labbro. Tipo B.230.C.3. n. 2 (Tav. 99, 5): spiedo in ferro con testa a ricciolo. Lungh. 53.5; spessore stelo 1. Superficie corrosa e ossidata. Ricomposto da più frammenti. Tipo Q.60.1.
n. 1 (Tav. 98, 10): olla globulare con fondo piano in impasto. Diam. fondo 10; alt. max. cons. 20. Impasto duro con rari vacuoli, frattura irregolare, con rari inclusi di piccole e medie
n. 3 (Tav. 99, 4): spada in ferro. Lungh. max. cons. 80; lama: lungh. max. cons. 68.5, largh. max. 4.7, spessore max. 1.2; elsa: largh. max. 4; 307
Capestrano, I
2.3. Mancante di parte dell’ago e della staffa. Tipo S.20.A.2.
spessore placca in ferro 0.4, spessore rivestimento in ferro 0.3. Superficie corrosa e ossidata. Manca di parte dell’elsa. Tipo T.20.1.
Tomba 268 (Campagna 2008; Tavv. 58, 93). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso sud-ovest/nord-est (lungh. 227; largh. 180; prof. 32 localizzata nella porzione centrale dell’area di scavo. La fossa è tagliata dalla tomba 218 (vedi, 283). Deposizione dorsale, primaria, in ambiente vuoto; il cranio è in posizione frontale; parte degli arti superiori aderenti al torace, con le mani giunte sul bacino; gli arti inferiori, conservati parzialmente, sono distesi e allineati. Dati antropologici. I resti umani appartengono ad un individuo adulto femminile di età matura. Lo stato di conservazione è pessimo e si può documentare la presenza del cranio, coste e vertebre, ossa lunghe degli arti superiori e inferiori, elementi dei piedi. L’aspetto e la morfologia della mandibola e della porzione di cranio con processo mastoideo presentano caratteristiche femminili, così come l’ampia incisura ischiatica nel bacino. Questa determinazione del sesso è compatibile inoltre con le caratteristiche metriche rilevate al caput femorale (41 mm). La stima dell’età alla morte non è possibile a causa dell’assenza di elementi diagnostici. Si rileva la diffusa presenza di carie sui pochi elementi dentari conservati. Dati archeologici. Il corredo si compone di due fibule in ferro, rinvenute una sotto il collo e una sul torace (nn. 4-5); un anello in argento infilato a un dito della mano destra (n. 6); frammenti di un alare rinvenuti a nord-est degli arti inferiori dell’inumato (n. 3); frammenti di un’olla che probabilmente faceva parte del ripostiglio (n. 1) e una fuseruola in impasto (n. 2) erano sparsi nel riempimento della fossa. Sulla base della mancanza delle armi, il sesso archeologico sembra determinabile come femminile. Inquadramento cronologico. VI secolo a.C.
n. 4 (Tav. 99, 2): punta di giavellotto in ferro. Lungh. 19; lama: lungh. 11, largh. max. 3.6, spessore max. 0.8; cannone: diam. 2.1. Superficie corrosa e ossidata. Ricomposta da due frammenti. Tipo T.50.1. n. 5 (Tav. 99, 3): frammento di lama in ferro di forma triangolare, pertinente a un rasoio o a un coltello. Lungh. max. cons. 4.5; largh. max. cons. 2.6, spessore 0.05. Superficie corrosa e ossidata. Si conserva solo parte della lama con foro passante, forse per il fissaggio del manico in materiale deperibile. Tipo non puntualizzabile. Tomba 267 (Campagna 2008; Tavv. 58, 93). Sepoltura a inumazione in fossa quadrangolare (lungh. 132; largh. 29; prof. 46), orientata in senso sud-est/nord-ovest localizzata nella porzione settentrionale del saggio di scavo, al limite con l’ampliamento del 2009. La fossa risulta sconvolta da interventi postdeposizionali di spoliazione e dall’impianto di un albero. I resti antropologici si presentano frammentari e non in posizione originaria. Dati antropologici. I resti scheletrici sono incompleti e in pessimo stato di conservazione. Analizzando gli elementi dentari, si può ipotizzare che si trattasse di un giovane individuo. Dati archeologici. Del corredo si conservano una fibula ad arco semplice in ferro (n. 1) ed una fibula ad arco semplice in bronzo (n. 2) rinvenute nella porzione centrale della fossa. Il sesso archeologico non è determinabile; le dimensioni della fossa ne suggeriscono l’attribuzione a un individuo sub-adulto. Inquadramento cronologico. VI secolo a.C.
n. 1 (Tav. 99, 13): olla globulare in impasto grezzo. Diam. orlo 21.8; alt. max. cons. 28.5. Impasto duro con frequenti vacuoli, frattura irregolare, con frequenti inclusi di piccole e medie dimensioni, distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 5YR 5/8. Superficie lisciata. Realizzata al tornio. Parzialmente ricomposta da più frammenti;
n. 1 (Tav. 99, 6): fibula in ferro ad arco semplice ribassato. Lungh. max. cons. 4; alt. 3. Superficie corrosa e ossidata. Mancante di parte dell’ago e della staffa. Tipo S.20.A.5. n. 2 (Tav. 99, 7): fibula in bronzo ad arco semplice a tutto sesto. Lungh. max. cons. 4; alt.
308
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
mancante del fondo e di parte del ventre. Tipo A.40.B.22. n. 2 (Tav. 99, 10): fuseruola troncoconica a profilo carenato in impasto. Diam. max. 3; alt. 3. Impasto tenero; colore: Munsell 7.5YR 3/1. Superficie liscia e lucidata. Realizzata a mano. Integra. Tipo Q.10.3.
n. 2 (Tav. 100, 4): spiedo in ferro con testa a ricciolo. Lungh. max. cons. 67; diam. testa 2; spessore stelo 1. Superficie ossidata e corrosa. Ricomposto da due frammenti Tipo Q.60.1. n. 3 (Tav. 100, 2): fibula in bronzo ad arco semplice a tutto sesto. Lungh. 8.5; alt. 4.2. Integra. Tipo S.20.A.2. n. 4 (Tav. 100, 3): lamina in bronzo ricomposta da vari frammenti. Lungh. frammento maggiore 7.4; spessore 0.05. Senza tipo di riferimento.
n. 3 (Tav. 99, 12): frammenti di alare in ferro. Lungh. 25.4, 7.4, 15.8, 7.3; diam. testa 1.2; spessore stelo 0.5-0.7. Superficie corrosa e ossidata. Si conservano parti delle staffe e un frammento di piede. Tipo non puntualizzabile.
Tomba 270 (Campagna 2008; Tavv. 58, 94). Sepoltura a inumazione in fossa, i cui limiti si definiscono con difficoltà, orientata in senso sud-ovest/nord-est (lungh. 233; largh. 70; prof. 52), localizzata nella porzione centrale del saggio di scavo. Risulta pesantemente manomessa da interventi post-deposizionali antropici e naturali (radici). Presso l’angolo settentrionale, si rinviene il ripostiglio litico, probabilmente alloggiato in origine in una nicchia. Sepoltura dorsale, primaria, in ambiente vuoto, con gli arti superiori e inferiori, distesi. Dati antropologici. Si conservano 19 elementi dentari, le diafisi del femore destro e sinistro e alcune ossa dei piedi. Lo stato di conservazione è pessimo e da due soli indicatori (morfologia del processo mastoideo e usura dei denti) è possibile ipotizzare che i resti umani appartengano a un individuo femminile di età compresa tra 35 e 45 anni. Dati archeologici. Del corredo si conserva una fibula in ferro, originariamente deposta sul torace (n. 3). Il ripostiglio è composto da un’olla in impasto (n. 1) e una brocchetta deposta al suo esterno (n. 2). Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. VI secolo a.C.
n. 4 (Tav. 99, 8): fibula in ferro ad arco semplice rialzato. Lungh. max. cons. 5; alt. 4. Superficie corrosa e ossidata. Mancante dell’ago e di parte della staffa. Tipo S.20.A.1, varietà a. n. 5 (Tav. 99, 9): fibula in ferro ad arco semplice ribassato. Lungh. max. cons. 5; alt. 4. Superficie corrosa e ossidata. Mancante dell’ago e di parte della staffa. Tipo S.20.A.5. n. 6 (Tav. 99, 11): anello in argento con verga sottile. Diam. 2; spessore verga 0.1. Tipo S.40.A.1. Tomba 269 (Campagna 2008; Tavv. 58, 93). Sepoltura a inumazione in fossa orientata in senso sud-ovest/nord-est (lungh. 207; largh. 70; prof. 23) localizzata a ridosso del margine occidentale del saggio di scavo. Dati antropologici. La sepoltura risulta priva di resti antropologici. Dati archeologici. Del corredo si conservano una fibula in bronzo presso il lato meridionale della fossa (n. 3); uno spiedo in ferro e una fuseruola in impasto deposti lungo il lato lungo settentrionale (nn. 1-2); nel riempimento si rinvengono frammenti di una lamina in bronzo (n. 4) e di impasto. Il sesso archeologico è determinabile come femminile. Inquadramento cronologico. Fine VI secolo a.C. n. 1 (Tav. 100, 1): fuseruola biconica in impasto. Diam. max. 3; alt. 3. Impasto duro; colore: Munsell 10YR 3/2. Superficie liscia e lucidata. Realizzata a mano. Integra. Tipo Q.10.1. 309
n. 1 (Tav. 100, 5): olla globulare in impasto grezzo. Diam. orlo 17.5; alt. 29.5. Impasto duro con rari vacuoli, frattura a scaglie, con frequenti inclusi di piccole e medie dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10YR 2/1. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo A.40.B.14.
Capestrano, I
rari vacuoli, frattura a scaglie, con frequenti inclusi di piccole e medie dimensioni distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 7.5YR 4/3. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Ricomposta da vari frammenti. Tipo A.40.B.1.
n. 2 (Tav. 100, 6): brocchetta globulare in impasto buccheroide. Diam. orlo 6.4; alt. 11. Impasto duro con vacuoli molto rari, frattura regolare, con inclusi molto rari di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 5Y 2.5/1. Superficie lisciata e lucidata. Realizzata al tornio. Ricomposta da vari frammenti; mancante di parte del ventre e del piede. Probabilmente Tipo B.110.4.
n. 2 (Tav. 100, 10): bacile a orlo perlinato con vasca a profilo svasato in lamina di bronzo. Diam. orlo 21.5; alt. 3.5. Integro. Tipo O.330.A.6.
n. 3 (Tav. 100, 7): frammenti di fibula in ferro, probabilmente ad arco semplice. Lungh. frammento max. cons. 3. Superficie corrosa e ossidata. Senza tipo di riferimento.
n. 3 (Tav. 100, 8): spiedo in ferro con testa a ricciolo e anellino innestato. Lungh. 72; diam. testa 3.2; spessore stelo 1. Superficie corrosa e ossidata. Ricomposto da più frammenti. Tipo Q.60.1.
Tomba 271 (Campagna 2008; Tavv. 58, 94). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare orientata in senso sud-ovest/nord-est (lungh. 290; largh. 100; prof. 42), localizzata nella porzione centrale del saggio di scavo. Lungo il lato settentrionale si rinviene un accumulo di spezzoni litici, probabilmente funzionale a contenere la deposizione, probabilmente originariamente deposta all’interno di un contenitore ligneo; nell’angolo settentrionale di fondo, un accumulo degli stessi spezzoni protegge il ripostiglio. Deposizione dorsale, supina e in ambiente vuoto; al momento dello scavo si segnala il rinvenimento di parte dei femori, in pessimo stato di conservazione. Dati antropologici. Si conservano solo pochi frammenti di piccole dimensioni non determinabili. Dati archeologici. Il corredo è composto quattro fibule in ferro integre e frammenti deposte sul torace (nn. 4-7), cui si aggiungono numerosi frammenti di altri esemplari rinvenuti nel riempimento; un bacile di bronzo ai piedi del defunto (n. 2); uno spiedo in ferro (n. 3). Il ripostiglio è composto da un’olla in impasto (n. 1). Sulla base della mancanza delle armi e dell’inquadramento cronologico proposto, il sesso archeologico sembra determinabile come femminile; le dimensioni della fossa ne suggeriscono l’attribuzione a un individuo adulto. Inquadramento cronologico. Ultimo quarto-fine del VI secolo a.C.
n. 4 (Tav. 100, 11): fibula in ferro, con arco semplice, probabilmente ribassato. Lungh. max. cons. 9.7; alt. max. ric. 5.3. Superficie corrosa e ossidata. Probabilmente ascrivibile al Tipo S.20.A.5. n. 5 (Tav. 100, 12): fibula in ferro con arco a tripla ondulazione. Lungh. max. cons. 5.7; alt. 3.3. Superficie corrosa e ossidata. Ricomposta da vari frammenti; mancante di parte della staffa e dell’ago. Tipo S.20.B.4. n. 6 (Tav. 100, 13): fibula in ferro con arco a tripla ondulazione. Lungh. 7.8; alt. 3.3. Superficie corrosa e ossidata. Integra. Tipo S.20.B.4. n. 7 (Tav. 100, 14): fibula in ferro con arco a tripla ondulazione. Lungh. 6.8; alt. 3.4. Superficie corrosa e ossidata. Ricomposta da due frammenti. Tipo S.20.B.4. Tomba 272 (Campagna 2008; Tavv. 58, 94). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso sud-ovest/nord-est (lungh. 190; largh. 70; prof. 36), localizzata nella porzione sud-occidentale del saggio di scavo. Risulta tagliata dalla tomba 229 (vedi, 289) Deposizione dorsale, primaria e in ambiente vuoto; gli arti superiori, aderenti al torace, sono flessi con le mani sul bacino; gli arti inferiori sono distesi.
n. 1 (Tav. 100, 9): olla globulare in impasto grezzo. Diam. orlo 25; alt. 39. Impasto duro con 310
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
n. 6 (Tav. 101, 6): fibula in ferro con arco a doppia ondulazione. Lungh. max. ric. 5.8; alt. max. ric. 3.4. Superficie corrosa e ossidata. Ricomposta da più frammenti e parzialmente ricostruibile. Si conserva una catenella in ferro infilata nell’ago; lungh. max. ric. catenella 2.3. Tipo S.20.B.2.
Dati antropologici. Si conservano pochi elementi scheletrici, appartenenti ad almeno tre individui. Lo stato di conservazione è pessimo e molto lacunoso. Si tratta di una mandibola, elementi vertebrali, frammenti di bacino, porzioni di femori e tibie. In particolare, elaborando i dati del calcolo del numero minimo di individui, è possibile ipotizzare che la mandibola sia pertinente l’individuo della tomba 229, mentre i resti postcraniali siano pertinenti un individuo adulto maschile e un altro individuo adulto della tomba 272. Dati archeologici. Il corredo è composto da sei fibule in ferro rinvenute sul torace (nn. 1-6) e due placchette di bronzo rinvenute ai piedi dell’inumato (nn. 7-8). Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. VI sec. a.C.
nn. 7-8 (Tav. 101, 7): due placchette rettangolari in bronzo, con fori passanti alle estremità. Lungh. 3 cm; alt. 0.9, 0.7. Integri. Tomba 273 (Campagna 2008; Tavv. 58, 94). Sepoltura molto probabilmente a fossa terragna dalla quale si recupera solo il ripostiglio, superficiale. Dati antropologici. La sepoltura risulta priva di resti antropologici. Dati archeologici. Si rinvengono un’olla in impasto frammentaria (n. 1), contenente una tazza in impasto buccheroide (n. 2). Inquadramento cronologico. Inizi III secolo a.C.
n. 1 (Tav. 101, 1): fibula in ferro con arco a doppia ondulazione. Lungh. max. cons. 5.8; alt. 2.9. Superficie corrosa e ossidata. Ricomposta da più frammenti e parzialmente ricostruibile. Tipo S.20.B.2.
n. 1 (Tav. 101, 8): olla in impasto. Diam. fondo 8.1; alt. max. cons. 8.3. Impasto tenero con vacuoli molto rari, frattura irregolare, con scarsi inclusi di piccole e medie dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 5/4. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Si conservano il fondo e parte del ventre. Tipo non puntualizzabile.
n. 2 (Tav. 101, 2): fibula in ferro con arco a doppia ondulazione. Lungh. max. ric. 7.5; alt. max. ric. 3.6. Superficie corrosa e ossidata. Ricomposta da più frammenti e parzialmente ricostruibile. Si conserva una catenella in ferro infilata nell’ago; lungh. max. catenella 4. Ricomposta da più frammenti. Tipo S.20.B.2.
n. 2 (Tav. 101, 9): tazza carenata miniaturistica in impasto buccheroide. Diam. orlo 6.2; alt. 4.8. Impasto duro compatto, frattura regolare, con inclusi molto rari di minute dimensioni, distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 2.5Y 2.5/1. Superficie liscia; lucidata. Presenta una decorazione a tre cerchielli impressi in corrispondenza della sulla carena e alla base dell’ansa. Realizzata al tornio. Ricomposta da vari frammenti. Tipo B.220.2.
n. 3 (Tav. 101, 3): fibula in ferro con arco a doppia ondulazione. Lungh. 8.5; alt. max. ric. 4.1. Superficie corrosa e ossidata. Ricomposta da più frammenti e parzialmente ricostruibile. Tipo S.20.B.2. n. 4 (Tav. 101, 4): fibula in ferro con arco a doppia ondulazione. Lungh. 7; alt. 3.5. Superficie corrosa e ossidata. Ricomposta da più frammenti e parzialmente ricostruibile. Tipo S.20.B.2.
Tomba 274 (Campagna 2008; Tavv. 58, 94). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare con orientamento sud-ovest/nord-est (lungh. 160; largh. 40; prof. 45), localizzata nella porzione sud-occidentale dell’area di scavo. La fossa è profondamente disturbata dall’impianto delle più recenti tombe 259 e 266 (vedi, 304-
n. 5 (Tav. 101, 5): fibula in ferro con arco a doppia ondulazione. Lungh. 7; alt. 3.1. Superficie corrosa e ossidata. Ricomposta da più frammenti e parzialmente ricostruibile. Si conserva una catenella in ferro infilata nell’ago; lungh. catenella 1.4. Tipo S.20.B.2. 311
Capestrano, I
in impasto (n. 1). Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. VI secolo a.C.
305, 307-308). Deposizione dorsale, primaria e in ambiente vuoto, con gli arti inferiori distesi. Dati antropologici. Lo stato di conservazione dei resti scheletrici è estremamente frammentario e lacunoso, infatti tra i materiali antropologici determinabili sono presenti porzioni di cranio, elementi dentari, diafisi di omeri, femori e tibia. Si tratta certamente di un individuo adulto, forse di sesso femminile e di età matura di oltre 35 anni. Dati archeologici. Il corredo è composto da due fibule in ferro deposte in corrispondenza del collo, di cui solo una integra (n. 1) e un’altra rinvenuta nella terra di riempimento (n. 2); un cinturone in materiale deperibile con placche in bronzo rinvenuto in pessimo stato di conservazione (non documentabile). Il sesso archeologico è determinabile come femminile. Inquadramento cronologico. VI secolo a.C.
n. 1 (Tav. 101, 12): olla in impasto. Diam. fondo 15; alt. max. ric. 7.3. Impasto tenero con vacuoli molto rari, frattura frastagliata, con abbondanti inclusi di piccole e medie dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 5/4. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Si conserva il fondo piano e indistinto. Tipo non puntualizzabile.
n. 1 (Tav. 101, 10): fibula in ferro con arco a doppia ondulazione. Lungh. max. cons. 5; alt. max. cons. 2.7. Superficie corrosa e ossidata. Ricomposta da più frammenti; mancante di parte della staffa e dell’ago. Tipo S.20.B.2. n. 2 (Tav. 101, 11): fibula in ferro con arco a doppia ondulazione. Lungh. max. ric. 5.5; alt. max. ric. 3.1. Superficie corrosa e ossidata. Ricomposta da più frammenti; mancante di parte della staffa e dell’ago. Tipo S.20.B.2. Tomba 275 (Campagna 2008; Tavv. 58, 95). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso sud-ovest/nord-est (lungh. 200; largh. 50; prof. 44), localizzata nella porzione sud-occidentale del saggio di scavo. Si conservano tracce di una cassa lignea. Nel lato corto di fondo della fossa è ricavata una piccola nicchia (largh. 41; prof. 32), all’interno della quale è alloggiato il ripostiglio. Deposizione dorsale, primaria e in ambiente vuoto; il cranio è volto a sud-ovest e gli arti superiori e inferiori sono distesi. Dati antropologici. I resti antropologici sono in stato di conservazione pessimo. Di questo individuo, un adulto forse di sesso femminile, sono stati rinvenuti soltanto frammenti di cranio, della mandibola e del bacino. Dati archeologici. Non si conservano elementi di corredo. Il ripostiglio è composto da un’olla 312
Tomba 276 (Campagna 2008; Tavv. 58, 95). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso sud-ovest/nord-est (lungh. 215; largh. 112; prof. 72), localizzata nella porzione meridionale del saggio di scavo. Il riempimento della fossa è caratterizzato dalla presenza di spezzoni litici di grandi dimensioni. Presso l’angolo settentrionale della fossa è alloggiato il ripostiglio protetto da spezzoni litici. Deposizione dorsale, primaria e in ambiente vuoto; si conserva in buono stato, con il cranio leggermente piegato a nord; gli arti superiori sono distesi lungo il torace; gli arti inferiori distesi. Dati antropologici. I resti umani appartengono ad un individuo adulto di sesso femminile e di età alla morte tra 25 e 35 anni. Lo stato di conservazione è discreto, ma non tutti i distretti scheletrici sono rappresentati. La morfologia del cranio nella porzione frontale e temporale e della mandibola è compatibile con le caratteristiche sessuali secondarie femminili, così come l’ampia incisura ischiatica osservabile in una porzione di bacino e il diametro del caput femorale (38 mm). La stima dell’età alla morte, a causa dell’assenza di ulteriori elementi diagnostici, è limitata alla osservazione dell’usura dentaria corrispondente a un range tra 25 e 35 anni. Dati archeologici. Il corredo si compone di quattro fibule in bronzo deposte a coppie sull’emitorace destro e sinistro (nn. 4-7); uno spiedo in ferro deposto dal torace alla zona pelvica (n. 2) e uno a ovest del cranio (n. 3). Il ripostiglio è composta da un’olla in impasto (n. 1). Sulla base della mancanza delle armi e dell’inquadramento cronologico, il sesso archeologico è determinabile come femminile.
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
sud-ovest/nord-est (lungh. 215; largh. 80; prof. 34). Sul piano di deposizione si conservano resti di una cassa lignea, posizionata nella porzione settentrionale della fossa e delimitata a sud da alcuni blocchi di medie dimensioni. In corrispondenza dell’angolo occidentale della fossa, è ricavata una piccola nicchia contenente il ripostiglio, protetto da spezzoni litici. Deposizione dorsale, primaria e in ambiente vuoto; gli arti superiori e inferiori sono distesi. Dati antropologici. I resti dell’individuo della tomba in esame non risultano presenti in deposito quindi non disponibili all’analisi. Dati archeologici. Il corredo è composto da un lungo spiedo in ferro in frammenti deposto tra gli arti inferiori (n. 4); una fibula in ferro deposta a nord dei piedi dell’inumato (n. 5); una scodella in impasto buccheroide ai piedi, contenente una tazza in impasto buccheroide (nn. 2-3). Il ripostiglio è composto da un’olla in impasto (n. 1). Sulla base della mancanza delle armi e dell’inquadramento cronologico proposto, il sesso archeologico è determinabile come femminile. Inquadramento cronologico. Fine VI-prima metà V secolo a.C.
Inquadramento cronologico. Fine VI-prima metà V secolo a.C. n. 1 (Tav. 101, 13): olla globulare in impasto grezzo. Diam. orlo 22, alt. 35. Impasto duro con rari vacuoli, frattura netta, con abbondanti inclusi di piccole e medie dimensioni, distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 7.5YR 5/4. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Ricomposta da vari frammenti. Tipo A.40.B.22. n. 2 (Tav. 101, 14): spiedo in ferro con testa a ricciolo. Lungh. max. cons. 36.2; spessore max. stelo 2. Superficie corrosa e ossidata. Ricomponibile da due frammenti; lacunoso della porzione inferiore. Tipo Q.60.1. n. 3 (Tav. 101, 15): spiedo in ferro con testa a ricciolo. Lungh. max. cons. 49.5; spessore max. stelo 2. Superficie corrosa e ossidata. Ricomponibile da tre frammenti. Tipo Q.60.1. n. 4 (Tav. 101, 16): fibula in bronzo con arco semplice a tutto sesto, con catenella in maglie di bronzo infilata sull’ago. Lungh. 6.1; alt. 2.9; lungh. max. ric. catenella 3. Presenta una decorazione a denti di lupo incisi sulla staffa. Integra. Tipo S.20.A.2. n. 5 (Tav. 101, 17): fibula in bronzo con arco semplice a tutto sesto, con catenella in maglie di bronzo infilata sull’ago. Lungh. 6; alt. 2.9; lungh. max. ric. catenella 8. Presenta una decorazione a denti di lupo incisi sulla staffa. Integra. Tipo S.20.A.2.
n. 1 (Tav. 102, 1): vaso a collo in impasto grezzo. Diam. orlo 20.7, alt. 40.3. Impasto duro con rari vacuoli, con rari inclusi di piccole e medie dimensioni, distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 5/4. Superficie liscia e lucidata. Presenta una decorazione a cordone ondulato applicato alla base del collo. Realizzato al tornio, con spalla asimmetrica. Integro. Tipo A.30.1.
n. 6 (Tav. 101, 18): fibula in bronzo con arco semplice a tutto sesto, con resti di catenella in maglie di bronzo infilata sull’ago. Lungh. 5.2; alt. 2.8; lungh. frammento catenella 1. Integra. Tipo S.20.A.2.. n. 7 (Tav. 101, 19): fibula in bronzo con arco semplice a tutto sesto, con catenella in maglie di bronzo infilata sull’ago. Lungh. 5.5; alt. 3; lungh. max. catenelle 2.5 e 3.3. Integra. Tipo S.20.A.2.
n. 2 (Tav. 102, 2): tazza in impasto buccheroide. Diam. orlo 10.8; alt. max. cons. 10. Impasto duro compatto, frattura regolare, con inclusi molto rari di minute dimensioni distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 2.5Y 2.5/. Superficie lisciata e lucidata. Realizzata al tornio. Ricomposta da vari frammenti; mancante di parte dell’ansa e del piede. Tipo B.220.1.
Tomba 277 (Campagna 2008; Tavv. 58, 95). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso est-ovest con orientamento
n. 3 (Tav. 102, 3): scodella carenata in impasto buccheroide. Diam. orlo 15.2, alt. 9. Argilla dura, con rari inclusi di minute dimensioni; 313
Capestrano, I
vacuoli, frattura regolare, con scarsi inclusi di piccole dimensioni, distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10YR 8/3. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Ricomposta da vari frammenti; lacunosa in corrispondenza del labbro e del ventre. Tipo I.50.A.3.
colore: Munsell 2.5Y 2.5/1. Superficie lisciata e lucidata. Realizzata al tornio. Ricomposta da vari frammenti; lacunosa in corrispondenza della carena. Tipo B.230.A.3. n. 4 (Tav. 102, 4): spiedo in ferro con testa a ricciolo. Lungh. 77; diam. testa 2.4, spessore stelo 1. Superficie corrosa e ossidata. Ricomposto da più frammenti. Tipo Q.60.1.
Tomba 279 (Campagna 2008; Tavv. 58, 95). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso sud-nord (lungh. 140; largh. 40; prof. 52), localizzata nella porzione settentrionale del saggio di scavo. La fossa è tagliata dalla tomba 217 (vedi, 282-283). Deposizione dorsale, primaria e in ambiente vuoto; gli arti superiori e inferiori sono distesi; i piedi sono sovrapposti. Dati antropologici. I resti umani appartengono a un individuo subadulto di circa 8-9 anni. Anche in questo caso lo stato di conservazione è pessimo e frammentario, infatti sono presenti solo alcuni elementi dentari, frammenti di coste, bacino e arti inferiori. La stima dell’età alla morte si basa esclusivamente sul grado di sviluppo dentario che risulta sicuramente maggiore di 6 anni e probabilmente inquadrabile tra 8 e 9 anni. Dati archeologici. Il corredo è composto da una coppetta in ceramica a vernice nera e un’olletta in ceramica comune (nn. 1-2), ai piedi dell’inumato. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Seconda metà IIIinizi II secolo a.C.
n. 5 (Tav. 102, 5): fibula in ferro con arco semplice a tutto sesto. Lungh. 6.2, alt. 3.2. Superficie corrosa e ossidata. Integra. Tipo S.20.A.3. Tipo S.20.A.3 Tomba 278 (Campagna 2008; Tav. 58, manca la planimetria di dettaglio). Si tratta del recupero di parte della deposizione e di un corredo pesantemente disturbato da lavori agricoli Dati antropologici. I resti umani appartengono probabilmente a un adolescente o giovane adulto, forse di sesso femminile, di 15 anni ± 30 mesi. Tale risultato si basa su pochi elementi a causa dell’alto grado di frammentazione e dell’incompleta conservazione dello scheletro. Tuttavia è evidente che nella mandibola lo stadio di sviluppo del terzo molare, poco sotto la linea di eruzione alveolare, corrisponde a una età di 15 anni ± 30 mesi. Tra le ossa lunghe conservate, le estremità metafisarie sia dell’osso femorale che tibiale sembrano avere un aspetto immaturo, ma a causa del degrado postdeposizionale non è possibile con attendibilità valutare questo dato. Dati archeologici. Si recuperano un kantharos in ceramica a vernice nera (n. 1) e un’olletta in impasto (n. 2). Inquadramento cronologico. II secolo a.C.
n. 1 (Tav. 103, 1): coppetta a profilo globulare in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 7; alt. 4.5. Impasto molto duro, compatto, frattura netta, privo di inclusi; colore: Munsell l0YR 7/4; vernice opaca coprente; colore: Munsell 5Y 2.5/1. Realizzata a tornio. Integra. Tipo H.260.A.16.
n. 1 (Tav. 102, 7): kantharos a profilo troncoconico in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 8.5; alt. 9. Impasto duro compatto, frattura regolare, con inclusi molto rari di minute dimensioni, distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10YR 7/4. Vernice opaca coprente; colore: Munsell 7.5YR 2/0. Realizzata al tornio. Mancante delle anse. Tipo H.210.2.
n. 2 (Tav. 103, 2): olletta ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 8.5; alt. 8.7. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di piccole dimensioni; colore: Munsell 7.5YR 4/3. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo I.50.B.9, varietà a.
n. 2 (Tav. 102, 6): olletta in ceramica comune. Diam. orlo 12.2; alt. 20. Impasto duro, con rari 314
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare orientata in senso sud-ovest/nord-est (lungh. 230; largh. 80; prof. 110), localizzata nell’angolo settentrionale del saggio di scavo. Sul piano di deposizione, si conserva la cassa lignea. A metà del lato lungo occidentale, a una quota superiore dal piano di deposizione, è scavata una nicchia (lungh. 57; prof. 30; alt. 67) all’interno della quale è alloggiato il ripostiglio. Deposizione dorsale, primaria e in ambiente vuoto; gli arti superiori sono piegati sul torace e sul bacino, gli arti inferiori allineati e distesi. Dati antropologici. Si conserva solo un frammento di cranio, in particolare la porzione occipitale in cui si osserva una cresta nucale pronunciata. Di conseguenza si può con cautela ipotizzare che questo reperto antropologico appartenesse a un individuo adulto forse maschile. Dati archeologici. Il corredo, contenuto all’interno della cassa, è composto da balsamario in ceramica (n. 7) deposto in corrispondenza del collo del defunto; una fibula ad arco semplice in ferro (n. 8) sul torace; un anello d’argento infilato a un dito della mano sinistra (n. 9); un’olletta in ceramica comune (n. 6), due coppe, uno skyphos e un piatto in ceramica a vernice nera (nn. 1-2, 4) deposti in corrispondenza dei piedi del defunto. Il ripostiglio è composto da un’olla in ceramica comune (n. 5), all’interno della quale è inserito uno skyphos a vernice nera, sporgente dall’orlo dell’olla stessa (n. 3). Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Metà/seconda metà III secolo a.C.
Tomba 280 (Campagna 2008; Tavv. 58, 96). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso sud-ovest/nord-est (lungh. 200; largh. 75; prof. 32), localizzata nella porzione sud-occidentale dell’area di scavo. La fossa risulta tagliata dalla più recente tomba 263 e taglia a sua volta le tombe 265 e 266 (vedi, 307-308). Sul piano di deposizione si conservano tracce di una cassa lignea. Deposizione dorsale, primaria e in ambiente vuoto; gli arti superiori e inferiori sono distesi. Dati antropologici. I resti umani appartengono ad un individuo adulto femminile di età avanzata, oltre 45 anni. I principali distretti scheletrici presenti sono cranio, arti superiori e inferiori, colonna vertebrale, bacino, piedi. Le caratteristiche sessuali secondarie sono femminili, in particolare nel profilo frontale e nella morfologia del processo mastoideo osservabili nel cranio, ma anche nell’incisura ischiatica del bacino e nel diametro del caput femorale (40 mm). Nella mandibola si rileva la caduta antemortem dei denti molari M1 e M3 a destra e M1, M2, M3 a sinistra con conseguente riassorbimento osseo e chiusura completa degli alveoli corrispondenti. Questo dato è indicativo di una età avanzata, genericamente stimabile di oltre 45 anni, tuttavia si deve sottolineare che non vi sono altre anomalie scheletriche indicative di degenerazione scheletrica dovute all’avanzare dell’età. Tra i resti umani attribuiti a questo contesto tombale è presente una porzione di bacino con incisura ischiatica maschile, forse da attribuire all’individuo della tomba 263. Dati archeologici. Il corredo è composto da una coppa in ceramica a vernice nera (n. 1), deposta presso l’angolo occidentale della fossa. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Fine IV-prima metà III secolo a.C.
n. 1 (Tav. 103, 4): coppa a profilo distinto in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 17.3; alt. 8. Impasto duro compatto, frattura regolare, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 8/; vernice evanide, opaca; colore: Munsell 2.5Y 2.5/1. Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.240.C.6.
n. 1 (Tav. 103, 3): coppetta a profilo globulare in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 13.7; alt. 5.3. Impasto molto duro, compatto, frattura netta, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 8/4; vernice opaca, coprente; colore: Munsell l0YR 2/1. Realizzata al tornio. Ricomposta da vari frammenti.Tipo H.260.A.2.
n. 2 (Tav. 103, 5): coppetta a profilo globulare in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 11.5; alt. 5.2. Impasto duro compatto, frattura regolare, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 8/3; vernice evanide, opaca; colore: Munsell 10YR 2/1. Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.260.A.7.
Tomba 281 (Campagna 2008; Tavv. 58, 96). 315
Capestrano, I
n. 3 (Tav. 103, 6): skyphos a profilo troncoconico in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 12; alt. 13.4. Impasto duro, con rari vacuoli distribuiti in maniera disomogenea, frattura irregolare, privo di inclusi; colore: Munsell 2.5Y 7/3. Vernice coprente, opaca; colore: Munsell 10YR 2/1. Realizzato al tornio. Mancante del labbro. Tipo H.280.8. n. 4 (Tav. 103, 7): piatto a vasca troncoconica e labbro svasato in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 17.2; alt. 4. Impasto duro, con rari vacuoli distribuiti in maniera disomogenea, frattura irregolare, privo di inclusi; colore: Munsell 7.5YR 7/6. Vernice opaca, coprente; colore: Munsell 7.5YR 2.5/1. Realizzato al tornio. Integro. Tipo H.290.C.1. n. 5 (Tav. 103, 9): olla globulare in ceramica comune. Diam. orlo 17; alt. 26. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di piccole e medie dimensioni; colore: Munsell 7.5YR 7/6. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Ricomposta da vari frammenti. Tipo I.40.3. n. 6 (Tav. 103, 8): poculum a profilo sinuoso in ceramica comune. Diam. orlo 8; alt. 8. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni; colore: Munsell 2.5YR 2.5/1. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Ricomposta da vari frammenti. Tipo I.190.3.
Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso sud-ovest/nord-est (lungh. 130; largh. 60; prof. 92), localizzata nell’angolo settentrionale del saggio di scavo. Dati antropologici. A questo contesto tombale sono forse riferibili i resti umani “intaccati dalla ruspa nei pressi della tomba 282”. Questi reperti osteologici appartengono ad un individuo subadulto giovane adolescente. L’analisi si avvale delle ossa lunghe degli arti inferiori, in particolare femori, il cui stato di maturazione scheletrica corrisponde ad una età minore di 14-17 / 16-19 anni. Dati archeologici. Il corredo è composto da una coppetta in ceramica a vernice nera (n. 1) e un balsamario in ceramica comune (n. 2) localizzati nella porzione orientale della fossa. Il sesso archeologico non è determinabile; le dimensioni della fossa ne suggeriscono l’attribuzione a un individuo sub-adulto. Inquadramento cronologico. Seconda metà IIIinizi II secolo a.C. n. 1 (Tav. 103, 13): coppetta a profilo globulare in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 12.2; alt. 5.5. Impasto duro compatto, frattura regolare, privo di inclusi; colore: Munsell 7.5YR 8/3. Vernice opaca, evanide in vari punti; colore: Munsell 2.5/1. Realizzata al tornio. Integra. Tipo H.260.A.8. n. 2 (Tav. 103, 14): balsamario ceramico fusiforme. Diam. orlo 2.7; alt. 17.4. Impasto molto duro, compatto, privo di inclusi; colore: Munsell 7.5YR 7/6. Superficie polverosa, con tracce di vernice; colore vernice: Munsell 2.5YR 4/6. Realizzato al tornio. Integro. Tipo N.130.3.
n. 7 (Tav. 103, 10): balsamario ceramico fusiforme. Diam. orlo 2; alt. 16. Impasto molto duro, compatto, privo di inclusi; colore: Munsell 2.5Y 7/4. Superficie liscia. Realizzato al tornio. Integro. Tipo N.130.3. n. 8 (Tav. 103, 11): fibula in ferro ad arco semplice, probabilmente ribassato. Lungh. max. ric. 7; alt. 3. Superficie corrosa e ossidata. Ricomposta da vari frammenti. Probabilmente pertinente al Tipo S.20.A.5.
Tomba 283 (Campagna 2008; Tavv. 58, 96). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso sud-ovest/nord-est (lungh. 210; largh. 60; prof. 35), localizzata nella porzione sud-occidentale del saggio di scavo. La fossa taglia la tomba 284 (vedi scheda successiva). Sul piano di deposizione si conservano tracce della cassa lignea. Nell’angolo settentrionale della fossa, è ricavata una nicchia (largh. 42; prof. 30) all’interno della quale è alloggiato il ripostiglio. Deposizione
n. 9 (Tav. 103, 12): anello in argento con castone circolare. Diam. 1.8; spessore verga 0.01; largh. castone 0.6. Integro. Tipo S.40.B.1. Tomba 282 (Campagna 2008; Tavv. 58, 96).
316
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
fossa è profondamente disturbata da interventi di età moderna e dall’impianto della tomba 283 (vedi scheda precedente). Mancano resti della deposizione, che doveva essere alloggiata originariamente in una cassa lignea, di cui si rinvengono le tracce. In corrispondenza del lato corto occidentale, è alloggiato il ripostiglio protetto da spezzoni litici di medie dimensioni. Dati antropologici. La sepoltura risulta priva di resti antropologici. Dati archeologici. Il corredo è composto da uno spiedo in ferro deposto nella posizione originariamente occupata dagli arti inferiori dell’inumato (n. 2); un sauroter in ferro deposto presso l’angolo sud-orientale della fossa (n. 3). Il ripostiglio è composto da un’olla in impasto (n. 1). Il sesso archeologico è determinabile come maschile. Inquadramento cronologico. Fine VI-prima metà V secolo a.C.
dorsale, primaria e in ambiente vuoto; gli arti superiori e inferiori sono distesi. Dati antropologici. I resti umani appartengono ad un individuo adulto, forse maschile, di età tra 25 e 35 anni. Lo stato di conservazione è pessimo e risultano conservati soltanto gli elementi dentari, frammenti di cranio, alcune diafisi di ossa lunghe degli arti superiori (omero) e inferiori (femore sinistro, tibia destra e sinistra). L’unico elemento utile per la determinazione del sesso è il profilo della cresta nucale nel cranio, mentre la stima dell’età alla morte si basa solo sulla osservazione dell’usura dentaria. Si rileva una anomalia di forma della parte coronale dell’incisivo laterale destro mascellare (fig.antr.online 283_01), in particolare un andamento anomalo del margine occlusale che potrebbe essere compatibile con un utilizzo extramasticatorio della dentatura. A causa delle lacune nella conservazione degli elementi dentari, non è possibile approfondire la diagnosi. Dati archeologici. Il corredo è composto da uno spiedo frammentario in ferro deposto lungo il fianco sinistro dell’inumato (n. 2). Il ripostiglio è composto da un’olla in impasto (n. 1). Sulla base della mancanza delle armi e dell’inquadramento cronologico proposto, il sesso archeologico è determinabile come femminile. Inquadramento cronologico. Fine VI-prima metà V secolo a.C. n. 1 (Tav. 104, 1): olla globulare in impasto grezzo. Diam. orlo 21.8; alt. 32. Impasto duro con rari vacuoli, frattura a scaglie, con abbondanti inclusi di piccole e medie dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 2.5YR 4/6. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Mancante di parte del labbro. Tipo A.40.B.23.
n. 1 (Tav. 104, 3): olla globulare in impasto grezzo. Diam. orlo 17, alt. 26. Impasto duro con rari vacuoli, frattura a scaglie, con inclusi molto abbondanti di piccole e medie dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 5YR 6/8. Superficie lisciata. Realizzata al tornio. Ricomposta da vari frammenti. Tipo A.40.B.23. n. 2 (Tav. 104, 5): spiedo in ferro con testa a ricciolo. Lungh. 58.5; spessore stelo 1. Superficie corrosa e ossidata. Frammentario; mancante della testa. Tipo Q.60.1. n. 3 (Tav. 104, 4): sauroter in ferro. Lungh. 7; diam. 1.9. Superficie corrosa e ossidata. Si conserva il chiodo per il fissaggio all’asta lignea. Integro. Tipo T.60.1.
n. 2 (Tav. 104, 2): spiedo in ferro con testa a ricciolo. Lungh. 93; diam. testa 1.6, spessore stelo 1. Superficie corrosa e ossidata. Ricomposto da vari frammenti. Tipo Q.60.1. Tomba 284 (Campagna 2008; Tavv. 58, 96). Sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, orientata in senso sud-ovest/nord-est (lungh. 160; largh. 70; prof. 80), localizzata nella porzione sud-occidentale dell’area di scavo. La 317
Capestrano, I
rinvenute in condizioni frammentarie all’interno del pozzetto. È probabile infatti che il corredo funerario fosse sottoposto a combustione insieme alle spoglie del defunto o frammentato intenzionalmente prima di essere deposto. A tale proposito, non è da escludersi che alcuni materiali frammentari rinvenuti all’interno di sepolture a incinerazione possano non essere ascritti ai rispettivi corredi, ma eventualmente allo sconvolgimento di altre sepolture, come indica ad esempio il caso della tomba 293, nella quale si rinviene un frammento di letto in osso, solitamente associato a tombe a camera e a sepolture a inumazione (vedi, ad esempio, la tomba 320). Nell’ambito delle sepolture a pozzetto, va sottolineato l’uso come cinerario nel caso della tomba 294 di una forma vascolare in impasto buccheroide, probabilmente recuperata da una delle tombe di età arcaica poste nelle vicinanze e sconvolta. Altre sepolture della prima età imperiale sono quelle realizzate, sempre con rituale incineratorio, all’interno di “cassette litiche” composte da blocchi parallelepipedi o spezzoni di calcare (le tombe 288 e 301). È molto probabile che proprio alla tomba 288 debba essere attribuita una iscrizione lapidea rinvenuta a stretto contatto con essa. Vi sono poi due tombe a camera costruita (le tombe 304 e 320), i cui elevati si conservavano per una breve porzione e al cui interno sono stati rinvenuti resti di più inumazioni sconvolte, con quelli dei corredi funerari, traccia evidente di pesanti rimaneggiamenti (per i materiali delle tombe a camera, vedi il Volume II di questo lavoro). Si presenta come una peculiarità la piccola struttura numerata come tomba 303, simile a quella delle tombe a camera appena ricordate, la quale però conteneva tre sepolture a incinerazione in olletta. Sono stati individuati due contesti, infine, la cui interpretazione risulta problematica. Si tratta di una piccola fossa (denominata in corso di scavo tomba 326, vedi 341-342) e di uno strato di livellamento di forma irregolare (denominato tomba 332, vedi 344-345), posto a chiudere le due tombe a incinerazione 340-341, ambedue ricchi di frammenti ceramici, vitrei e metallici, pertinenti a materiali probabilmente ascrivibili a corredi di età tardo-ellenistica-primo imperiale. Essi sono stati identificati in corso di scavo
III.4. FOSSASCOPANA: LA CAMPAGNA 2009 (TOMBE 285-341) (Serena Torello Di Nino; Francesca Mancini; Elena Rossi; Deneb Cesana per le analisi antropologiche)8. Il saggio di scavo del 2009, condotto dalle Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara (prof. Oliva Menozzi) e Roma Tre (prof. Alessandro Guidi e dott. Massimo Pennacchioni), è stato realizzato al fine di chiarire la posizione dei saggi precedentemente aperti (campagne 2003, 2007-2008) rispetto alla strada già portata alla luce nel corso degli scavi del 1934. L’estesa area di indagine, lunga 121 m per una larghezza massima di 11 m, ha restituito resti del tracciato stradale antico, lungo il quale sono state rinvenute numerose sepolture, prevalentemente di età tardorepubblicana e primo-imperiale (nella zona a est del saggio 2007-2008 e del Saggio D del 2003) e, nella parte settentrionale, alcune tombe a fossa prive di resti scheletrici e corredo funerario, che probabilmente corrispondono a sepolture già indagate nel 1934. In corrispondenza del Saggio D, l’apertura della trincea di scavo sembra aver determinato l’asporto dei piani di battuto in terra e pietre portati alla luce nel 2003 (vedi, Tav. 5). Contrariamente a quanto emerso dalle ricerche degli anni precedenti, la maggior parte delle evidenze portate alla luce sono tombe a incinerazione alloggiate in piccoli pozzetti nel banco geologico, databili in età tardorepubblicana-primo imperiale. Queste ultime si caratterizzano per una notevole standardizzazione: quasi tutte presentano un’olla/olletta chiusa da un coperchio come contenitore per le ceneri e il corredo è composto da poche forme ceramiche o vitree, spesso 8
Le schede delle tombe descritte in questa sezione sono rielaborate da lavori di tesi di laurea in Archeologia Classica coordinati dalla prof.ssa O. Menozzi dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di ChietiPescara. Le schede delle tombe 285-287, 291-292, 296, 298, 300, 308-309, 325, 330, 342 sono a cura di Serena Torello Di Nino. Le schede delle tombe 288-290, 293295, 297, 301-303, 305-306, 307, 310-319, 321-323, 326329, 331-329 e 331-342 sono a cura di Francesca Mancini e Serena Torello Di Nino. Le schede delle tombe 303, 304, 320 sono a cura di Elena Rossi. L’analisi dei dati antropologici è a cura di Deneb Cesana. 318
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
probabilmente di circa 28.7 anni, comunque compresa tra 21 e 46 anni. Eccetto un frammento di cranio, è esclusivamente conservato lo scheletro postcraniale. La morfologia di una porzione di bacino e i dati antropometrici relativi al caput femorale (53.16 mm) sono compatibili con una determinazione del sesso maschile. La stima dell’età alla morte è basata sull’aspetto della sinfisi pubica e della superficie auricolare dell’ileo. A partire dalla lunghezza massima delle tibie (sinistra 343 mm; destra 342 mm) è possibile calcolare una statura in vita di 165 cm. Nel contesto tombale sono stati raccolti anche reperti osteologici faunistici. Dati archeologici. La sepoltura era priva di elementi di corredo. Inquadramento cronologico. Incerto.
come resti di offerte all’interno della necropoli, anche se è plausibile che si tratti di strati formatisi a seguito della rimozione dei resti di tombe sconvolte o di aree utilizzate per le pratiche incineratorie e utilizzati per livellare il terreno. Nota: nel catalogo dei materiali, nel caso di tombe a incinerazione in cui il cinerario sia rappresentato da un’olla/olletta chiusa da un coperchio, la schedatura dei due elementi viene proposta di seguito, anche nel caso vi siano altri esemplari in ceramica comune che, sulla base della sequenza tipologica impostata nel Capitolo II, siano ascritti a forme intermedie tra le olle/ollette (Forme 40 e 50) e i coperchi (Forma 300; vedi, 46). Tomba 285 (Campagna 2009; Tav. 105A; pianta di dettaglio della tomba non realizzata). Sepoltura a inumazione in fossa di forma rettangolare, orientata in senso nord-sud (lungh. 150; largh. 75; prof. 41), localizzata nella porzione meridionale del saggio di scavo. La sepoltura risulta estremamente disturbata da interventi post-deposizionali e non ha restituito materiali di corredo, è stato raccolto un solo elemento osseo non determinabile. Nella terra di riempimento della fossa si recuperano alcuni frammenti non diagnostici di forme chiuse in ceramica comune e un frammento di lucerna, anch’esso scarsamente diagnostico. Sulla base delle dimensioni della fossa, è plausibile ipotizzare che fosse originariamente destinata a un individuo sub-adulto. Inquadramento cronologico. Età ellenistica. Tomba 286 (Campagna 2009; Tavv. 105A,106). Sepoltura a inumazione in fossa di forma rettangolare, orientata in senso sud-ovest/nordest (lungh. 175; largh. max. 90; prof. 64), localizzata nella porzione meridionale del saggio di scavo. Deposizione dorsale, primaria, probabilmente avvenuta in spazio pieno; il cranio è volto lievemente verso sud-ovest; gli arti superiori sono distesi ed aderenti ai fianchi, con le mani sulla zona pelvica; gli arti inferiori allineati e distesi. Dati antropologici. I resti umani, in condizioni di conservazione frammentarie, appartengono ad un individuo adulto di sesso maschile, 319
Tomba 287 (Campagna 2009; Tavv. 105A,106). Sepoltura a inumazione in fossa di forma pressoché rettangolare orientata in senso sudovest/nord-est (lungh. 180; largh. 55; prof. 45), localizzata nella porzione meridionale del saggio di scavo. Deposizione dorsale, primaria, probabilmente avvenuta in spazio pieno; il cranio è piegato in avanti; gli arti superiori sono piegati con le mani sul ventre; gli arti inferiori allineati e distesi. Dati antropologici. L’inumato è un individuo adulto femminile di 48.1 anni circa (25-83 anni). Lo stato di conservazione è discreto e tutti i distretti scheletrici sono rappresentati. Il cranio nella porzione occipitale presenta una morfologia femminile e la mandibola è priva di eversione goniale. Le misure del caput femorale destro (42.41 mm) e omerale destro (40.7 mm) confermano la determinazione di sesso femminile. L’aspetto della sinfisi pubica ormai priva di crestine e con segni di infiammazione è compatibile con età alla morte di 48.1 anni circa (nel range 25-83 anni). L’avanzato stato di ossificazione delle suture ectocraniche lambdoidea e sagittale e lo stadio di usura dei denti molari mandibolari (35-45 anni) confermano l’età matura-avanzata. I denti anteriori mostrano una anomalia di usura, particolarmente accentuata nell’aspetto labiale. Il radio destro presenta una deformazione del processo stiloideo radiale. In
Capestrano, I
probabilmente tenuta ferma da grappe in ferro. In superficie la sepoltura era segnata da un circolo di pietre. I resti incinerati del defunto erano misti a cenere. Dati antropologici. In questo contesto tombale sono stati raccolti esclusivamente reperti faunistici: due ossa di ovicaprino e una mandibola sinistra di giovane suino. Dati archeologici. La sepoltura risulta priva di corredo. La lastra calcarea (n. 1; Tav. 112), danneggiata e rinvenuta in tre frammenti, presenta forma parallelepipeda (alt. 120; largh. 60; spessore non rilevato), specchio epigrafico centrale liscio, modanato lungo il perimetro. Reca la dedica: Ann[i]ae T[itii filiae] Posi[ll]ae Bas[sus] frater p(osuit) (vedi il Volume II di questo lavoro). Inquadramento cronologico. I secolo. a.C.-I secolo d.C.
visione anteriore, dall’analisi macroscopica, è visibile una traccia lineare obliqua compatibile con esito di frattura incompleta presso la metafisi distale del radio. Nel punto di deviazione il tessuto osseo è compatto e liscio compatibile con una morfologia di “callo osseo”, ovvero rimodellamento, completo formatosi per un periodo di 6-9 anni prima. Dunque si tratta dell’esito di un trauma avvenuto molto tempo prima in vita limitato a questo elemento scheletrico, non rilevandosi simili tracce sulle ossa delle mani né del radio controlaterale (fig.antr.online 287_01A,B,C,D, E). Spesso tale tipologia di lesione è dovuta a una caduta a braccio teso e trauma del polso. La statura in vita risulta di 159 cm calcolata a partire dalla lunghezza massima del femore sinistro (425 mm). Dati archeologici. Il corredo è composto da un’olletta in ceramica comune (n. 1) deposta tra le tibie dell’inumato; nella terra di riempimento si rinviene un chiodo in ferro (n. 2). Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. II-I secolo a.C. n. 1 (Tav. 112, 1): olletta in ceramica comune. Diam. orlo 7; alt. 12. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con rari inclusi di medie e piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 6/4. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Ricomposta da vari frammenti. Tipo I.50.B.15, varietà c. n. 2 (Tav. 112, 2): chiodo in ferro. Lungh. 9.6; largh. testa 2.8. Superficie corrosa e ossidata. Integro. Tipo Q.110.1. Tomba 288 (Campagna 2009; Tavv. 105A,106). Sepoltura a incinerazione realizzata in una cassetta litica ricavata in un blocco calcareo di forma parallelepipeda, alloggiata in un taglio rettangolare (lungh. 70; largh. 56; prof. 50), localizzata nella porzione centrale del saggio di scavo, a ovest del limite del saggio 2007/2008. L’alloggiamento per le ceneri presenta forma circolare (diam. 30; prof. 23) ed è delimitato da due canalette scolpite nel blocco, probabilmente funzionali alla messa in opera della lastra iscritta con dedica funeraria rinvenuta in stretta prossimità (vedi, avanti), 320
Tomba 289 (Campagna 2009; Tavv. 105A,106). Sepoltura a incinerazione realizzata in un taglio di forma pressoché ovale, orientato in senso sud-ovest/nord-est (lungh. 108; largh. 65; prof. 10), localizzata nella porzione centrale del saggio di scavo, a ovest del limite del saggio 2007/2008. I resti combusti del defunto sono contenuti all’interno del taglio e il corredo si rinviene distribuito in frammenti nel riempimento. Dati antropologici. Dell’incinerato deposto in questa tomba non restano che pochi frammenti combusti, probabilmente appartenenti ad un individuo adulto. A questi si aggiungono i resti di un neonato: una costa e una diafisi di osso lungo. I resti dell’incinerato pesano in totale 409.7 gr. Dati archeologici. Nella terra di riempimento si rinvengono in frammenti di un’olletta in ceramica comune (n. 1) e numerosi frammenti non diagnostici di una lagynos in ceramica comune e ad altre forme chiuse della stessa classe. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. I secolo d.C. n.1 (Tav. 112, 3): olletta in ceramica comune. Diam. orlo 6.8; alt. max. ric. 10.5. Impasto duro, compatto, frattura frastagliata, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 2.5Y 6/1. Superficie
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
frattura regolare, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Ricomposta da vari frammenti, lacunosa di parte del ventre e del collo. Tipo I.20.5.
ruvida. Ricomposta da vari frammenti. Realizzata al tornio. Tipo I.50.B.14, varietà b. Tomba 290 (Campagna 2009; Tavv. 105A, 106). Sepoltura a incinerazione realizzata in un taglio di forma pressoché ovale, orientata in senso nord-est/sud-ovest (lungh. 140; largh. 80; prof. 40), localizzata nella porzione centrale del saggio di scavo, a ovest del limite del saggio 2007/2008. I resti combusti del defunto sono contenuti all’interno di un’olletta in ceramica comune (n. 1) chiusa da un coperchio (n. 2), all’esterno della quale si rinviene il corredo in frammenti. Dati antropologici. L’incinerato era un individuo adulto di cui si sono conservati frammenti dello scheletro postcraniale con evidenti tracce dell’azione del fuoco, in particolare deformazioni, riduzioni dimensionali e fessurazioni (fig.antr.online 290_01). Il peso totale risulta di 955.6 gr. Dati archeologici. Nella terra di riempimento del pozzetto si rinvengono un’anforetta in ceramica comune (n. 3), un frammento di piatto in ceramica sigillata italica (n. 4), un frammento di lucerna (n. 5), un balsamario ceramico (n. 6) un anello metallico (n. 8) e quattro chiodi in ferro (n. 7). Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. I secolo d.C.
n. 4 (Tav. 112, 6): piatto troncoconico in ceramica sigillata italica. Diam. orlo ric. 18; alt. max. cons. 3. Impasto duro, compatto, frattura netta, privo di inclusi. Superficie ingobbiata. Realizzato al tornio. Si conserva solo un frammento del labbro e parte della vasca. Tipo K.290.5. n. 5 (Tav. 112, 9): lucerna. Lungh. max. cons. 3.6; alt. max. cons. 0.5. Impasto duro, compatto, frattura netta, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Realizzata a stampo. Si conserva solo un frammento della vasca, decorata da incisioni lineari concentriche. Tipo non puntualizzabile. n. 6 (Tav. 112, 8): balsamario ceramico piriforme. Diam. orlo 2; alt. 10. Impasto duro, privo di inclusi, superficie polverosa. Il collo presenta una fascia di sovradipintura rossa. Realizzato al tornio. Integro. Tipo N.130.7, varietà b. n. 7 (Tav. 112, 10): quattro chiodi in ferro. Lungh. 8-6; diam. testa 1.5-1; spessore verga 0.3. Superficie ossidata e corrosa. Integri. Due del Tipo Q.110.1; due del Tipo Q.110.2.
n. 1 (Tav. 112, 5): olletta in ceramica comune. Diam. orlo 17; alt. 20. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera disomogenea. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Integra. Tipo I.50.A.6, varietà b.
n. 8 (Tav. 112, 11): anello in ferro con verga sottile. Diam. 3; spessore verga 0.3. Superficie corrosa e ossidata. Integro. Tipo S.40.A.1.
n. 2 (Tav. 112, 4): coperchio in ceramica comune. Diam. orlo 16; alt. 7.5. Impasto duro, poroso con rari vacuoli distribuiti in maniera omogenea, frattura frastagliata, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa. Realizzato al tornio. Ricomposto da vari frammenti, mancante di parte del labbro e della parete. Tipo non puntualizzabile. n. 3 (Tav. 112, 7): anforetta in ceramica comune. Diam. orlo 7; alt. 12. Impasto duro, compatto, 321
Tomba 291 (Campagna 2009; Tavv. 105A, 106). Sepoltura a inumazione in fossa di forma rettangolare orientata in senso sud-ovest/nordest (lungh. 220, largh. 80 m; prof. 52), localizzata nella porzione centrale del saggio di scavo, a ovest del limite del saggio del 2007/2008. È tagliata dalla tomba 313 (vedi, 334-335), il cui impianto risulta aver asportato la parte superiore dell’inumato. In corrispondenza dell’angolo nord-occidentale è ricavata una nicchia (largh. 100; lungh. max. 98), all’interno della quale è alloggiato il
Capestrano, I
ripostiglio, protetto da alcune pietre. La deposizione, in pessimo stato di conservazione, è dorsale e primaria, con gli arti inferiori conservati allineati e distesi. Dati antropologici. I resti antropologici appartengono ad un individuo adulto, ma sono pessimamente conservati e molto frammentari. Tra i pochi elementi determinabili si distinguono 17 elementi dentari, due diafisi di omero, due diafisi di tibie, alcuni elementi tarsali del piede. Dal medesimo contesto tombale provengono anche resti umani di subadulto, probabilmente un neonato: alcuni metacarpali, una costa, una metafisi distale di omero e una diafisi di femore. Dati archeologici. Il corredo è composto da una punta di lancia in ferro (n. 4) deposta presso l’angolo meridionale della fossa, in corrispondenza del cranio dell’inumato; uno spiedo in ferro frammentario (n. 3) lungo il lato sud-occidentale; nel riempimento si rinvengono frammenti di una brocchetta di impasto buccheroide (n. 2). Il ripostiglio è composto da un’olla in impasto (n. 1). Il sesso archeologico è determinabile come maschile. Inquadramento cronologico. VI secolo a.C.
Tomba 292 (Campagna 2009; Tavv. 105A, 107). Sepoltura a inumazione in fossa di forma pressoché rettangolare, con una espansione presso l’angolo meridionale, orientata in senso nord-ovest/sud-est (lungh. 156; largh. min. 50; largh. max. 115; prof. 18), localizzata nella porzione meridionale del saggio di scavo. La deposizione è dorsale, primaria, in pessimo stato di conservazione. Dati antropologici. L’inumato è un subadulto di circa 2-3 anni, di cui è stato possibile raccogliere alcuni frammenti di cranio, inclusa una pars lateralis non fusa, elementi vertebrali, diafisi di femore e ileo. La lunghezza massima della clavicola (68.14 mm) corrisponde a una età di 2-3 anni. Nel contesto tombale sono state raccolte anche ossa di animali, in particolare si individua una porzione di corno di ovicaprino. Dati archeologici. Il corredo è composto da due balsamari ceramici (nn. 1-2). Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. I secolo d.C. n. 1 (Tav. 113, 5): balsamario ceramico piriforme. Diam. orlo 2.8; alt. 10.5. Impasto duro, compatto, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 6/6. Superficie polverosa; sul collo si conserva una fascia di vernice opaca; colore della vernice: Munsell 5YR 4/6. Realizzato al tornio. Integro. Tipo N.130.7, varietà b.
n. 1 (Tav. 113, 1): olla in impasto. Diam. orlo 24; alt. 32.5. Impasto tenero, con frequenti inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 2.5YR 4/4. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo A.40.B.28. n. 2 (Tav. 113, 2): brocchetta in impasto buccheroide. Diam. orlo 9; alt. max. cons. 4.2. Impasto tenero, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10YR 2/1. Realizzata al tornio. Si conserva solo il labbro e parte della spalla. Probabilmente Tipo B.110.4.
n. 2 (Tav. 113, 6): balsamario ceramico piriforme. Diam. orlo 2.6; alt. 9.5. Impasto duro, compatto, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 75YR 6/6. Superficie polverosa. Realizzato al tornio. Integro. Tipo N.130.7, varietà b.
n. 3 (Tav. 113, 3): frammenti di spiedi in ferro. Lungh. frammenti 10.2-3.3; spessore stelo 0.5. Superfici corrose e ossidate. Tipo non puntualizzabile. n. 4 (Tav. 113, 4): punta di lancia in ferro. Lungh. max. lama 19; lungh. Cannone 11.8; diam. cannone 2.4. Superficie corrosa e ossidata. Ricomposta da vari frammenti. Tipo T.40.2. 322
Tomba 293 (Campagna 2009; Tavv. 105A, 107). Sepoltura a incinerazione realizzata in un taglio di forma pressoché ovale, orientato in senso nord-ovest/sud-est (lungh. 100; largh. 70; prof. 35), localizzata nella porzione centrale del saggio di scavo, a ovest del limite del saggio 2007/2008. I resti combusti del defunto sono
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
frattura irregolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera disomogenea. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Ricomposta da più frammenti. Manca di parte del collo e della spalla, il ventre è completamente lacunoso. Tipo non puntualizzabile.
deposti all’interno di un’olletta in ceramica comune chiusa da un coperchio (nn. 1-2), al cui esterno è deposto il corredo. Dati antropologici. L’incinerato è un subadulto di circa 4 anni ± 12 mesi. Lo stato di conservazione è pessimo e molto frammentario a causa dell’azione di combustione. Tra i frustoli di piccole dimensioni si distingue la presenza di alcuni denti decidui, in particolare un premolare mandibolare con corona in formazione corrispondente a circa 4 anni ± 12 mesi. Gli elementi postcraniali confermano l’appartenenza a un bambino: porzione di metafisi di radio prossimale e tibia prossimale con aspetto dell’epifisi immatura, corpi vertebrali non saldati. Il peso totale risulta di 241.1 gr. Dati archeologici. Nella terra di riempimento del pozzetto si rinvengono frammenti di una lagynos in ceramica comune (n. 3), una lucerna (n. 4), un balsamario in vetro (n. 5) e dieci laminette o cinghie bronzee (n. 6), probabilmente funzionali a rivestire un elemento in materiale deperibile (cassetta lignea? elemento dell’abbigliamento / cinturone?). Si rinviene anche un frammento di rivestimento in osso, forse appartenuto a un letto, decorato con un motivo non identificabile, probabilmente un’ala. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. I secolo d.C.
n. 4 (Tav. 113, 12): lucerna a volute. Lungh. max. cons. 8; lungh. max. becco cons. 1.2; diam. disco 8.5; alt. max. cons. non registrata. Impasto duro, compatto, frattura netta, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera disomogenea. Superficie ruvida. Mancante dell’ansa e di parte della vasca. Nella vasca si conserva parte di una decorazione fitomorfa, forse delle spighe. Tipo non puntualizzabile. n. 5 (Tav. 113, 10): balsamario piriforme in vetro. Diam. orlo 2; alt. 7. Patina iridescente sulla superficie. Integro. Tipo P.130.3. n. 6 (Tav. 113, 11): dieci frammenti di rivestimenti/cinghie rettangolari in bronzo, con inserti di chiodini in ferro. Lungh. 10-1.2; largh. 1.3-1; spessore lamina 0.2; diam. testa chiodini 0.8. Patina verde sulla superficie. Tomba 294 (Campagna 2009; Tavv. 105B, 107). Sepoltura a incinerazione realizzata in un taglio di forma pressoché trapezoidale, orientato in senso est-ovest (lungh. 60; largh. 54; prof. 12), localizzata nella porzione settentrionale del saggio di scavo. I resti combusti del defunto sono contenuti in una forma chiusa in impasto buccheroide, rinvenuta pesantemente danneggiata da interventi post-deposizionali (n. 1). La datazione del cinerario non coincide con quella della tomba, che per il rituale funerario adottato è da ascrivere alla prima età imperiale. Si può pertanto ipotizzare un riutilizzo di una forma vascolare recuperata da una delle tombe arcaiche della stessa area. Dati antropologici. I resti dell’individuo della tomba in esame non risultano presenti in deposito quindi non disponibili all’analisi. Dati archeologici. Il corredo risultava mancante. Inquadramento cronologico. Prima età imperiale.
n. 1 (Tav. 113, 8): olletta ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 15; alt. 22. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Integra. Tipo I.50.A.12. n. 2 (Tav. 113, 7): coperchio in ceramica comune. Diam. orlo 15, alt. 4.5. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa. Realizzato al tornio. Mancante di piccole porzioni del labbro. Tipo I.300.5. n. 3 (Tav. 113, 9): lagynos in ceramica comune. Frammento superiore: diam. orlo 4; alt. max. cons. 7; frammento inferiore: diam. fondo 6.5; alt. max. cons. 3.5. Impasto duro, compatto, 323
Capestrano, I
irregolare; con frequenti inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Manca di parte del labbro. Tipo I.50.A.15.
n. 1 (Tav. 113, 13): forma chiusa in impasto buccheroide. Corpo ovoide e piede ad anello rilevato; nella parte inferiore del ventre è applicato un cordone orizzontale. Diam. piede 6; alt. max. cons. 21.4. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Realizzata al tornio. Lacunosa della spalla, del collo e del labbro. Tipo non puntualizzabile.
n. 2 (Tav. 114, 1): coperchio in ceramica comune. Diam. orlo 17; alt. 5. Impasto duro, poroso con frequenti vacuoli di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; frattura irregolare; con frequenti inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa. Realizzato al tornio. Lacunoso di gran parte della parete e del labbro. Tipo I.300.5.
Tomba 295 (Campagna 2009; Tav. 107, manca il posizionamento puntuale della tomba nell’area di scavo). Sepoltura a incinerazione realizzata in un taglio di forma irregolarmente ovale, orientato in senso sud-ovest/nord-est (lungh. 103; largh. 70; prof. 20), la cui localizzazione nell’ambito del saggio di scavo non è stata registrata nella planimetria generale. I resti combusti del defunto sono contenuti in un’olletta chiusa da un coperchio (nn. 1-2), alloggiata a sua volta in un approfondimento del taglio; al suo esterno si rinviene il corredo. Il sesso archeologico non è determinabile. Dati antropologici. L’individuo incinerato era probabilmente un adulto femminile, anche se i resti combusti sono estremamente frammentari e pochi elementi scheletrici sono identificabili. Tra questi, una porzione di ileo sembra avere morfologia femminile e le estremità prossimali fuse di omero, radio e femore confermano l’appartenenza a un individuo adulto. Tuttavia in questo caso, come negli altri contesti a incinerazione, è necessaria la massima prudenza nell’analisi dei resti umani a causa dell’effetto di deformazione e riduzione dimensionale dovuto all’azione del fuoco. Il peso totale dei resti umani incinerati risulta di 1237.5 gr. Dati archeologici. Nella terra di riempimento del pozzetto si rinvengono frammenti di un piatto in ceramica a vernice nera (n. 3) e uno in ceramica sigillata italica; due balsamari ceramici integri (nn. 4-5) e tre chiodi in ferro (nn. 6-7). Inquadramento cronologico. Fine I secolo a.C.inizi I secolo d.C.
n. 3 (Tav. 114, 3): piatto in ceramica a vernice nera. Diam. fondo 6; alt. max. cons. 2. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie liscia, con vernice opaca ed evanide. Realizzato al tornio. Lacunoso del labbro. Tipo non puntualizzabile. n. 4 (Tav. 114, 4): balsamario ceramico piriforme. Diam. orlo 2.5; alt. 9.1. Impasto duro, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa; sul collo si conserva una fascia di sovradipintura scura. Realizzato al tornio. Lacunoso del fondo. Tipo N.130.7, varietà b. n. 5 (Tav. 114, 5): balsamario ceramico piriforme. Diam. orlo 2.5; alt. max. cons. 10.1. Impasto duro, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa; sul collo si conserva una fascia di sovradipintura scura. Realizzato al tornio. Integro. Tipo N.130.7, varietà b. n. 6 (Tav. 114, 6): due chiodi in ferro. Lungh. 11-8; diam. testa 1.5-1.6. Superfici corrose e ossidate. Integri. Tipo Q.110.1. n. 7 (Tav. 114, 7): chiodo in ferro. Lungh. 2.5; diam. testa 1.5. Superficie corrosa e ossidata. Integro. Tipo Q.110.1. Tomba 296 (Campagna 2009; Tavv. 105A, 107). Sepoltura a inumazione in fossa di forma irregolare, pressoché romboidale (lungh. 78; largh. 65; prof. 20), localizzata nella porzione
n. 1 (Tav. 114, 2): olletta in ceramica comune. Diam. orlo 17; alt. 19. Impasto duro, poroso con frequenti vacuoli di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; frattura 324
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
(n. 3) e un kantharos in impasto grezzo (n. 2), che però plausibilmente non è coerente cronologicamente con gli altri materiali. È possibile che l’emergenza vada interpretata come il resto di un ripostiglio. Dati antropologici. All’interno di questo contesto sono stati recuperati pochi frammenti scheletrici, tra cui una porzione di diafisi di tibia. A cui si aggiunge un frammento osseo appartenente a un neonato. Inquadramento cronologico. Ultimo quarto VIprima metà V secolo a.C.
centrale del saggio di scavo, a ovest del limite del saggio 2007/2008. La tomba è profondamente disturbata da interventi postdeposizionali di età antica e moderna. Si conserva solo il ripostiglio, in corrispondenza del suo limite orientale. I resti antropologici risultano completamente sconvolti. Dati antropologici. I resti dell’individuo della tomba in esame non risultano presenti in deposito quindi non disponibili all’analisi. Dati archeologici. Il ripostiglio è composto da un’olla in impasto (n. 1) contenente una tazza in impasto buccheroide (n. 2). Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Seconda metà/fine VI-prima metà V secolo a.C. n. 1 (Tav. 114, 9): olla ovoide in impasto grezzo. Diam. orlo 19; alt. 28. Impasto tenero, poroso con rari vacuoli distribuiti in maniera omogenea, frattura frastagliata, con frequenti inclusi di piccole e medie dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 5YR 4/4. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Parzialmente ricomposta da vari frammenti. Tipo A.40.A.2. n. 2 (Tav. 114, 8): tazza carenata in impasto buccheroide. Diam. orlo 12.5; alt. 10. Impasto compatto, con rari vacuoli di piccole dimensioni distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 10YR 4/1. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo B.220.1.
n. 1 (Tav. 114, 12): olla in impasto grezzo. Diam. fondo 15.5; alt. max. cons. 24. Impasto tenero, poroso con frequenti vacuoli distribuiti in maniera disomogenea, frattura frastagliata, con inclusi molto abbondanti di grandi e medie dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10R 3/4. Realizzata a mano. Mancante del labbro. Tipo non puntualizzabile. n. 2 (Tav. 114, 10): kantharos in impasto grezzo. Diam. orlo 7.2; alt. 7.6. Impasto tenero, poroso con rari vacuoli distribuiti in maniera omogenea, frattura irregolare, rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 7.5YR 6/6. Superficie ruvida. Tipo A.210.2. n. 3 (Tav. 114, 13): ansa a nastro con margini rilevati di anforetta in impasto buccheroide. Spessore ansa 1.3. Impasto tenero, poroso con frequenti vacuoli distribuiti in maniera disomogenea, frattura frastagliata, con inclusi molto abbondanti di grandi e medie dimensioni; colore: Munsell 10YR 3/3. Realizzata a mano. Tipo non puntualizzabile. n. 4 (Tav. 114, 11): tazza in impasto buccheroide. Diam. orlo 11.6; alt. max. cons. 6. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 4/3. Superficie polverosa. Ricomposta da vari frammenti; mancante dell’ansa. Tipo B.230.A.5.
Tomba 297 (Campagna 2009; Tavv. 105A, 107). Con questo numero viene individuato un taglio di forma ovale, orientato in senso nordovest/sud-est (lungh. 35; largh. 30; prof. 24), localizzato nella porzione centrale del saggio di scavo, a ovest del limite del saggio 2007/2008, all’interno del quale era alloggiata un’olla in impasto grezzo (n. 1). Sulla base della documentazione di scavo, all’interno dell’olla sarebbe stato rinvenuto un “attingitoio in impasto buccheroide”, anche se la verifica dei materiali conservati in magazzino ha consentito di recuperare (come provenienti dalla tomba 297) una tazza in impasto buccheroide (n. 4; forse quella identificata come “attingitoio”), un’ansa di una anforetta in impasto buccheroide
Tomba 298 (Campagna 2009; Tav. 105A, pianta di dettaglio della tomba non realizzata in corso di scavo). Sepoltura a inumazione in fossa di forma irregolarmente rettangolare, orientata in senso 325
Capestrano, I
n. 1 (Tav. 114, 14): olletta in ceramica comune. Diam. fondo 9; alt. max. cons. 17. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Lacunosa della parte superiore. Tipo non puntualizzabile.
sud-est/nord-ovest (lungh. 220; largh. 80; prof. 21), localizzata nella porzione centrale del saggio di scavo, a ovest del limite del saggio 2007/2008. Si presenta estremamente disturbata da interventi post-deposizionali di età antica e moderna. Della deposizione si conservano solo pochi resti degli arti inferiori. Dati antropologici. I resti dell’individuo della tomba in esame non risultano presenti in deposito quindi non disponibili all’analisi. Dati archeologici. Nella scheda di rinvenimento è segnalata la presenza di una “olletta monoansata”, che però non è stata recuperata in magazzino. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Incerto.
Tomba 300 (Campagna 2009; Tavv. 105A, 107). Taglio di forma pressoché circolare (diam. 60; prof. 35), localizzato nella porzione del saggio di scavo, a ovest del limite del saggio 2007/2008 e probabilmente da identificare come il ripostiglio di una sepoltura a fossa completamente sconvolta da interventi postdeposizionali. Dati antropologici. I resti dell’individuo della tomba in esame non risultano presenti in deposito quindi non disponibili all’analisi. Dati archeologici. Nella fossa era alloggiata un’olla in ceramica comune (n. 2), contenente uno skyphos in ceramica a vernice nera (n. 1). Inquadramento cronologico. III secolo a.C.
Tomba 299 (Campagna 2009; Tavv. 105A, 107). Sepoltura a incinerazione realizzata in un taglio di forma ovale, orientato in senso nord-est/sudovest (lungh. 60; largh. 40; prof. 20), localizzata nella porzione centrale del saggio di scavo, a ovest del limite del saggio 2007/2008. I resti combusti del defunto sono contenuti in un’olletta in ceramica comune (n. 1) pesantemente danneggiata da interventi postdeposizionali. Il sesso archeologico non è determinabile. Dati antropologici. L’individuo incinerato era un adulto probabilmente di sesso femminile. Le condizioni di conservazione sono discrete, i reperti osteologici presentano un colore bianco calcinato. È possibile identificare la mandibola con alcune radici di denti e frammenti di cranio, ma anche coste, vertebre e ossa lunghe degli arti superiori e inferiori. I dati metrici relativi al capitello radiale (17.23 mm) (fig.antr.online 299_01) e al caput femorale (33.01 mm) sono compatibili con un individuo di sesso femminile, tuttavia anche in questo caso è necessaria la massima prudenza nell’analisi dei resti umani a causa dell’effetto di deformazione e riduzione dimensionale dovuto all’azione del fuoco (fig.antr.online 299_02). Il peso totale risulta di 943.8 gr. Dati archeologici. Il corredo risulta assente. Inquadramento cronologico. Prima età imperiale.
n. 1 (Tav. 115, 2): skyphos a profilo troncoconico in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 12; alt. 13.4. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10YR 8/2: Superficie liscia, con tracce di vernice opaca ed evanide; colore vernice: Munsell 10R 4/1. Realizzato al tornio. Ricomposto da vari frammenti. Tipo H.280.8. n. 2 (Tav. 115, 1): olla biansata globulare in ceramica comune. Diam. orlo 17; alt. 33. Impasto duro, poroso con rari vacuoli di piccole dimensioni distribuiti in maniera disomogenea, frattura irregolare; con inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 5YR 6/8. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Integra. Tipo I.60.3. Tomba 301 (Campagna 2009; Tavv. 105A, 108). Sepoltura a incinerazione realizzata in una cassetta di forma parallelepipeda composta di spezzoni di calcare legati da malta e alloggiata in un taglio rettangolare, orientato in senso nord-ovest/sud-est (lungh. 90; largh. 90; prof. 40), localizzata nella porzione centrale del 326
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
323; alt. max. cons. 20-30), localizzata nella porzione centrale del saggio di scavo, a ovest del limite del saggio 2007/2008. Presenta un’apertura in corrispondenza dell’angolo sudorientale. Le murature sono realizzate in blocchi irregolari di calcare, di medie e grandi dimensioni, legati da una malta incoerente di colore biancastro. Al suo interno si rinvengono tre sepolture a incinerazione, in tre ollette (nn. 1-3) in ceramica comune, una delle quali chiusa da un coperchio (n. 4). La documentazione di scavo conservata non consente di attribuire i vari materiali di corredo alle singole deposizioni, che vengono pertanto elencati di seguito seguendo l’ordine tipologico (ad esclusione dei cinerari; vedi, 319). Agli esemplari nn. 5-19 del catalogo che segue, si aggiungono numerosi frammenti non diagnostici di forme aperte e chiuse in ceramica comune. Dati antropologici. Nel deposito risulta disponibile per l’analisi soltanto uno dei tre individui incinerati, probabilmente un adulto di sesso maschile. Le condizioni di conservazione sono pessime ed estremamente frammentarie. Tra gli elementi identificabili si rileva la presenza di coste, corpi vertebrali, ossa lunghe degli arti inferiori. I dati metrici relativi al caput femorale (45 mm) farebbero propendere per una determinazione del sesso maschile, tuttavia anche in questo caso è necessaria la massima prudenza nell’analisi dei resti umani a causa dell’effetto di deformazione e riduzione dimensionale dovuto all’azione del fuoco. Il peso totale dei resti umani incinerati risulta di 408.3 gr. Inquadramento cronologico. I secolo d.C.
saggio di scavo, a ovest del limite del saggio 2007/2008. La sua messa in opera disturba il taglio della tomba 334 (vedi, 346). L’alloggiamento per le ceneri, contenute da frammenti di una forma chiusa in ceramica comune, presenta forma irregolarmente rettangolare (lungh. 65; largh. 45; prof. 10). Dati antropologici. Dell’incinerato non restano che pochi frammenti combusti di piccole dimensioni e di difficile identificazione, appartenenti ad un individuo adulto. Il peso totale risulta di 236.55 gr. Dati archeologici. Non si conserva il corredo. Inquadramento cronologico. Prima età imperiale. Tomba 302 (Campagna 2009; Tavv. 105A, 108). Con il numero 302 viene individuato in corso di scavo un taglio di forma pressoché ovale, orientato in senso nord/sud (lungh. 80; largh. 55; prof. 19), localizzato nella porzione centrale del saggio, a ovest del limite del saggio 2007/2008. È tagliato dall’impianto della più recente tomba 331. Al suo interno del quale si conservano frammenti di un’olla in impasto (n. 1), profondamente danneggiata da interventi post-deposizionali di età antica e moderna. Si può ipotizzare che, come nel caso della tomba 297, questa evidenza debba essere interpretata come il ripostiglio di una sepoltura a fossa completamente sconvolta. Dati antropologici. Non sono disponibili resti antropologici per l’analisi. Inquadramento cronologico. VI-IV secolo a.C. (?). n. 1 (Tav. 115, 3): olla ovoide in impasto grezzo. Diam. orlo 32; alt. 52. Impasto tenero, poroso con frequenti vacuoli distribuiti in maniera disomogenea, frattura frastagliata, con inclusi di grandi dimensioni molto frequenti distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 2.5YR 4/6. Superficie ruvida. Realizzata a mano. Ricomposta da numerosi frammenti; mancante di parte del labbro. Tipo A.40.A.1. Tomba 303 (Campagna 2009; Tavv. 105A, 109). Struttura di forma rettangolare, orientata in senso nord-est/sud-ovest (lungh. 234; largh.
Sepoltura 303A. n. 1 (Tav. 116, 1): olletta ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 19.9; alt. 21.1. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera disomogenea. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Manca di piccole porzioni del labbro. Tipo I.50.B.9, varietà d. Sepoltura 303B. n. 2 (Tav. 116, 2): olletta ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 16; alt. 19.7. Impasto duro,
327
Capestrano, I
Realizzata al tornio. Mancante del fondo Tipo I.50.B.9, varietà d.
compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera disomogenea. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Integra. Tipo I.50.B.9, varietà d.
n. 9 (Tav. 116, 9): lagynos in ceramica comune. Diam. orlo 4.8; alt. max. cons. 14. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera disomogenea. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Lacunosa di parte del ventre e del fondo. Tipo I.120.4.
Sepoltura 303C. n. 3 (Tav. 116, 4): olletta ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 16; alt. 18.9. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera disomogenea. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Integra. Tipo I.50.B.9, varietà d.
n. 10 (Tav. 116, 10): frammento di collo di lagynos in ceramica comune, decorato da due fasce di tre linee incise. Diam. collo 3.9; alt. max. cons. 5.8. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera disomogenea. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Tipo non puntualizzabile.
n. 4 (Tav. 116, 3): coperchio globulare in ceramica comune. Diam. orlo 15.9; alt. 5.3. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera disomogenea. Superficie polverosa. Realizzato al tornio. Integro. Tipo I.300.1.
n. 11 (Tav. 116, 11): scodella a profilo troncoconico in ceramica comune. Diam. orlo l0.5; alt. max. cons. 5.8. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Ricomposta da vari frammenti. Tipo I.230.1.
Materiali dei corredi. n. 5 (Tav. 116, 5): olletta globulare in ceramica comune. Diam. orlo 13.1; alt. 13. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Lacunosa di parte della vasca. Tipo I.50.B.4.
n. 12 (Tav. 116, 12): lucerna a volute. Lunghezza complessiva 10.4; diam. vasca 7.2. Impasto duro, compatto, frattura netta; privo di inclusi. Superficie liscia; si conservano tracce di ingobbio opaco. Realizzata a stampo. Lacunosa di parte della vasca. Sul fondo reca impressa una lettera V. Tipo M.C.2.
n. 6 (Tav. 116, 6): olletta ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 9; alt. 10.9. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Integra. Tipo I.50.B.8.
n. 13 (Tav. 116, 13): frammento di vasca di lucerna decorata sul margine da incisioni concentriche. Lunghezza 5.5, larghezza 1.1. Impasto duro, compatto, frattura netta; privo di inclusi. Superficie liscia. Tipo non puntualizzabile.
n. 7 (Tav. 116, 7): olletta ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 12.1; alt. max. cons. 5.2. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Mancante del fondo. Tipo I.50.B.9, varietà d.
n. 14 (Tav. 116, 14): balsamario ceramico piriforme. Diam. orlo 1.4; alt. 8. Impasto duro, compatto, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera disomogenea. Superficie polverosa. Si conserva una fascia di colore grigiastro sul collo. Realizzato al tornio. Integro. Tipo N.130.7, varietà b.
n. 8 (Tav. 116, 8): olletta ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 5.8; alt. max. cons. 4.22. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa.
328
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
n. 15 (Tav. 116, 15): balsamario ceramico piriforme. Diam. orlo 1.4; alt. 8. Impasto duro, compatto, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera disomogenea. Superficie polverosa. Si conserva una fascia di colore grigiastro sul collo. Realizzato al tornio. Integro. Tipo N.130.7, varietà b. n. 16 (Tav. 116, 16): balsamario ceramico. Diam. orlo 2.5; alt. max. cons. 7.7. Impasto duro, compatto, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera disomogenea. Superficie polverosa. Si conserva parte di una fascia di colore grigiastro sul collo. Realizzato al tornio. Mancante del ventre. Tipo non puntualizzabile. n. 17 (Tav. 116, 17): balsamario ceramico piriforme. Diam. fondo 1.2; alt. max. cons. 5.1. Impasto duro, compatto, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera disomogenea. Superficie polverosa. Realizzato al tornio. Mancante del collo. Tipo N.130.7, varietà b. n. 18 (Tav. 116, 18): chiodo in ferro. Diam. testa 1.2; lungh. 5.6. Superficie corrosa e ossidata. Integro. Tipo Q.110.2. n. 19 (Tav. 116, 19): anello in bronzo con verga sottile. Diam. 3.1; spessore verga 0.2. Si conserva una patina verde sulla superficie. Tipo S.40.A.1. Tomba 304 (Campagna 2009; Tavv. 105A, 109). Tomba a camera costruita di forma quadrangolare, orientata in senso sud-ovest/ nord-est (lungh. 380; largh. 420; alt. max. cons. 110), localizzata nella porzione centrale del saggio di scavo, a ovest del limite del saggio 2007/2008; direttamente a sud della tomba a camera 320 (vedi, 339-340). Le murature sono composte da spezzoni irregolari di calcare di medie e grandi dimensioni, legati da una malta incoerente di colore biancastro. La soglia è tamponata da pezzame litico di medie dimensioni. Il piano pavimentale interno è realizzato in terra battuta. Dati antropologici. In questo contesto tombale i resti osteologici antropologici appartengono a due neonati e a due individui adulti.
Tra le ossa di individui subadulti sono identificabili: una mandibola, vertebre, coste, arti superiori. In particolare una mandibola destra (lunghezza obliqua 56.8 mm e lunghezza del corpo mandibolare 49.18 mm), ulna destra (66.4 mm) e un omero sinistro (71 mm), una tibia destra (72.5 mm) e un femore destro (80.5 mm) sono attribuibili ad un neonato. La presenza di una metafisi prossimale di ulna destra di subadulto e di una mandibola destra (lunghezza obliqua 57.6 mm e lunghezza del corpo mandibolare 48 mm) lasciano ipotizzare la presenza di un altro neonato. Agli individui adulti appartengono solo alcune ossa delle estremità degli arti superiori, mani, e inferiori piedi, ma anche diafisi di ossa lunghe (omero, tibia, femore), coste e vertebre. Oltre ai resti umani, anche i reperti faunistici sono stati raccolti in abbondanza in questa tomba. Una preliminare determinazione di specie ha permesso l’identificazione di ossa di giovane equide con ossa immature, una falange di bovino, mandibola di giovanissimo ovicaprino ancora con dente deciduo dP4, un femore di canide, alcune ossa lunghe di avifauna e microfauna. Dati archeologici. Come per i resti antropologici, i materiali di corredo si presentano estremamente disturbati e in condizioni frammentarie. Si rinvengono un fondo di poculum in ceramica comune; un fondo di brocca in ceramica depurata acroma; un frammento di dolio in ceramica comune; due balsamari ceramici; frammenti di piatti in ceramica a vernice nera e rossa; una scodella monoansata in ceramica comune; una conchiglia in bronzo; una moneta in bronzo e uno specchio anch’esso in bronzo e altri frammenti ceramici pertinenti a varie forme. Per la schedatura di dettaglio del corredo di questa tomba, vedi il II Volume di questo lavoro. Inquadramento cronologico. Prima età imperiale. Tomba 305 (Campagna 2009; Tavv. 105B; 108). Sepoltura a incinerazione realizzata in un taglio di forma pressoché ovale, orientato in senso nord-ovest/sud-est (lungh. 60; largh. 45; prof. 30), localizzata nella porzione settentrionale del
329
Capestrano, I
Inquadramento cronologico. I secolo d.C.
saggio di scavo. I resti combusti del defunto sono contenuti all’interno di un’olletta in ceramica comune (n. 1) rinvenuta in frammenti. Dati antropologici. I resti antropologici conservati provengono dallo svuotamento dell’urna cineraria che li conteneva. Di conseguenza non sono ricavabili utili informazioni riguardo l’ossilegio, e oltretutto lo stato di conservazione è pessimo. Molto probabilmente, come segnalerebbe la presenza di una porzione distale di ulna, l’incinerato era un individuo adulto. Il peso totale dei resti umani incinerati risulta di 1984.15 gr. Dati archeologici. Il corredo risulta assente. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Fine I secolo a.C.I secolo d.C.
n. 1 (Tav. 117, 3): olletta tronco-ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 16; alt. 20. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera disomogenea. Superficie ruvida. Realizzata al tornio. Integra. Tipo I.50.A.4. n. 2 (Tav. 117, 2): coperchio in ceramica comune. Diam. orlo 16; alt. 6.5. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera disomogenea. Superficie ruvida. Realizzato al tornio. Integro. Tipo I.300.3. n. 3 (Tav. 117, 4): piatto in ceramica a vernice nera. Diam. piede 10; alt. max. cons. 2.4. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie liscia; conserva tracce di vernice opaca ed evanide. Realizzato al tornio, frammentario. Tipo non puntualizzabile..
n. 1 (Tav. 117, 1): olletta globulare in ceramica comune. Diam. orlo 20; alt. 25. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie ruvida. Realizzata al tornio. Ricomposta da vari frammenti e mancante di parte della spalla e del labbro. Tipo I.50.A.6, varietà b.
n. 4 (Tav. 117, 6): olletta globulare in ceramica comune. Diam. orlo 8.5; alt. max. ric. 4.5. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera disomogenea. Superficie ruvida. Realizzata al tornio. Mutilo, Si conserva solo parte del labbro e del ventre. Tipo I.50.B.3.
Tomba 306 (Campagna 2009; Tavv. 105A, 108). Sepoltura a incinerazione realizzata in un taglio di forma pressoché circolare (diam. 60; prof. 40), localizzata nella porzione centrale del saggio di scavo, a ovest del limite del saggio 2007/2008. I resti combusti del defunto sono contenuti in un’olletta in ceramica comune chiusa da un coperchio (nn. 1-2), all’interno e all’esterno della quale si rinviene il corredo. Dati antropologici. Di questo inumato non restano che pochi resti appartenenti al cranio e alla parte inferiore dello scheletro: un femore adulto e una porzione di ileo con incisura dalla morfologia forse femminile. I resti incinerati pesano in totale 822.2 gr. Dati archeologici. All’interno del cinerario e nella terra di riempimento del pozzetto, si rinvengono frammenti di un piatto in ceramica a vernice nera (n. 3), tre ollette in ceramica comune (nn. 4-6), una lagynos in ceramica comune (n. 7) e sei balsamari ceramici, di cui quattro integri (nn. 8-13). Il sesso archeologico non è determinabile.
n. 5 (Tav. 117, 5): olletta globulare in ceramica comune. Diam. orlo 10; alt. max. cons. 7. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera disomogenea. Superficie ruvida. Realizzata al tornio. Mutilo, Si conserva solo parte del labbro e del ventre. Tipo I.50.B.14, varietà a. n. 6 (Tav. 117, 7): frammento di fondo piano di olletta in ceramica comune. Diam. fondo 6.4; alt. max. cons. 4. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera disomogenea. Superficie ruvida. Realizzata al tornio. Tipo non puntualizzabile.
330
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa; sul collo si conserva una fascia di sovradipintura scura. Realizzato al tornio. Si conserva solo il collo. Tipo N.130.7, varietà b.
n. 7 (Tav. 117, 8): frammenti di fondo con piede a disco di lagynos in ceramica comune. Diam. piede 7; alt. max. cons. 3. Impasto duro, frattura regolare, rarissimi inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera disomogenea. Superficie liscia. Tipo non puntualizzabile. n. 8 (Tav. 117, 9): balsamario ceramico piriforme. Diam. orlo 2.5; alt. 10. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa. Fascia di sovradipintura rossa sul collo. Realizzato al tornio. Integro. Tipo N.130.7, varietà b. n. 9 (Tav. 117, 10): balsamario ceramico. Diam. orlo 2; alt. 7. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa. Fascia di sovradipintura nerastra sul collo. Realizzato al tornio. Integro. Tipo N.130.7, varietà b. n. 10 (Tav. 117, 11): balsamario ceramico piriforme. Diam. orlo 2; alt. 7.5. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa. Fascia di sovradipintura nerastra sul collo. Realizzato al tornio. Integro. Tipo N.130.7, varietà b. n. 11 (Tav. 117, 12): balsamario ceramico piriforme. Diam. orlo 2; alt. 7.5. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa. Fascia di sovradipintura nerastra sul collo. Realizzato al tornio. Integro. Tipo N.130.7, varietà b. n. 12 (Tav. 117, 13): balsamario ceramico piriforme. Diam. orlo 2; alt. max. cons. 4. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa. Fascia di sovradipintura nerastra sul collo. Realizzato al tornio. Si conserva solo il collo. Tipo N.130.7, varietà b.
Tomba 307 (Campagna 2009; Tav. 105B, pianta di dettaglio della tomba non realizzata in corso di scavo). Sepoltura a inumazione in fossa di forma irregolarmente rettangolare, orientata in senso nord-sud (lungh. 140; largh. 55; prof. 10), localizzata nella porzione settentrionale del saggio di scavo. Sulla base del posizionamento effettuato dei saggi di scavo del 1934, la tomba 307 sembra coincidere con la tomba 13 degli scavi Annibaldi (vedi, 19). Sulla base della documentazione di scavo, nella terra di riempimento sarebbero stati recuperati numerosi ribattini in bronzo, un pendente trapezoidale in bronzo, un bottone rettangolare in bronzo e una bulla in bronzo, non individuati però in magazzino. In mancanza di riscontri diretti, è possibile che questi materiali siano il resto del corredo della tomba 13, non recuperato integralmente al momento del primo scavo. Quest’ultimo, ad esempio, comprendeva un cinturone in materiale deperibile decorato da chiodini in bronzo cui possono essere attribuiti i resti rinvenuti nel 2009. Dati antropologici. Per questo contesto non sono stati recuperati in magazzino resti umani per l’analisi, anche se le foto in corso scavo attestano il rinvenimento in questa sepoltura delle tibie dell’inumato, che potrebbero comunque non essere state recuperate nel corso dello scavo del 1934. Dati archeologici e inquadramento cronologico. Vedi, il catalogo delle tombe scavate nel 1934 nel II Volume di questo lavoro. Tomba 308 (Campagna 2009; Tavv. 105A, 108). Sepoltura a inumazione in fossa di forma rettangolare, orientata in senso sud-ovest/ nordest (lungh. 170; largh. 90; prof. 36), localizzata nella porzione centrale del saggio di scavo, a ovest del limite del saggio 2007/2008. La porzione nord-occidentale della fossa si presenta pesantemente disturbata da interventi post-deposizionali di età antica e moderna.
n. 13 (Tav. 117, 14): balsamario ceramico piriforme. Diam. orlo 2; alt. max. cons. 6. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con 331
Capestrano, I
Deposizione dorsale, primaria e in ambiente pieno; il cranio è lievemente piegato in avanti; gli arti superiori sono piegati, con le mani sul ventre; gli arti inferiori allineati e distesi. Dati antropologici. L’inumato è un giovane adulto di sesso femminile. Lo stato di conservazione è pessimo e frammentario. Si rileva la presenza di frammenti di cranio, elementi dentari, diafisi degli arti del lato destro e sinistro (omeri, femori, tibie, fibule). La determinazione del sesso è limitata all’osservazione della morfologia del processo mastoideo e del profilo del mento. L’età alla morte può essere genericamente indicata come giovanile, considerando lo stato di ossificazione delle suture ectocraniche ancora ben separate. Dati archeologici. Il corredo è composto da tre balsamari ceramici (nn. 5-7), una chiave in ferro (n. 8), una lucerna (n. 4), un’olletta, una lagynos ed un bicchiere in ceramica comune (nn. 1-3), deposti allineati lungo il lato lungo settentrionale della fossa. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. I secolo d.C.
Realizzato a mano. Mancante di parte del labbro. Tipo I.180.1.
n. 1 (Tav. 117, 15): olletta ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 10.5; alt. max. ric. 12. Impasto duro, poroso con rari vacuoli distribuiti in maniera omogenea, frattura irregolare, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 4/3; superficie polverosa. Realizzata al tornio Parzialmente ricomposta da vari frammenti, mancante di buona parte del ventre. Tipo I.50.B.9, varietà b.
n. 7 (Tav. 118, 21): balsamario ceramico piriforme. Diam. orlo 2; alt. 7.5. Impasto duro, compatto, frattura regolare, privo di inclusi. Superficie polverosa; si conserva una fascia sovradipinta in nero sul collo. Realizzato al tornio. Integro. Tipo N.130.7, varietà b.
n. 2 (Tav. 117, 16): lagynos globulare in ceramica comune. Diam. orlo 4, alt. 15.5. Impasto duro, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 5YR 7/4. Superficie liscia, si conservano tracce di vernice opaca; colore vernice: Munsell 5YR 4/6. Realizzata al tornio. Integra. Tipo I.120.3.
Tomba 309 (Campagna 2009; Tav. 105B, pianta di dettaglio della tomba non realizzata in corso di scavo). Sepoltura a inumazione in fossa di forma rettangolare, orientata in senso nord-sud (lungh. 190; largh. 72; prof. 87), localizzata nella porzione settentrionale del saggio di scavo. Sulla base del posizionamento dei saggi di scavo del 1934, la tomba 309 sembra coincidere con la tomba 1 degli scavi Annibaldi (vedi, 19). Al momento dello scavo, mancavano sia resti scheletrici sia materiali di corredo.
n. 4 (Tav. 117, 18): lucerna a volute. Lungh. complessiva 10.5; lungh. becco 3.6; diam. vasca 5.4; alt. 3.2. Impasto duro, compatto, frattura regolare, privo di inclusi. Superficie liscia. Realizzata a stampo. Ricomposta da vari frammenti. Tipo M.C.1. n. 5 (Tav. 118, 19): balsamario ceramico piriforme. Diam. orlo 2.2; alt. 9.5. Impasto duro, compatto, frattura regolare, privo di inclusi. Superficie polverosa. Realizzato al tornio. Mancante di piccola porzione del labbro. Tipo N.130.7, varietà b. n. 6 (Tav. 118, 20): balsamario ceramico piriforme. Diam. orlo 2.2; alt. max. cons. 9. Impasto duro, compatto, frattura regolare, privo di inclusi. Superficie polverosa; si conserva una fascia sovradipinta in nero sul collo. Realizzato al tornio. Mancante del labbro. Tipo N.130.7, varietà b.
n. 8 (Tav. 118, 22): chiave in ferro a verga ricurva. Lungh. 10.5; diam. verga 0.6. Superficie corrosa e ossidata. Integra.
n. 3 (Tav. 117, 17): bicchiere troncoconico in ceramica comune. Diam. orlo m 9, alt. 8.5. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con frequenti inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 5YR 6/6. Superficie polverosa.
Tomba 310 (Campagna 2009; Tavv. 105A, 108). 332
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
frequenti inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa. Realizzato al tornio. Mancante di parte dell’orlo. Tipo I.300.5.
Sepoltura a incinerazione realizzata in un taglio di forma pressoché circolare, con una lieve espansione a sud-ovest (lungh. 70; largh. 65; prof. 24), localizzata nella porzione centrale del saggio di scavo, a ovest del limite del saggio 2007/2008. I resti combusti del defunto sono contenuti in un’olletta in ceramica comune chiusa da un coperchio (nn. 1-2), al cui interno è deposta una lucerna (n. 6). Al suo esterno si rinviene il corredo. Dati antropologici. L’incinerato era un individuo adulto, di cui l’avanzato stato di combustione e pessimo grado di conservazione non permettono di approfondire il profilo biologico. I reperti presentano la colorazione variabile indicativa di una incinerazione non uniforme: alcuni di colore bianco, le vertebre di colore scuro e in particolare l’osso sacro di colore nero. I dati metrici relativi al capitello radiale (20.16 mm) farebbero propendere per una determinazione del sesso maschile, tuttavia anche in questo caso è necessaria la massima prudenza nell’analisi dei resti umani a causa dell’effetto di deformazione e riduzione dimensionale dovuto all’azione del fuoco. Sempre da questo contesto provengono schegge di ossa non combuste e una mandibola di individuo adulto forse femminile. In totale il peso dei resti umani incinerati risulta di 1995.5 gr. Dati archeologici. Nella terra di riempimento del pozzetto si rinvengono un’olletta in ceramica comune (n. 3), frammenti di un’olletta simile (n. 4) e di una lagynos in ceramica comune (n. 5); frammenti non diagnostici di un’altra lucerna e frammenti di un balsamario (n. 7) e di una coppa in vetro, fusi dall’esposizione al calore. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. I secolo d.C.
n. 3 (Tav. 118, 3): olletta piriforme in ceramica comune. Diam. orlo 11; alt. 11. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con frequenti inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Mancante di parte del labbro e del ventre. Tipo I.50.B.15, varietà a. n. 4 (Tav. 118, 4): olletta in ceramica comune. Diam. orlo 6.1; alt. max. cons. 3.7. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con frequenti inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Si conserva solo parte del labbro e del ventre. Tipo non puntualizzabile. n. 5 (Tav. 118, 5): lagynos in ceramica comune. Diam. orlo 3; alt. max. cons. 7.5. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minuti dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Realizzata al tornio. Si conserva il collo e parte della spalla. Tipo non puntualizzabile. n. 6 (Tav. 118, 6 e dettaglio): lucerna a volute. Lungh. complessiva 11.7; lungh. becco 1.2; diam. disco 10.5; alt. 4.2. Impasto duro, compatto, frattura netta, privo di inclusi. Superficie liscia. Il disco è decorato con scena mitologica della lotta tra Ercole e Nesso. Realizzata a stampo. Lacunosa di parte della vasca. Si ascrive al gruppo delle lucerne a volute (M.C). n. 7 (Tav. 118, 7): balsamario in vetro. Diam. orlo 1; alt. max. cons. 4.6. Risulta fuso dal calore. Colore blu. Tipo non puntualizzabile.
n. 1 (Tav. 118, 2): olla ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 20; alt. 24.4. Impasto duro, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Integra. Tipo I.40.7.
Tomba 311 (Campagna 2009; Tavv. 105B, 108). Sepoltura a incinerazione realizzata in un taglio di forma pressoché ovale, orientato in senso nord-ovest/sud-est (lungh. 50; largh. 30; prof. 22), localizzata nella porzione settentrionale del saggio di scavo, a ovest del limite del Saggio D del 2003. Taglia la tomba 321 (vedi, 340). I
n. 2 (Tav. 118, 1): coperchio in ceramica comune. Diam. orlo 16.5; alt. max. cons. 5.5. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con 333
Capestrano, I
Dati antropologici. I resti dell’individuo della tomba in esame non risultano presenti in deposito quindi non disponibili all’analisi. Dati archeologici. Il corredo risulta assente. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Fine I secolo a.C.inizi I secolo d.C.
resti combusti del defunto sono contenuti in un’olletta in ceramica comune chiusa da un coperchio (nn. 1-2), all’esterno della quale si rinviene il corredo. Dati antropologici. I resti dell’individuo della tomba in esame non risultano presenti in deposito quindi non disponibili all’analisi. Dati archeologici. Nella terra di riempimento del pozzetto si rinvengono un’olletta in ceramica comune (n. 3) e frammenti di un chiodo in ferro. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. I secolo d.C.
n. 1 (Tav. 118, 12): olletta globulare in ceramica comune. Diam. orlo 18.5; alt. 26. Impasto duro, poroso con frequenti vacuoli distribuiti in maniera omogenea; frattura regolare; con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Ricomposta da vari frammenti. Tipo I.50.A.6, varietà b.
n. 1 (Tav. 118, 9): olletta tronco-ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 15.5; alt. 19. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Mancante del labbro in più punti. Tipo I.50.A.5. n. 2 (Tav. 118, 8): coperchio in ceramica comune. Diam. orlo 14.2; alt. 5.8. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con frequenti inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa. Realizzato al tornio. Mancante di parte dell’orlo. Tipo I.300.3. n. 3 (Tav. 118, 10): olletta ovoide in ceramica comune, frammentaria. Diam. orlo 8; alt. 10. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con frequenti inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera disomogenea. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Mancante di parte del labbro e del ventre. Tipo I.50.B.9, varietà d. Tomba 312 (Campagna 2009; Tavv. 105A, 108). Sepoltura a incinerazione realizzata in un taglio di forma rettangolare, con margini irregolari e orientato in senso nord-est/sud-ovest (lungh. 75; largh. 60; prof. 40), localizzata nella porzione centrale del saggio di scavo, a ovest del limite del saggio 2007/2008. I resti combusti del defunto sono contenuti in un’olla in ceramica comune chiusa da un coperchio (nn. 1-2).
334
n. 2 (Tav. 118, 11): coperchio in ceramica comune. Diam. orlo 17; alt. 4.5. Impasto duro, poroso con frequenti vacuoli distribuiti in maniera omogenea; frattura regolare; con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie liscia. Realizzato al tornio. Lacunoso di parte del labbro. Tipo I.300.3. Tomba 313 (Campagna 2009; Tavv. 105A,106). Sepoltura a inumazione in fossa di forma pressoché quadrangolare (le misure specificate nella scheda di scavo – lungh. 103; largh. 101; prof. 29 – non corrispondo alla documentazione planimetrica della sepoltura, pertanto nella Tav. 106 si indica genericamente la posizione), localizzata nella porzione centrale del saggio di scavo, a ovest del limite del saggio 2007/2008. Taglia la tomba 291 (vedi, 321-322). La deposizione si rinviene in pessimo stato di conservazione, con i soli femori allineati. Dati antropologici. I resti umani, molto frammentari, appartengono a un subadulto di circa 1-2 anni. Si conservano la mandibola ed alcuni elementi dentari decidui e permanenti corrispondenti a una età di circa 2 anni ± 8 mesi. La presenza di alcune ossa degli arti permette ulteriori misure di lunghezza utili alla stima dell’età che si può confermare intorno a un anno e mezzo. Dati archeologici. Sulla base dei dati di scavo, il corredo è composto da quattro balsamari ceramici, di cui si conservano in magazzino solo due esemplari (nn. 2-3). A questi si
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
Inquadramento cronologico. Fine I secolo a.C.inizi I secolo d.C.
aggiunge, non registrata in corso di scavo, un piatto a vernice nera (n. 1). Le dimensioni della fossa confermano l’età infantile del defunto. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Età augustea.
n. 1 (Tav. 119, 2): olla ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 18.5; alt. 26.5. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Mancante di parte del labbro. Tipo I.40.8.
n. 1 (Tav. 118, 13): piatto con vasca carenata a vernice nera. Diam. orlo 15; alt. 3.1. Impasto duro, compatto, frattura netta, privo di inclusi; colore: Munsell 7.5YR 8/3. Vernice opaca ed evanide; colore interno: 5YR 4/1; colore esterno: Munsell 7.5YR 3/2. Realizzato al tornio. Ricomposto da vari frammenti. Tipo H.290.E.1.
n. 2 (Tav. 119, 1): coperchio troncoconico a profilo continuo in ceramica comune. Diam. pomello 3.1; alt. max. cons. 4.5. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa. Realizzato al tornio. Si conserva il pomello e parte della parete. Tipo I.300.4.
n. 2 (Tav. 118, 14): balsamario ceramico piriforme. Diam. orlo 2.4; alt. 10.1. Impasto duro, compatto, privo di inclusi; colore: Munsell 5YR 7/6. Superficie ruvida; si conserva una fascia dipinta sul collo con colatura sul ventre; colore: Munsell 7R 4/6. Realizzato al tornio. Integro. Tipo N.130.7, varietà b.
n. 3 (Tav. 119, 3): frammento di vasca di lucerna. Lungh. max. cons. 3.3; alt. max. cons. 1.1. Impasto duro, compatto, frattura netta, privo di inclusi. Superficie polverosa. Realizzata a stampo. Si conserva parte di una voluta. Tipo non puntualizzabile.
n. 3 (Tav. 118, 15): balsamario ceramico piriforme. Diam. orlo 1; alt. 5.1. Impasto duro, compatto, privo di inclusi; colore: Munsell 5YR 7/6. Superficie ruvida; si conserva una fascia dipinta sul collo con colatura sul ventre; colore: Munsell 7R 4/6. Realizzato al tornio. Integro. Tipo N.130.7, varietà a
n. 4 (tav. 119, 4): balsamario in vetro. Diam. orlo 0.7; alt. 3.8. Colore blu. Integro. Tipo P.130.1. n. 5 (Tav. 119, 5): grappa in ferro. Lungh. 10.2; spessore verga 0.4. Superficie corrosa e ossidata. Presenta la punta lievemente piegata. Tipo Q.120.1.
Tomba 314 (Campagna 2009; Tavv. 105A, 110). Sepoltura a incinerazione realizzata in un taglio di forma ovale, orientato in senso nord-est/sudovest (lungh. 110; largh. 60; prof. 40), localizzata nella porzione centrale del saggio di scavo, a ovest del limite del saggio 2007/2008. I resti combusti del defunto sono contenuti in un’olla in ceramica comune chiusa da un coperchio (nn. 1-2), all’esterno della quale si rinviene il corredo. Dati antropologici. I resti dell’individuo della tomba in esame non risultano presenti in deposito quindi non disponibili all’analisi. Dati archeologici. Il corredo si compone di un frammento di lucerna (n. 3); tre balsamari in vetro, di cui due completamente fusi (n. 4) e tre grappe in ferro (nn. 5-7). Il sesso archeologico non è determinabile.
n. 6 (Tav. 119, 6): grappa in ferro. Lungh. 4.2; spessore verga 0.2. Superficie corrosa e ossidata. Presenta la punta piegata a comporre un angolo retto. Tipo Q.120.1. n. 7 (Tav. 119, 7): grappa in ferro. Lungh. 4.1; spessore verga 0.3. Superficie corrosa e ossidata. Presenta la testa e la punta piegata a comporre un angolo retto. Tipo Q.120.1. Tomba 315 (Campagna 2009; Tav. 105B, pianta di dettaglio della tomba non realizzata in corso di scavo). Sepoltura a inumazione in fossa di forma rettangolare, orientata in senso est/ovest (lungh. 335
Capestrano, I
mm) e destra (318 mm) e risulta di 153.5 cm. Dati archeologici. Si recuperano dal riempimento della fossa un’olletta in ceramica a pareti sottili (n. 2) e cinque aghi crinali in osso (nn. 3-7); a questi si aggiungono, non registrati nella documentazione di scavo ma presenti in magazzino, un frammento di coppa in ceramica sigillata italica (n. 1), un chiodo in ferro (n. 8) e una laminetta in bronzo forata alle due estremità (n. 9), oltre a numerosi frammenti di forme chiuse in ceramica comune. Risulta invece mancante uno spillo in bronzo recuperato in corso di scavo. Sulla base della presenza degli aghi crinali è possibile che il sesso archeologico sia identificabile come femminile. Inquadramento cronologico. I secolo d.C.
156; largh. 66; prof. 40), localizzata nella porzione settentrionale del saggio di scavo, a ovest del limite del Saggio D del 2003. È tagliata dalla fossa numerata come tomba 317 (vedi, 337-338). Dati antropologici. L’inumato è un adulto femminile di circa 45 anni di età il cui scheletro è integralmente conservato e include cranio, coste e vertebre, arti superiori e inferiori. La morfologia dell’ileo e del cranio è femminile, infatti il margine sovraorbitario è affilato, il frontale verticale, il processo mastoideo piccolo, la cresta nucale assente. L’età alla morte è stabilita a partire dall’aspetto della sinfisi pubica corrispondente a una età di 48.1 (range 25-83). L’avanzata età è confermata anche dal grado di ossificazione delle suture ectocraniche coronale, sagittale e lambdoidea corrispondenti a età di 48.8 anni (35-60 anni). Inoltre molti elementi dentari risultano persi in vita come dimostra il completo riassorbimento antemortem degli alveoli dei molari sul lato destro e sinistro della mandibola. Le misure del caput omerale destro (48.6 mm) e femorale sinistro (52.8 mm) rientrano nella variabilità maschile. Una anomalia si rileva nella colonna vertebrale, ben conservata, in particolare presso la quarta vertebra toracica (T4) che presenta un volume del corpo vertebrale minore e compresso (visione superiore e inferiore, vedi fig.antr.online 315_01A,B,C). Tale paleopatologia è circoscritta a questo elemento vertebrale e nessun’altra anomalia è rilevata nella colonna vertebrale. Le superfici del corpo vertebrale non presentano anomalie. L’andamento della compressione ha inclinazione laterale che deve aver causato una lieve cifosi in quel tratto. Da queste caratteristiche non è possibile procedere con precisione a una diagnosi, tuttavia è probabile che si tratti di una malformazione genetica, forse una lieve ipoplasia laterale congenita della colonna vertebrale. Per quanto riguarda la dentatura, una marcata apposizione di tartaro è osservabile sul canino sinistro mandibolare e l’incisivo mandibolare mostra una usura labiale (fig.antr.online 315_02A,B). La statura può essere calcolata a partire dalla lunghezza massima della tibia sinistra (317
n. 1 (Tav. 119, 8): frammento di labbro di piatto troncoconico in ceramica sigillata italica. Diam. 17.8; alt. max. cons. 2.2. Impasto durissimo, compatto, frattura netta, privo di inclusi; colore: Munsell 10R 7/6. Superficie liscia con ingobbio compatto e lucente; colore ingobbio: Munsell 7.5R 4/6. Si conserva una decorazione zoomorfa a stampo (un delfino). Realizzata al tornio. Tipo K.290.4. n. 2 (Tav. 119, 9): olletta ovoide in ceramica a pareti sottili. Diam. orlo 8.5; alt. 12. Impasto molto duro, compatto, frattura irregolare, con rari inclusi di dimensioni minute distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 5YR 5/1. Superficie ruvida. Realizzata al tornio. Ricomposta da vari frammenti. Tipo L.50.1. n. 3 (Tav. 119, 10): ago in osso. Lungh. max. cons. 15.3; largh, 0.7; spessore 0.3. Mancante dell’estremità superiore. Tipo Q.40.1. n. 4 (Tav. 119, 11): ago in osso. Lungh. max. cons. 5.5; largh, 0.7; spessore 0.3. Mancante dell’estremità superiore e inferiore. Tipo Q.40.1. n. 5 (Tav. 119, 12): ago in osso. Lungh. max. cons. 15.6; largh, 0.7; spessore 0.3. Mancante dell’estremità superiore. Tipo Q.40.1. n. 6 (Tav. 119, 13): ago in osso. Lungh. max. cons. 8.5; largh, 0.7; spessore 0.3. Mancante dell’estremità superiore e inferiore. Tipo Q.40.1.
336
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
n. 3 (Tav. 119, 19): coperchio in ceramica comune. Diam. pomello 4.6; alt. max. cons. 5.4. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa. Realizzato al tornio. Si conserva il pomello e parte della parete. Tipo non puntualizzabile.
n. 7 (Tav. 119, 14): ago in osso. Lungh. max. cons. 3.2; largh, 0.7; spessore 0.3. Si conserva solo l’estremità superiore. Tipo Q.40.1. n. 8 (Tav. 119, 15): chiodo in ferro. Lungh. 9; diam. testa 1.7. Superficie corrosa e ossidata. Integro. Tipo Q.110.1.
Tomba 317 (Campagna 2009; Tav. 105B, pianta di dettaglio della tomba non realizzata in corso di scavo). Sepoltura a incinerazione realizzata in un taglio di forma circolare di forma rettangolare (lungh. 60; largh. 53) localizzata nella porzione settentrionale del saggio di scavo, a ovest del limite del Saggio D del 2003. Il suo impianto disturba la tomba 315 (vedi, 336-337). La documentazione di scavo non registra la presenza di un’urna cineraria all’interno della fossa, anche se nel suo riempimento si rinvengono resti antropologici. Dati antropologici. Di questo incinerato non si conservano che un frammento di osso occipitale del cranio e alcune schegge combuste di un individuo adulto il cui peso totale risulta di 287.2 gr. Dati archeologici. Nel riempimento si rinvengono frammenti di ceramica comune (fra cui, n. 1), di ceramica sigillata italica (tra cui, n. 2), di ceramica a pareti sottili (fra cui, n. 3) e di balsamari (fra cui, n. 4). Il sesso archeologico non è determinabile Inquadramento cronologico. I secolo d.C.
n. 9 (Tav. 119, 16): laminetta in bronzo di forma rettangolare, con due fori passanti alle estremità. Lungh. max. cons. 5; largh. 2; spessore 0.2. Patina verde sulla superficie. Mancante di una breve porzione. Tomba 316 (Campagna 2009; Tavv. 105B, 110). Sepoltura a incinerazione realizzata in un taglio di forma circolare (diam. 40; prof. 32), localizzata nella porzione settentrionale del saggio di scavo, a ovest del limite del Saggio D del 2003. Taglia a sud la tomba 319 e a nord la 321 (vedi, 338-340). I resti combusti del defunto sono contenuti all’interno di un’olla in ceramica comune chiusa da un coperchio (nn. 1-2) e contenente a sua volta un frammento di un altro coperchio (n. 3). Dati antropologici. I resti dell’individuo della tomba in esame non risultano presenti in deposito quindi non disponibili all’analisi. Dati archeologici. Il corredo risulta assente. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Fine I secolo a.C.inizi I secolo d.C.
n. 1 (Tav. 119, 20): olletta ovoide/piriforme in ceramica comune. Diam. orlo 9.4; alt. max. cons. 2.5. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10R 5/6. Superficie polverosa, con aloni di cottura. Realizzata al tornio. Si conserva parte del labbro e della spalla. Tipo I.50.B.15.
n. 1 (Tav. 119, 18): olletta ovoide/globulare in ceramica comune. Diam. orlo 18.5; alt. 26. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Lacunosa in corrispondenza del collo e del ventre. Tipo I.50.A.13. n. 2 (Tav. 119, 17): coperchio in ceramica comune. Diam. pomello 3.7; alt. max. cons. 4.6. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa. Realizzato al tornio. Si conserva il pomello e parte della parete. Tipo non puntualizzabile.
n. 2 (Tav. 119, 21): coppetta troncoconica in ceramica sigillata italica. Diam. orlo 8.8; alt. max. cons. 2.3. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, privo di inclusi; colore: Munsell 10R 7/6. Superficie con ingobbio coprente e lucente; colore ingobbio: Munsell 7.5R 4/6. Realizzata
337
Capestrano, I
n. 2 (Tav. 119, 25): balsamario piriforme in vetro. Diam. orlo 1.05; alt. 5.1. Colore: blu. Integro. Tipo P.130.7.
al tornio. Si conserva solo parte del labbro. Tipo K.260.2. n. 3 (Tav. 119, 22): coppetta globulare in ceramica a pareti sottili. Diam. orlo 10.8; alt. max. ric. 3.6. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, privo di inclusi; colore: Munsell 10R 5/8. Superficie ruvida. Realizzata a mano. Si conserva parte dell’orlo e della vasca. Tipo L.260.3.
Tomba 319 (Campagna 2009; Tavv. 105B, 110). Sepoltura a inumazione in fossa di forma irregolare, orientata in senso nord-sud (lungh. max. cons. 90; largh. max. cons. 40; prof. 33), localizzata nella porzione settentrionale del saggio di scavo, a ovest del limite del Saggio D del 2003. È tagliata a nord dalla tomba 316, taglia a ovest la tomba 327 (vedi, 337, 342) e si presenta estremamente disturbata. Si rinvengono nel suo riempimento solo scarsi frammenti scheletrici e del corredo. Dati antropologici. In questo contesto tombale i resti umani raccolti appartengono ad un subadulto di circa 1-2 anni. Nonostante la pessima conservazione, la stima dell’età è valutata a partire dal grado di sviluppo dentario e dalla misura della clavicola (circa 62.4 mm) corrispondenti ad una età di un anno e mezzo. La sutura metopica del cranio risulta ancora aperta, per cui questo bambino doveva avere una età minore di due anni. Dati archeologici. Nel riempimento della fossa si rinvengono un’olletta in ceramica comune frammentaria (n. 1), un frammento di lagynos in ceramica comune (n. 2) e un peso in impasto (da rete? n. 3). Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Prima età imperiale.
n. 4 (Tav. 119, 23): balsamario ceramico. Diam. fondo 2.6; alt. max. ric. 2. Impasto duro, compatto, frattura netta, privo di inclusi; colore: Munsell 10R 7/6. Superficie ruvida. Realizzato al tornio. Mancante del collo e di parte del ventre. Tipo non puntualizzabile. Tomba 318 (Campagna 2009; Tavv. 105B, 110). Sepoltura a incinerazione realizzata in un taglio di forma pressoché circolare (diam. 40-45; prof. 25), localizzata nella porzione settentrionale del saggio di scavo, a ovest del limite del Saggio D del 2003. Taglia la tomba 321 (vedi, 340). I resti combusti del defunto sono contenuti all’interno di un’olla in ceramica comune mancante del collo e del labbro (n. 1), all’esterno della quale si rinvengono i resti del corredo. Dati antropologici. I resti dell’individuo della tomba in esame non risultano presenti in deposito quindi non disponibili all’analisi. Dati archeologici. Nel riempimento del pozzetto si rinvengono un balsamario in vetro (n. 2) e un altro esemplare fuso. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Prima età imperiale.
n. 1 (Tav. 119, 26): olletta ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 12; alt. max. cons. 4.6. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 4/6. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Si conserva solo parte del labbro e della spalla. Tipo I.50.B.9, varietà f.
n. 1 (Tav. 119, 24): olla in ceramica comune. Diam. fondo 8.5; alt. max. cons. 23.5. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Mancante del labbro del collo e di parte della spalla. Tipo non puntualizzabile.
n. 2 (Tav. 119, 27): frammento di collo di lagynos in ceramica comune. Diam. orlo 4; alt. max. cons. 7. Impasto duro, compatto, frattura netta, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 8/2. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Tipo non puntualizzabile.
338
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
clavicola destra di dimensioni accorciate e andamento dell’asse della diafisi anomalo. La diafisi mostra un andamento deviato e un inspessimento localizzato presso il terzo distale clavicolare (fig.antr.online 320_02A,B). La forma e la tipologia di proliferazione ossea sono compatibili con un callo osseo, cioè rimodellamento in seguito ad una frattura scomposta, in questo caso, dell’epifisi distale di tipologia semplice che ha comportato una divisione in due parti dell’osso. In ogni caso la formazione del callo osseo ben avanzato e senza segni di attività in corso indica una sopravvivenza alla lesione di alcuni anni. L’esito è un accorciamento, che in questo caso non è quantificabile in quanto il contro laterale è assente, altrettanto non valutabile il cambiamento angolare. Le cause più comuni della frattura della clavicola includono caduta su una spalla, trauma diretto, sovraccarico monolaterale. Su un osso navicolare del piede sinistro è osservabile una anomalia al margine dell’articolazione di tipo proliferativo e compatibile con osteoartrosi (fig.antr.online 320_03A,B). I reperti faunistici in sintesi attestano la presenza nel contesto di: equide, suino, carnivoro, ovicaprino nel Q1; avifauna, suino, equide nel Q2; suino, carnivoro nel Q3. Dati archeologici. Nella camera si rinvengono i frammenti del rivestimento in osso di un letto funerario; uno strigile in ferro; due balsamari in vetro; una lagynos in ceramica depurata; due monete di bronzo; il fondo di un vaso polipode in ceramica comune e una scodella in ceramica depurata, oltre a un chiodo in ferro. Per la schedatura di dettaglio del corredo di questa tomba, vedi il II Volume di questo lavoro. Inquadramento cronologico. Prima età imperiale. Tomba 321 (Campagna 2009; Tav. 105B, pianta di dettaglio della tomba non realizzata in corso di scavo). Sepoltura a inumazione in fossa di forma rettangolare, orientata in senso nord-est/sudovest (lungh. max. cons. 63; largh. 63; prof. 35), localizzata nella porzione settentrionale del saggio di scavo, a ridosso del limite del Saggio D del 2003. La sepoltura è profondamente
n. 3 (Tav. 119, 28): peso discoidale in impasto (da rete?). Diam. 4.5; spessore 1.1. Impasto duro, compatto, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 2.5/2. Superficie liscia. Realizzato a mano. Integro. Tipo Q.25.1. Tomba 320 (Campagna 2009; Tavv. 105A, 111). Tomba a camera costruita di forma quadrangolare, orientata in senso nordovest/sud-est (lungh. 390; largh. 403; alt. max. cons. 62), localizzata nella porzione centrale del saggio di scavo, a ovest del limite del saggio 2007/2008; a contatto direttamente a nord con la tomba a camera 304 (vedi, 329-330). Le murature sono composte da spezzoni irregolari di calcare di medie e grandi dimensioni, legati da una malta di colore biancastro e probabilmente in origine rivestite all’interno di uno strato di intonaco bianco, rinvenuto nel riempimento della camera. Il piano pavimentale interno è realizzato in malta. All’esterno della soglia, inquadrata da blocchi parallelepipedi sovrapposti, si rinviene parte dell’architrave d’accesso. Dati antropologici. All’interno della tomba sono stati raccolti abbonanti materiali antropologici e archeozoologici. Per quanto riguarda gli individui deposti, dal calcolo del numero minimo, risultano presenti almeno 5 adulti e 3 subadulti (1 feto, 1 bambino di 1.5 mesi, 1 bambino di 6 mesi). Dall’analisi delle porzioni di mandibola conservate risultano presenti: un maschile di oltre 45 anni, un adulto indeterminabile, uno femminile di oltre 45 anni, uno femminile di 35-45 anni. Nello sporadico: un altro adulto maschile di 35-45 anni. Tra gli inumati vi sono certamente almeno tre subadulti che, per quanto di età molto ravvicinate, è possibile distinguere grazie al differente grado di sviluppo dentario e maturazione scheletrica. In particolare tre femori destri di subadulto misurano una lunghezza massima di 78.4 mm, 92.55 mm, 115 mm (fig.antr.online 320_01). A causa della conservazione non individuale degli scheletri, non è possibile raccogliere ulteriori informazioni. Si segnala tra le ossa postcraniali degli adulti, la presenza di una 339
Capestrano, I
frammenti di vertebre e una porzione di condilo di mandibola destra, l’incinerato era un individuo adulto. In totale i resti umani incinerati pesano 1203.52 gr. Dati archeologici. All’interno del cinerario si rinvengono due balsamari in vetro (nn. 3-4) e un bicchiere miniaturistico in vetro con un coperchio in sfoglia d’argento e oro (n. 5). Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. I secolo d.C.
disturbata dalle più recenti tombe 311, 316 e 318 (vedi, 334, 337-338). Dati antropologici. L’inumato è un subadulto di età all’incirca 1.5 anni. La sutura metopale non è ancora chiusa, ma i denti decidui sono tutti erotti. La pars basilaris presenta le seguenti misure: L 23.06 mm, W 26.48 mm e S15.54 mm. Lo scheletro postcraniale è ben conservato e include gli arti superiori e inferiori, tra cui è misurabile la lunghezza massima dell’ulna destra (100.84 mm) e delle tibie (destra 126.4 mm e sinistra 126.5 mm). L’arco vertebrale si presenta ben ossificato sia nelle vertebre toraciche che lombari. Dati archeologici. La scheda di scavo registra il rinvenimento nel riempimento della fossa di una lagynos, un poculum e una coppa in ceramica comune; una lucerna; sette aghi in osso; una testina in osso con rivestimento in oro e vari frammenti ceramici pertinenti a un poculum, un’olletta, un coperchio in ceramica comune. La sepoltura risulta al momento in corso di restauro presso il laboratorio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo e non è stato possibile effettuare la documentazione di dettaglio dei materiali. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. La sepoltura sembra ascrivibile al periodo ellenistico avanzato, comunque anteriore all’impianto della tomba 311.
n. 1 (Tav. 120, 1): olla in ceramica comune. Diam. orlo 16; alt. 25.2. l. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con frequenti inclusi di minute e piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Si ricompone da vari frammenti; lacunosa di parte del labbro. Tipo I.50.A.10. n. 2 (Tav. 120, 2): piatto in ceramica sigillata italica. Diam. piede 9.5; alt. max. cons. 2.4. Impasto molto duro, compatto, privo di inclusi. Superficie rivestita di ingobbio coprente e lucente. Sul fondo della vasca, in planta pedis è impresso un bollo poco leggibile. Lacunoso del labbro. Tipo non puntualizzabile. n. 3 (Tav. 120, 3): balsamario piriforme in vetro. Diam. orlo 2.1; alt. 8.7. Colore: azzurro. Integro. Tipo P.130.5. n. 4 (Tav. 120, 4): balsamario piriforme in vetro. Diam. orlo 2.2; alt. 7.3. Colore: azzurro. Integro. Tipo P.130.4.
Tomba 322 (Campagna 2009; Tavv. 105A, 110). Sepoltura a incinerazione realizzata in un taglio di forma pressoché circolare (diam. 40-44; prof. 22), localizzata nella porzione centrale del saggio di scavo, a ovest del limite del saggio 2007/2008. I resti combusti del defunto sono contenuti all’interno di un’olletta in ceramica comune chiusa da un piatto in ceramica sigillata italica (nn. 1-2). Dati antropologici. I resti antropologici conservati provengono dallo svuotamento dell’urna cineraria che li conteneva. Di conseguenza non sono ricavabili utili informazioni riguardo l’ossilegio, e oltretutto lo stato di conservazione è pessimo. Molto probabilmente, come segnalerebbe la presenza di una porzione prossimale di femore,
n. 5 (Tav. 120, 6): bicchiere troncoconico in vetro. Diam. orlo 3.3; alt. max. cons. 3.7. Colore bianco, opaco. Mancante del labbro. Tipo non puntualizzabile. n. 6 (Tav. 120, 5 e dettaglio della decorazione): coperchio conico in lamina aurea (pertinente al n. 5). Diam. max. cons. 3.6; alt. max. conservata dei due frammenti 2.3, 3.9. Decorato a sbalzo con motivi vegetali e (probabilmente) due ali. Manca di parte della presa e del labbro. Tomba 323 (Campagna 2009; Tav. 105A, pianta di dettaglio della tomba non realizzata in corso di scavo). 340
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
Dati archeologici. Del ripostiglio si conserva solo un frammento di fondo di un’olla in impasto (n. 1). Inquadramento cronologico. Età arcaica (?).
Sepoltura a incinerazione realizzata in un taglio di forma ovale, orientato in senso nord-sud (lungh. 62; largh. 37; prof. 11), localizzata nella porzione centrale del saggio di scavo, a ovest del limite del saggio 2007/2008. La sepoltura risulta completamente sconvolta da interventi post-deposizionali di età antica e moderna. Dati antropologici. Da questo contesto tombale provengono solo alcuni piccoli frammenti di schegge ossee non determinabili. Inquadramento cronologico. Prima età imperiale.
n. 1 (Tav. 120, 7): fondo piano di olla troncoconica in impasto. Diam. fondo 27; alt. max. cons. 33.6. Impasto tenero, poroso con frequenti vacuoli distribuiti in maniera disomogenea, frattura frastagliata, con frequenti inclusi di piccole e medie dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 2.5 YR 3/4. Superficie liscia. Realizzata a mano. Ricomposto da vari frammenti. Tipo non puntualizzabile.
Tomba 324 (Campagna 2009; Tav. 105A, pianta di dettaglio della tomba non realizzata in corso di scavo). Sepoltura a incinerazione realizzata in un taglio di forma pressoché circolare (diam. 55; prof. 13), localizzata nella porzione centrale del saggio di scavo, a ovest del limite del saggio 2007/2008. La sepoltura risulta completamente sconvolta da interventi post-deposizionali di età antica e moderna. Dati antropologici. I resti dell’individuo della tomba in esame non risultano presenti in deposito quindi non disponibili all’analisi. Inquadramento cronologico. Prima età imperiale.
Si numera in corso di scavo come tomba 326 (Tav. 105B, pianta di dettaglio della tomba non realizzata in corso di scavo) una fossa di forma pressoché circolare (diam. 40; prof. 24), localizzata nella porzione settentrionale del saggio, a ridosso del limite del Saggio D del 2003, al cui interno sono rinvenuti numerosi frammenti ceramici (tra cui, diagnostici, i nn. 16). Si tratta probabilmente di un accumulo formatosi a seguito di una pulizia dei resti di tombe sconvolte (vedi anche la n. 332, 344345). Dati antropologici. Il contesto risulta privo di resti antropologici. Inquadramento cronologico. I secolo d.C.
Tomba 325 (Campagna 2009; Tavv. 105A, 110). Sepoltura a inumazione in fossa di forma rettangolare, orientata in senso sud-est/nordovest (lungh. 90; largh. 255; prof. 45), localizzata nella porzione centrale del saggio di scavo, a ovest del limite del saggio 2007/2008. La sepoltura risulta estremamente disturbata da interventi post-deposizionali di età antica e moderna, che hanno determinato l’asporto di gran parte dei resti scheletrici, del corredo, intaccando parzialmente anche il ripostiglio, originariamente deposto presso il lato sudoccidentale della fossa. Dati antropologici. Di questo inumato non restano che pochi frammenti di diafisi di femore e ossa postcraniali non determinabili, appartenenti a un individuo adulto. Si segnala la presenza di una diafisi di femore di subadulto di un neonato di età di 2-3 mesi circa.
n. 1 (Tav. 120, 8): olletta ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 12; alt. max. cons. 5.5. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10YR 4/1. Superficie ruvida. Realizzata al tornio. Si conserva parte del labbro e del ventre. Tipo I.50.B.9, varietà b. n. 2 (Tav. 120, 9): olletta in ceramica comune. Diam. orlo 12; alt. max. cons. 5.6. Impasto duro, compatto, frattura netta, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10YR 4/1. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Si conserva parte del labbro. Tipo I.50.B.9, varietà b.
341
Capestrano, I
n. 3 (Tav. 120, 10): poculum in ceramica comune. Diam. orlo 10; alt. max. cons. 3.6. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10YR 4/3. Superficie ruvida. Realizzata al tornio. Si conserva parte del labbro e del ventre. Tipo non puntualizzabile. n. 4 (Tav. 120, 11): coperchio troncoconico in ceramica comune. Diam. orlo 19; alt. max. cons. 4.7. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con abbondanti inclusi di piccole e medie dimensioni distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 10R 5/6. Superficie polverosa. Realizzato al tornio. Si conserva parte del labbro e della tesa. Tipo non puntualizzabile. n. 5 (Tav. 120, 12): coperchio troncoconico in ceramica comune. Diam. orlo 18; alt. max. cons. 1.6. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con abbondanti inclusi di piccole e medie dimensioni distribuiti in maniera disomogenea; colore: Munsell 10R 5/6. Superficie polverosa. Realizzato al tornio. Si conserva parte del labbro e della tesa. Tipo non puntualizzabile.
Dati antropologici. La sepoltura risulta priva di resti antropologici. Dati archeologici. Nel riempimento della fossa si rinvengono un frammento di lagynos in ceramica comune (n. 1), una lucerna (n. 2) e quattro chiodi in ferro (n. 3), insieme a numerosi frammenti non diagnostici in ceramica comune e a vernice nera. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. I secolo d.C. n. 1 (Tav. 120, 14): lagynos in ceramica comune. Diam. orlo 3.5; alt. max. cons. 7.6. Impasto duro, compatto, frattura netta, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10R 4/2. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Si conserva solo il collo e l’ansa. Tipo non puntualizzabile. n. 2 (Tav. 120, 15): lucerna (a disco?). Lungh. max. cons. 9.5; diam. vasca 7.8; alt. max. cons. 2.7. Impasto duro, compatto, frattura netta, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 5/2. Superficie ruvida. Realizzata a stampo. Lacunosa del fondo. Tipo non puntualizzabile. n. 3 (Tav. 120, 16): quattro chiodi in ferro. Lungh. 10-7 (esemplare piegato 7.3); diam. testa 2.8-1.8. Superficie corrosa e ossidata. Tre esemplari sono integri, di cui uno piegato; uno manca della punta. Tipo Q.110.1.
n. 6 (Tav. 120, 13 e dettaglio): lucerna (a volute?). Diam. disco 7.5. Impasto duro, compatto, frattura netta, privo di inclusi; colore: 10YR 4/2. Superficie liscia e ingobbiata; ingobbio opaco, colore: Munsell 7.5YR 5/2. Realizzata a stampo. Si conserva parte della vasca, decorata con scena gladiatoria. Tipo non puntualizzabile. Tomba 327 (Campagna 2009; Tav. 105B, pianta di dettaglio della tomba non realizzata in corso di scavo). Sepoltura a inumazione in fossa di forma rettangolare, orientata in senso est/ovest (lungh. max. cons. 130; largh. 52; prof. 41), localizzata nella porzione settentrionale del saggio di scavo, a ridosso del limite del Saggio D del 2003. È tagliata lungo il suo lato orientale dalla tomba 319 e lungo quello meridionale dal taglio denominato tomba 335 (vedi, 338-339, 346). Nella documentazione di scavo non sono registrati i dati relativi al rinvenimento di resti scheletrici o alla disposizione del corredo.
342
Tomba 328 (Campagna 2009; Tav. 105A, pianta di dettaglio della tomba non realizzata in corso di scavo). Sepoltura a incinerazione realizzata in un taglio di forma pressoché circolare (diam. 40; prof. 24), localizzata nella porzione centrale del saggio di scavo, a ovest del limite del saggio 2007/2008. Sulla base di quanto registrato nella scheda di rinvenimento, la sepoltura doveva essere profondamente disturbata al momento dello scavo, con il cinerario e il corredo asportati. Dati antropologici. I resti dell’individuo della tomba in esame non risultano presenti in deposito quindi non disponibili all’analisi. Dati archeologici. Al riempimento del pozzetto di questa tomba sono stati attribuiti un frammento di olla in ceramica comune (n. 1) e
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
un balsamario ceramico (n. 2), non segnalati in corso di scavo. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. I secolo d.C. n. 1 (Tav. Tav. 121, 1): olletta globulare in ceramica comune. Diam. orlo 19; alt. max. cons. 7.2. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10R 5/6. Superficie ruvida. Realizzata al tornio. Si conserva fino alla spalla. Tipo I.50.A.6, varietà b. n. 2 (Tav. 121, 2): balsamario ceramico piriforme. Diam. orlo 2.2; alt. 7.5. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, privo di inclusi; colore: Munsell 10R 5/4. Superficie ruvida; sul collo si conserva una banda sovradipinta di vernice opaca; colore: Munsell 7.5YR 4/1. Realizzato al tornio. Integro. Tipo N.130.7, varietà b. Tomba 329 (Campagna 2009; Tav. 105A, pianta di dettaglio della tomba non realizzata in corso di scavo). Sepoltura a incinerazione realizzata in un taglio di forma ovale (lungh. 66; largh. 40; prof. 18), localizzata nella porzione centrale del saggio di scavo, a ovest del limite del saggio 2007/2008. La sepoltura risultava pesantemente disturbata e mancava pertanto sia del cinerario che del corredo. Dati antropologici. Non sono disponibili resti umani da questo contesto. Inquadramento cronologico. Prima età imperiale.
scavo numerato come tomba 330, successivamente espunta). Essa, inoltre, taglia l’evidenza già identificata con il numero 302, che è stata interpretata come il resto del ripostiglio di un’altra sepoltura più antica (vedi, 327). L’evidenza risulta profondamente disturbata da interventi a carattere postdeposizionale di età antica e moderna, che hanno asportato i resti scheletrici, il corredo e danneggiato il ripostiglio. Dati antropologici. Alcuni frammenti di ossa lunghe di adulto e una mandibola appartengono a un individuo adulto femminile di circa 35-45 anni, in base alla morfologia del mento e all’usura dentaria. Nel medesimo contesto tombale sono stati raccolti i resti umani di un subadulto. Lo scheletro è parzialmente conservato e include elementi dentari, la parte frontale e occipitale del cranio, le diafisi degli arti inferiori e superiori, frammenti. I denti sono decidui e permanenti in formazione e corrispondono a una età di 5 anni ± 16 mesi. A questo si aggiunge la presenza tra i reperti osteologici di una vertebra di animale tagliata, macellata, sagittalmente. Dati archeologici. Del ripostiglio si conserva parte di un’olla in impasto (n. 1). Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. VI secolo a.C.
Per la tomba 330, vedi scheda successiva.
n. 1 (Tav. 121, 3): dolio in impasto grezzo. Diam. orlo 38; alt. 72. Impasto molto tenero, poroso con frequenti vacuoli distribuiti in maniera omogenea; frattura frastagliata, con abbondanti inclusi di piccole, medie e grandi dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10R 4/6. Superficie ruvida. Realizzata a mano. Ricomposta da numerosi frammenti. Tipo A.80.1.
Tomba 331 (Campagna 2009; Tav. 105A, pianta di dettaglio della tomba non realizzata in corso di scavo). Sepoltura a inumazione in fossa di forma rettangolare, orientata in senso nord-ovest/sudest (lungh. 250; largh. 140; prof. 36), localizzata nella porzione centrale del saggio di scavo, a ovest del limite del saggio 2007/2008. Presenta una nicchia scavata presso l’angolo meridionale (largh. max. 40; prof. max. 50), all’interno della quale è alloggiato il ripostiglio (e in corso di
Si numera come tomba 332 (Campagna 2009; Tav. 105A) uno strato di forma irregolare localizzato nella porzione centrale del saggio di scavo, a ovest del limite del saggio 2007/2008, che copriva le tombe a incinerazione 340 e 341 (pianta di dettaglio non realizzata in corso di scavo). Lo strato, probabilmente un livellamento intenzionale realizzato per proteggere le due sepolture (vedi, 349-350), restituisce esemplari integri e frammentari di ceramica a vernice nera, ceramica comune, 343
Capestrano, I
ceramica sigillata italica, lucerne, balsamari (nn. 1-17), a cui si aggiungono alcuni frammenti combusti di ossa lunghe, tra cui è possibile identificare una tibia di adulto. Si data intorno alla fine del I secolo a.C.-I secolo d.C. n. 1 (Tav. 122, 1): piatto con vasca troncoconica e labbro rientrante in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 17.5; alt. 4. Impasto duro, compatto, con rarissimi inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 5YR 5/6. Superficie liscia; vernice opaca, evanide, non uniforme, con tracce di colatura; colore: Munsell 7.5YR 4/1. Realizzato al tornio. Ricomposto da vari frammenti. Tipo H.290.B.5.
n. 5 (Tav. 122, 5): coperchio globulare in ceramica comune. Diam. orlo 11.5; alt. max. cons. 9. Impasto duro, poroso con rari vacuoli distribuiti in maniera omogenea, frattura frastagliata, con inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10R 5/4. Superficie ruvida. Realizzata al tornio. Ricomposta da vari frammenti. Tipo I.300.1. Agli esemplari precedenti si aggiungono numerosi frammenti pertinenti a forme chiuse in ceramica comune (ollette, lagynoi). n. 6 (Tav. 122, 6): piatto a profilo troncoconico in ceramica sigillata italica. Diam. 18; alt. 4.8. Impasto durissimo, compatto, frattura netta, privo di inclusi; colore: Munsell 10R 6/6. Superficie ingobbiata; ingobbio compatto e lucente; colore: Munsell 10R 4/6. È decorato con una testa barbuta applicata a rilievo sul labbro; sul fondo si conserva in planta pedis lo stampiglio C. Meti. Ricomposta da vari frammenti. Realizzata al tornio. Tipo K.290.3.
n. 2 (Tav. 122, 2): piatto con vasca troncoconica e labbro rientrante in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 17.2; alt. 3.5. Impasto duro, compatto, con rarissimi inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 5YR 5/6. Superficie liscia; vernice evanide, non uniforme, con tracce di colatura; colore: Munsell 7.5YR 4/1. Realizzato al tornio. Ricomposto da vari frammenti. Tipo H.290.B.5.
n. 7 (Tav. 122, 7): piatto a profilo troncoconico in ceramica sigillata italica. Diam. orlo 16.7; alt. 4. Impasto durissimo, compatto, frattura netta, privo di inclusi. Colore: Munsell 10R 6/6. Superficie ingobbiata; ingobbio compatto e lucente; colore ingobbio: Munsell 10R 4/6. Ricomposta da vari frammenti. Tipo K.290.2.
Agli esemplari precedenti si aggiungono vari frammenti pertinenti a forme aperte in ceramica a vernice nera (coppe, piatti). n. 3 (Tav. 122, 3): olletta ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 11.5; alt. max. 19. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 5/1. Superficie ruvida. Realizzata al tornio. Ricomposta da vari frammenti. Tipo I.50.B.9, varietà b.
n. 8 (Tav. 122, 8): coppa globulare in ceramica a pareti sottili. Diam. orlo 13.6; alt. max. cons. 4.8. Impasto duro, compatto, frattura netta, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10YR 4/1. Superficie ruvida. Realizzata al tornio. Ricomposta da vari frammenti. Tipo L.240.1. All’esemplare precedente si aggiungono numerosi frammenti non diagnostici di forme chiuse a pareti sottili, di cui una parete decorata a squame.
n. 4 (Tav. 122, 4): lagynos in ceramica comune. Diam. orlo 5.2; alt. max. cons. 5.5. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con frequenti inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10YR 8/3. Superficie ruvida. Realizzata al tornio. Si conserva solo il labbro, il collo e l’ansa. Tipo non puntualizzabile.
n. 9 (Tav. 122, 9): lucerna (a disco?). Lungh. max. cons. del frammento di vasca 5; diam. ric. vasca 8; lungh. max. cons. becco 2; alt. max. cons. 1.5. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con inclusi molto rari distribuiti in 344
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
n. 15 (Tav. 122, 15): balsamario ceramico piriforme. Diam. orlo 2; alt. 7.3. Impasto duro, compatto, frattura netta, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 7/3. Superficie polverosa, con fascia di vernice opaca sul collo; colore vernice: Munsell 7.5YR 4/2. Realizzato al tornio. Ricomposto da vari frammenti. Tipo N.130.7, varietà b.
maniera omogenea; colore: Munsell 10YR 4/1. Realizzata a stampo. Si conserva parte della vasca con l’ansa e parte del becco. Tipo non puntualizzabile. n. 10 (Tav. 122, 10): balsamario ceramico piriforme. Diam. orlo 3.2; alt. 12. Impasto duro, compatto, frattura netta, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 7/3. Superficie polverosa, con fascia di vernice opaca sul collo; colore vernice: Munsell 7.5YR 4/2. Realizzato al tornio. Ricomposto da vari frammenti. Tipo N.130.7, varietà b. n. 11 (Tav. 122, 11): balsamario ceramico piriforme. Diam. orlo 2.7; alt. 11.2. Impasto duro, compatto, frattura netta, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 7/3. Superficie polverosa, con fascia di vernice opaca sul collo; colore vernice: Munsell 7.5YR 4/2. Realizzato al tornio. Ricomposto da vari frammenti. Tipo N.130.7, varietà b. n. 12 (Tav. 122, 12): balsamario ceramico piriforme. Diam. fondo 2.4; alt. max. cons. 10.5. Impasto duro, compatto, frattura netta, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 7/3. Superficie polverosa, con fascia di vernice opaca sul collo; colore vernice: Munsell 7.5YR 4/2. Realizzato al tornio. Ricomposto da vari frammenti; mancante del labbro. Tipo N.130.7, varietà b. n. 13 (Tav. 122, 13): balsamario ceramico piriforme. Diam. orlo 2.5; alt. 8.7. Impasto duro, compatto, frattura netta, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 7/3. Superficie polverosa, con fascia di vernice opaca sul collo; colore vernice: Munsell 7.5YR 4/2. Realizzato al tornio. Ricomposto da vari frammenti. Tipo N.130.7, varietà b. n. 14 (Tav. 122, 14): balsamario ceramico piriforme. Diam. orlo 2.5; alt. 8. Impasto duro, compatto, frattura netta, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 7/3. Superficie polverosa, con fascia di vernice opaca sul collo; colore vernice: Munsell 7.5YR 4/2. Realizzato al tornio. Ricomposto da vari frammenti. Tipo N.130.7, varietà b.
n. 16 (Tav. 122, 16): balsamario ceramico piriforme. Diam. fondo 1.8; alt. max. cons. 6. Impasto duro, compatto, frattura netta, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 7/3. Superficie polverosa, con fascia di vernice opaca sul collo; colore vernice: Munsell 7.5YR 4/2. Realizzato al tornio. Mancante del collo e del labbro. Tipo N.130.7, varietà b. n. 17 (Tav. 122, 17): balsamario ceramico piriforme. Diam. orlo 2.6; alt. max. cons. 4. Impasto duro, compatto, frattura netta, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 7/3. Superficie polverosa, con fascia di vernice opaca sul collo; colore vernice: Munsell 7.5YR 4/2. Realizzato al tornio. Si conservano solo il collo e il labbro. Tipo N.130.7, varietà b. Tomba 333 (Campagna 2009; Tav. 105A, pianta di dettaglio della tomba non realizzata in corso di scavo). Sepoltura a incinerazione realizzata in un taglio di forma pressoché circolare (diam. 65; prof. 18), localizzata nella porzione centrale del saggio di scavo, a ovest del limite del saggio 2007/2008. La sepoltura risultava pesantemente disturbata da interventi post-deposizionali che ne avevano asportato sia il cinerario che il corredo. Dati antropologici. Non sono disponibili resti umani da questo contesto. Inquadramento cronologico. Prima età imperiale. Tomba 334 (Campagna 2009; Tavv. 105A, 110). Sepoltura a incinerazione realizzata in un taglio di forma pressoché rettangolare, orientato in senso nord-est/sud-ovest (lungh. 125; largh. 75; prof. 48), localizzata nella porzione centrale del saggio di scavo, a ovest del limite del saggio 2007/2008. Il taglio è disturbato presso il
345
Capestrano, I
compatto, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 4/4. Superficie ruvida, con una abrasione precedente alla fase di cottura. Realizzata al tornio. Integra. Tipo I.50.B.9, varietà f.
margine nord-occidentale dalla messa in opera della cassetta litica della tomba 301 (vedi, 327). I resti combusti del defunto sono contenuti all’interno di un’olletta in ceramica comune chiusa da un coperchio (nn. 1-2). Dati antropologici. I resti dell’individuo della tomba in esame non risultano presenti in deposito quindi non disponibili all’analisi. Dati archeologici. All’esterno del cinerario si rinviene una chiave in ferro (n. 3). Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Fine I secolo a.C.inizi I secolo d.C.
n. 2 (Tav. 122, 22): olletta ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 8; alt. 10. Impasto duro, compatto, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 7.5YR 4/4. Superficie ruvida. Realizzata al tornio. Integra. Tipo I.50.B.9, varietà f.
n. 1 (Tav. 122, 19): olletta ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 16; alt. 20. Impasto compatto, duro, frattura regolare; con rari inclusi di minute e piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Lacunosa di porzioni del labbro. Tipo I.50.A.8.
n. 3 (Tav. 122, 23): tegame a profilo troncoconico in ceramica comune. Diam. orlo 17.3; alt. 3.9. Impasto duro, compatto, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea; colore: Munsell 10R 4/6. Superficie ruvida. Realizzato al tornio. Ricomposto da vari frammenti. Tipo 295.3.
n. 2 (Tav. 122, 18): coperchio in ceramica comune. Diam. orlo 15; alt. 6. Impasto compatto, duro, frattura regolare; con rari inclusi di minute e piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa. Realizzato al tornio. Lacunoso di porzioni del labbro. Tipo I.300.3. n. 3 (Tav. 122, 20): chiave in ferro con verga ricurva e occhiello circolare. Lungh. 6; diam. verga 0.8. Superficie corrosa e ossidata. Integra. Con il numero di tomba 335 (Tav. 105B, pianta di dettaglio non realizzata in corso di scavo) si identifica in corso di scavo un taglio di forma ovale, orientato in senso nord-ovest/sud-est (lungh. 80; largh. max. 43; prof. 26), localizzato nella porzione settentrionale del saggio di scavo, a ridosso del limite del Saggio D del 2003, che disturba a nord la tomba 327 e a sud la tomba 315. Al suo interno si rinvengono numerosi frammenti di forme chiuse e aperte in ceramica comune, di cui alcuni diagnostici a cui si aggiungono quattro schegge di osso di colore bianco appartenenti ad un individuo adulto il cui peso totale è di 149.35 gr. Inquadramento cronologico. I secolo a.C.
Tomba 336 (Campagna 2009; Tavv. 105A, 110). Sepoltura a incinerazione realizzata in un taglio di forma pressoché circolare (diam. 50-60; prof. 40), localizzata nella porzione centrale del saggio di scavo, a ovest del limite del saggio 2007/2008. Il taglio è a sua volta realizzato sul fondo di una fossa di forma ovale (lungh. 176; largh. 100; prof. 12), all’interno della quale era alloggiata anche la tomba 337 (vedi, scheda seguente) I resti combusti del defunto sono contenuti all’interno di un’olletta in ceramica comune chiusa da un coperchio (nn. 1-2), all’interno e all’esterno della quale si rinviene il corredo. Dati antropologici. I resti dell’individuo della tomba in esame non risultano presenti in deposito quindi non disponibili all’analisi. Dati archeologici. Il corredo è composto da sette balsamari (nn. 5-11), una coppa in ceramica a vernice nera (n. 3), un’olletta in ceramica comune (n. 4) e un piccolo chiodo in ferro (n. 12). Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. I secolo d.C.
n. 1 (Tav. 122, 21): olletta ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 7; alt. 9.5. Impasto duro,
n. 1 (Tav. 123, 2): olletta globulare in ceramica comune. Diam. orlo 18.7; alt. 24.8. Impasto 346
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
n. 8 (Tav. 123, 8): balsamario ceramico piriforme. Diam. orlo 2.8; alt. max. cons. 9.6. Impasto duro, compatto, frattura netta, privo di inclusi. Superficie polverosa; sul collo si conserva una fascia di sovradipintura rossa. Realizzata al tornio. Mancante del ventre. Tipo N.130.7, varietà b.
duro, compatto, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Integra. Tipo I.50.A.6, varietà a. n. 2 (Tav. 123, 1): coperchio troncoconico a profilo sagomato in ceramica comune. Diam. orlo 18.3; alt. 7.5. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa. Realizzato al tornio. Ricomposto da vari frammenti; lacunoso di piccole porzioni dell’orlo. Tipo I.300.3.
n. 9 (Tav. 123, 9): balsamario ceramico piriforme. Diam. orlo 3.8; alt. max. cons. 8.2. Impasto duro, compatto, frattura netta, privo di inclusi. Superficie polverosa; sul collo si conserva una fascia di sovradipintura arancione. Realizzata al tornio. Mancante del ventre. Tipo N.130.7, varietà b.
n. 3 (Tav. 123, 3): frammento di piede ad anello di coppa in ceramica a vernice nera. Diam. piede 5.5; alt. max. cons. 2.2. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie liscia, con tracce di vernice opaca ed evanide. Realizzata al tornio. Tipo non puntualizzabile.
n. 10 (Tav. 123, 10): balsamario ceramico piriforme. Diam. orlo 3.9; alt max. cons. 8.3. Impasto duro, compatto, frattura netta, privo di inclusi. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Mancante del ventre. Tipo N.130.7, varietà b.
n. 4 (Tav. 123, 4): olletta globulare in ceramica comune. Diam. orlo 8.6; alt. max. cons. 5.5. Impasto duro, compatto, frattura irregolare, con frequenti inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Realizzata al tornio. Superficie polverosa. Si conserva parte del labbro e del ventre. Tipo I.50.B.14, varietà a. n. 5 (Tav. 123, 5): balsamario ceramico piriforme. Diam. orlo 2.6; alt. 13.6. Impasto duro, compatto, frattura netta, privo di inclusi. Superficie polverosa; sul collo si conserva una fascia di sovradipintura scura. Realizzata al tornio. Integro. Tipo N.130.7, varietà b. n. 6 (Tav. 123, 6): balsamario ceramico piriforme. Diam. orlo 3.2; alt. 11.6. Impasto duro, compatto, frattura netta, privo di inclusi. Superficie polverosa; sul collo si conserva una fascia di sovradipintura scura. Realizzata al tornio. Integro. Tipo N.130.7, varietà b. n. 7 (Tav. 123, 7): balsamario ceramico piriforme. Diam. orlo 2.8; alt. max. cons. 7.7. Impasto duro, compatto, frattura netta, privo di inclusi. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Mancante del collo. Tipo N.130.7, varietà b. 347
n. 11 (Tav. 123, 11): balsamario ceramico. Diam. orlo 3.5; alt. max. cons. 2.8. Impasto duro, compatto, frattura netta, privo di inclusi. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Mancante del ventre Tipo non puntualizzabile. Tomba 337 (Campagna 2009; Tavv. 105A, 110). Sepoltura a incinerazione realizzata in un taglio di forma pressoché circolare (diam. 55; prof. 35), localizzata nella porzione centrale del saggio di scavo, a ovest del limite del saggio 2007/2008. Il taglio è a sua volta realizzato nella fossa in cui era anche alloggiata la tomba 337 (vedi, scheda precedente) La sepoltura accoglieva due deposizioni, i cui resti combusti erano contenuti in due ollette in ceramica comune chiuse da coperchi, di dimensioni differenti (nn. 1-4). All’esterno delle ollette si rinviene il corredo. Dati antropologici. I resti dell’individuo della tomba in esame non risultano presenti in deposito quindi non disponibili all’analisi. Dati archeologici. Nella terra di riempimento del pozzetto si rinvengono una coppa a vernice nera (n. 5), un’olletta e frammenti di due lagynoi in ceramica comune (nn. 6-8), un bicchiere in ceramica sigillata italica (n. 9) e
Capestrano, I
frammenti di una lucerna (n. 10). Il sesso archeologico non è determinabile per ambedue le deposizioni; le diverse dimensioni delle ollette potrebbero suggerire l’attribuzione a individui di età diversa (adulta e sub-adulta?). Inquadramento cronologico. Fine I secolo a.C.inizi I secolo d.C.
n. 6 (Tav. 123, 16): olletta ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 8; alt. max. cons. 6. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Mancante del fondo e di parte dell’orlo. Tipo I.50.B.2.
Sepoltura 337A. n. 1 (Tav. 123, 12): olletta globulare in ceramica comune. Diam. orlo 10; alt. 25. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con frequenti inclusi di minute e piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Integra. Tipo I.50.A.6, varietà b.
n. 7 (Tav. 123, 17): frammento di spalla di una lagynos in ceramica comune. Diam. max. collo 2. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con inclusi molto rari di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Si conserva solo la spalla e parte del collo. Tipo non puntualizzabile.
n. 2: coperchio in ceramica comune, non recuperato in magazzino ma presente al momento dello scavo. Rinvenuto in frammenti a chiudere l’olletta n. 1. Non è stato possibile effettuarne la documentazione di dettaglio.
n. 8 (Tav. 123, 18): frammento di piede ad anello di una lagynos in ceramica comune. Diam. piede 12; alt. max. cons. 5.5. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con inclusi molto rari di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie liscia. Realizzata al tornio. Tipo non puntualizzabile.
Sepoltura 337B. n. 3 (Tav. 123, 14): olletta globulare in ceramica comune. Diam. orlo 14; alt. 13.7. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con frequenti inclusi di minute e piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Integra. Tipo I.50.B.5.
n. 9 (Tav. 123, 19): frammento di coppetta carenata in ceramica sigillata italica. Diam. orlo 12; alt. max. cons. 5. Impasto duro, compatto, frattura netta, privo di inclusi. Superficie liscia e ingobbiata; ingobbio compatto e lucente. Tipo K.260.1. n. 10 (Tav. 123, 20): lucerna (tipo “Vogelkopflamen”?). Lungh. max. cons. complessiva 9.2; diam. disco 5.1; lungh. max. cons. becco 1.8; alt. max. cons. 1.3. Impasto molto duro, compatto, frattura netta, privo di inclusi. Superficie polverosa. Realizzata a stampo. Lacunosa di parte della vasca. Tipo non puntualizzabile.
n. 4 (Tav. 123, 13): coperchio in ceramica comune. Diam. orlo 14; alt. 7. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con frequenti inclusi di minute e piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa. Realizzato al tornio. Integro. Tipo I.300.2. Materiali di corredo. n. 5 (Tav. 123, 15): piatto con vasca troncoconica e labbro rientrante in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 16.1; alt. 3.8. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di minute dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie liscia; vernice opaca e non uniforme. Sul fondo si conserva un bollo di forma rettangolare scarsamente leggibile. Realizzato al tornio. Ricomposto da vari frammenti. Tipo H.290.B.8.
Tomba 338 (Campagna 2009; Tavv. 105A, 111). Sepoltura a incinerazione realizzata in un taglio di forma pressoché ovale (lungh. 90; largh. 78; prof. 35), localizzata nella porzione centrale del saggio di scavo, a ovest del limite del saggio 2007/2008. I resti combusti del defunto sono contenuti all’interno di un’olletta in ceramica comune chiusa da un coperchio (nn. 1-2).
348
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
della spalla e puntualizzabile.
Dati antropologici. Non sono disponibili per l’analisi i materiali antropologici. Dati archeologici. La sepoltura era priva di materiali di corredo. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Fine I secolo a.C.inizi I secolo d.C.
del
labbro.
Tipo
non
Tomba 340 (Campagna 2009; Tavv. 105A, 111). Sepoltura a incinerazione realizzata in un taglio di forma irregolare (lungh. 70; largh. 50; prof. 40), localizzata nella porzione centrale del saggio di scavo, a ovest del limite del saggio 2007/2008. È coperta dallo strato di accumulo e livellamento denominato tomba 332 (vedi, 344345) che copre anche la vicina tomba 341 (vedi, scheda seguente). I resti combusti del defunto sono contenuti all’interno di un’olletta in ceramica comune, priva di coperchio (n. 1). Dati antropologici. Non sono disponibili per l’analisi i materiali antropologici. Dati archeologici. La sepoltura era priva di materiali di corredo. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. La tomba risultava coperta dallo strato 332 (essa può essere datata ala fine del I secolo a.C.-inizi I secolo d.C.
n. 1 (Tav. 123, 22): olletta in ceramica comune. Diam. orlo 9.3; alt. 13,5. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Mancante di piccole porzioni del labbro e del ventre. Tipo I.50.B.9, varietà f. n. 2 (Tav. 123, 21): coperchio in ceramica comune. Diam. pomello 1.9; alt. max. cons. 2.3. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa. Realizzato al tornio. Mancante del labbro. Vicino al Tipo I.300.3.
n. 1 (Tav. 124, 1): olletta cilindro-ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 18.5; alt. 20. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Manca di piccole porzioni del labbro. Tipo I.50.A.7.
Tomba 339 (Campagna 2009; Tavv. 105A, 111). Sepoltura a incinerazione realizzata in un taglio di forma pressoché circolare (diam. 60-65; prof. 45), localizzata nella porzione centrale del saggio di scavo, a ovest del limite del saggio 2007/2008. Risulta disturbata a sud dalla messa in opera dal blocco calcareo della tomba 288 (vedi, 320). I resti combusti del defunto sono contenuti all’interno di un’olletta in ceramica comune, disturbata nella sua parte superiore (n. 1). Dati antropologici. Non sono disponibili per l’analisi i materiali antropologici. Dati archeologici. La sepoltura era priva di materiali di corredo. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Prima età imperiale.
Tomba 341 (Campagna 2009; Tavv. 105A, 111). Sepoltura a incinerazione realizzata in un taglio di forma irregolare (lungh. 70; largh. 40; prof. 40), localizzata nella porzione centrale del saggio di scavo, a ovest del limite del saggio 2007/2008. È coperta dallo strato di accumulo e livellamento denominato tomba 332 (vedi, 344345) che copre anche la vicina tomba 340 (vedi, scheda precedente). I resti combusti del defunto sono contenuti all’interno di un’olla in ceramica comune (n. 1), priva di coperchio, all’interno e all’esterno della quale si rinvengono i resti del corredo. Dati antropologici. I resti dell’individuo della tomba in esame non risultano presenti in deposito quindi non disponibili all’analisi. Dati archeologici. Nella terra di riempimento del pozzetto e all’interno del cinerario, si
n. 1 (Tav. 123, 23): olletta in ceramica comune. Diam. fondo 9; alt. max. cons. 22. 1. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa. Realizzato al tornio. Manca completamente
349
Capestrano, I
compatto, privo di inclusi. Superficie polverosa. Realizzata a stampo. Integra. Tipo M.B.2.
rinvengono un piatto in ceramica a vernice nera (n. 2), due ollette frammentarie in ceramica comune (nn. 3-4), sei balsamari ceramici (nn. 5-10) e una lucerna (n. 11). Dalla documentazione di scavo, si evince che i balsamari e i frammenti di ollette erano disposti intenzionalmente a contatto con il cinerario. Il sesso archeologico non è determinabile. Inquadramento cronologico. Anche la tomba 341 era coperta dallo strato 332: questo dato conferma la sua datazione, desumibile anche dalle associazioni di corredo, alla fine del I secolo a.C.-inizi del I secolo d.C.
n. 6 (Tav. 124, 7): balsamario ceramico piriforme. Diam. orlo 2; alt. 7.8. Impasto duro, compatto, frattura regolare, privo di inclusi; colore: Munsell 10R 5/6. Superficie liscia; sul collo si conserva una fascia di vernice opaca; colore vernice: Munsell 10R 4/6. Realizzato al tornio. Ricomposto da vari frammenti. Tipo N.130.7, varietà b. n. 7 (Tav. 124, 8): balsamario ceramico piriforme. Diam. orlo 1.8; alt. 7.2. Impasto duro, compatto, frattura regolare, privo di inclusi; colore: Munsell 10YR 8/4. Superficie liscia; sul collo si conserva una fascia di colore bruno. Realizzato al tornio. Ricomposto da vari frammenti. Tipo N.130.7, varietà b.
n. 1 (Tav. 124, 2): olla ovoide in ceramica comune. Diam. orlo 20.7; alt. 30.8. Impasto duro, con rari inclusi di piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Integra. Tipo I.40.7.
n. 8 (Tav. 124, 9): balsamario ceramico pririforme. Diam. orlo 1.2; alt. 5.5. Impasto duro, compatto, frattura regolare, privo di inclusi; colore: Munsell 7.5YR 7/4. Superficie liscia; sul collo si conserva una fascia di vernice opaca; colore vernice: Munsell 7.5R 4/1. Realizzato al tornio. Ricomposto da vari frammenti. Tipo N.130.7, varietà a.
n. 2 (Tav. 124, 3): piatto con vasca troncoconica e labbro rientrante in ceramica a vernice nera. Diam. orlo 15.3; alt. 4.1. Impasto duro, compatto, privo di inclusi. Superficie polverosa; vernice disomogenea e opaca. Realizzato al tornio. Mancante di parte del labbro e della vasca. Tipo H.290.B.5. n. 3 (Tav. 124, 5): olletta globulare in ceramica comune. Diam. orlo 7.8; alt. 8.8. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con frequenti inclusi di minute e piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Ricomposta da vari frammenti; mancante di parte del labbro. Tipo I.50.B.3.
n. 9 (Tav. 124, 10): balsamario ceramico piriforme. Diam. orlo 2.1; alt. 10. Impasto duro, compatto, frattura regolare, privo di inclusi; colore: Munsell 7.5YR 7/4. Superficie liscia; sul collo si conserva una fascia di vernice opaca; colore vernice: Munsell 10R 4/6. Realizzato al tornio. Ricomposto da vari frammenti. Tipo N.130.7, varietà b.
n. 4 (Tav. 124, 4): olletta globulare in ceramica comune. Diam. orlo 11.9; alt. 12.9. Impasto duro, compatto, frattura regolare, con frequenti inclusi di minute e piccole dimensioni distribuiti in maniera omogenea. Superficie polverosa. Realizzata al tornio. Ricomposta da vari frammenti; mancante di piccole porzioni del labbro. Tipo I.50.B.14, varietà a.
n. 10 (Tav. 124, 11): balsamario ceramico pririforme. Diam. fondo 1.4; alt. max. cons. 5.4. Impasto duro, compatto, frattura regolare, privo di inclusi; colore: Munsell 7.5YR 7/4. Superficie liscia; sul collo si conserva una fascia di vernice opaca; colore vernice: Munsell 10R 4/6. Realizzato al tornio. Ricomposto da vari frammenti. Tipo N.130.7, varietà a.
n. 5 (Tav. 124, 6): lucerna tipo “Vogelkopflampen” di piccole dimensioni. Lungh. complessiva 7.7; lungh. becco 1.3; diam. disco 1.9; alt. 3.3. Impasto molto duro,
350
n. 11 (Tav. 124, 12): balsamario ceramico piriforme. Diam. orlo 1.5; alt. 5.5. Impasto duro, compatto, frattura regolare, privo di inclusi; colore: Munsell 7.5YR 7/4. Superficie liscia;
Capo d’Acqua-Fossascopana: il catalogo delle sepolture
sul collo si conserva una fascia di vernice opaca; colore vernice: Munsell 10R 4/6. Realizzato al tornio. Ricomposto da vari frammenti. Tipo N.130.7, varietà a. Tomba 342 (Campagna 2009; Tav. 105B, pianta di dettaglio della tomba non realizzata in corso di scavo). Sepoltura a inumazione in fossa di forma rettangolare, orientata in senso sud-nord (lungh. 103; largh. 32; prof. 18), localizzata nella porzione settentrionale del saggio di scavo La sepoltura risulta pesantemente disturbata da interventi post-deposizionali di età antica e moderna che hanno completamente asportato i resti scheletrici e il corredo. Dati antropologici. Nessun materiale antropologico proviene da questo contesto. Si segnala la presenza di una porzione distale di tibia di equino. Inquadramento cronologico. Incerto. La tomba 343 viene individuata nella porzione settentrionale del saggio di scavo, ma di essa non risultano realizzati né il posizionamento planimetrico né la documentazione di dettaglio. Si conserva esclusivamente l’annotazione del rinvenimento al suo interno di rari frammenti ossei. Dell’inumato si conservano solo alcune schegge non determinabili.
351
TAVOLE
Capestrano, I
354
Tavole
355
Capestrano, I
356
Tavole
357
Capestrano, I
358
Tavole
359
Capestrano, I
360
Tavole
361
Capestrano, I
362
Tavole
363
Capestrano, I
364
Tavole
365
Capestrano, I
366
Tavole
367
Capestrano, I
368
Tavole
369
Capestrano, I
370
Tavole
371
Capestrano, I
372
Tavole
373
Capestrano, I
374
Tavole
375
Capestrano, I
376
Tavole
377
Capestrano, I
378
Tavole
379
Capestrano, I
380
Tavole
381
Capestrano, I
382
Tavole
383
Capestrano, I
384
Tavole
385
Capestrano, I
386
Tavole
387
Capestrano, I
388
Tavole
389
Capestrano, I
390
Tavole
391
Capestrano, I
392
Tavole
393
Capestrano, I
394
Tavole
395
Capestrano, I
396
Tavole
397
Capestrano, I
398
Tavole
399
Capestrano, I
400
Tavole
401
Capestrano, I
402
Tavole
403
Capestrano, I
404
Tavole
405
Capestrano, I
406
Tavole
407
Capestrano, I
408
Tavole
409
Capestrano, I
410
Tavole
411
Capestrano, I
412
Tavole
413
Capestrano, I
414
Tavole
415
Capestrano, I
416
Tavole
417
Capestrano, I
418
Tavole
419
Capestrano, I
420
Tavole
421
Capestrano, I
422
Tavole
423
Capestrano, I
424
Tavole
425
Capestrano, I
426
Tavole
427
Capestrano, I
428
Tavole
429
Capestrano, I
430
Tavole
431
Capestrano, I
432
Tavole
433
Capestrano, I
434
Tavole
435
Capestrano, I
436
Tavole
437
Capestrano, I
438
Tavole
439
Capestrano, I
440
Tavole
441
Capestrano, I
442
Tavole
443
Capestrano, I
444
Tavole
445
Capestrano, I
446
Tavole
447
Capestrano, I
448
Tavole
449
Capestrano, I
450
Tavole
451
Capestrano, I
452
Tavole
453
Capestrano, I
454
Tavole
455
Capestrano, I
456
Tavole
457
Capestrano, I
458
Tavole
459
Capestrano, I
460
Tavole
461
Capestrano, I
462
Tavole
463
Capestrano, I
464
Tavole
465
Capestrano, I
466
Tavole
467
Capestrano, I
468
Tavole
469
Capestrano, I
470
Tavole
471
Capestrano, I
472
Tavole
473
Capestrano, I
474
Tavole
475
Capestrano, I
476
Tavole
477
BIBLIOGRAFIA Acconcia, Valeria. 2012. “La produzione e la circolazione del bucchero in area medioadriatica.” Officina Etruscologia 7 (2012): 99140.
Albanese Procelli, Rosa Maria. 1985. “Considerazioni sulla distribuzione dei bacini bronzei in area tirrenica e in Sicilia. “ In Il commercio etrusco arcaico, Atti dell’Incontro di Studi (Roma 5-7 dicembre 1983), a cura di Mauro Cristofani, 179-206. Roma: Consiglio Nazionale delle Ricerche, 1985.
Acconcia, Valeria. 2014. Ritualità funeraria e convivialità. Tra rigore e ostentazione nell’Abruzzo preromano, Officina Etruscologia 10. Roma: Officina Edizioni, 2014.
Albanese Procelli, Rosa Maria. 2006. “I recipienti in bronzo a labbro perlato.” In Gli Etruschi da Genova ad Ampurias, Atti del XXIV Convegno di Studi Etruschi e Italici (Marseille-Lattes 26 settembre – 1 ottobre 2002), a cura di Stefano Gori, 307-318. PisaRoma: Instituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2006.
Acconcia, Valeria. 2015. “Riflessioni sullo sviluppo degli spazi funerari nell’Abruzzo interno in età preromana.” Archeologia Classica LXVI (2015): 1-39. Acconcia, Valeria, e Vincenzo D’Ercole. 2012. “La ripresa delle ricerche a Fossa (2010). L’Abruzzo tra il Bronzo Finale e la fine dell’età del Ferro: proposta di periodizzazione sulla base dei contesti funerari”, in Archeologia Classica 63 n.s. II,2 (2012): 7-53.
Alvino, Giovanna. 1997. “La necropoli di Poggio Sommavilla.” In I Sabini. La vita, la morte, gli dei, Catalogo della mostra (Rieti Sala dei Cordari, 30 ottobre – 15 dicembre 1997), a cura di Giovanna Alvino, 61-75. Roma: SAL Soprintendenza Archeologica del Lazio, 1997.
Acconcia, Valeria, Vincenzo d’Ercole, e Raffaella Papi. 2012. “Capestrano (AQ), loc. Fonte di Presciano: campagna di scavo 2010.” Quaderni di Archeologia d’Abruzzo 2/2010 (2012): 494-500.
Alvino, Giovanna. 2004, “Il tumulo di Corvaro di Borgorose.” In Gli Equi tra Abruzzo e Lazio, Catalogo della Mostra (Oricola, 2004), a cura di Sandra Lapenna, 61-76. Sulmona: Synapsi, 2004.
Acconcia, Valeria, Vincenzo d’Ercole, e Francesca Lerza. 2011. “La necropoli preromana di Peltuinum: le indagini del 2009. “ In Il Fucino e le aree limitrofe nell’antichità, Atti del III Convegno di Archeologia (Avezzano 13-15 novembre 2009), a cura di Adele Campanelli, e Walter Cianciusi, 443-469. Avezzano: Archeoclub d’Italia, Sezione della Marsica, 2011.
Bailey, Donald M. 1980. A Catalogue of the lamps in the British Museum, II, Roman lamps made in Italy. London: British Museum Publications, 1980. Baldelli Gabriele, e Maria Ruggeri Giove. 1982. “Necropoli dell’età del Ferro di Atri.” Studi in onore di Ferrante Rittatore Vonwiller 1, Preistoria e protostoria, 631-651. Como: Malinverno, 1982.
Acconcia, Valeria, e Ilaria Di Sabatino. 2016. “Capestrano (AQ). La necropoli preromana in loc. Fontanelle di Capo d’Acqua: scavi 2012.” Quaderni di Archeologia d’Abruzzo 4/2012 (2016): 156-159.
Bartoloni, Gilda. 1972. Le tombe da Poggio Buco nel Museo Archeologico di Firenze, Monumenti etruschi 3. Firenze: L.S.Olschki, 1972.
Acconcia, Valeria, Ilaria Di Sabatino, Serafino L. Ferreri, e Federica Properzio. 2017. “Rituale funerario e cultura materiale nell’Abruzzo interno: il caso di Navelli.” Mediterranea XIV (2017): 63-82.
Bellelli, Vincenzo. 1993. “Tombe con bronzi etruschi da Nocera.” In Miscellanea etruscoitalica I, QuadAEI 22, a cura di Mauro 479
Capestrano, I
Cristofani, 65-104. Roma: Consiglio nazionale delle ricerche, 1993.
1996-6 gennaio 1997). S. Giovanni in Persiceto: edizioni Aspasia, 1997.
Bellelli, Vincenzo. 2002. “Artigianato del bronzo e contesti produttivi: bilancio etruscocampano.” Orizzonti. Rassegna di Archeologia 3 (2002): 29-52.
Bini, Maria Paola, Gianluca Caramella, e Sandra Buccioli. 1995. I bronzi etruschi e romani, Materiali del Museo archeologico nazionale di Tarquinia 13. Roma: G.Bretschneider, 1995.
Benedettini, Maria G. (a cura di). 2012. Il Museo delle Antichità Etrusche e Italiche. III. I bronzi della collezione Gorga. Roma: Università La Sapienza, 2012.
Bonini, Paolo. 2003. “Monete dalle tombe romane di Brescia. Osservazioni sui vecchi scavi.” Antenor IV (2003): 15-51. Bonomi Ponzi, Laura. 1997. La necropoli plestina di Colfiorito di Foligno. Ponte San Giovanni: Quattroemme, 1997.
Benelli, Enrico, e Francesco M. Cifarelli. 2011. “Materiali e tipi ceramici arcaici tra Abruzzo, Campania settentrionale e il Lazio meridionale interno: tradizioni locali e circolazione di modelli.” In Gli Etruschi e la Campania settentrionale, Atti del XXVI Convegno di Studi Etruschi e Italici (Caserta-Santa Maria Capua Vetere-Capua-Teano 11-15 novembre 2007), 105-114. Pisa: Serra, 2011.
Bonomi, Simonetta, Nicoletta Camerin, e Katia Tamassia. 2000. “Aggiornamenti sulla ceramica alto-adriatica di Adria.” In Adriatico tra IV e III sec. a.C. Vasi alto-adriatici tra Piceno, Spina e Adria (Atti del Convegno di Studi, Ancona 2021 giugno 1997), a cura di Maurizio Landolfi, 47-70. Roma: L’Erma di Bretschneider, 2000.
Benelli, Enrico, e Alessandro Naso. 2003. “Relazioni e scambi nell’Abruzzo in epoca preromana.” In Genti e culture dell’Abruzzo in epoca preromana, Actes de la journée d’études (Roma 19 gennaio 2001), Mélanges de l’Ècole Française de Rome Antiquité 115, 1 (2003): 177-205, Roma: Ècole Française de Rome, 2003.
Bonuccelli, Giuseppina, e Lucia Faedo. 1968. “Il villaggio a ceramica impressa di Capo d’Acqua.” Atti della Società Toscana di Scienze Naturali, Memorie, ser. A, LXXVI, fasc. 1 (1968): 87-101. Bosio, Brunella, e Alessandra Pugnetti (a cura di). 1986. Gli Etruschi di Cerveteri, Catalogo della mostra (Milano Museo Archeologico 1986). Modena: edizioni Panini, 1986.
Benelli, Enrico, e Claudia Rizzitelli. 2010. Culture funerarie d’Abruzzo (IV-I secolo a.C.), Mediterranea suppl. 5. Pisa-Roma: F.Serra, 2010.
Bottini, Angelo. 1982. Principi guerrieri dalla Daunia del VII secolo. Le tombe principesche di Lavello. Bari: De Donato, 1982.
Benelli, Enrico, e Joachim Weidig. 2006. “Elementi per una definizione degli aspetti della conca aquilana in età arcaica. Considerazioni sulle anforette di tipo aquilano.” Orizzonti VII (2006): 11-22.
Bouloumié, Bernard. 1968. “Les oenochoés à bec en bronze des Musées d’Étrurie centrale et méridionale.” MEFRA 80, 2 (1968): 399-460.
Bernardini, Paola. 1986. Museo Nazionale Romano. Le Ceramiche. V.1. La ceramica a vernice nera dal Tevere. Roma: De Luca, 1986.
Bouloumié, Bernard. 1973. Les oenochoés en bronze du type “Schnabelkanne” en Italie. Roma: École Française de Rome, 1973.
Berti, Fede, Simonetta Bonomi, e Maurizio Landolfi. 1997. Classico e Anticlassico. Vasi alto-adriatici tra Piceno Spina e Adria, Catalogo della Mostra (Comacchio 25 giugno
Bourdin, Stéphane, e Vincenzo d’Ercole (a cura di). 2014. I Vestini e il loro territorio dalla Preistoria al Medioevo, Collection de l’École 480
Bibliografia
française de Rome 494. Roma: École française de Rome, 2014.
SOMA 2003 - Symposium on Mediterranean Archaeology, Proceedings of the Seventh Meeting of Postgraduate Researchers at the Institute of Archaeology, University College (London 21st-23rd February 2003), BAR International Series 1391, a cura di Camilla Briault, Jack Green, Anthi Kaldelis, e Anna Stellatou, 21-25. Oxford: Hadrian Books, 2005.
Bracci, Federica. 2007. “I vaghi in pasta vitrea di ambito piceno (VIII-V sec. a.C.): proposta di un inquadramento tipologico e cronologico.” Picus 27 (2007): 39-83. Brecciaroli Taborelli, Luisa. 1996-1997. “Jesi (Ancona). L’officina ceramica di Aesis (III sec. a.C. - I sec. d.C.).” Notizie degli Scavi, IX, VIIVIII (1996-97): 5-277.
Caravale, Alessandra. 2006. Museo Claudio Faina di Orvieto. Vasellame. Milano: Electa, 2006.
Brecciaroli Taborelli, Luisa. 2013. “La ceramica a vernice nera da Sentinum, centro di consumo dell’Umbria adriatica tra II e I secolo a.C.” Picus, XXXIII (2013): 9-81.
Castoldi, Marina. 1995. Recipienti di bronzo greci, magnogreci ed etrusco-italici nelle Civiche Raccolte Archeologiche di Milano, Notizie dal chiostro del Monastero Maggiore, Suppl. 15. Milano: Civico Museo archeologico, 1995.
Buonocore, Marco, e Giulio Firpo. 1998. Fonti latine e greche per la storia dell’Abruzzo antico, II, 1-2 (Documenti per la Storia d’Abruzzo, N.10/ II, 1-2). L’Aquila: Colacchi 1998.
Cattaneo, Cristina, e Marco Grandi. 2004. Antropologia e odontologia forense. Guida allo studio dei resti umani, testo Atlante. Bologna: Monduzzi, 2004.
Canci, Alessandro, e Simona Minozzi. 2010. Archeologia dei resti umani. Dallo scavo al laboratorio, 7a ristampa. Roma: Carocci, 2010.
Ceci, Francesca. 2001. “L’interpretazione di monete e chiodi in contesti funerari: esempi dal suburbio romano.” In Römischer Bestattungsbrauch und Beigabensitten/ Culto dei morti e costumi funerari romani, Internationales Kolloquium (Rom 1-3 April 1998), Palilia 8, a cura di Michael Heinzelmann, Jacopo Ortalli, Peter Fasold, e Marion Witteyer, 87-91. Wiesbaden: Reichert, 2001.
Cantilena, Renata. 1995. “Un obolo per Caronte?” In Caronte. Un obolo per l’Aldilà, Atti del Convegno (Salerno 20-22 febbraio 1995), Parola del Passato Rivista di studi classici 50, fasc. 282-285 (1995), 165-177. Napoli: Macchiaioli, 1995. Cantù, Magda. 2010. “Il bucchero e le sue imitazioni nella Sabina tiberina settentrionale.” In Tra centro e periferia. Nuovi dati sul bucchero nell’Italia centrale e tirrenica, Officina etruscologia 3, a cura di Gilda Bartoloni, 141-168. Roma: Officina Ed., 2010.
Cella, Elisa. 2012. “La necropoli di Capestrano: « nuove acquisizioni ».” Mediterranea IX (2012): 57-105. Cesano, Lorenza. 1938. “Ripostiglio di monete romane del III sec. a.C.” Notizie degli Scavi di Antichità (1938): 20-22.
Capini, Stefania. 1984. “La ceramica ellenistica dallo scarico A del santuario di Ercole a Campochiaro.” Conoscenze. Rivista annuale della Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Molise, 1 (1984): 9-57.
Chiaramonte Treré, Cristina. 2003. “La necropoli di Campovalano. Spunti per una rilettura della fase arcaica.” In Genti e culture dell’Abruzzo in epoca preromana, Actes de la journée d’études (Roma 19 gennaio 2001), Mélanges de l’Ècole Française de Rome
Capodicasa, Monica. 2005. “The Necropolis of Capestrano: new excavations and finds.” In 481
Capestrano, I
Colonna, Giovanni. 1992. “Praeneste arcaica e il mondo etrusco-italico.” In La necropoli di Praeneste, periodi orientalizzante e mediorepubblicano, Atti del II Convegno di studi archeologici (Palestrina 21-22 aprile 1990), 1346. Palestrina: Comune di Palestrina, 1992.
Antiquité 115, 1 (2003): 51-84, Roma: Ècole Française de Rome, 2003. Chiaramonte Treré, Cristina. 2011. “Gli Ausoni/Aurunci e le aristocrazie centro-italiche: identità etniche e differenziazioni culturali tra VII e VI secolo a.C. Alcuni spunti.” In Gli Etruschi e la Campania settentrionale, Atti del XXVI Convegno di Studi Etruschi e Italici (Caserta-Santa Maria Capua Vetere-CapuaTeano 11-15 novembre 2007), pp. 135-147. Pisa: Serra, 2011.
Conspectus = Ettlinger, Elisabeth, Hedinger B., Hoffmann B., Kenrick P.M., Pucci G., RothRubi K., Schneider G., Schnurbein S. von, Wells C.M., Zabehlicky-Scheffenegger S. Conspectus formarum terrae sigillatae Italico modo confectae, Materialen zur römischgermanischen Keramik 10. Bonn: Habelt, 1990.
Chiaramonte Treré, Cristina, e Vincenzo d’Ercole. 2003. La necropoli di Campovalano. Tombe orientalizzanti ed arcaiche, I, BAR International Series 1177. Oxford: BAR Publishing, 2003.
Cosentino, Serena, Vincenzo d’Ercole, e Gianfranco Mieli. 2001. La necropoli di Fossa. Le testimonianze più antiche, I. Pescara: Carsa, 2001.
Chiaramonte Treré, Cristina, Vincenzo d’Ercole, e Cecilia Scotti. 2010. La necropoli di Campovalano. Tombe orientalizzanti ed arcaiche, II, BAR International Series 2174. Oxford: BAR Publishing, 2010.
Cosentino, Serena, Vincenzo d’Ercole, e Gianfranco Mieli. 2003. “Prima dei Vestini. La necropoli di Fossa. Le testimonianze più antiche.” In Genti e culture dell’Abruzzo in epoca preromana, Actes de la journée d’études (Roma 19 gennaio 2001), Mélanges de l’Ècole Française de Rome Antiquité 115, 1 (2003): 750, Roma: Ècole Française de Rome, 2003.
Cianfarani, Valerio. 1976. “Culture arcaiche dell’Italia medio-adriatica.” In Popoli e Civiltà dell’Italia antica, V, a cura di Valerio Cianfarani, Delia G. Lollini, e Mario Zuffa, 9106. Roma: Biblioteca di Storia Patria,1976.
Cristofani, Mauro, ed. 1985. Civiltà degli Etruschi, Catalogo della Mostra (Firenze Museo Archeologico 16 maggio – 20 ottobre 1985). Milano: Electa, Regione Toscana, 1985.
Coen, Alessandra. 2002-2003. “Materiali da Montegiorgio della collezione Gian Battista Compagnoni Natali.” Bullettino di Paletnologia Italiana 93-94 (2002-2003): 155-217.
Cuozzo, Mariassunta, e Andrea D’Andrea. 1991. “Proposta di periodizzazione del repertorio locale di Pontecagnano tra la fine del VII e la metà del V sec. a.C. alla luce della stratigrafia della necropoli.” AION Annali di archeologia e storia antica. Istituto universitario orientale. Dipartimento di studi del mondo classico e del Mediterraneo antico, 13 (1991): 47-114.
Coen, Alessandra. 2015. “I materiali da Belmonte Piceno al Museo Preistorico ed Etnografico Luigi Pigorini” Picus XXXV (2015): 193-253. Colivicchi, Fabio. 2002. La necropoli di Ancona (IV-I secolo a.C.): una comunità italica fra ellenismo e romanizzazione, Quaderni di Ostraka, 7. Napoli: Loffredo 2002.
D’Alascio, Germana. 2002. Le lucerne di Saepinum. Campobasso: IRESMO, 2002.
Colonna, Giovanni. 1958. “Placche arcaiche di cinturone di produzione capenate.” Archeologia Classica 10 (1958): 69-80.
D’Alessandro, Silvia, Vincenzo d’Ercole, Ilaria Di Sabatino, e Alberta Martellone. 2014. “Capestrano (AQ). Archeologia d’emergenza.”
482
Bibliografia
d’Ercole, Vincenzo. 2016. “Campovalano e i Celti in Abruzzo.” In La necropoli di Campovalano. Tombe italico-ellenistiche, III, BAR International Series 2804, a cura di Vincenzo d’Ercole, Alberta Martellone, e Deneb Cesana, 153-163. Oxford: BAR Publishing, 2016.
Quaderni di Archeologia d’Abruzzo 3/2011 (2014): 297-302. Dall’Osso, Innocenzo. 1910. “Alla scoperta dell’Abruzzo preistorico: escursione dall’Agosto al Settembre 1909.” Rivista Abruzzese di Scienze Lettere ed Arti, anno XXV, fasc. VII-VIII (1910): 368-404.
d’Ercole, Vincenzo, e Enrico Benelli. 2004. La necropoli di Fossa. II. I corredi orientalizzanti e arcaici, Documenti dell’Abruzzo antico. Pescara: Carsa 2004.
d’Ercole, Vincenzo. 2000. “Il guerriero e la necropoli di Capestrano.” In Principi Europei dell’età del Ferro, Catalogo della Mostra (Chieti 21 giugno- 3 settembre 2000), a cura di Anna Maria Bietti Sestieri, Maria Ruggeri, e Amalia Faustoferri, 43-46. Roma: De Luca, 2000.
d’Ercole, Vincenzo, e Roberta Cairoli. 2005. Ricerche archeologiche a Capestrano: dal cantiere al laboratorio, Roma: 2005. d’Ercole, Vincenzo, e Elisa Cella. 2007a. “Il guerriero di Capestrano.” In Guerrieri e Re dell’Abruzzo antico, a cura di Maria Ruggeri, 32-45, Pescara: Carsa, 2007.
d’Ercole, Vincenzo. 2010a. “I Vestini e la guerra prima di Roma.” In Pinna Vestinorum e il popolo dei Vestini, Storia e civiltà di Penne, 1, a cura di Luisa Franchi Dell’Orto, 138-177. Roma: L’Erma di Bretschneider, 2010.
d’Ercole, Vincenzo, e Elisa Cella. 2007b. “Le ultime indagini archeologiche a Capestrano.” In I campi aperti di Peltuinum dove tramonta il sole… Saggi sulla terra di Prata d’Ansidonia dalla Protostoria all’età moderna, Studi sulla Storia del Territorio 1, Deputazione Abruzzese di Storia Patria, a cura di Alessandro Clementi, 111-121. L’Aquila: Colacchi, 2007.
d’Ercole, Vincenzo. 2010b. “Vestini cismontani.” In Pinna Vestinorum e il popolo dei Vestini, Storia e civiltà di Penne, 1, a cura di Luisa Franchi Dell’Orto, 110-137. Roma: L’Erma di Bretschneider, 2010. d’Ercole, Vincenzo. 2014. “Per una definizione della Koinè culturale vestina.” In I Vestini e il loro territorio dalla Preistoria al Medioevo, Collection de l’École française de Rome 494, a cura di Stéphane Bourdin, e Vincenzo d’Ercole, 29-61. Roma: École française de Rome, 2014.
d’Ercole, Vincenzo, e Elisa Cella. 2007c. “I semata in pietra della necropoli di Capestrano.” In I campi aperti di Peltuinum dove tramonta il sole… Saggi sulla terra di Prata d’Ansidonia dalla Protostoria all’età moderna, Studi sulla Storia del Territorio 1, Deputazione Abruzzese di Storia Patria, a cura di Alessandro Clementi, 122-131. L’Aquila: Colacchi, 2007.
d’Ercole, Vincenzo. 2015a. “Capestrano: 10.000 anni di storia prima di Roma.” In Capestrano nella Valle Tritana, a cura di Giuseppe Chiarizia, e Luca Iagnemma, 99-111. L’Aquila: One Group edizioni, 2015.
d’Ercole, Vincenzo, Maria R. Copersino. La necropoli di Fossa. IV. L’età ellenisticoromana, Documenti dell’Abruzzo antico. Pescara: Carsa 2003.
d’Ercole, Vincenzo. 2015b. “Le spade tipo Capestrano: tipologia, distribuzione, cronologia, funzione e significato.” In Sui due versanti dell’Appennino. Necropoli e distretti culturali tra VII e VI sec. a.C., Atti del Seminario (Santa Maria Capua Vetere 12 novembre 2013), Biblioteca di Studi Etruschi 55, a cura di Fernando Gilotta, e Gianluca Tagliamonte, 215268. Roma: G.Bretschneider, 2015.
d’Ercole, Vincenzo, e Ilaria Di Sabatino. 2014. “Capestrano (AQ). Ulteriori indagini archeologiche in loc. Presciano.” Quaderni di Archeologia d’Abruzzo 3/2011 (2014): 302305.
483
Capestrano, I
dicembre 2015), Annali della Fondazione per il Museo Claudio Faina, a cura di Giuseppe M. Della Fina, 413-442. Roma: Quasar, 2016.
d’Ercole, Vincenzo, e Alberta Martellone. 2003. “La necropoli arcaica di Vestea” In Dalla valle del Fino alla valle del medio e alto Pescara, Documenti dell’Abruzzo teramano VI.1, a cura di Luisa Franchi Dell’Orto, 109-112. Teramo: Fondazione Tercas, 2003.
d’Ercole, Vincenzo, Oliva Menozzi, e Serena Torello di Nino. 2011. “Gli ultimi scavi nella necropoli di Capestrano.” In Il Fucino e le aree limitrofe nell’antichità, Atti del III Convegno di Archeologia (Avezzano 13-15 novembre 2009), a cura di Adele Campanelli, e Walter Cianciusi, 487-504. Avezzano: Archeoclub d’Italia, Sezione della Marsica, 2011.
d’Ercole, Vincenzo, e Alberta Martellone. 2006. “Le necropoli protostoriche di Teramo.” In Museo Civico Archeologico “F.Savini” di Teramo, a cura di Paola Di Felice, e Vincenzo Torrieri, 55-57. Teramo: Museo civico archeologico, 2006.
d’Ercole, Vincenzo, Raffaella Papi, e Giuseppe Grossi. 1990. Antica terra d’Abruzzo. Volume primo. Dalle origini alla nascita delle repubbliche italiche. L’Aquila: Editoriale Abruzzese, 1990.
d’Ercole, Vincenzo, e Alberta Martellone. 2007a. “Peltuinum e il territorio vestino prima di Roma.” In I campi aperti di Peltuinum dove tramonta il sole… Saggi sulla terra di Prata d’Ansidonia dalla Protostoria all’età moderna, Studi sulla Storia del Territorio 1, Deputazione Abruzzese di Storia Patria, a cura di Alessandro Clementi, 17-38. L’Aquila: Colacchi, 2007.
Darling, Margaret J., e Barbara Precious. 2014. A Corpus of Roman Pottery from Lincoln, Lincoln archaeological studies 6. Oxford: Oxbow Books, 2014. De Tommaso, Giandomenico. 1990. Ampullae Vitreae. Contenitori in vetro di unguenti e sostanze aromatiche dell’Italia romana (I secolo a.C.-III secolo d.C.). Roma: G.Bretschneider, 1990.
d’Ercole, Vincenzo, e Alberta Martellone (a cura di). 2007b. Regine d’Abruzzo. La ricchezza nelle sepolture del I millennio a.C., Catalogo della mostra (L’Aquila 23 Agosto 17 novembre 2007). L’Aquila: Carispaq, 2007. d’Ercole, Vincenzo, e Alberta Martellone. 2008. “Rituali funerari vestini dell’età del Ferro.” In Ricerche di archeologia medio-adriatica I. Le necropoli: contesti e materiali, Atti dell’Incontro di Studi (Cavallino-Lecce 27-28 maggio 2005), Università del Salento: Archeologia e Storia 8, a cura di Gianluca Tagliamonte, 143-161. Galatina: Congedo, 2008.
Deneauve, Jean. 1969. Lampes de Carthage. Paris: Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1969. Delpino Chiara, Stefano Finocchi, e Giorgio Postrioti. 2016. “Necropoli del Piceno. Dati acquisiti e prospettive di ricerca.” In Dalla Valdelsa al Conero: ricerche di archeologia e topografia storica in ricordo di Giuliano de Marinis, Atti del convegno internazionale di studi (Colle di Val d’Elsa - San Gimignano Poggibonsi, 27-29 novembre 2015), Notiziario della Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana, suppl. 2, a cura di Giacomo Baldini, e Pierluigi Giroldini, 287 - 304. Firenze: All’Insegna del Giglio, 2016.
d’Ercole, Vincenzo, Alberta Martellone, e Deneb Cesana. 2016. La necropoli di Campovalano. Tombe italico-ellenistiche, III, BAR International Series 2804. Oxford: BAR Publishing, 2016. d’Ercole, Vincenzo, e Oliva Menozzi. 2016. “Strutture abitative nell’Abruzzo preromano.” In Dalla capanna al palazzo. Edilizia abitativa nell’Italia preromana, Atti del XXIII Convegno Internazionale di Studi sulla Storia e l’Archeologia dell’Etruria (Orvieto 11-13
Di Filippo Balestrazzi, Elena. 1988. Lucerne del Museo di Aquileia, 1-2, lucerne romane di età repubblicana ed imperiale. Aquileia: Associazione Nazionale, 1988.
484
Bibliografia
di Gennaro, Francesco, e Vincenzo d’Ercole. 2017. “L’abitato e le tombe di età preromana di Campli. Un racconto millenario.” In Campli. Indagini sul patrimonio culturale, a cura di Roberto Orsatti, Aldo G. Pezzi, e Emanuela Tritella, 71-96. Pineto: Riccardo Condò, 2017.
Empereur Jean Yves, e Antoinette Hesnard. 1987. “Les amphores hellénistiques du monde egéen.” In Céramiques hellénistiques et romaines II, a cura di Pierre Lévêque, e Jean Paul Morel, 9-71. Paris: Belles Lettres, 1987. Faustoferri, Amalia. 1997. “L’area sacra di Fonte San Nicola: i Votivi.” In I luoghi degli dei. Sacro e natura nell’Abruzzo italico (Catalogo Mostra Chieti, 16 maggio – 18 agosto 1997), Documenti dell’Abruzzo antico, a cura di Adele Campanelli, e Amalia Faustoferri, 99100, 106-108. Pescara: Carsa edizioni, 1997.
Di Meo S. 2006a. “Vogelkopflampen.” In Roma. Memorie dal sottosuolo. Ritrovamenti archeologici 1980/2006 (Catalogo della Mostra di Roma, 2006), a cura di Maria Antonietta Tomei, 203-204. Milano: Electa, 2006. Di Meo S. 2006b. “Instrumentum domesticum.” In Roma. Memorie dal sottosuolo. Ritrovamenti archeologici 1980/2006 (Catalogo della Mostra di Roma, 2006), a cura di Maria Antonietta Tomei, 208-209. Milano: Electa, 2006.
Faustoferri Amalia. 2001. “Tornareccio. La necropoli di via De Gasperi.” In Eroi e Regine. Piceni Popolo d’Europa, Catalogo della Mostra (Roma 12 aprile-1 luglio 2001), 318-321. Roma: De Luca, 2001.
Di Niro, Angela (a cura di). 2007. Il Museo sannitico di Campobasso. Catalogo della collezione provinciale. Pescara: Carsa Ed., 2007.
Ferrara, Bianca. 2009. I pozzi votivi nel santuario di Hera alla foce di Sele, Quaderni del Centro Studi Magna Grecia 8 (Silaris 1). Pozzuoli: Naus, 2009.
Di Sabatino, Ilaria, e Valeria Acconcia. 2016. “Capestrano (AQ). La necropoli preromana in loc. Fontanelle di Capo d’Acqua: scavi 2012.” Quaderni di Archeologia d’Abruzzo 4/2012 (2016): 156-159.
Ferrara, Bianca. 2017. Il santuario di Hera alla foce del Sele. La ceramica a vernice nera, Quaderni del Centro di Studi Magna Grecia 15 (Silaris 2). Pozzuoli: Naus Editoria Archeologica, 2017.
Di Sabatino, Ilaria, Serafino L. Ferreri, e Federica Properzio. 2014. “La necropoli in località Fontanelle a Capo d’Acqua, Capestrano.” In Ritualità funeraria e convivialità. Tra rigore e ostentazione nell’Abruzzo preromano, Officina Etruscologia 10, a cura di Valeria Acconcia, 275-284. Roma: Officina Edizioni, 2014.
Ferreri, Serafino L. 2014. “Progettazione del «Repertorio georeferenziato di archeologia abruzzese».” Atti 18a Conferenza Nazionale ASITA (Firenze 14-16 ottobre 2014): 541-548.
Dionisio, Anna. 2015. La valle del Sagittario e la conca peligna, Abruzzo, tra il IV e il I secolo A.C: dinamiche e sviluppi della romanizzazione, BAR International Series 2735. Oxford: BAR Publishing, 2015. Dyson, Stephen L. 1976. Cosa. The utilitarian pottery, Memoirs of the American Academy in Rome 33. Roma: American Academy in Rome, 1976.
Ferreri, Serafino L. 2016. “Fotointerpretazioni archeologiche su dati cartografici web-based in ambiente QGIS: alcune applicazioni nel territorio aquilano-vestino.” In ArcheoFOSS. Free, Libre and Open Source Software e Open Format nei processi di ricerca archeologica, Atti del IX Workshop (Verona 19-20 giugno 2014), Archeologia e Calcolatori, suppl.8, a cura di Patrizia Basso, Alessandra Caravale, Piergiovanna Grossi, 121-125. Firenze: All’Insegna del Giglio, 2016. Ferreri, Serafino L., e Paolo Panci. 2017. “Ricerche epigrafiche nei territori di Aufinum e
485
Capestrano, I
Peltuinum: considerazioni topografiche inediti.” Epigraphica 79 (2017): 434-454.
e Giuliani Pomes, Maria Vittoria. 1954. “Cronologia delle situle rinvenute in Etruria.” Studi Etruschi 23 (1954): 149-194.
Finkielsztejn Gérald. 2001. Chronologie détaillée et révisée des éponymes amphoriques rhodiens, de 270 à 180 av. J.C. environ: premier bilan. BAR International Series 990. Oxford: BAR Publishing, 2001.
Grassi, Barbara. 2000. Vasellame e oggetti in bronzo: artigiani e committenza, Capua Preromana, VIII, Catalogo del Museo provinciale Campano. Pisa: Ist. Ed. e poligr. Internaz., 2000.
Fossataro, Domenico. 2008. “Progetto Capestrano: ricognizioni e scavi, campagne 2000-2004.” In SOMA2005, Proceedings IX Symposium Mediterranean Archaeology (Chieti 24-26 February 2005), BAR International Series 1739, a cura di Oliva Menozzi, Domenico Fossataro, e Maria L. Di Marzio, 357-368. Oxford: BAR Publishing, 2008.
Grassi, Barbara. 2003. “Il vasellame e l’instrumentum in bronzo della necropoli di Campovalano nel quadro delle produzioni dell’Italia preromana.” In I Piceni e l’Italia medio-adriatica, Atti del XXII Convegno di Studi Etruschi ed Italici (Ascoli PicenoTeramo-Ancona 9-13 aprile 2000), a cura dell’Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici, 491-518. Pisa-Roma: IEPI, 2003.
Franchi Dell’Orto, Luisa. 2010a. “Il Guerriero di Capestrano e la statuaria medio-adriatica.” In Pinna Vestinorum e il popolo dei Vestini, Storia e civiltà di Penne, 1, a cura di Luisa Franchi dell’Orto, 180-225. Roma: L’Erma di Bretschneider, 2010.
Greco, Giovanna, e Angela Pontrandolfo, a cura di. 1990. Fratte, un insediamento etruscocampano, Catalogo della Mostra (Museo Archeologico provinciale di Salerno). Modena: Franco Cosimo Panini, 1990.
Furger, Alex R. 1990. “Les ateliers de poterie de la ville d’Augusta Rauricorum (Augst et Kaiseraugst, Suisse).” Société Française d’Étude de la Céramique Antique en Gaule (Actes du Congrès de Mandeure-Mathay, 24-27 maggio 1990), 107-127.
Grifoni Cremonesi, Renata. 1969. “La grotta cultuale delle «Marmitte» presso Ofena (L’Aquila).” Atti Società Toscana di Scienze Naturali, Memorie, Serie A, LXXVI (1969): 131-150.
Gabrielli, Roberta. 2010. Ceramica etruscocorinzia del museo archeologico di Tarquinia. Archaeologica 155, Materiali del Museo archeologico nazionale di Tarquinia 19. Roma: G. Bretschneider, 2010.
Grinder Hansen, Keld. 1991. “Charon’s fee in ancient Greece? Some remarks on a wellknown death rite.” Acta Hyperborea III (1991): 207-218. Guidi, Alessandro, e Antonia Arnoldus Huyzenveld, Federico Bistolfi, Olga Colazingari, Maria Teresa Fulgenzi, Massimo Ruffo, Andrea Zifferero. 1996. “Cures Sabini. Lo scavo, le strutture, la cultura materiale, le attività economiche.” In Identità e civiltà dei Sabini (Atti del XVIII Convegno di Studi Etruschi e Italici, Rieti-Magliano Sabina, 30 maggio - 3 giugno 1993), 143-204. Firenze : Olschki, 1996.
Gamba, Mariolina. 1987. “Analisi preliminare della necropoli di Arquà Petrarca (Padova).” In Celti ed Etruschi nell’Italia centrosettentrionale dal V secolo a.C. alla romanizzazione (Atti del Colloquio Internazionale Bologna, 12-14 aprile 1985), a cura di Daniele Vitali, 237-270. Bologna: University Press, 1987. Gilotta Fernando, e Colonna Passaro (a cura di). 2012. La necropoli del Migliaro a Cales. Materiali di età arcaica, Monumenti Etruschi 11. Pisa: Serra, 2012.
Guidobaldi, Maria Paola. 1995. La romanizzazione dell’ager Praetutianus (secoli 486
Bibliografia
III-I a.C.), Aucnus III. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 1995.
späthallstattzeitlichen Fürstengrab von Eberdingen-Hochdorf (Kr. Ludwigsburg), 3. Stuttgart: Theiss, 1996.
Guzzo, Pier Giovanni. 1972. Le fibule in Etruria dal VI al I sec. a.C., Studi e materiali di etruscologia e antichità italiche XI. Firenze: Sansoni, 1972.
La Regina, Adriano. 1968. “Ricerche sugli insediamenti vestini.” Atti della Accademia nazionale dei Lincei. Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche. Memorie, s. 8, vol. 13, fasc. 5 (1968): 363-446.
Guzzo, Pier Giovanni. 1993. Oreficerie della Magna Grecia, Ornamenti in oro e argento dall’Italia Meridionale tra l’VIII ed il I secolo. Taranto: La Colomba, 1993.
La Regina, Adriano. 2010. “Il guerriero di Capestrano e le iscrizioni paleosabelliche.” In Pinna Vestinorum e il popolo dei Vestini, Storia e civiltà di Penne, 1, a cura di Luisa Franchi Dell’Orto, 230-273. Roma: L’Erma di Bretschneider, 2010.
Iaculli, Gabriele. 1981. “Attività della Soprintendenza archeologica d’Abruzzo (19701980).” Quaderni dell’Istituto di Archeologia e Storia antica dell’Università di Chieti 2 (1981): 193-215.
Landolfi, Maurizio. 1992. “Numana e la necropoli picena. La tomba 225 e 407 dell’area Davanzali di Sirolo.” In La civiltà picena nelle Marche. Studi in onore di Giovanni Annibaldi, Atti del Convegno (Ancona 10-13 luglio 1988), a cura della Soprintendenza ai beni archeologici delle Marche, 302-330. Ripatransone: Maroni, 1992.
Iezzi, Roberta. 2001. “Le tombe e i corredi (Comino di Guardiagrele).” In Terra di Confine tra Marrucini e Carricini. Archeologia nel territorio della Comunità Montana Maielletta, a cura di Sandra Lapenna, e Maria Ruggeri, 4559. Pennapiedimonte : Comunità montana della Maielletta, 2001.
Liberatore, Daniela. 1998. “La ceramica a vernice nera di Peltuinum.” In Indagini archeometriche relative alla ceramica a vernice nera: nuovi dati sulla provenienza e la diffusione (atti), a cura di Patrizia Frontini e Maria Teresa Grassi, 179-187. Como: Edizioni New Press, 1998.
Isernia. 1980, AA.VV., Sannio. Pentri e Frentani dal VI al I sec. a.C., catalogo della mostra (Isernia Ottobre-Dicembre 1980), Roma: De Luca, 1980. Isings, Clasina. 1957. Roman Glass from dated finds. Groningen: J.B. Wolters, 1957.
Lippolis, Enzo. 1984. La necropoli del Palazzone a Perugia. Ceramiche comuni e verniciate, Archaeologia Perusina 2. Roma: G.Bretschneider, 1984.
Jurgeit, Fritzi. 1999. Die Etruskischen und Italischen bronzen sowie gegenstände aus eisen, blei und leder im Badischen Landesmuseum Karlsruhe, Terra Italia Studi archeol.Italia antica 5. Pisa-Roma: Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 1999.
Lo Schiavo, Fulvia. 2010. Le fibule dell’Italia meridionale e della Sicilia dall’età del Bronzo recente al VI secolo a.C., Prähistorische Bronzefunde 14, 1-3. Stuttgart: Steiner, 2010.
Kohler, Christoph. 2000. “Die obeloi der Heuneburg.” In Importe und Mediterranee Einflüsse auf der Heuneburg, Heuneburgstudien 11, a cura di Wolfgang Kimming, 197-213. Mainz: v. Zabern, 2000.
Loeschcke, von Siegfried. 1919. Lampen aus Vindonissa. Ein Beitrag zur Geschichte von Vindonissa und des antiken Beleuchtungswesens. Zürich: In Kommission bei Beer & Cie, 1919.
Krausse, Dirk. 1996. Hochdorf III. Das Trinkund Speiseservice aus dem 487
Capestrano, I
Martelli, Marina. 1977. “Per una definizione archeologica della Sabina: la situazione storicoculturale di Poggio Sommavilla in età arcaica.” In Civiltà arcaica dei Sabini nella valle del Tevere. III. Rilettura critica della necropoli di Poggio Sommavilla, a cura di Paola Santoro, 948. Roma: CNR, 1977.
Lollini, Delia G. 1976. “La civiltà picena.” In Popoli e Civiltà dell’Italia antica 5, a cura di Valerio Cianfarani, Delia G. Lollini, e Mario Zuffa, 109-195. Roma: Biblioteca di storia patria, 1976. Lollini, Delia G. 1979. “I Senoni nell’Adriatico alla luce delle recenti scoperte.” In Les mouvements celtiques du Ve au Ier siècle avant nôtre ère, Actes du XXVIIIe colloque organisé à l’occasion du IXe Congrés International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques (Nice 19 settembre 1976), a cura di Paul M. Duval, e Venceslas Kruta, 55-79. Paris: Éditions du C.N.R.S., 1979.
Martellone, Alberta. 2010a. “Vetri fenici in Abruzzo.” In Pinna Vestinorum e il popolo dei Vestini, Storia e civiltà di Penne, 1, a cura di Luisa Franchi Dell’Orto, 308-327. Roma: L’Erma di Bretschneider, 2010. Martellone, Alberta. 2010b. “I raffinati mobili degli aristocratici: letti funerari in osso dal territorio vestino.” In Pinna Vestinorum e il popolo dei Vestini, Storia e civiltà di Penne, 1, a cura di Luisa Franchi Dell’Orto, 328-361. Roma: L’Erma di Bretschneider, 2010.
Lollini, Delia G. 1985. “Rapporto tra area romagnola e picena nel VI-IV sec. a.C.” In La Romagna tra VI e IV sec. a.C. nel quadro della protostoria dell’Italia centrale, Atti del Convegno (Bologna, 23 – 24 ottobre 1982), a cura di G. Bermond Montanari, 323-350. Bologna: University Press 1985.
Mattingly, Harold, e Edward A. Sydenham (a cura di). 1926. Roman Imperial Coinage, vol. II. London: Spink & Son Ltd, 1926.
Macchiarola, Ida. 1989. “I corredi del sepolcreto sannitico di Gildone.” In Il sepolcreto sannitico di Gildone. I corredi del sepolcreto di Gildone, in Conoscenze Rivista annuale della Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Molise, 5 (1989): 27-71.
Mattingly, Harold (a cura di). 1936. Coins of the Roman Empire in the British Museum, vol. III. London: British Museum, 1936. Maurizio A.M. 1995. “Sei tombe di età repubblicana da Tocco da Casauria” Quaderni dell’Istituto di Archeologia e Storia Antica dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio”di Chieti-Pescara, 5 (1995): 130-160.
Mangani, Elisabetta. 1986. Corpus Vasorum Antiquorum, Grosseto, II, Italia, fasc. LXIII. Roma: La libreria dello Stato, 1986.
Mazzeo Saracino, Luisa (a cura di). 2005. Il complesso edilizio di età romana nell’area dell’ex Vescovado a Rimini, Studi e Scavi 21. Firenze: All’Insegna del Giglio, 2005.
Marabini Moevs, Maria Teresa. 1973. The Roman Thin Walled Pottery from Cosa (19481954), Memoirs of the American Academy in Rome, 32. Roma: American Academy in Rome, 1973.
Melandri, Gianluca. 2012. “Un esempio di pianificazione funeraria nella necropoli di Bazzano (AQ)” Mediterranea IX (2012): 157194.
Marinangeli, Giacinto. 1977. Il guerriero italico di Capestrano, Quaderni storico artistici dell’Aquilano 4. Spoleto: Grafiche Panetto e Petrelli, 1977.
Menozzi, Oliva, e Maria G. Di Antonio. 2014. “Aufinum (Capestrano): scavi e ricognizioni.” Quaderni di Archeologia d’Abruzzo 3/2011 (2014): 288-297.
Marini, Silvia. 2012. “Sigillata italica, sigillata africana e lucerne dal museo di Rosignano Marittimo.” Fastionline 258 (2012): 1-20
488
Bibliografia
Menozzi, Oliva, e Domenico Fossataro. 2011. “Capestrano: scavi e ricognizioni 2003-2009.” In Il Fucino e le aree limitrofe nell’antichità, Atti del III Convegno di Archeologia (Avezzano 13-15 novembre 2009), a cura di Adele Campanelli, e Walter Cianciusi, 476-480. Avezzano: Archeoclub d’Italia, Sezione della Marsica, 2011.
l’Etruria. Cultura, identità e territorio dei Falisci, a cura di Gabriele Cifani, 173-216. Roma: edizioni Quasar, 2013. Mieli, Gianfranco. 1998. “I reperti della necropoli di Colle Santa Rosa.” In Archeologia in Abruzzo. Storia di un metanodotto tra industria e cultura, a cura di Vincenzo d’Ercole, e Roberta Cairoli, 43-62. Montalto di Castro: Arethusa, 1998.
Menozzi, Oliva, Domenico Fossataro, Serena Torello di Nino, e Vincenzo d’Ercole. 2014. “Aufinum: città e necropoli.” In I Vestini e il loro territorio dalla Preistoria al Medioevo, Collection de l’École française de Rome 494, a cura di Stéphane Bourdin, e Vincenzo d’Ercole, 265-290. Roma: École française de Rome, 2014.
Milano 1980 = Gli Etruschi e Cerveteri: nuove acquisizioni delle civiche raccolte archeologiche. La prospezione archeologica nell’attività della Fondazione Lerici (catalogo della mostra, Milano Palazzo Reale settembre 1980-gennaio 1981). Milano: Electa, 1980.
Menzel, Heinz. 1954. Antike Lampen im Römisch-Germanischen Zentralmuseum zu Mainz,Kataloge des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 15. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 1954.
Montanaro, Andrea C. 2015. “I vasi di bronzo della « Collezione Sansone » di Mattinata (FG): osservazioni sulle produzioni e sulla circolazione” Mélanges de l’École Française de Rome – Antiquité 127, 1 (2015): 57-95.
Mercando, Liliana. 1974a. “Marche Rinvenimenti di tombe di età romana.” Notizie degli Scavi, VIII, XXVIII (1974): 88-143.
Montelius, Oscar. 1895-1910. La civilisation primitive en Italie depuis l’introduction des métaux. Stockholm: Imprimerie royale, 18951910.
Mercando, Liliana. 1974b. “Portorecanati (Macerata) - La necropoli romana di Portorecanati.” Notizie degli Scavi, s. VIII, XXVIII (1974): 142-445.
Morel, Jean-Paul Maurice. 1981. Céramique campanienne: les formes, Bibliothèque des écoles françaises dAthènes et de Rome 244. Roma: Écoles Françaises de Rome, 1994.
Mercuri, Laurence. 2004. Eubéens en Calabre à l’èpoque archaïque: formes de contacts et d’implantation, Biliothèque des écoles françaises d’Athènes et de Rome, fasc. 321. Rome: École française de Rome, 2004.
Morelli, Anna L. 1999. “Monete da contesti funerari dell’Emilia Romagna.” In Trouvailles monétaires de tombes, Actes du deuxième colloque international du Groupe Suisse pour l’étude des trouvailles monétaires (Neuchâtel 34 mars 1995), a cura di Oivier F. Dubuis, Suzanne Frey-Kupper, e Gilles Perret, 169-180. Lausanne: Editions du Zèbre, 1999.
Messineo, Gaetano. 1997. “La stipe di Basciano.” In Δ’Eπιστημoνική Συνάντηση για την Eλληνιστική Kεραμική. ρoνoλoγικά πρoβλήματα, κλειστά σύνoλα, εργαστήρια (Atti del IV Convegno Internazionale sulla Ceramica Ellenistica, Mitilene 1994), 183-193. Aθήνα: K’ Eφoρεία Πρoϊστoρικών και Kλασικών Aρχαιóτητων, 1997.
Moretti, Giuseppe. 1936/7. “Il guerriero italico e la necropoli di Capestrano.” Bullettino di Paletnologia Italiana, n.s. 1 (1936/7): 94-114. Moretti, Giuseppe. 1938. Il guerriero italico di Capestrano. Roma: Istituto Poligrafico dello Stato, 1938.
Michetti, Laura Maria. 2013. “Appunti sull’agro falisco tra V e III sec. a.C. alla luce di un corredo di Corchiano.” In Tra Roma e 489
Capestrano, I
di Archeologia 28. Mantova: Archeologica Padana, 2003.
Mura Sommella, Anna. 2015. “La tomba 114 della necropoli di San Martino a Capena.” In I falisci attraverso lo specchio, Atti della giornata di studio per festeggiare Maria Anna De Brolli (Mazzano Romano 31 ottobre 2015), a cura di Maria Cristina Biella e Jacopo Tabolli, 206215. Roma: Officina Edizioni, 2015.
Società
Ortner, Donald J. 2003. Identification of pathological conditions in human remains, 2nd Edition. San Diego: Academic Press, 2003. Papi, Raffella. 1979. “Materiali archeologici da Villalfonsina (Chieti).” Archeologia Classica XXXI (1979): 18-95.
Naso, Alessandro. 2003. I bronzi etruschi e italici del Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Kataloge vorund frühgeschichtlicher Altertümer 33. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 2003.
Papi, Raffaella. 1980. “Materiali sporadici da Loreto Aprutino (PE).” Archeologia Classica XXXII (1980): 16-49. Parise Badoni, Franca. 2002. “Alfedena: una comunità del Sannio Pentro.” Studi Etruschi LXV (2002): 71-89. Parise Badoni Franca, e Maria Ruggeri Giove. 1980. Alfedena. La necropoli di Campo Consolino: scavi 1974-1979. Chieti: Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo, 1980.
Naso, Alessandro, e Gerhard Tomedi. 2015. “Spade corte tra Piceno ed Europa centrale.” In Sui due versanti dell’Appennino. Necropoli e distretti culturali tra VII e VI sec. a.C., Atti del Seminario (Santa Maria Capua Vetere 12 novembre 2013), Biblioteca di Studi Etruschi 55, a cura di Fernando Gilotta, e Gianluca Tagliamonte, 235-245. Roma: G.Bretschneider, 2015.
Parise Badoni, Franca, Maria Ruggeri Giove, Camillo Brambilla, Gherardini P. 1982, “Necropoli di Alfedena (scavi 1974-1979): proposta di una cronologia relativa.” AION Annali di archeologia e storia antica. Istituto universitario orientale. Dipartimento di studi del mondo classico e del Mediterraneo antico, n.s. 4 (1982): 1-41.
Negroni Catacchio, Nuccia. 2003. “Le ambre picene. Indagine sui manufatti non figurati e contatti e scambi con le aree adriatiche.” In I Piceni e l’Italia medio-adriatica, Atti del XXII Convegno di Studi Etruschi ed Italici (Ascoli Piceno-Teramo-Ancona 9-13 aprile 2000), a cura dell’Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici, 451-469. Pisa-Roma: IEPI, 2003.
Pavić, Izida. 2007. “Feinware: Becher und Faltenbecher des 2. und 3. Jahrhunderts von Wien 1, Michaelerplatz – Grabungen 1990/1991.” Fundort Wien. Berichte zur Archäologie 10 (2007): 134-193.
Nicosia, Angelo. 1976. Ceramica a vernice nera dalla stipe di Mèfete (Aquinum nel territorio di Castrocielo-Frosinone). Pontecorvo : Gruppo Archeologico, 1976.
Pavolini Carlo. 1981. “Le Lucerne dell’Italia romana.” In Società romana e produzioni schiavistica II. Merci, mercati e scambi nel Mediterraneo, a cura di Andrea Giardina e Aldo Schiavone, 139-184. Bari: Laterza, 1981.
Olcese, Gloria. 1993. Le ceramiche comuni di Albintimilium. Indagine archeologica e archeometrica sui materiali dell’area del Cardine, Quaderni del Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti Sezione Archeologica – Università di Siena 35. Firenze: All’Insegna del Giglio, 1993.
Pavolini Carlo. 1987. “Le lucerne romane tra il III secolo a.C. e il III secolo d.C.” In Ceramiques Hellénistiques et Romaines II, a cura di J.Pierre Lévêque e Jean Paul Maurice Morel, 139-166. Paris: Belle Lettres, 1987.
Olcese, Gloria. 2003. Ceramiche comuni a Roma e in area romana. Produzione, circolazione e tecnologia (tarda età repubblicana-prima età imperiale), Documenti 490
Bibliografia
Colombaria, serie studi 19. Firenze: L.S. Olschki, 1971.
Pellegrini, Enrico. 1989, La necropoli di Poggio Buco: nuovi dati per lo studio di un centro dell’Etruria interna nei periodi orientalizzante ed arcaico, Monumenti etruschi 6. Firenze: L.S.Olschki, 1989.
Peroni Renato. 1998. “Classificazione tipologica, seriazione cronologica, distribuzione geografica.” Aquileia Nostra 69 (1998): 9-28.
Pera, Rossella. 1993. “La moneta antica come talismano.” In Moneta e non moneta, Atti del Convegno Internazionale di Studi Numismatici in occasione del Centenario della Società Numismatica Italiana (1892-1992) (Milano 1115 maggio 1992), Rivista Italiana di Numismatica e scienze affini XCV, a cura di Vincenzo Cubelli, Daniele Foraboschi, e Adriano Savio, 347-361. Milano: Società Numismatica Italiana, 1993.
Pizzoferrato, Orietta. 2004. “Le indagini archeologiche nell’area urbana.” In Gli Equi tra Abruzzo e Lazio, Catalogo della Mostra (Oricola, 2004), a cura di Sandra Lapenna, 131147. Sulmona: Synapsi, 2004. Pucci, Giuseppe. 1981. “La ceramica italica. Terra sigillata.” In Società romana e produzioni schiavistica. 2. Merci, mercati e scambi nel Mediterraneo, a cura di Andrea Giardina, e Schiavone Aldo, 99-121. Roma: Laterza, 1981.
Perassi, Claudia. 1999. “Monete nelle tombe di età romana imperiale: casi di scelta intenzionale sulla base dei soggetti e delle scritte?”, In Trouvailles monétaires de tombes, Actes du deuxième colloque international du Groupe Suisse pour l’étude des trouvailles monétaires (Neuchâtel 3-4 mars 1995), a cura di Oivier F. Dubuis, Suzanne Frey-Kupper, e Gilles Perret, 43-69. Lausanne: Editions du Zèbre, 1999.
Pucci, Giuseppe. 1985. “Terra sigillata italica.” In Enciclopedia dell’arte antica classica e orientale. Atlante delle forme ceramiche. Ceramica fine romana nel bacino mediterraneo (tardo ellenismo e primo impero), II, 359-406. Roma: Istituto della Enciclopedia italiana, 1985. Radmilli, Antonio M. 1977. Storia dell’Abruzzo dalle origini all’età del bronzo, Collana di studi paletnologici, 1. Pisa: Giardini, 1977.
Perassi, Claudia. 2011. “Monete amuleto e monete talismano. Fonti scritte, indizi, realia per l’età romana.” Numismatica e Antichità Classiche. Quaderni Ticinesi 40 (2011): 223276.
Rasmussen, Tom B. 1979. Bucchero Pottery from Southern Etruria. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
Percossi Serenelli, Edvige. 1992. “La tomba di Sant’Egidio di Tolentino nella problematica dell’orientalizzante piceno.” In La civiltà picena nelle Marche. Studi in onore di Giovanni Annibaldi, Atti del Convegno (Ancona 10-13 luglio 1988), a cura della Soprintendenza ai beni archeologici delle Marche, 140-177. Ripatransone: Maroni, 1992.
Ricci, Andreina. 1985. “Ceramica a pareti sottili.” In Enciclopedia dell’arte antica classica e orientale. Atlante delle forme ceramiche. Ceramica fine romana nel bacino mediterraneo (tardo ellenismo e primo impero), II, 241-357. Roma: Istituto della Enciclopedia italiana, 1985.
Peroni, Renato. 1967. “Tipologia e analisi stilistica dei materiali nella preistoria. Breve messa a punto.” Dialoghi di Archeologia 1,2 (1967): 155-158.
Ricci Marina. 1973. “Per una cronologia delle lucerne tardo-repubblicane.” Rivista di Studi Liguri 39, 2-4 (1973): 168-234.
Peroni, Renato. 1971, L’età del Bronzo nella penisola italiana. I. L’antica età del Bronzo, Accademia toscana di scienze e lettere La
Riccitelli, Paola. 1998. “L’uso funerario di Campo Valentino.” In Archeologia in Abruzzo. Storia di un metanodotto tra industria e cultura,
491
Capestrano, I
Salvia Del Rosario, Rosella. 1984. “La necropoli di Capestrano. Nota preliminare.” Quaderni dell’Istituto di Archeologia e Storia antica dell’Università di Chieti 3 (1984): 49-55.
a cura di Vincenzo d’Ercole, e Roberta Cairoli, 81-92. Montalto di Castro: Arethusa, 1998. Riccitelli, Paola. 2001. “Tomba 22.” In Terra di Confine tra Marrucini e Carricini. Archeologia nel territorio della Comunità Montana Maielletta, a cura di Sandra Lapenna, e Maria Ruggeri, 58-59. Pennapiedimonte : Comunità montana della Maielletta, 2001.
Salvia Del Rosario, Rosella. 1985. “Necropoli arcaiche d’Abruzzo. La necropoli di Capestrano.” Papers in Italian Archaeology, 4, 3. Patterns in protohistory (Cambridge Conference January 1984), BAR International Series 245 (1985): 165-173.
Rizzo, Maria Antonietta (a cura di). 1990. Le anfore da trasporto e il commercio Etrusco arcaico. I. Complessi tombali dall’Etruria meridionale, Studi di archeologia 3, catalogo della mostra (Roma, Museo nazionale di Villa Giulia 1984). Roma: De Luca, 1990.
Salvini, Monica. 2003. “Il territorio camerte: un crocevia.” In I Piceni e l’Italia medio-adriatica, Atti del XXII Convegno di Studi Etruschi ed Italici (Ascoli Piceno-Teramo-Ancona 9-13 aprile 2000), a cura dell’Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici, 171-180. Pisa-Roma: IEPI, 2003.
Robino, Mirella T.A. 2003. “Alcune considerazioni morfologiche e stilistiche sulla ceramica alto-adriatica dalle necropoli di Adria: i crateri, gli skyphoi e gli stamnoi.” Padusa 39 (2003): 103-141.
Salzani, Luciano (a cura di). 1996. La necropoli gallica e romana di S. Maria di Zevio (Verona), Documenti di Archeologia 9. Mantova: Editrice S.A.P., 1996.
Roma 2001. Eroi e Regine. Piceni Popolo d’Europa, Catalogo della Mostra (Roma 12 aprile-1 luglio 2001). Roma: De Luca, 2001.
Sannazaro, Marco (a cura di). 2001. Ricerche archeologiche nei cortili dell’Università Cattolica. La necropoli tardoantica, Atti delle giornate di studio (Milano 25-26 gennaio 1999), Contributi di Archeologia 1. Milano: Vita e Pensiero, 2001.
Romito, Felicia, e Daniela Sangiovanni. 2008. “Tombe « a grotticella » peligne di età ellenistica.” In Ricerche di archeologia medioadriatica I. Le necropoli: contesti e materiali, Atti dell’Incontro di Studi (Cavallino-Lecce 2728 maggio 2005), Università del Salento: Archeologia e Storia 8, a cura di Gianluca Tagliamonte, 195-230. Galatina: Congedo, 2008.
Sannibale, Maurizio. 2008. La raccolta Giacinto Guglielmi. Parte II. Bronzi e materiali vari, Catalogo Museo gregoriano etrusco 4.2. Roma: L’Erma di Bretschneider, 2008.
Rossi D. 2006. “Via Aurelia, centro commerciale Colasanti (Municipio XVI Ovest). Abitazione.” In Roma. Memorie dal sottosuolo. Ritrovamenti archeologici 1980/2006 (Catalogo della Mostra di Roma, 2006), a cura di Maria Antonietta Tomei, 526-529. Milano: Electa, 2006.
Savini, Valentina, e Vincenzo Torrieri. 2002. La Via Sacra di Interamnia alla luce dei recenti scavi. Teramo: Deltagrafica, 2002.
Sabbatini, Tommaso. 2008. “Le armi: ostentazione e uso.” In Potere e splendore. Gli antichi Piceni a Matelica, Catalogo della Mostra (Matelica 19 aprile – 31 ottobre 2008), a cura di Mara Silvestrini, e Tommaso Sabbatini, 207-214. Roma: L’Erma di Bretschneider, 2008.
Schaefer, Maureen, Sue Black, e Louise Scheuer. 2009. Juvenile Osteology. A Laboratory Field Manual. San Diego: Academic Press, 2009.
Scatozza Höricht, Lucia A. 1986. I vetri romani di Ercolano. Roma: L’Erma di Bretschneider, 1986.
492
Bibliografia
Schmidt, Christopher W, e Steven A. Symes, eds. 2015. The analysis of burned human remains, second edition. San Diego: Academic Press, 2015.
Spanu, Marcello. 2004. “Aufinum.” In Viabilità e insediamenti nell’Italia antica, Atlante Tematico di Topografia Antica, 13, a cura di Stefania Quilici Gigli, e Lorenzo Quilici, 381392. Roma: L’Erma di Bretschneider, 2004.
Seidel, Stefan. 2006. “Die “Grabcomplexe”aus Montegiorgio – Untersuchungen zur Tracht und kulturhistorischen, regionalen Einordnung. I complessi tombali di Montegiorgio – Ricerche sul costume e valutazione storico-culturale.” In Montegiorgio. Die Sammlung CompagnoniNatali in Jena. La Collezione CompagnoniNatali a Jena a cura di Peter Ettel e Alessandro Naso, 74-176. Jena: Friederich-SchillerUniversität, 2006.
Sparkes, Brian A., e Lucy Talcott. 1970. Black and Plain Pottery of the 6th, 5th and 4th centuries B.C., 1-2, The Athenian Agora XII. Princeton/New Jersey: The American School of Classical Studies, 1970. Staffa, Andrea R .2000. “La necropoli italica del tratturo di Vasto (CH). Scavi 1911-1914.” Atti della Accademia nazionale dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche. Rendiconti 9,11 (2000): 543-637.
Serra Ridgway, Francesca R. 1996. I corredi del Fondo Scataglini a Tarquinia. Scavi della Fondazione ing. Carlo M. Lerici del Politecnico di Milano per la Soprintendenza Archeologica dell’Etruria Meridionale. Milano: 1996.
Staffa, Andrea R. 2001. “La necropoli presso il Campo Sportivo ex Gesuiti e l’abitato antico sui Colli di Pescara.” In Dalla valle del Piomba alla valle del basso Pescara, Documenti dell’Abruzzo Teramano V.1, a cura di Luisa Franchi Dell’Orto, 79-93. 2001. Teramo: Cassa di Risparmio, 2001.
Serritella, Antonia. 1995. Pontecagnano. 2.3. Le nuove aree di necropoli del IV e III secolo a.C., AION Annali di archeologia e storia antica. Istituto universitario orientale. Dipartimento di studi del mondo classico e del Mediterraneo antico, Quaderni 9. Napoli: Istituto Universitario Orientale, 1995. Serritella, Antonia. 2013, Un nucleo di tombe di armati tra IV e III sec. a.C. a Pontecagnano, Ergasteria 3. Salerno: Pandemos, 2013.
Staffa, Andrea R. 2003. “Nuove acquisizioni dal territorio dei Vestini Transmontani (VI-IV secolo a.C.).” In I Piceni e l’Italia medioadriatica, Atti del XXII Convegno di Studi Etruschi ed Italici (Ascoli Piceno-TeramoAncona 9-13 aprile 2000), a cura dell’Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici, 555-590. Pisa-Roma: IEPI, 2003.
Sgubini Moretti, Anna Maria. 1973. “Confronti con l’opposta riva del Tevere.” In Civiltà Arcaica dei Sabini nella valle del Tevere, II, Le scoperte della necropoli di Colle del Forno (Catalogo della Mostra maggio-luglio 1973), a cura di Paola Santoro,104-114. Roma: CNR, 1974.
Staffa, Andrea Rosario. 2003b. “La necropoli vestina in località Cappuccini di Loreto Aprutino.” In Dalla valle del Fino alla valle del medio e alto Pescara, Documenti dell’Abruzzo teramano VI.1, a cura di Luisa Franchi Dell’Orto, 83-97. Teramo: Fondazione Tercas, 2003.
Shefton, Brian Benjamin. 1979. Die “rhodischen” Bronzekannen. Mainz am Rhein: Zebern, 1979.
Stary, Peter F. 1981. Zur eisenzeitlichen bewaffnung und Kampfesweise in Mitteilitalien (ca. 9 bis 6 Jh. V. Vhr.), Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte, Bd. 3. Mainz am Rheim: von Zabern, 1981. Stevens, Susan T. 1991. “Charon’s Obol and Other Coins in Ancient Funerary Practice.” Phoenix XLV, 3 (1991): 215-229.
Silvestrini, Mara, e Tommaso Sabbatini (a cura di). 2008. Potere e splendore. Gli antichi Piceni a Matelica, Catalogo della Mostra (Matelica 19 aprile - 31 ottobre 2008). Roma: L’Erma di Bretschneider, 2008.
493
Capestrano, I
Stopponi, Simonetta. 2003. “Note su alcune morfologie vascolari medio-adriatiche.” In I Piceni e l’Italia medio-adriatica, Atti del XXII Convegno di Studi Etruschi ed Italici (Ascoli Piceno-Teramo-Ancona 9-13 aprile 2000), a cura dell’Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici, 391-416. Pisa-Roma: IEPI, 2003.
Monitoring, GIS Applications, and Geology VIII (Cardiff 15-18 September 2008),vol. 7110, a cura di Michel Ulrich, Daniel L. Civco, Manfred Ehlers, e Hermann J. Kaufmann, 711008/1-12. doi: 10.1117/12.801284. Tartara, Patrizia. 2016. “Attività di ricerca e sistematizzazione dei dati archeologici in Abruzzo.” In I tratturi fra ricerca e valorizzazione, Atti del Convegno (Foggia 28 novembre 2014), Collana di ricerche storiche tra Basso Medioevo ed Età Moderna, 2, a cura di Saverio Russo, e Stéphane Bourdin, 27-47. Foggia: Claudio Grenzi Editore, 2016.
Szilágy, János György. 1998. Ceramica etrusco-corinzia figurata. Parte II. 590/580 – 550 a.C. Firenze: Olschki, 1998. Tagliamonte, Gianluca, e Marina Raccar. 2007. “Materiali di tipo e di ascendenza lateniana nel medio e basso Adriatico italiano.” In Piceni ed Europa, Atti del Convegno internazionale (Piran 14-17 settembre 2006), Archeologia di Frontiera 6, a cura di Mitja Guštin, Peter Ettel, Maurizio Buora, 211-220. Udine: Società Friulana di Archeologia, 2007.
ten Kortenaar, Silvia. 2011. Il colore e la materia. Tra tradizione e innovazione nella produzione dell’impasto rosso nell’Italia medio-tirrenica, Officina Etruscologia 4. Roma: Officina Edizioni, 2011.
Tamassia, Katia. 1993. “La necropoli preromana di Adria, loc. Retratto-Donà.” Padusa 29 (1993):7-90.
Terrosi Zanco, Ornella. 1967. “Capestrano (L’Aquila). Su alcune tombe italiche rinvenute in località Capo d’Acqua.” Notizie degli Scavi di Antichità XXI (1967): 320-330.
Tartara, Patrizia. 2007. “Il territorio aquilano lungo il Tratturo Regio: primi dati per una carta archeologica sistematica (Area tra Bazzano e Capestrano).” In I campi aperti di Peltuinum dove tramonta il sole… Saggi sulla terra di Prata d’Ansidonia dalla Protostoria all’età moderna, Studi sulla Storia del Territorio 1, Deputazione Abruzzese di Storia Patria, a cura di Alessandro Clementi, 448-565. L’Aquila: Colacchi, 2007.
Terzani, Cristiana, e Maurizio Matteini Chiari (a cura di). 1997. Isernia. La necropoli romana in Località Quadrella. Roma: Gangemi Ed., 1997. Tiné Bertocchi, Fernanda. 1985. Le necropoli daunie di Ascoli Satriano e Arpi. Genova: Sagep, 1985. Torelli, Mario, J. B. Ward-Perkins, and Leslie Murray Threipland. “A Semi-Subterranean Etruscan Building in the Casale Pian Roseto (Veii) Area.” Papers of the British School at Rome 38 (1970): 62-121.
Tartara, Patrizia. 2008a. “Apporti della fotografia aerea all’identificazione delle necropoli e degli insediamenti vestini.” In Ricerche di archeologia medio-adriatica I. Le necropoli: contesti e materiali, Atti dell’Incontro di Studi (Cavallino-Lecce 27-28 maggio 2005), Università del Salento: Archeologia e Storia 8, a cura di Gianluca Tagliamonte, 163-194. Galatina: Congedo, 2008.
Tozzi, Carlo. 1966. “Il giacimento mesolitico di Capo d’Acqua (L’Aquila).” Bullettino di Paletnologia Italiana, n.s., XVII, 75 (1966): 13-25. Usai, Alessandro. 1993. “Capestrano, loc. Capo d’Acqua (Prov. de L’Aquila).” Notiziario Scavi e Scoperte Rivista di Scienze Preistoriche XLV (1993): 299-300.
Tartara, Patrizia. 2008b. “Historical and modern aerial photography for Cultural Heritage and environmental knowledge.” Proceedings of SPIE, Remote Sensing for Environmental 494
Bibliografia
Vegas, Mercedes, e Annarela Martín López. 1982. “Ceramica comun y de paredes finas.” In El santuario de Juno en Gabii, Bibliotheca Itálica 17, a cura di Martín Almagro-Gorbea, 451-504. Roma: Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, 1982. Vitali, Daniele (a cura di). 2003. La necropoli di Monte Tamburino a Monte Bibele, Studi e scavi 19. Bologna: Gedit: 2003. Von Eles Masi, Patrizia. 1982. La Romagna tra VI e IV secolo a.C. La necropoli di Montericco e la protostoria romagnola, Realtà regionale Fonti e studi 5. Bologna: University Press 1982. Vorlauf, Dirk. 1997. Die etruskischen Bronzeschnabelkannen. Eine Untersuchung anhand der technologisch-typologischen Methode, Internationale Archäologie 11. Espelkamp: Leidorf, 1997. Weber, Thomas. 1983. Bronzekannen. Studien zu ausgewählten archaischen und klassischen Oinochoenformen aus Metall in Griechenland und Etrurien, Archäologische Studien 5. Frankfurt am Main: P.Lang, 1983. Weidig, Joachim. 2008. “I pugnali a stami. Considerazioni su aspetti tecnici, tipologici, cronologici e distribuzione in area abruzzese.” In Ricerche di archeologia medio-adriatica I. Le necropoli: contesti e materiali, Atti dell’Incontro di Studi (Cavallino-Lecce 27-28 maggio 2005), Università del Salento: Archeologia e Storia 8, a cura di Gianluca Tagliamonte, 105-141. Galatina: Congedo, 2008. Weidig, Joachim. 2014. Bazzano - ein Gräberfeld bei L’Aquila (Abruzzen). I. Die Bestattungen des 8. - 5. Jh. v.Chr. Untersuchungen zu Chronologie, Bestattungsbräuchen und Sozialstrukturen im apenninischen Mittelitalien (Die Ausgrabungen 1992-2004 einschließlich einiger Fundkontexte der Grabung 2004-2005), Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseum Bd 112. Mainz: Schnell & Steiner, 2014.
495
APPENDICE NUMISMATICA La moneta della Tomba 206 di Capestrano Stefania Montanaro Le operazioni di scavo, condotte nel corso della campagna del 2007, hanno portato al rinvenimento della tomba 206. Una sepoltura a inumazione in fossa rettangolare, localizzata nell’area sud-occidentale del saggio di scavo, di un individuo subadulto in pessimo stato di conservazione. Il suo corredo (oltre a comporsi di tre balsamari in vetro, una coppetta, una lucerna, un’anforetta e un’olletta in ceramica comune) presenta una moneta. Si tratta di un dupondio emesso dall’imperatore Adriano tra il 119 e il 121 d.C. (fig. 1)1. Al fine di comprendere se la moneta sia stata introdotta in tomba insieme al defunto, oppure se deve essere considerata frutto di interventi successivi, si è proceduto ad una analisi del contesto. Quest’ultima ha rilevato la presenza della moneta in giacitura primaria, dunque non estranea all’atto delle esequie. I dati sugli altri materiali del corredo, ottenuti grazie ad un diligente esame, scalfiscono l’apparente dicotomia cronologica fra tali materiali e la moneta rinvenuta. La datazione degli altri oggetti, difatti, rientra in un range cronologico piuttosto ampio che spazia dall’età ellenistica alla prima età imperiale. Un altro elemento analizzato è la posizione della moneta rispetto al defunto. Dalle ricostruzioni effettuate, in base a ciò che si conserva dell’inumato, la moneta sarebbe stata deposta all’altezza del cranio, probabilmente nella zona della bocca. L’uso di deporre moneta all’interno delle sepolture è testimoniata nel mondo greco a partire dal V secolo a.C. 2 , si diffonde progressivamente dal IV sec. a.C. e si espande, anche in altre zone del Mediterraneo e non solo,
in età ellenistica. Tale usanza raggiunge l’apice nei primi decenni dell’età imperiale, senza, tuttavia, diventare un rito sistematico3. Queste offerte funerarie, spesso limitate ad una sola moneta ma non sempre, costituiscono il corredo di accompagnamento del defunto nel suo viaggio nell’Aldilà e sono state generalmente interpretate, dalla letteratura archeologica, con la definizione di “obolo di Caronte”. Unica credenza documentata nel mondo antico che potesse offrire una spiegazione. È ben nota, difatti, dalle fonti greche 4 e latine 5 la tradizione secondo cui doveva essere posta all’interno della bocca del defunto una moneta per il pagamento da versare a Caronte, demone traghettatore, affinché trasportasse l’anima al di là del fiume infernale Acheronte. Secondo la concezione antica la testa era la sede dell’anima, la quale lasciava il corpo sotto forma di ultimo respiro passando attraverso la bocca6; porre la moneta in bocca ne sottolineava la destinazione a Caronte. Veniva così offerta come atto di pietas per evitare che il defunto, impossibilitato a raggiungere gli Inferi, potesse tornare nel mondo terreno con grave danno e timore dei vivi7. Alla moneta destinata ad uso funerario era 3
Cantilena 1995, 166-167. La più antica testimonianza di Caronte, fine del VIinizi V sec. a.C., è in un frammento del poema epico Miniade (Fr. 1, p. 215 KinKel) riportato da Pausania. Nel quale, però, non si fa alcun riferimento al pagamento per il trasporto. Il compenso è indicato per la prima volta da Aristofane nella commedia le Rane, rappresentata nel 405 a.C. Qui Caronte richiede il pagamento di due oboli, e non di uno, per il trasporto negli Inferi. Si tratta di un commento ironico all’aumento dei prezzi nella società ateniese durante la guerra del Peloponeso (Aristofane, vv. 136-208; 140, 270). 5 Apuleio, Metamorphoses 6,18.; Giovenale, Saturae 3, 267-268. Inoltre Luciano, nel suo De Luctu X, menziona ironicamente questa tradizione. Egli nota come i coniugi inseriscano, al fine di pagare il trasporto, all’interno della bocca del caro defunto una moneta, non ponendosi però il problema di quale moneta sia in vigore nell’Aldilà. 6 Plinio, Naturalis Historia, 7, 53, 174. 7 Bonini 2003, 20-21. 4
1
Si rimanda al catalogo. Le prime attestazioni sono del terzo quarto del V secolo a.C. per la necropoli di Corinto e al secondo quarto dello stesso secolo per la necropoli di Olinto (Grinder-Hansen 1991, 211-212). Alla fine del V sec. a.C. si registra tale presenza a Poseidonia, Megara Iblea, Camarina, Pontecagnano e Alife (Cantilena 1995, 166-167).
2
497
Capestrano, I
attribuito anche un significato magico-rituale8, grazie alla sua forma rotonda (si riteneva che gli spiriti maligni non riuscissero a penetrare negli oggetti circolari) e in quanto metallica9. Per l’età romana la documentazione letteraria ci fornisce i termini utilizzati per indicare la tariffa richiesta dal nocchiero infernale 10 , oltre al termine generico di uiaticum 11 , ritroviamo: aes12, triens13, e stips14. Le fonti, sia di età greca che romana, qualificano questo tipo di offerta come costituito dalla collocazione di una sola moneta di scarso valore economico nella bocca del defunto. La documentazione archeologica offerta da ogni necropoli, fin dall’età greca, presenta, invece, una vasta gamma di variabili del rituale, sia per numero e tipo di esemplari, sia per la modalità della loro collocazione. Anzi rispetto alla totalità delle tombe con corredo monetale il numero di deposizioni con le canoniche caratteristiche indicate per “l’obolo di Caronte” (unica moneta in bocca) risulta esiguo15. La deposizione di moneta, inoltre, non doveva costituire una conditio sine qua non per arrivare o far giungere un’anima agli Inferi, altrimenti si dovrebbe ritrovare in tutte le sepolture o almeno nella maggior parte dei ritrovamenti16. K. Grinder-Hansen, dopo aver analizzato le fonti letterarie che citano il mito di Caronte e le evidenze archeologiche delle monete in tomba, ha proposto la sostituzione dell’espressione “obolo di Caronte” con una più generica “moneta per il defunto”, formula più neutra e generica che può essere applicata a più usi e funzioni della moneta17. Da queste riflessioni risulta evidente come la comprensione del legame moneta-tomba abbia
dato avvio ad un campo d’indagine ampio e complesso che appare ancora aperto18. Ad ogni modo l’utilizzo di questo dato è fondamentale per comprendere le varie e complesse sequenze del rituale funebre; tale elemento, dunque, deve essere analizzato, con un approccio contestuale, caso per caso. Gli oggetti deposti nelle tombe sono, difatti, parte del contesto in cui è collocato il defunto: in altre parole possono informarci sui gesti funebri. Il momento della sepoltura è di fondamentale importanza perché “…coinvolge una persona nelle sue convinzioni e nei suoi sentimenti più intimi…” 19 . L’interpretazione della presenza della moneta non è generalizzabile, indubbiamente non bisogna più nominare le monete in tomba tout court come “obolo di Caronte”20 e bisogna ammettere la possibilità di una pluralità di significati collaterali. La pratica di deposizione monetale in tomba era fortemente soggettiva e probabilmente “…dettata da tradizioni familiari, da gusti e volontà personali, su cui avranno influito ad un tempo modelli proposti da Roma come usi di origine italica, anche assai lontani nei tempi e nei luoghi… Certamente, in conclusione, non si può parlare di significato collettivo, ma piuttosto di scelta individuale, accanto alla quale si può forse intravedere, al più, una valenza familiare…”21. Per quando concerne la moneta rinvenuta nella tomba 206 di Capestrano possiamo cercare di cogliere dei dati utili a comprendere le valenze rituali. Primo dato è quello fornito dalla posizione dell’esemplare all’interno della tomba, ovvero nella zona della bocca (entro la bocca o appoggiata sulle labbra). Un’unica moneta posta in tale posizione coinciderebbe con le 18
Le conferenze tenute a Salerno ("Caronte Un obolo per l'Aldilà", 20-22 febbraio 1995) e a Neuchâtel ("Trouvailles monétaires de tombes", 3-4 marzo 1995) sono state le prime ad affrontare i problemi interpretativi relativi alla moneta proveniente dai contesti funerari greci e romani. Di recente si è svolta ad Atene un’altra conferenza (“A coin for the dead, coins for the living. Charon’s obol: the end of a myth?”, 23-24 novembre 2017) nel corso della quale si è cercato di analizzare le monete provenienti dai contesti funerari alla luce dei nuovi metodi di indagine nel campo dell’archeologia funeraria. 19 Perassi 1999, 46. 20 Perassi 1999, 46, nota 11. 21 Morelli 1999, 177.
8
Anche il chiodo rivestiva lo stesso significato simbolico (Ceci 2001, 90). 9 Perassi 2011, 223-274; Ceci 2001, pp. 90-91; Sannazaro 2001, 101; Pera 1993, 347-361; Stevens 1991, 215-229. 10 Perassi 1999, p. 46. 11 Plauto, Poenulus 71; Apuleio, Metamorphoses 6, 18. 12 Properzio, Elegiae 4, 11, 7-8; Apuleio, Metamorphoses 6, 18. 13 Giovenale, Saturae 3, 265-268. 14 Apuleio, Metamorphoses 6, 18. 20. 15 Sannazaro 2001, 101. 16 Ceci 2001, 91. 17 Grinder-Hansen 1991, 215-216. 498
Appendice numismatica
testimonianze letterarie che parlano del pagamento dovuto a Caronte, ovvero con specifica funzione di viatico per l’Aldilà. Da sottolineare come, anche in questo caso, il significato può non essere univoco. Il nominale utilizzato è il dupondio, il cui rinvenimento è attestato fra le deposizioni monetali in tomba di età romano-imperiale22. Rilevante, inoltre, l’alto numero di chiodi presenti nella sepoltura. Sarebbe interessante capire se tali chiodi siano tutti pertinenti alla cassa lignea, che conteneva l’inumato, oppure se ci può essere una associazione chiodomoneta. Quest’ultima è stata posta in evidenza in molte necropoli romano-imperiali23 e assume un forte rilievo nella visione della possibile funzione apotropaica della moneta in tomba24. Non si può, infine, escludere che “…anche gli aspetti iconografici e (o) epigrafici delle monete da deporre nelle sepolture potessero essere tenuti, da qualcuno, in considerazione, rivelando in tal modo la propria concezione sull’Aldilà…” 25 . Nel caso della moneta della tomba 206 potrebbe essere una scelta intenzionale la deposizione di un esemplare con la raffigurazione sul rovescio dell’Aeternitas, che regge nella mano destra la testa del sole e nella sinistra la testa della luna26, e la legenda: AETERNITAS AVGVSTI (fig. 2). L’immagine e l’iscrizione del rovescio di tale moneta alludono all’eternità del potere imperiale, tuttavia potrebbero acquistare, in questo ambito strettamente funerario, una spiccata valenza escatologica 27 . Probabilmente si è voluto, intenzionalmente, porre l’accento sul concetto di eternità in relazione al nuovo stato del giovane defunto28.
Fig. 1- Dupondio di Adriano coniato dalla zecca di Roma, 119-121 d.C. Fuori scala.
Fig. 2- Aeternitas stante drappeggiata, testa volta a s.; nella mano d., testa del sole; nella mano s., testa della luna. A s., [AET]ER[N]IT[AS AVGVSTI]. Fuori scala.
22
Ceci 2001, 88. Ceci 2001, 90. 24 L’uso dei chiodi rappresenterebbe una difesa contro ogni attentato ai resti custoditi in tomba (Sannazaro 2001, 110). 25 Perassi 1999, 43. 26 Il sole e la luna, il ciclo infinito del giorno e della notte, forniscono il concetto di immutabilità eterna. 27 Perassi 1999, 59. 28 Tandem liber, tandem tutus, tandem aeternus est (Consolatio ad Polybium 9,7); Ipse quidem aeternus meliorisque nunc status est, despoliatus oneribus alienis et sibi relictus (Consolatio ad Marciam, 5). 23
499