Fortificazioni tardo classiche e ellenistiche in Magna Grecia: I casi esemplari nell'Italia del Sud 9781841713953, 9781407327709
231 98 10MB
Italian Pages [201] Year 2005
Cover
Title Page
Copyright
Preface
Contents
Introduction
Part I
Ch. 1
Ch. 2
Part II
Ch. 1
Ch. 2
Ch. 3
Ch. 4
Ch. 5
Ch. 6
Ch. 7
Ch. 8
Part III
References
Illustrations
Recommend Papers

- Author / Uploaded
- Roberto Sconfienza
File loading please wait...
Citation preview
BAR S1341 2005 SCONFIENZA FORTIFICAZIONI TARDO CLASSICHE E ELLENISTICHE IN MAGNA GRECIA
Notebooks on Military Archaeology and Architecture No 1 Edited by Roberto Sconfienza
Fortificazioni tardo classiche e ellenistiche in Magna Grecia I casi esemplari nell’Italia del Sud
Roberto Sconfienza
BAR International Series 1341 9 781841 713953
B A R
2005
Fortificazioni tardo classiche e ellenistiche in Magna Grecia
NOTEBOOKS ON MILITARY ARCHAEOLOGY AND ARCHITECTURE EDITED BY ROBERTO SCONFIENZA
No 1
Fortificazioni tardo classiche e ellenistiche in Magna Grecia I casi esemplari nell’Italia del Sud
Roberto Sconfienza
BAR International Series 1341 2005
ISBN 9781841713953 paperback ISBN 9781407327709 e-format DOI https://doi.org/10.30861/9781841713953 A catalogue record for this book is available from the British Library
BAR
PUBLISHING
NOTEBOOKS ON MILITARY ARCHAEOLOGY AND ARCHITECTURE EDITED BY ROBERTO SCONFIENZA La nuova collana promossa dai BAR, della quale il presente volume costituisce il primo numero, nasce in seguito al desiderio di poter aprire uno spazio autonomo per le pubblicazioni di un settore specialistico degli studi archeologici e storicoarchitettonici, che è quello relativo al più ampio tema della storia militare. Non si danno perciò fin d’ora limiti cronologici o spaziali, volendo fornire al maggior numero di studiosi la possibilità di pubblicare studi inerenti il tema della collana. Per comunicazioni e proposte di pubblicazioni fare riferimento al responsabile: ROBERTO SCONFIENZA
***** La nouvelle collection lancée par les BAR, dont la présente édition constitue le premier exemplaire, remonte au désir de faire place aux publications concernant le secteur de l’histoire militaire, un secteur très spécialisé dans le panorama des études d’archéologie et d’histoire de l’architecture. Dans le but d’offrir au plus grand nombre d’auteurs la possibilité de publier leurs ouvrages, on n’a donné aucune limite spatiotemporelle aux sujets traités. Pour tout renseignement et proposition de publication s’adresser au responsable: ROBERTO SCONFIENZA
***** The new series, promoted by BAR, of which the present volume is the first issue, originates from the desire to open a new, autonomous ground for specialized publications concerning archaeological and historical studies, in particular relating to the wider field of military studies. No boundaries are set, concerning time and space, since the aim is to offer the most scholars the possibility to publish their works relating to the topic of the series. For any further suggestions and proposals of publications please contact the editor: ROBERTO SCONFIENZA
***** Der vorliegende Band stellt die erste Nummer der neuen von Bar geförderte Reihe dar. Diese Serie entsteht infolge des Wunsches einen selbständigen Platz zu schaffen, der für die Ausgaben eines fachmännischen Gebietes von der archäologischen und architektonisch-geschichtlichen Untersuchungen bestimmt ist. Von jetzt an, setzt man keine chronologischen oder räumlichen Grenzen; auf diese Weise hat ein größer Teil der Gelehrten die Gelegenheit die Untersuchung über den Gegenstand dieser Bücherreihe zu veröffentlichen. Für die Mitteilungen und Veröffentlichungsvorschlage darf man sich auf den Verantwortliche beziehen: ROBERTO SCONFIENZA
Roberto Sconfienza, via per Aglié n. 12, 10090, Cuceglio, (Torino), Italia n. tel. 0039-0124-492237; 0039-333-4265619 mail: [email protected] sito internet: http://www.archeofortificazioni.org
Prefazione Questo libro è nato in seguito ad uno studio condotto durante l’anno 2002, come conclusione del corso di Specializzazione in Archeologia Classica, seguito dall’autore presso l’Università di Torino. Si coglie l’occasione per rivolgere il pensiero alla professoressa Barra Bagnasco e per ringraziarla della sua costante presenza e dell’interessamento sempre dimostrato per queste ricerche. È anche l’occasione per ringraziare il professor Dario Palermo che ha spesso fornito suggerimenti e saggi consigli in merito al tema della ricerca, così come la dottoressa Rosina Leone, carissima amica e stimolante soggetto di confronto. Le ragioni che hanno spinto allo sviluppo del lavoro sono innanzitutto emotive, legate infatti a molti anni di frequentazione dell’Italia del Sud da parte di chi, nato all’ombra delle Alpi, ha conosciuto e amato i luoghi della Magna Grecia, negli anni in cui fu possibile vedere con i proprii occhi tanti posti, che fino ad allora erano soltanto parole scritte sui libri del Liceo o sui manuali universitari. Sempre di carattere affettivo è l’interesse e l’amore per le costruzioni militari, nato proprio durante gli anni dell’Università, avvicinandosi al tema dell’architettura militare greca attraverso i lavori di Garlan, Winter, Adam, prima ancora di sviluppare tale passione anche per le epoche successive. È a questo punto che trova la sua giusta collocazione il motivo razionale del presente lavoro, ossia la volontà di dare concretezza ad una suggestione derivante dal confronto fra epoche diverse della storia dell’architettura militare. È infatti assai stimolante scoprire che l’evoluzione della poliorcetica e della teichopoiìa greca, dal IV sec. a.C. in poi, ha dato origine a riflessioni teoriche e produzioni reali di fortificazioni, che hanno certamente precorso i tempi dell’architettura militare europea sviluppatasi in età moderna. Concetti come l’adeguamento costante alla natura del suolo, il fiancheggiamento e il tiro radente il terreno, la copertura reciproca fondano la sistematicità delle strutture difensive ellenistiche, così come accade nelle fortezze europee del XVI o del XVII secolo. Erano certamente diverse le tecnologie a disposizione degli ingegneri militari, la loro stessa condizione sociale, le fonti di energia, anche il materiale umano e le situazioni politiche, ma sia alle soglie dell’età ellenistica sia a quelle dell’età moderna la civiltà occidentale aveva raggiunto quelle particolari condizioni culturali e quegli strumenti conoscitivi, quali per esempio le nozioni di prospettiva rispettivamente multifocale e monofocale, che permettevano di concepire un rapporto dinamico fra opere e strumenti difensivi, con le logiche conseguenze nell’ambito della progettazione dei circuiti murari e delle singole strutture fortificate. Si è tentato perciò nel presente lavoro di capire quale fosse in Magna Grecia il livello di partecipazione a questa rinnovata cultura fortificatoria, tentando di ricostruire gli impianti difensivi delle antiche colonie, scelte come esempi, alla luce della loro effettiva operatività bellica e funzionalità strategica, ma tornando ancora con l’emozione ad immaginare le mura di Locri, Velia, Paestum, Taranto svettanti davanti al mare, con le loro catapulte pronte in batteria, e irradiate dal sole del Sud. A Maria Teresa e Pietro, i miei genitori 8 dicembre 2004
II
INDICE Prefazione
p. I
INDICE
p. III
INTRODUZIONE
p. IX
PARTE PRIMA
Il contesto storico militare
p. 1
CAPITOLO 1 La Poliorcetica e l’architettura militare greca dal IV sec. a. C. alla fine dell’età ellenistica - La strategia bellica fra Arcaismo e IV sec. a.C. - La città senza mura di Platone - La città ben difesa di Aristotele - Senofonte e il territorio - L’arte ossidionale nel IV sec. a.C. - Enea Tattico e la città funzionale alla difesa - Macchine d’assalto e artiglieria - La poliorcetica ellenistica - Filone di Bisanzio e la nuova teichopoiìa - Fortificazione ellenica e innovazioni ellenistiche
p. 3 p. 3 p. 4 p. 5 p. 7 p. 7 p. 8 p. 9 p. 11 p. 12 p. 14
CAPITOLO 2 Le vicende storico-militari della Magna Grecia fra IV e III sec. a. C. - Le Leghe Achea e Italiota - Le guerre dionigiane - L’avanzata degli Italici - La guerra di Pirro - La guerra annibalica
p. 21 p. 21 p. 21 p. 22 p. 22 p. 23
PARTE SECONDA
L’architettura militare tardo classica e ellenistica nelle città della Magna Grecia
p. 25
CAPITOLO 1 Taranto - Le fortificazioni taratine § L’acropoli § La città nuova - Datazione dell’impianto difensivo - Questioni interpretative § La Geländemauern § La tecnica costruttiva § Il fossato orientale § La porta Temenide § Il diateìchisma urbano
p. 27 p. 27 p. 27 p. 28 p. 29 p. 29 p. 29 p. 30 p. 30 p. 30 p. 31
CAPITOLO 2 Metaponto - L’impianto difensivo metapontino § Datazione § Il fronte settentrionale § Il fronte occidentale
p. 33 p. 33 p. 33 p. 34 p. 35
III
§ Il fronte meridionale § Il fronte orientale § Il fossato - Questioni interpretative § La fase arcaica § La tecnica costruttiva § Le torri e le porte di Metaponto § Le mura e il drenaggio urbano § I momenti finali
p. 36 p. 37 p. 37 p. 38 p. 38 p. 38 p. 39 p. 39 p. 39
CAPITOLO 3 Castiglione di Paludi - L’impianto difensivo § La porta a cortile § La porta a tenaglia § Cortine e fiancheggiamento § La tenaglia settentrionale § La tecnica costruttiva - Questioni interpretative § Datazione § La piazzaforte brezza § Alessandro il Molosso
p. 41 p. 41 p. 41 p. 42 p. 42 p. 42 p. 43 p. 43 p. 43 p. 43 p. 44
CAPITOLO 4 Crotone - L’impianto difensivo tardo classico § I fronti orientale e occidentale § Il fronte settentrionale § L’acropoli § Le fasi più antiche - Questioni interpretative § La Geländemauern § I capisaldi d’altura
p. 45 p. 45 p. 45 p. 47 p. 47 p. 47 p. 48 p. 48 p. 48
CAPITOLO 5 Caulonia - Le fortificazioni cauloniati § Datazione § Il fronte settentrionale § Il fronte nord-occidentale § La Neapolis occidentale § Il fronte sud-occidentale § Il fronte orientale § La fase di età classica - Questioni interpretative § La Geländemauern § Torri e fiancheggiamento § Le porte di Caulonia § La tecnica costruttiva § La funzionalità del sistema
p. 49 p. 49 p. 49 p. 50 p. 51 p. 52 p. 52 p. 53 p. 54 p. 54 p. 54 p. 55 p. 55 p. 56 p. 56
CAPITOLO 6 Locri Epizefiri - Il sistema difensivo locrese § Il circuito arcaico § Il fronte di mare § Il fronte meridionale § Il sistema fortificato delle alture § Il fronte settentrionale
p. 57 p. 57 p. 57 p. 58 p. 60 p. 61 p. 62
IV
- Questioni interpretative § La Geländemauern § La teichopoiìa locrese § Le mura e l’idrografia del sito § L’acropoli di Locri § Le duae arces di Livio
p. 63 p. 63 p. 63 p. 65 p. 65 p. 66
CAPITOLO 7 Velia - L’impianto difensivo velino § Tecniche costruttive e cronologia § Il Castelluccio § Il fronte settentrionale § Il diateìchisma fra il Castelluccio e l’acropoli § Il diateìchisma fra il Porta Rosa e il fronte di mare § Il fronte orientale § Il fronte di mare § L’acropoli di Velia - Questioni interpretative § I diateichìsmata § I porti e il fiancheggiamento § Le porte di Velia - La difesa del territorio § Le fortezze limitanee § Difesa territoriale e precetti teorici
p. 69 p. 69 p. 69 p. 70 p. 70 p. 71 p. 71 p. 72 p. 72 p. 73 p. 74 p. 74 p. 74 p. 74 p. 75 p. 75 p. 75
CAPITOLO 8 Paestum - Le fortificazioni di Paestum § Datazione dell’impianto § Il fronte settentrionale § Il fronte orientale § Il fronte meridionale § Il fronte occidentale § Il fossato - Questioni interpretative § Natura e fasi del circuito difensivo § Le fortificazioni della colonia latina § Il sistema di fiancheggiamento e tiro radente § Le porte di Paestum § Il fronte portuale
p. 77 p. 77 p. 77 p. 78 p. 79 p. 79 p. 81 p. 82 p. 83 p. 83 p. 84 p. 84 p. 85 p. 85
PARTE TERZA
La cultura fortificatoria della Magna Grecia fra il IV sec. a.C. e l’Ellenismo
p. 87
- La Geländemauern - Origine degli impianti difensivi - L’urbanistica e le mura § Impianto urbano e impianto difensivo § La funzionalità difensiva degli impianti urbani § I porti e le fortificazioni § Le acropoli § Sistema di drenaggio e sistema difensivo - Le opere della nuova teichopoiìa § Le torri § Le porte - Livello di «modernità» della nuova teichopoiìa - Conclusione
p. 87 p. 87 p. 88 p. 88 p. 88 p. 89 p. 89 p. 89 p. 90 p. 90 p. 90 p. 91 p. 91
V
BIBLIOGRAFIA
p. 93
- Abbreviazioni di periodici - Abbreviazioni di opere miscellanee e di autori vari - Fonti antiche - Storia, urbanistica, ingegneria, architettura militare - Ricerche storiche e archeologiche in Magna Grecia
p. 93 p. 93 p. 94 p. 94 p. 97
ILLUSTRAZIONI
p. 105
- Didascalie - Tavole fuori testo
p. 105 I - LXXIV
VI
... tØn ésfalestãthn §rumnÒthta t«n teix«n ofiht°on e‰nai polemikvtãthn, êllvw te ka‹ nËn eÍrhm°nvn t«n per‹ tå b°lh ka‹ tåw mhxanåw efiw ékr¤beian prÚw tåw poliork¤aw. … bisogna pensare che le mura solidamente edificate sono le più sicure in tempo di guerra, soprattutto adesso con le nuove invenzioni relative all’efficacia dei proiettili e delle macchine per l’assedio delle città. (ARISTOTELE, Politica, VII, 11, 9)
VII
VIII
INTRODUZIONE
sato o attualmente indagate, ma ancor oggi in gran parte apprezzabili sul terreno e rappresentative di tutte le altre fortificazioni magnogreche coeve.
Lo studio delle fortificazioni e dell’architettura militare in genere nell’ambito dell’Archeologia Classica costituisce un settore della ricerca che ha per oggetto manufatti specifici con funzioni e finalità proprie, connesse all’attività difensiva.
Un quadro di sintesi sul tema trattato in questa sede è inoltre reperibile in un articolo specifico dello stesso autore, di recente produzione, in cui si affronta l’argomento ampliando lo sguardo ad altre città della Magna Grecia, oltre alle otto qui analizzate per esteso, ma facendo convergere i dati in tematiche generali proprie dello studio architettonico militare, quali le tipologie difensive, il rapporto fra l’impianto urbanistico e le fortificazioni, le tecniche costruttive, la sistematicità dei circuiti difensivi1.
L’indagine può riguardare un insediamento urbano a tutti gli effetti o una semplice aggregazione di natura oppianea, un’entità territoriale di ridotte dimensioni, come la chòra di una città greca, ma anche una di respiro maggiore, com’erano gli stati ellenistici, o addirittura di ambito continentale come l’estensione dei limites imperiali romani. Si tratta sempre comunque dello studio di un diaframma che l’uomo antico poneva fra un «dentro» e un «fuori», il cui valore era dettato dalla cultura di chi lo pensava, di chi all’interno di un circuito difensivo, come quello delle città seleucidi d’oriente, sentiva racchiuse le manifestazioni precipue della grecità nei templi, nelle agoraì o nei ginnasi, di chi all’interno delle mura delle colonie d’occidente conservava le tradizioni più antiche delle proprie origini o anche di chi sui limites dell’impero aveva la sensazione di presidiare il confine fra il mondo civile e le terre ignote, dove non era giunta la cultura di Roma.
La documentazione grafica del presente lavoro, costituita da didascalie e illustrazioni dei diversi tipi di struttura difensiva presi in esame e dalle piante delle città italiote studiate, è allegata alla fine del testo, dopo la bibliografia.
Certamente, in ambito classico, la ricerca storica delle motivazioni che portarono alla creazione di una fortificazione coinvolge l’interesse di tutti gli studiosi che si occupano del mondo antico, poiché si tratta di un’attività implicante la lettura e la valutazione delle fonti letterarie ed epigrafiche e la ricerca delle testimonianze materiali sul terreno. In particolare la documentazione archeologica deve essere compresa sia a livello tecnico, in quanto si tratta di manufatti architettonici, sia a livello urbanistico e storicoterritoriale, in quanto espressione di un intervento umano nell’ambito di realtà insediative nascenti o già esistenti in un momento storico definito e in un sito specifico. Nel caso della presente ricerca, che pone mano ad un vasto argomento per quantità di dati e di località indagate o da indagarsi, si è ristretto il campo di studio all’ambito geografico dell’Italia meridionale, escludendo la Sicilia, e a quello cronologico del tardo classicismo ed ellenismo per innegabili ragioni di interesse e gusto personale e per la presenza di una stimolante corrispondenza fra gli eventi storici e lo sviluppo delle fortificazioni urbane. Nel tentativo di fornire un quadro esemplificativo generale e sufficientemente capace di sintetizzare i caratteri dell’architettura militare magnogreca e della strategia difensiva connessa alla creazione dei circuiti urbani, si è proceduto con la ricerca dei principi teorici elaborati in ambito poliorcetico ellenico a partire dal IV sec. a.C., per costruire un quadro contestuale in cui inserire l’analisi dei dati, reperiti nella bibliografia edita, inerenti otto città della Magna Grecia, scelte come esempi per ragioni storiche e in virtù delle testimonianze archeologiche, in pas-
1
IX
SCONFIENZA 2003.
X
PARTE PRIMA Il contesto storico-militare
classificazione delle opere difensive in quanto manufatti architettonici presenti in contesti archeologici, sia una lettura diacronica della loro funzione nell’ambito di studi più ampi riguardanti l’analisi storica della poliorcetica antica. I concetti fondamentali espressi da questi autori in materia di storia militare greca, riscritta alla luce dei dati letterari e archeologici e secondo una interpretazione che giustifica le scelte strategiche nell’ambito dello sviluppo socio-culturale, economico e politico della civiltà ellenica, sono basilari per capire le dinamiche storiche e territoriali che causarono il particolare sviluppo dell’architettura militare a partire dal IV sec. a.C., non solo nella Grecia continentale e in Asia, ma anche nelle aree di nostro specifico interesse, ovvero la Sicilia e soprattutto la Magna Grecia.
L’architettura militare antica è un argomento che interessa in modo particolare gli storici e gli archeologi da circa una trentina d’anni, dopo che le opere di alcuni studiosi hanno portato l’attenzione sull’argomento, chiarendo soprattutto che il manufatto difensivo appartiene a pieno diritto alla storia della cultura delle antiche civiltà e ad essa risulta strettamente connesso quanto alla genesi, all’utilizzo e all’evoluzione. Due autori sono certamente il punto di riferimento per chi si occupi di questa materia e nel caso della presente ricerca sono tanto più importanti quanto più risulta centrale il loro interesse per il mondo greco; si tratta di Frederik Elliot Winter, autore del volume Greek Fortifications edito nel 1971, e di Yvon Garlan, che ha pubblicato nel 1974 il libro intitolato Recherches de poliorcétique grecque. Essi hanno proposto sia una prima
1
2
CAPITOLO 1
La poliorcetica e l’architettura militare greca dal IV sec. a.C. alla fine dell’età ellenistica
Per capire le motivazioni storiche che stanno alla base della produzione di strutture difensive come quelle che si analizzano nella seconda parte di questo libro, è necessario considerare rapidamente l’evoluzione della strategia bellica nel mondo greco a partire dall’età arcaica, seguendo la linea indicata dal Garlan1.
valore ad un attacco diretto alla città, che non era luogo in cui si facesse la guerra. La strategia tradizionale restò in vigore fino alla Seconda Guerra del Peloponneso e fu praticata in occasione del medesimo conflitto attuando spesso l’epiteichismòs. Tuttavia è in questa occasione che si rileva una novità eccezionale, ovvero l’abbandono dell’Attica da parte degli Ateniesi alle scorrerie dell’esercito spartano e il ritiro di tutti gli abitanti della chòra all’interno delle mura, che circondavano e collegavano Atene e il Pireo, squilibrando così il rapporto fra città e territorio totalmente a favore della prima e capovolgendo le priorità della strategia tradizionale7. La ragio-ne per cui, fin dal 431 a.C., Pericle decise di non difendere l’Attica e di non affrontare in campo aperto l’armata di Archidamo era strettamente connessa alla consapevolezza di non poter vincere gli Spartani in battaglia, non-ché alla fiducia riposta nella forza navale di Atene e nel sicuro appoggio degli alleati. Pertanto il mezzo che consentì l’attuazione di tale strategia fu, per la prima volta nella storia greca, il riconoscimento di un valore assoluto conferito alla fortificazione; esso era già in embrione fin dagli anni successivi a Salamina, quando Temistocle volle l’edificazione delle Lunghe Mura per assicurare il collegamento protetto fra la città e il Pireo, il porto che per nessuna ragione avrebbe dovuto cadere in mano nemica8. Al momento in cui Pericle ruppe il rapporto tradizionale pòlis-chòra, non più le montagne dell’Attica, ma le mura di Atene sorsero come principale linea di difesa terrestre della città.
La strategia bellica fra Arcaismo e IV sec. a.C. È ben noto che lo stato greco si fondava sull’interazione di due componenti basilari che insistevano sulla stessa realtà territoriale e che trovavano l’una nell’altra una reciproca ragion d’essere, la chòra, il territorio esterno alla città, che da quest’ultima traeva la determinazione politica e giuridica e ad essa forniva i principali mezzi di sostentamento, e la pòlis, ossia la città vera e propria, costituita dalla realtà edificata, l’àsty, e dalla cittadinanza, i polìtai a pieno diritto2. Fin dai tempi più antichi, come potevano essere per esempio quelli delle guerre messeniche o della guerra lelantina3, la strategia attuata dalle pòleis in lotta aveva come principale obiettivo la conquista del territorio della città nemica e, come dice il Garlan, era questa «si non une loi de la guerre, du moin un prejugé attaché à la conduite des opérations militaires, que l’on pouvait evidemment transgresser […] non sans raisons sérieuses ni précautions»4. L’invasione o il controllo di un territorio, tramite incursioni e il possesso di punti strategici fortificati, secondo la pratica del cosiddetto epiteichismòs5, doveva indurre la città nemica al negoziato o allo scontro in campo aperto, dove l’esito della battaglia fra due eserciti oplitici sanciva i diritti del vincitore e gli oneri del vinto6. Si tratta di una strategia che fondava le proprie radici nelle tradizioni epiche ancestrali dei Greci e per questo motivo assunse il carattere assiomatico sottolineato dal Garlan, ma aveva inoltre una ragion d’essere elementare, che si esplicava nel controllo delle fonti di sostentamento principali del nemico, provenienti dalla chòra, e negava ogni
Dopo la guerra del Peloponneso si affermò quella che il Garlan definisce «stratégie nouvelle», caratterizzante il IV sec. a.C. e tutto l’Ellenismo. La strategia periclea e molte altre operazioni di natura ossidionale, svoltesi durante la guerra fra Atene e Sparta, dimostrarono con chiarezza il nuovo valore conferito alle fortificazioni urbane, tanto che la strategia del IV sec. a.C. si configurava come un temperamento empirico fra quella tradizionale e quella di Pericle, dando più valore ora alla difesa del territorio ora a quella della città secondo le necessità momentanee. Se si vuole cercare una regola generale per l’attuazione della nuova strategia, si può rilevare che permaneva uno squilibrio a favore della pòlis e a scapito della chòra, ma la seconda non veniva più totalmente abbandonata all’invasione nemica, diventava invece la sede di centri fortificati territoriali che si frapponevano in successione fra le frontiere e la città, ormai concepita come perno cen-
1 GARLAN 1974, pp. 20-103; GARLAN 1983. Un altro profilo storico che illustra l’evoluzione della starategia bellica nel mondo ellenico tenendo come punto di vista la trasformazione delle fortificazioni si trova in WINTER 1971, pp. 289-333. 2 BENGSTON 1988, pp. 130-132. 3 BENGSTON 1988, pp. 133-136. 4 GARLAN 1974, p. 21. 5 GARLAN 1974, pp. 33-34. 6 Per la guerra e la falange oplitica WARRY 1980, pp. 34-35, pp. 46-47; COURBIN 1985; DETIENNE 1985; FINLEY 1985; GARLAN 1985a, pp. 133-138; VIDAL NAQUET 1985; CANFORA 1989, pp. 53-59; HANSON 1990; SNODGRASS 1991, pp. 59-119; WARRY 1998, pp. 46-49; HANSON 1999, pp. 48-79; DUCAT 2000; PROST 2000a; SEKUNDA 2000; ANGLIM e a. 2002, pp. 17-31; BRIZZI 2002, pp. 9-18.
7
BENGSTON 1988, pp. 373-375; WARRY 1998, pp. 58-60; HANSON 1999, pp. 105-120. 8 GARLAN 1974, pp. 44-50; BENGSTON 1988, pp. 317-318.
3
trale della difesa dello stato, grazie al suo apparato di fortificazioni.
acque di scolo e gli abitanti, sentendosi protetti dalle fortificazioni, si rammolliscono ed evitano di lottare per trovare scampo dietro una difesa artificiale.
I motivi che determinarono la diffusione di questo nuovo modo di concepire la difesa e il valore delle sue componenti devono essere identificati nelle complesse vicende storiche che attraverso le fasi dell’egemonia spartana e di quella tebana vanno dal 404 a.C., ultimo anno della guerra del Peloponneso, al 338 a.C., anno della battaglia di Cheronea e dell’affermazione del dominio della Macedonia nella penisola ellenica9. In questo periodo le città greche non operarono più come singole entità nazionali, ma divennero parti integranti di leghe e anfizionie che svilupparono strategie di gruppo, per cui ogni pòlis era costretta a sacrificare l’interesse immediato e particolare, rappresentato innanzitutto dalla difesa del proprio territorio, ma doveva ottemperare alle esigenze comuni dell’organismo superiore al quale apparteneva. D’altro canto in una contingenza storica di guerra quasi endemica e di moltiplicazione esponenziale di occasioni di conflitto le pòleis non potevano sperare di mantenere un’assoluta autonomia10. Le battaglie campali si ridussero e prese piede una tattica di attacco e difesa territoriale che prevedeva il progressivo ritiro dei difensori verso le proprie città e, da parte degli aggressori, la conquista della città nemica per privare il blocco avversario di un suo organo operativo. Per tali ragioni le fortificazioni urbane assunsero un posto di primaria importanza, quale già si era manifestato nel caso di Atene all’inizio della Guerra del Peloponneso, ma da allora divenne un fenomeno riguardante tutta la Grecia e le colonie del Mar Nero e d’Occidente, dove altre potenze si confrontavano, seguendo però la stessa logica della madrepatria.
[…] Riguardo alle mura, Megillo, concordo con Sparta che bisogna lasciarle riposare e dormire nella terra, senza elevarle, per queste ragioni. Bene canta il detto poetico a loro proposito “il bronzo e il ferro devono formare le mura, piuttosto che la pietra”; ma inoltre ci copriremmo meritatamente di ridicolo a inviare ogni anno i nostri giovani nel territorio a scavare fossi, fare trincee, costruire opere per fermare i nemici, con il pretesto di non lasciare che questi invadano le frontiere del territorio, quando noi ci circondassimo di mura che innanzitutto non sono di alcuna utilità per la sanità pubblica e inoltre dispongono gli abitanti alla mollezza invitandoli a rifugiarsi laggiù senza lottare contro il nemico, a non perseguire la salvezza con guardie continue di notte e di giorno, ma a credere che, una volta barricati dietro mura e porte, essi non dovranno che dormire per essere protetti con sicurezza, come se non fossero nati per faticare e ignorassero che la facilità nasce in realtà dalla fatica […]13
Platone tuttavia prende anche in considerazione l’eventuale possibilità di fortificare la città, poiché gli uomini sentono comunque la necessità della protezione fornita dalle mura; egli pensa che le abitazioni più esterne debbano essere edificate su robuste fondazioni e con le pareti perimetrali allineate fra di loro lungo il perimetro circolare della città, in modo che essa appaia dall’esterno come un’unica grande casa, ovvero una compatta fortezza chiusa in se stessa: […] Tuttavia, se gli uomini hanno comunque bisogno di mura, è necessario fin dall’inizio gettare le fondamenta delle abitazioni dei singoli in modo che tutta la città sia un unico muro, allineando tutte le case sullo stesso piano dalla parte delle strade per assicurarne la difesa, considerando che l’aspetto di una città non è spiacevole quando assomigli ad un’unica casa e che, se così facilita la guardia, differirebbe soprattutto per la sicurezza […]14
La città platonica, oggetto di ampie dissertazioni nella Repubblica e nelle Leggi, è lo stato in cui si attua la giustizia perfetta, poiché governa un’oligarchia di filosofi; essa deve essere tutelata dai cattivi influssi provenienti dal mondo esterno e quindi è isolata e assolutamente autarchica. Pertanto la scelta del sito è vincolata a tali presupposti e porta ad individuare una località lontana dal mare, quindi esclusa dai grandi traffici commerciali e dal rapporto con altre genti e città, su un’altura nel cuore di un territorio boscoso e montuoso15. La posizione fortificata naturalmente induce Platone a svalutare la funzione difensiva delle fortificazioni urbane; cosicché la scelta di difendere il perimetro esterno della città con le pareti delle case limitanee diventa un’immagine metaforica della compattezza del corpo civico, più che un precetto tecnico di ingegneria difensiva.
La città senza mura di Platone Alla luce del cambiamento di strategia difensiva è interessante individuare quale fosse la valutazione che i Greci del IV sec. a.C. esprimevano in merito alla difesa della città e all’edificazione delle mura. Le opinioni espresse da Platone e Aristotele nelle opere in cui essi trattano della città e della sua costituzione, sembrano le più rappresentative ed emblematiche in materia11. Il passo platonico più significativo sul tema della difesa urbana si trova nel Libro VI delle Leggi12, in cui l’autore, dopo aver rilevato che le questioni pratiche da affrontare per fondare una nuova città sono l’edificazione dei templi, presso l’agorà, e la realizzazione delle fortificazioni, sostiene che è certamente preferibile la soluzione adottata da Sparta che era priva di mura. Infatti Platone ritiene che sia un nobile atteggiamento quello di considerare il bronzo e il ferro delle armi la vera difesa della città, piuttosto che la pietra che si utilizza per le mura. La cinta urbana compromette la salute pubblica, poiché fa da ostacolo alle
È comunque importante notare che la trasformazione dell’abitato più esterno in area difensiva comune a tutti i cittadini determina anche un mutamento della qualificazione di quel settore dello spazio privato, che in caso di necessità diventa pubblico. Pare quindi di scorgere in Platone la riconduzione palese delle fortificazioni alla sfera dello spazio pubblico e ancor più importante la loro in-
9
BENGSTON 1988, pp. 415-457; BENGSTON 1989, pp. 57-84; BETTALLI 1998, pp. 729-736; WARRY 1998, pp. 71-92. BETTALLI 1998, pp. 740-742. 11 GARLAN 1974, pp. 72-75; MARTIN 1974, pp. 18-24; GRECO-TORELLI 1983, pp. 248-250; ZACCARIA RUGGIU 1995, pp. 82-118. 12 Leggi (1951), VI, 778a-e, 779a-d.
13 Leggi (1951), VI, 778d-779a. Tutte le traduzioni dei passi citati sono a cura dell’autore, in nota è indicata l’edizione filologica di riferimento. 14 Leggi (1951), VI, 779b. 15 Leggi (1951), IV, 704a-d, 705a-b.
10
4
dividuazione come zona della città con specifica funzione difensiva, che impone la prevalenza della necessità pubblica sul carattere privato delle abitazioni periferiche.
testimone dell’evoluzione che l’arte militare greca del IV sec. a.C. stava attuando poiché, sebbene svaluti la fortificazione urbana, valorizza la difesa attiva di tutta la chòra e limita ad extrema ratio il ritiro all’interno delle mura per sostenere un assedio. Egli infatti, sempre nel passo delle Leggi su riportato, dice che sarebbe ridicolo che la città si cingesse di mura quando annualmente vengono inviati giovani guerrieri in tutto il territorio che, per prevenire le invasioni nemiche, scavano fossati ed elevano opere fortificate,
Esiste però un luogo della città platonica, l’acropoli, per il quale la fortificazione è prevista e risulta importante e qualificante. Secondo Platone la città deve essere divisa in dodici quartieri, ciascuno dei quali è dotato di acropoli; il cuore dell’impianto urbano è la zona più elevata dell’altura scelta per l’insediamento di ogni quartiere e su di essa devono sorgere i templi delle divinità eponime, raccolti intorno ad un’area aperta: praticamente l’agorà coincide con l’acropoli e la città non possiede una piazza autonoma. Le abitazioni private si raggruppano in cerchio attorno all’area dei templi, che, essendo nel punto orograficamente più rilevante del sito, deve essere fortificata nel modo migliore possibile.
tå d¢ tafreÊsontaw, tå d¢ ka‹ diã tinvn ofikodomÆsevn e‡rjontaw toÁw polem¤ouw18.
La città ben difesa di Aristotele La concezione della città nel pensiero di Aristotele risulta assai diversa rispetto a quella di Platone, dal momento che è diversa la considerazione del singolo cittadino di fronte allo stato. Aristotele non valuta infatti il polìtes semplice componente di una cittadinanza, uniforme e livellata dalla legislazione dei filosofi, come avviene nella città platonica, ma ciascun cittadino rappresenta un’individualità valida di per sé, che concorre con le altre al conseguimento del fine comune, la felicità e il benessere19. Deriva da questo presupposto che la casa privata, luogo in cui ogni cittadino esplica la sua individualità, non può essere morfologicamente uniformata ad un modello, come consiglia Platone20, né assolutamente divenire parte integrante di un sistema difensivo con carattere pubblico. In Aristotele dunque il problema della difesa urbana è affrontato separatamente da quello relativo all’individuazione e all’educazione del cittadino.
[…] Bisogna che ci siano dodici quartieri, uno nel centro di ciascuno dei dodici distretti. In ogni quartiere si deve sceglier dapprima la localizzazione dei templi e dell’agorà in onore degli dei e dei demoni che fan da corteo agli dei, sia le divinità locali dei Magneti, alle quali spettano gli onori che loro rendevano gli uomini di un tempo, sia Hestia, Zeus e Athena, sia tutte le altre divinità patrone dei dodici quartieri; dovunque si devono costruire i loro templi. Le case prima devono raggrupparsi intorno a questi templi, là dove il terreno sia più elevato, in modo da costituire il miglior posto fortificato possibile per il presidio […]16
Questa concezione è strettamente connessa alla costituzione oligarchica con cui Platone intende ordinare l’assetto politico della sua città e la fortificazione dell’acropoli, in quanto sede delle tradizioni religiose e immagine della patria, ne è la diretta conseguenza17. Platone per indicare le mura urbane, quando ne parla esplicitamente, come nel primo passo citato sopra, utilizza il termine te›xow al singolare, che significa «muro», ed è quello specifico che la lingua greca possiede per identificare la cinta muraria in genere, ovvero il diaframma che divide l’abitato dal territorio esterno. Quindi per l’autore la fortificazione è innanzitutto un muro, che come si è visto serve a separare l’acropoli da altri settori urbani. Nelle Leggi inoltre non compaiono indicazioni di torri o strutture sporgenti dal perimetro di cinta, né tanto meno dalla linea difesa delle case più esterne. Sembra pertanto che Platone percepisca ancora le mura in qualità di opere difensive statiche che devono dividere il «dentro» e il «fuori», l’attaccante e il difensore. Ciò potrebbe anche essere confermato dalle sue considerazioni morali sull’effetto negativo che la presenza delle mura esercita sull’indole dei cittadini: senza le mura i polìtai riescono a concepire e ad attuare una strategia difensiva attiva sul territorio, di attacco, senza rammollirsi al riparo delle fortificazioni. In questa prospettiva paradossalmente Platone è
Nel Libro VII della Politica compaiono innanzitutto considerazioni importanti sul territorio della città. Anche Aristotele sostiene che la chòra deve garantire l’autarchia, cioè deve rendere indipendente la città dai bisogni materiali e dalla mediazione di terzi per offrire ai cittadini una vita libera, piacevole e temperante21Tuttavia è fondamentale considerare l’imperativo della difesa. La chòra deve essere difficile da invadere per i nemici, facile da difendere o evacuare per gli abitanti e visibile interamente a colpo d’occhio. Perciò la città va collocata in una posizione strategica che tenga conto sia del rapporto con il mare sia di quello con il territorio e ogni punto della chòra deve essere agevolmente collegato con la città per stornare tempestivamente minacce o penetrazioni nemiche, ma anche per facilitare il trasporto dei prodotti in città, sia in pace sia in guerra22. Quindi Aristotele è favorevole all’apertura al mare della città, valutando più convenienti i vantaggi portati dal commercio marittimo che i rischi possibili per la morale cittadina23. Ma di nuovo ricorre una considerazione di carattere difensivo: l’apertura al mare offre, con quella di terra, una seconda via per ricevere
16
Leggi (1956),VIII, 848d-e. A questo proposito si può menzionare la descrizione della città di Atene arcaica, precedente alla catastrofe del tempo di Deucallione, che Platone presenta nel Crizia (1985, 112a-b), ricordando che gli antichi Ateniesi avevano costruito sull’acropoli i templi di Atena ed Efesto e intorno un’unica poderosa fortificazione. All’interno delle mura e a corona dei santuari sorgevano anche le abitazioni dei guerrieri, la classe più importante, all’esterno c’era la periferia costituita dall’abitato degli artigiani e degli agricoltori, poiché la collina dell’acropoli in quel tempo era assai più vasta e si estendeva dall’Eridano all’Ilisso.
17
18
supra p. 4 nota n. 13. Politica, II, 2, 22 ss. (1261a) . Leggi (1956), VIII, 847a-b. 21 Politica (1986), VII, 5, 1 (1326b). 22 Politica (1986), VII, 5, 3-4 (1326b). 23 Politica (1986), VII, 6, 1-2, 4 (1326b-1327a). 19 20
5
soccorsi in tempo di guerra e anche una migliore mobilità tattica per reagire agli attacchi degli invasori24.
Aristotele giunge così a parlare delle fortificazioni urbane. Egli afferma che coloro i quali negano valore alle mura e le considerano dannose per il coraggio e l’abilità militare della cittadinanza hanno una visione del problema troppo antiquata. Infatti è necessario tenere conto che il nemico può raggiungere una superiorità numerica tale, per cui il solo valore non è sufficiente a fermare l’invasione del territorio cittadino; inoltre lo stesso nemico dispone sempre più frequentemente di armi d’assedio distruttive:
A partire dal nono capitolo del Libro VII compaiono considerazioni più direttamente connesse alla difesa della città in rapporto all’urbanistica e alle strutture architettoniche. Aristotele dice che la città aperta sul mare deve essere collocata lungo la costa tenendo valido come primo parametro di valutazione per la scelta del sito la salubrità25. Segue immediatamente un secondo parametro che è quello inerente la localizzazione strategica in un punto che deve offrire ai cittadini un facile scampo e rendere difficili le operazioni ossidionali ai nemici. Aristotele rileva inoltre, come fatto importante in termini difensivi la scelta di un sito ricco di acque sorgive e la realizzazione di cisterne per le riserve idriche in caso di assedio, qualora i nemici interrompano gli acquedotti26.
Riguardo alle mura quelli che dicono che le città fiere del loro valore non ne devono avere, hanno una concezione troppo antiquata, e tanto più quando vedono che i fatti smentiscono quelle che così si vantano. Di fronte a nemici simili e appena superiori di numero, non c’è nulla di nobile nel provare a riporre la propria salvezza nella fortificazione delle mura. Ma, poiché capita e può verificarsi che la superiorità degli assalitori sia superiore al valore umano e alla virtù di pochi soldati, se bisogna assicurare la propria salvezza e non subire mali né oltraggi, è necessario pensare che le mura solidamente edificate sono le più efficaci in tempo di guerra, e ancor di più adesso che ci sono nuove invenzioni finalizzate all’aumento dell’efficacia nell’ambito dei proiettili e delle macchine d’assedio delle città28
Passando al tema della conformazione della città, prima di trattare il problema delle mura, Aristotele elabora alcune considerazioni relative all’impianto urbano. Esiste infatti un risvolto di carattere strategico e difensivo nella scelta di un tipo specifico di impianto; l’autore considera assolutamente funzionale e garante di un buon tenore di vita l’impianto ad assi ortogonali di Ippodamo di Mileto, che definisce «più moderno», tÚn ne≈teron trÒpon, ma per la difesa della città è migliore il tipo «antico», katå tÚn érxa›on xrÒnon, poiché le strade anguste, ad andamento irregolare e generalmente a schema concentrico, rendono difficoltosa l’azione dei nemici nell’abitato e facile la reazione dei difensori. Aristotele propone pertanto di adottare un sistema misto che prevede la partizione ortogonale solo di alcuni quartieri, mentre per altri, quelli strategicamente rilevanti per la difesa, è conveniente disporre le case non allineate, ma sfalsate l’una rispetto all’altra, come nelle coltivazioni delle viti, per rendere disagevole l’accesso all’abitato complicandone la viabilità.
Destano particolare interesse le parole finali di questo passo del Libro VII, in cui Aristotele dimostra piena consapevolezza del livello raggiunto dalla tecnologia delle macchine d’assedio. Egli sottolinea infatti che il risultato più importante raggiunto in questo campo è la miglior precisione di tiro e quindi l’efficacia dei proiettili lanciati che possono avere effetti estremamente dannosi sull’abitato, qualora non lo si voglia proteggere con le mura, e dimostra così di intuire immediatamente il rapporto serrato che si sta determinando fra le artiglierie e le strutture difensive. Dunque le fortificazioni della pòlis divengono essenziali, poiché sono lo strumento che integra la disparità numerica o un’eventuale inferiorità tecnologica dei difensori e che permette di resistere ancora sebbene il collegamento con la chòra sia stato interrotto dall’invasore. Aristotele spiega che la mancanza di mura è una sorta di invito per il nemico ad invadere più agevolmente il territorio29, dimostrando anche in questa occasione di essere testimone cosciente del suo tempo e di avere colto l’aspetto essenziale della nuova strategia difensiva che prevede un’interazione costante fra pòlis e chòra, in vista della prioritaria difesa urbana. La città, che rappresenta il cuore di uno stato greco, deve assumere l’aspetto di un robusto baluardo nel cuore del territorio, un’estensione geografica da difendere sui confini e regressivamente fino alla linea principale posta sulle mura: secondo quanto lo stesso Aristotele dice, le mura stanno alla pòlis come le montagne stanno alla chòra o i muri perimetrali ad una singola dimora.
D’altro canto si ritiene che la disposizione delle case private sia più piacevole e utile per le diverse attività, se essa adotta un impianto regolare, secondo un genere più moderno, ovvero quello di Ippodamo; ma per la sicurezza in guerra, va meglio il contrario, com’era nei tempi antichi. Perciò bisogna combinare queste due maniere, cosa che è possibile, se si dispongono le case come sono definite le vigne sfalsate presso i contadini, e non si deve ripartire tutta l’intera città secondo un piano regolare, ma soltanto in base alle parti e ai quartieri. Così, sia in vista della sicurezza, sia anche dell’eleganza, tutto sarà ben disposto 27
24 Politica (1986), VII, 6, 3 (1327a). D’altro canto nota il filosofo che ai suoi tempi sono ben visibili città o territori dotati di porti fortificati, lontani dal centro urbano, ma ad esso collegati da fortificazioni che garantiscono la protezione per queste «finestre» aperte sul mare (Politica [1986], VII, 6, 5 [1327a]). Sembra chiaro che Aristotele abbia in mente l’assetto topografico del Pireo rispetto ad Atene, collegato alla città dalle Lunghe Mura. 25 Politica (1986), VII, 11, 1-2 (1330a). Le città migliori e più sane sono quelle orientate verso est, seguono quelle esposte al vento del nord. 26 Politica (1986), VII, 11, 3 (1330a). Gli acquedotti delle città greche erano generalmente realizzati con percorso ipogeo e a scorrimento per gravità; l’invenzione degli acquedotti su arcate risale già all’età ellenistica, ma certamente le motivazioni strategiche e difensive hanno un peso rilevante nella scelta del percorso sotterraneo (WINTER 1971, p. 51; BURNS 1974, p. 405; KLINGENBERG 1980, pp. 208-209; TÖLLE KASTENBEIN 1993, pp. 51-68; SCONFIENZA 1996, pp. 27-28; SCONFIENZAZANNONI 1998, pp. 43-44). 27 Politica (1986), VII, 11, 6-7 (1330b).
Infine, in chiusura del capitolo undicesimo, Aristotele si preoccupa di dire «come» devono essere costruite le fortificazioni. Egli premette che la presenza delle mura non impedisce alla cittadinanza di comportarsi come se esse non ci fossero e quindi esorta a non perdere di vista il valore militare e l’educazione al coraggio in campo, ma riconosce che l’assenza di esse è un dato di fatto assoluta28 29
6
Politica (1986), VII, 11, 8-9 (1330b). Politica (1986), VII, 11, 10 (1330b).
mente negativo in caso di necessità. Il filosofo prosegue poi affermando in primo luogo che la cintura di fortificazioni deve contribuire all’ornamento della città e contemporaneamente assolvere la funzione difensiva nel migliore dei modi.
zione dell’assedio nella civiltà greca. Anche in quest’ambito gli studi del Garlan sono la fonte principale di dati e interpretazioni: essi mettono in luce il passaggio dalla pratica dell’assedio a blocco, «l’investissement», a quella dell’assalto34.
Ma assolutamente non si deve trascurare questo fatto, che coloro la cui città è circondata di mura possono utilizzarla in entrambi i modi, come munita o no di fortificazioni; ma per le città prive di mura non è possibile la scelta. Se questa è la condizione, non bisogna soltanto costruire una cintura di mura, ma anche apprestarle affinché contribuiscano all’ornamento della città e alle necessità belliche, nonché fra l’altro alle attuali invenzioni. Come infatti gli assalitori hanno l’appoggio di mezzi con cui assicurarsi il vantaggio, così i difensori ne hanno già scoperti alcuni, ma devono cercarne e immaginarne altri; infatti non si tenta affatto di attaccare chi sia ben preparato30
Nei secoli precedenti la Seconda Guerra del Peloponneso, come si è chiarito sopra, la conquista di una città non rappresentava la finalità principale della strategia d’invasione di uno stato, quindi poco importava condurre lo sviluppo delle ostilità fin sotto le mura della pòlis nemica. Nell’ultimo trentennio del V sec. a.C., durante il grande conflitto fra Atene e Sparta, risultava invece molto frequente l’investimento delle città, finalizzato al blocco di esse, interrompendo il rapporto con la chòra grazie alla presenza fisica dell’assediante di fronte alle mura. Le città erano circondate da opere d’assedio, quali i muri di controvallazione, i periteichìsmata, e gli assedianti attendevano che gli assediati, non potendo più tollerare il blocco a causa della fame e della sete o della situazione politica interna, cedessero le armi o decidessero di parlamentare. Questa è la prassi tradizionale di quell’arte dell’assedio che Tucidide definì poliorkìa, ossia il complesso di operazioni militari per cui si attuava l’investimento di una città, bloccandola fino alla resa35. Tale strategia prevedeva una reazione da parte dei difensori che opponeva al nemico la stessa determinazione nel saper resistere ad oltranza in una sorta di gara allo sfinimento; ne consegue che, dopo il fallimento dei tentativi in campo aperto per evitare l’assedio e la realizzazione delle opere di blocco, i difensori e gli assedianti erano separati soltanto dalle mura urbane, un diaframma invalicabile e inattaccabile che determinava un atteggiamento passivo nei confronti dell’attività ossidionale, specialmente da parte di un soldato qual era l’oplita nel suo ruolo tradizionale di componente della falange, concepita per lo scontro campale.
Secondo Aristotele dunque, come già sopra si è accennato, l’edificazione delle mura deve tenere conto delle invenzioni contemporanee in materia di tecnologie ossidionali, ma anche dei nuovi mezzi di reazione che sono a disposizione degli assediati e prevedere la possibile evoluzione degli stessi grazie a nuove invenzioni: in questo modo egli ribadisce una consapevolezza assoluta del rapporto armamento-fortificazione nato e rapidamente evolutosi nel corso del IV sec. a.C. Senofonte e il territorio È utile rilevare, al termine di questo excursus sul pensiero dei due maggiori sapienti greci, che il tema della difesa del territorio, così significativa nel IV sec. a.C., è ben presente in più luoghi dell’opera di Senofonte. A riprova del grande valore strategico assunto dal binomio pòlis-chòra in termini di difesa attiva, nell’Ipparchico l’autore presenta il caso di Atene e il problema della difesa dell’Attica sulle frontiere, proponendo l’utilizzo della cavalleria come arma dinamica e vincente per la resistenza sul territorio al di fuori delle mura urbane31.
Sempre in occasione della guerra del Peloponneso emerse accanto alla pratica dell’investimento quella dell’assalto, che consisteva nell’attacco ad un territorio nemico, facendo incursioni o occupandolo, per giungere fino alla conquista diretta della città. Tale pratica però non rientrava nella definizione tucididea di poliorkìa, in quanto risultava parallela e autonoma rispetto all’assedio tradizionale. L’assalto rivolto alle mura di una città nemica aveva carattere eccezionale, ma inizia ad essere registrato più frequentemente durante la terza ed ultima fase della guerra del Peloponneso (411-403 a.C.)36, dopo la rivoluzionaria esperienza dell’assedio ateniese di Siracusa del 415-414 a.C.37. In questa occasione fu applicata su vasta scala e con grandi mezzi la strategia dell’assalto, che precedentemente era scelta come soluzione eccezionale per conquistare rapidamente una città. Il teatro degli scontri fu la collina dell’Epipole, dove vennero poi realizzati il castel-
Nei Memorabili Senofonte si spinge oltre e propone la creazione di una vera e propria catena di posizioni fortificate per difendere l’Attica presso i passi montani al confine con la Beozia32. Infine nelle Entrate lo storico affronta anche il risvolto economico di una buona difesa territoriale e le sue ricadute sugli interessi ateniesi, giungendo a considerare necessario un rinforzo delle due fortezze che proteggevano le miniere del Laurion con l’edificazione di un terzo centro fortificato33. L’arte ossidionale nel IV sec. a.C. La natura della nuova strategia difensiva permette di approfondire una tematica fondamentale per la comprensione delle trasformazioni di cui furono oggetto le fortificazioni urbane a partire dal IV sec. a.C., ovvero la conce-
34
GARLAN 1974, pp. 106-147; GARLAN 1985a, pp. 164-168; GARLAN 1985b, pp. 251-253; SCONFIENZA-ZANNONI 1998, pp. 43-46. 35 GARLAN 1974, pp. 3-5. Per gli eventi bellici principali GARLAN 1974, pp. 108-125 passim; WARRY 1998, pp. 63-65; BENTLEY KERN 1999, pp. 97-134; MONTAGU 2000, pp. 62-81 passim. 36 BENGSTON 1988, pp. 397-406. 37 BENGSTON 1988, pp. 390-395; BENTLEY KERN 1999, pp. 123-134; MONTAGU 2000, pp. 71-75; ANGLIM e a. 2002, pp. 192-197.
30
Politica (1986), VII, 11, 11-12 (1330b-1331a). Ipparchico (1973), VII, 6-7. 32 Memorabili (1959), III, 5, 25, 27. 33 Entrate (1956), IV, 43-44. 31
7
lo Eurialo e la porta del Trìpylon, ma nel 414 a.C. sulla stessa altura i Siracusani, uscendo dalle mura, sferrarono ripetuti attacchi alla linea di controvallazione ateniese, inducendo gli assedianti a reiterati assalti alle fortificazioni, che finirono comunque per sfiancarli e costringerli a ritirarsi verso l’interno della Sicilia. Il corso di tali avvenimenti aveva così trasformato un assedio iniziato secondo la strategia tradizionale dell’investimento in uno scontro attivo fra due eserciti, che non si fronteggiarono in una pianura, schierati in linea secondo la formazione a falange, ma presso le mura di una città per il controllo del terreno esterno circostante e per la conquista delle opere difensive stesse.
toie: in questo caso è necessario scegliere punti di resistenza vantaggiosi per i difensori da tenere ad oltranza prima di ritirarsi in città e, qualora sia necessario il ripiegamento, essi devono essere localizzati in maniera che l’operazione non causi perdite41. Pertanto la ritirata avviene quando l’invasore è più forte del difensore, che deve utilizzare senza indugio la strategia della terra bruciata, sacrificando le risorse territoriali per impedire al nemico di poterle sfruttare a suo vantaggio durante l’investimento della città42. La difesa del territorio deve dunque essere condotta senza compromettere quella della città, che costituisce l’altro grande tema della Poliorcetica. Enea Tattico fonda i suoi precetti su esempi di avvenimenti reali e precisi, tanto che gli studiosi hanno potuto collocare cronologicamente l’opera intorno al 357-355 a.C. tenendo conto dei fatti citati e di quelli assenti. Questo legame con la pratica degli avvenimenti e dei luoghi rende la prospettiva dell’autore molto concreta e mirata all’illustrazione di una casistica di attività che devono essere svolte durante la resistenza all’assedio e all’assalto dell’invasore. Ma in questa sede sembra importante sottolineare che dalle pagine della Poliorcetica scaturisce un modello generale di città le cui componenti essenziali sono l’agorà, l’abitato e le mura, che assumono funzioni reali nell’ambito delle attività di difesa. Enea non insegna come costruire una pòlis e le sue opere difensive, ma ne considera le componenti alla luce delle loro funzioni e caratteristiche, positive o negative, nella realtà dell’evento ossidionale e degli esempi storici, derivandone precetti che possono migliorarle. Questo atteggiamento, che pervade il trattato, emerge subito all’inizio del Libro I, quando comincia la trattazione sulla disposizione delle truppe all’interno della città, che deve tenere conto dei servizi da svolgersi in relazione alle dimensioni della cinta fortificata e dell’assetto topografico urbano; la coscienza della forma della città è la prima condizione per una buona difesa.
La storia greca del IV sec. a.C., in cui si susseguirono fitte le guerre fra Sparta, Atene, Tebe, la Macedonia e in Occidente quelle fra Siracusa, Cartagine e la Lega Italiota, è ricca di eventi bellici in cui la conduzione degli assedi abbandonò la strategia del blocco e seguì un programma di approccio alla fortificazione nemica che doveva favorire le condizioni tattiche adeguate per sferrare l’assalto generale. Fu un momento in cui, parallelamente e per consequenzialità reciproca, la pratica dell’assalto si presentava come una componente essenziale della «stratégie nouvelle», che all’atto pratico dimostrava l’importanza assunta dalla fortificazione urbana nella nuova concezione difensiva della pòlis, ma che di questa fortificazione era soprattutto la causa principale quanto a sviluppo morfologico e tecnico. Enea Tattico e la città funzionale alla difesa È nell’ambito di questo nuovo modo di concepire l’assedio e la difesa di una città che trova posto la Poliorcetica di Enea Tattico, il più importante studioso di strategia ossidionale vissuto nel IV sec. a.C.38. Nell’opera sono distinte due tematiche principali che riflettono chiaramente la contemporanea adozione della «stratégie nouvelle» e della pratica dell’assalto: la difesa del territorio in occasione di invasione nemica e la difesa della città assediata e sotto attacco nemico.
Dopo aver studiato la disposizione delle truppe in rapporto alla grandezza della città e alla sua disposizione topografica, alle ordinanze delle sentinelle, alle ronde e a tutti gli altri servizi che necessitano di uomini nell’area della città, bisogna fare la ripartizione delle medesime tenendo conto di tutto ciò43
Per la prima tematica Enea sviluppa una strategia difensiva all’insegna della resistenza ad oltranza su tutto il territorio e attestata in più punti di esso per cederne a caro prezzo le porzioni che man mano il nemico riesce a conquistare. La norma ferrea è quella di non dare mai battaglia in campo all’invasore, sia in fase di resistenza sia di contrattacco, a meno che non si disponga di un numero superiore di uomini39. È poi necessario organizzare il territorio in modo tale che sia difficile per il nemico penetrarvi, accamparsi, rifornirsi e attraversare i corsi d’acqua40. I territori geograficamente difficili da invadere vanno difesi mantenendo il controllo delle poche e anguste vie per ritardare o impedire totalmente l’avanzata del nemico verso la città. Tale avanzata è più agevole se la natura del territorio non crea passaggi obbligati o stret-
Ma quando le forze sono chiuse dentro le mura ed hanno come obiettivo la salvezza dei cittadini, non bisogna più prendere disposizioni in merito a nulla di simile, ma in relazione alle posizioni in città e al pericolo che si corre al momento44
Nel Capitolo III Enea spiega come organizzare la reazione dei polìtai ad un attacco nemico; innanzitutto le tribù urbane devono tirare a sorte il settore di fortificazione da sorvegliare e difendere, facendo salvo tuttavia il principio che uniforma la grandezza della tribù alla lunghezza del tratto murario affidato45. Le adunate devono compiersi nell’agorà, in piazze pubbliche secondarie e nel teatro, luoghi in cui i capi di ogni isolato limitrofo conducono, in 41
Poliorcetica (1967), XVI, 16-18. Poliorcetica (1967), VIII, 3-5. 43 Poliorcetica (1967), I, 1. 44 Poliorcetica (1967), I, 3. 45 Poliorcetica (1967), III, 1. 42
38
BON 1967, pp. VII-XXX; LORETO 1995, pp. 576-579. Poliorcetica (1967), XVI, 7. 40 Poliorcetica (1967), VIII, 1. 39
8
caso di allarme, i proprii uomini e da lì, seguendo il percorso più breve, ogni reparto raggiunge le mura.
d’appoggio per protezioni di schermi lignei e gabbioni colmi di terra e sassi o addirtittura per la tensione di vele fra una torre e l’altra che possono intercettare i dardi o costringerli a traiettorie troppo elevate51. Nel secondo caso le fortificazioni stesse divengono l’oggetto del contendere, perché i difensori devono riuscire a neutralizzare l’azione delle macchine d’assalto, prima fra tutte l’ariete che batte in breccia le strutture murarie52; è necessario quindi riuscire a intercettare la testa dell’ariete dall’alto degli spalti e poi distruggere la macchina facendovi precipitare sopra un pesante macigno:
Necessita che i capi degli isolati conducano gli uomini degli isolati più vicini all’agorà nell’agorà, quelli degli isolati vicini al teatro nel teatro, e che i capi li riuniscano negli altri luoghi aperti, ciascuno in quello più vicino, accompagnati da quelli che sono venuti a raggiungerli in armi. In questo modo dunque ciascuno potrebbe raggiungere le postazioni convenienti assai velocemente, restando il più vicino possibile alla propria abitazione, e mandare le sue disposizioni a quelli che sono rimasti a casa, figli e moglie, non essendo distante da essi […]46
Questo tipo di organizzazione illustra palesemente il rapporto funzionale che lega ai fini difensivi le componenti urbanistiche, infatti gli spazi pubblici sono punti di raccolta per gli uomini che provengono dalle aree residenzali e che devono essere guidati presso quelle difensive, muovendosi attraverso il tessuto connettivo costituito dall’impianto stradale. A tal proposito Enea consiglia inoltre di sopprimere tutte quelle parti della città che possono creare problemi tattici o di ordine pubblico durante il periodo d’assedio, come per esempio le piazze secondarie o addirittura le agoraì che richiedono l’utilizzo di troppi uomini per la guardia47. Così pure l’autore sostiene che tutte le porte della città devono essere ostruite, per evitare la presenza di troppi varchi percorribili attraverso le mura; se ne deve mantenere aperta una sola, quella il cui accesso dall’esterno è più difficile e meglio governato dalle strutture difensive.
Preparare anche protezioni contro le macchine, arieti e altre simili a questa, che battono le merlature; sospendere davanti sacchi pieni di paglia, ceste piene di lana, otri in cuoio di bue scorticato di fresco gonfiati o riempiti di qualunque cosa e altre cose con la stessa funzione. E quando o una porta o un altro settore delle mura sia battuto in breccia, bisogna sollevare la testa dell’ariete con un laccio, affinché la macchina non possa più colpire. E star pronti a colpire e a spaccare il trapano facendo cadere un macigno grande come un carico di carro; far scivolare il macigno da travi sporgenti , trattenuto con dei ganci53
In tali frangenti le mura possono anche essere oggetto di parziali interventi strutturali, aprendovi una piccola breccia per far passare una macchina difensiva, il contrariete o antìkrion, un lungo palo che colpisce la macchina nemica durante l’approccio al settore sotto attacco. Anche questo è un eccellente sistema da provvedere contro le macchine che battono le mura in breccia. Quando si sappia verso quale punto delle mura stiano avanzando, bisogna in quello stesso punto preparare un contrariete davanti alla parte interna delle mura, forandole fino al paramento esterno dei mattoni , affinché i nemici non vedano nulla prima. Quando la macchina sia ben vicina, colpire così verso l’esterno con il contrariete; e il contrariete è di granlunga assai potente54
Quando una città è in allarme, è necessario anche provvedere a queste cose. Tener chiuse tutte le altre porte, ma averne una aperta, dalla quale è più difficile l’avvicinamento alla città e saranno avvistati il più rapidamente possibile quelli che si avvicinano48
Le fortificazioni inoltre devono essere costantemente sorvegliate dai servizi di ronda. Questi vengono adunati presso l’agorà e, divisi in due gruppi che seguono percorsi opposti, ispezionano tutto il perimetro stando al piano della città; contemporaneamente lungo i camminamenti delle cortine e delle torri compiono lo stesso percorso altri reparti di soldati divisi per file che si preoccupano di controllare la parte interna delle fortificazioni e il terreno esterno.
Macchine d’assalto e artiglieria Il nuovo clima culturale in ambito militare permise definitivamente di concepire lo scontro con il nemico oltre i limiti della battaglia campale e di ritrovare anche nell’assalto alle mura l’esercizio delle antiche virtù guerriere che l’oplita manifestava in campo aperto, imitando un modello epico tradizionale. Questa stessa cultura tuttavia era aperta anche all’applicazione di nuove tecnologie echeggiate nel trattato di Enea Tattico e che forse in maniera prosaica, ma decisamente efficace, fornivano un valido appoggio ai soldati impegnati nell’assalto alle fortificazioni di una città55. Questa è infatti l’epoca in cui iniziò il grande sviluppo della meccanica militare per la produzione di macchine d’assalto, fondamentali nelle azioni contro le mura nemiche, sia come strumenti d’appoggio alle fanterie, sia come dirette armi d’offesa56.
In caso di pericolo bisogna dapprima che due compagnie di quelle adunate nell’agorà svolgano delle ronde ai piedi delle mura, in senso inverso l’una rispetto all’altra, e che i soldati siano dotati di armi e segni distintivi, per riconoscersi senza errore il più lontano possibile49 Se contemporaneamente fanno altre ronde sulle mura ‹…› in modo che alcuni sorveglino l’interno delle mura, altri l’esterno50
Infine nel Capitolo XXXII Enea Tattico tratta l’argomento dei dispositivi di difesa che si pongono in opera sulle mura per respingere l’assalto nemico. La fortificazione è qui percepita come contesto d’azione e rappresenta sia il diaframma che deve intercettare i proiettili scagliati dalle macchine d’assedio, sia il vero e proprio campo di battaglia. Nel primo caso le componenti delle mura servono
51
Poliorcetica (1967), XXXII, 1-2. infra p. 10 nota n. 57. 53 Poliorcetica (1967), XXXII, 3-5. 54 Poliorcetica (1967), XXXII, 7. 55 Sulla posizione delle tèchnai nella società e nella cultura classica e sul loro sviluppo teorico PLEKET 1973. 56 L’argomento è stato trattato in una sintesi generale, attingendo dalla bibliografia relativa, in SCONFIENZA-ZANNONI 1998, pp. 49-58. In questa sede si fa solo rapidamente cenno ai vari tipi di macchine per evidenziarne l’importanza in relazione alla trasformazioni tecniche e architettoniche delle fortificazioni greche. 52
46
Poliorcetica (1967), III, 5-6. Poliorcetica (1967), II, 1. 48 Poliorcetica (1967), XXVIII, 1. 49 Poliorcetica (1967), XXVI, 1. 50 Poliorcetica (1967), XXVI, 5. 47
9
Uno strumento d’assalto di origine assai antica, diffuso nel Vicino Oriente e nel mondo greco, fu certamente l’ariete57, che a partire dal IV sec. a.C. e per tutto l’Ellenismo, abbandonò le dimensioni ridotte per il trasporto e l’utilizzo manuale e si trasformò in una grande macchina, il cui palo percussore poteva anche superare una lunghezza di 50 metri e infliggere danni gravissimi alle mura urbane. L’utilizzo era rivolto soprattutto verso gli spigoli vivi delle torri, provocandone il crollo, e contro le cortine per praticarne l’apertura in breccia; l’ariete era la macchina intorno alla quale generalmente si concentrava l’assalto, che permetteva di vanificare la funzione di ostacolo invalicabile rappresentato dalle mura e che fu sempre considerata dagli ingegneri militari la principale minaccia a cui trovare rimedio, modificando la morfologia della fortificazione.
ma se Siracusa è la città nella quale per la prima volta furono prodotte su vasta scala le più antiche artiglierie è a Taranto che probabilmente esse furono studiate e pensate dalla mente di Archita, che fra le diverse attività scientifiche si dedicò anche all’analisi del funzionamento fisico delle macchine in connessione alla sua attività politica e militare60. Archita fu eletto stratego a Taranto per ben sette volte, non produsse concretamente pezzi d’artiglieria, ma fu il primo sapiente antico che applicò la matematica alla meccanica sperimentale, fondandone così i presupposti scientifici e prendendo spunto per le sue ricerche anche dall’osservazione del moto dei proiettili scagliati dalle macchine da lancio. A riprova di questa attività di ricerca tarantina, che doveva avere tanto riflesso in campo militare, si ha notizia di altri due meccanici oriundi della colonia spartana. Il primo, Eraclide, visse alla fine del III sec. a.C. e produsse macchine da guerra per i Romani, durante l’assedio di Siracusa del 213-211 a.C., e poi per Filippo V di Macedonia; l’altro, di nome Zopiro, visse durante il IV sec. a.C., e, probabilmente formatosi alla scuola di Archita, operò durante la seconda metà del secolo producendo gastraphètai del tipo a pretorsione, utilizzato già negli anni precedenti dai Siracusani61.
Accanto all’ariete comparvero dall’inizio del IV sec. a.C. le torri d’assalto; si trattava di grandi macchine in legno che potevano raggiungere in altezza i cammini di ronda e, grazie a ponti mobili e a un armamento autonomo di catapulte, permettevano a forti contingenti di assalitori di riversarsi sulle mura nemiche, compiendo una scalata al riparo del corpo stesso della macchina. Le elepòleis raggiunsero dimensioni eccezionali durante le campagne di Alessandro Magno e soprattutto alla fine del IV sec. a.C. con Demetrio Poliorcete all’assedio di Rodi del 305-304 a.C., per poi assestarsi su dimensioni standardizzate e costituire parte integrante dei parchi d’assedio delle armate ellenistiche e romane58. La paternità di tali macchine sembra attribuibile agli ingegneri di Dionisio I di Siracusa, che le utilizzò per la prima volta all’assedio di Mozia nel 397 a.C. La notizia in questa sede è degna di rilievo e permette di ricordare che in Occidente e soprattutto a Siracusa la meccanica e l’ingegneria militare furono oggetto di grandissimo sviluppo durante l’ultimo decennio del V e il primo ventennio del IV sec. a.C., anni in cui Dionisio I era in guerra con Cartagine e le sue maestranze risultavano all’avanguardia non solo per la produzione di macchine d’assalto, ma anche per quelle da lancio59.
Le prime artiglierie erano delle grandi balestre, denominate gastraphètai e caratterizzate dall’utilizzo dell’arco composito, capace di imprimere un impulso dirompente ad un grande dardo62. Dopo la metà del IV sec. a.C. fecero la loro comparsa le prime macchine neurobalistiche, i cui archi erano costituiti da bracci imbrigliati in matasse di nervi, i tònoi, che permettevano di sviluppare forze propulsive assai intense per proiettili di vario genere. Queste macchine, denominate genericamente catapulte, katapèltai, si distinguevano in oxybelaì, eutitoni o palintoni a seconda della struttura del meccanismo propulsivo, quando scagliavano dardi, e in lithobòloi se lanciavano pietre. Come nel caso delle torri d’assalto, anche le catapulte raggiunsero dimensioni eccezionali durante il periodo compreso fra la spedizione di Alessandro e le guerre dei Diadochi, ma fin dalle prime realizzazioni le oxybelaì costituivano le artiglierie di peso medio, impiegate sia in campo sia nella difesa ordinaria dei cammini di ronda. I lithobòloi costituivano i pezzi pesanti dei parchi d’assedio e di difesa, potendo raggiungere dimensioni tali da scagliare proiettili di circa 80 chilogrammi a distanze fra i 100 e i 300 metri63. Chiude la serie delle macchine da lancio un’invenzione ricondotta al mondo cartaginese, il monàgkon, l’onager romano, ossia la grande catapulta petrobola con un solo braccio imbrigliato in matasse di ner-
Risiede appunto nelle macchine da lancio la grande novità tecnologica dell’armamento pesante degli eserciti greci a partire dal IV sec. a.C.; con la nascita di questi strumenti, per la prima volta nel mondo occidentale, comparvero accanto ai tradizionali contingenti di fanteria e cavalleria reparti specializzati ed esclusivamente destinati all’utilizzo delle macchine da lancio e all’attività ingegneristica, che in buona sostanza rappresentano le prime testimonianze delle cosiddette «armi colte», l’Artiglieria e il Genio Militare. La nascita di queste macchine è ricondotta all’ambiente siracusano del tempo di Dionisio I e trova la sua motivazione nello sviluppo della cultura scientifica pitagorica del mondo coloniale d’Occidente. Non solo,
60
GARLAN 1974, pp. 164-166. CAMBIANO 1996, pp. 475-487. 62 L’arco composito o riflesso, il palìntonon tòxon, è un’invenzione orientale, che a riposo presenta i bracci in curvatura opposta a quella assunta in tensione, così da sviluppare una forza praticamente doppia rispetto a quella di un arco semplice (MARSDEN 1969, pp. 5-12; GARLAN 1985a, pp. 150-151; HANSON 1999, p. 154). 63 MARSDEN 1969, in particolare pp. 16-85 per la presentazione dello sviluppo storico delle artiglierie; GARLAN 1974, pp. 212-225; LANDELS 1978, pp. 99-132; WARRY 1980, pp. 78-79, pp. 178-179; FERRARI 1985, pp. 242-256; GARLAN 1985a, pp. 176-178; LEVÊQUE 1985, p. 72; GARLAN 1992c, pp. 328-330; FAURE 1993, pp. 225-230; KEYSER 1994; BETTALLI 1998, pp. 737-740; SOLIS SANTOS 1998, pp. 709-711; HANSON 1999, pp. 154-163, p. 190; RUSSO 2002, pp. 99-161. 61
57
GARLAN 1974, pp. 137-140, pp. 236-239; WARRY 1980, pp. 62-63; GARLAN 1985a, pp. 172-173; LEVÊQUE 1985, pp. 272-273; RUSSO 2002, pp. 93-95. 58 MARSDEN 1969, p. 100; GARLAN 1974, pp. 175-176; pp. 225-234; WARRY 1980, pp. 90-91; GARLAN 1985a, pp. 173-176; LEVÊQUE 1985, pp. 272-273; GARLAN 1992c, pp. 330-335; FAURE 1993, pp. 230-234; BETTALLI 1998, p. 738; SOLIS SANTOS 1998, pp. 709-712. 59 GARLAN 1974, pp. 156-163.
10
vi, le cui prime testi-monianze risalgono al III sec. a.C., ma che si ritiene sia stata inventata già nel IV sec. a.C.64.
ra, che aveva come oggetto la conquista e la difesa delle città. Nell’ambito di questa scienza emergono gli scritti di autori come Enea Tattico e Filone di Bisanzio, ma in generale, durante un lungo periodo, che va dall’alto ellenismo al tardo impero romano e oltre, fiorirono gli studi dedicati alla costruzione delle macchine d’assedio e da difesa, quelli di tattica ossidionale e di stratagemmi difensivi e infine i precetti per l’edificazione delle fortificazioni secondo i nuovi principi elaborati fra IV e III sec. a.C., che tenevano conto dell’eccezionale sviluppo dei mezzi d’attacco e della predisposizione all’assalto, caratteristica ormai acquisita dagli assedianti69.
La poliorcetica ellenistica Risulta chiaro a questo punto che dal IV sec. a.C. e per tutto il III sec. a.C. l’arte militare greca visse una grande stagione di rinnovamento, dovuta ad innovazioni tecniche come l’introduzione delle macchine da guerra, ma anche l’adozione ecumenica dello schieramento di battaglia macedone, basato sulla possente falange armata di sarisse e sugli squadroni di cavalleria, posizionati ai fianchi della fanteria. Comparvero inoltre corpi specializzati, quali i fanti leggeri, le sezioni di carri falcati e i reparti di elefanti, operanti all’unisono con la fanteria pesante e la cavalleria in occasione degli scontri campali, che costituivano sempre e comunque la situazione elettiva per il confronto fra due eserciti65. Tuttavia, sia nella Grecia propria sia in quella d’Occidente, dove furono protagonisti della politica internazionale le Leghe Etolica, Achea, Italiota e i regni di Macedonia ed Epiro, sia in Oriente e in Egitto, dove si fronteggiarono le monarchie dei Tolomei, Seleucidi, Arsacidi e poi degli Attalidi66, la nuova strategia, che eleggeva la città a fulcro di resistenza territoriale, costrinse le grandi armate in lunghe operazioni d’assedio che videro come protagonisti non solo i contingenti di fanteria, destinati all’assalto o alla difesa delle mura urbane, ma anche quantità di soldati specializzati, operanti nelle file degli artiglieri e dei genieri, gli organopoioì e i mechanopoioì, al comando di ingegneri militari esperti nell’utilizzo e costruzione delle macchine e nella difesa delle fortificazioni67.
La trattatistica militare in lingua greca si sviluppa attraverso un lungo intervallo cronologico a partire dall’opera attribuita a Democrito di Abdera, intitolata Taktikòn e risalente circa al terzo quarto del V sec. a.C., per giungere fino all’età bizantina, quando gli imperatori d’Oriente, ritenendosi i diretti eredi della tradizione e della cultura militare ellenica e romana, ordinavano ai loro copisti imponenti lavori per la raccolta di corpora tattici e poliorcetici, al fine di dedicarsi allo studio teorico e all’applicazione pratica sui campi di battaglia, non più calcati allora dalle armate ellenistiche o romane, ma da quelle degli Arabi e dei Turchi. La tradizione manoscritta bizantina ha conservato un intero corpus di Poliorketikà in cui sono raccolti, oltre all’opera di Filone, i trattati di Bitone, ingegnere di Attalo I di Pergamo, attivo nel terzo quarto del III sec. a.C., di Agesistrato, di Ateneo il Meccanico70, di Erone d’Alessandria, il principale scrittore antico di meccanica vissuto nella seconda metà del I sec. d.C., e di Apollodoro di Damasco, l’ingegnere militare che operò con Traiano e Adriano. Riguardo alle opere di Bitone e Ateneo, autori di epoca ellenistica, è noto il contenuto esclusivamente concernente la costruzione delle macchine da guerra e spiace non poter fruire di un eventuale scritto realizzato dal secondo inerente l’architettura militare, essendo egli di origine greco-occidentale71; entrambi appartengono comunque ad un filone di scrittori meramente tecnici, che trasferiscono nei loro testi le istruzioni pratiche per la realizzazione delle artiglierie e ai quali può essere ricondotto anche lo stesso Vitruvio del Libro X del De Architectura, quando tratta la medesima materia72.
Fin dai tempi di Dionisio I di Siracusa e Filippo II di Macedonia dunque la parola poliorkìa perse il significato tucidideo, relativo alla pratica dell’investimento a blocco, e indicò le operazioni militari, fra cui l’attacco a sorpresa e l’assalto alla città, compiute da un’armata d’invasione in un territorio nemico, ma anche tutte le attività difensive e la resistenza attestata sulle strutture fortificate, posta in at-to dagli assediati68. Pertanto l’espressione che iniziava a diffondersi, tà poliorketikà, utilizzava l’aggettivo sostantivato plurale per riassumere il complesso delle operazioni ossidionali e difensive e nacque la «Poliorcetica», una disciplina autonoma nell’ambito delle arti della guer-
Durante l’età ellenistica l’utilizzo delle grandi artiglierie in occasione delle operazioni d’assedio e di difesa delle piazze divenne ordinario e determinò notevoli conseguenze sulla morfologia delle fortificazioni. Già Filone di Bisanzio dedicò parte dei suoi scritti allo studio per il migliore impiego delle artiglierie nella difesa delle mura, ma
64
MARSDEN 1969, p. 80. TAM 1930; MOMIGLIANO 1935; ADCOCK 1957; ANDRONIKOS 1970; GARLAN 1974, pp. 202-207; BAR KOCHVA 1976; WARRY 1980, p. 82, pp. 72-73, p. 95; GARLAN 1985a, pp. 138-140, pp. 158-159; LEVÊQUE 1985, pp. 266-275; LAUNEY 1987; SEKUNDA 1987; BENGSTON 1989, p. 59, pp. 217-247 passim; SEKUNDA 1994; SEKUNDA 1995; FAURE 1993, pp. 33-78; ASHLEY 1998; WARRY 1998, pp. 90-92, pp. 97-99, pp. 120123; HANSON 1999, p. 126, pp. 136-154; ANGLIM e a. 2002, pp. 31-41; BRIZZI 2002, pp. 18-24. 66 Per gli avvenimenti militari e le lunghe guerre che caratterizzano l’età ellenistica dalla morte di Alessandro Magno e dalla nascita dei regni dei Diadochi, fino alla conquista romana, attraverso le lotte in Oriente fra Seleucidi, Arsacidi e Tolomei, in Grecia fra la Macedonia e le grandi Leghe e in Occidente fra le città italiote e siceliote, Siracusa, le popolazioni italiche ed i Cartaginesi, WALBANK 1983, pp. 47-61, pp. 241-266; BENGSTON 1989, pp. 135-343; MONTAGU 2000, pp. 101-138. 67 GARLAN 1974, pp. 207-211. 68 GARLAN 1974, pp. 5-6. 65
69 Sulla poliorcetica greca ed i suoi sviluppi in età ellenistica, oltre al fondamentale e impareggiabile GARLAN 1974, si vedano MC NICOLL 1978; MC NICOLL 1986; WALBANK 1983, pp. 201-205 passim, pp. 205207; GARLAN 1985a, pp. 164-169; GARLAN 1992a; GARLAN 1992b; BETTALLI 1998, pp. 736-740; WARRY 1998, pp. 116-117; HANSON 1999, pp. 154-163; BENTLEY KERN 1999, pp. 163-226, 237-248; ANGLIM E A. 2002, pp. 197-203. 70 La cronologia di questo personaggio è discussa fra la fine del III sec. a.C. (LORETO 1995, p. 572) e il I sec. a.C. (REPELLINI 1993, p. 342 e nota n. 52). 71 LORETO 1995, p. 572. 72 REPELLINI 1993, p. 342.
11
studiosi moderni come il Marsden e l’Adam73 hanno vagliato la documentazione archeologica disponibile in tutto il mondo ellenico ed ellenizzato per ricostruire l’utilizzo effettivo dell’artiglieria in relazione alla struttura difensiva. In questa sede tuttavia, rimandando l’illustrazione dei dati agli autori succitati, sembra opportuno sottolineare piuttosto un assunto di partenza nell’ambito di tali ricerche, che nega un rapporto meccanicistico fra l’evoluzione della macchina da guerra e quella della fortificazione74. Come nel periodo a cavallo fra i secoli XV e XVI della nostra era l’invenzione dell’artiglieria a polvere nera non determinò meccanicamente la nascita del bastione, ma entrambe furono il prodotto di una cultura scientifica e tecnologica che poteva grazie agli studi di prospettiva, sintetizzare geometricamente i profili dei tiri con quelli delle opere fortificate, in ordine ad un principio di difesa reciproca fra più strutture difensive75, così a partire dal IV sec. a.C. la cultura scientifica ellenica non solo produsse sul versante tecnologico le nuove macchine da guerra, ma fu in grado di razionalizzare in un progetto costruttivo l’utilizzo migliore delle artiglierie, anche in virtù delle scoperte di prospettiva multifocale nell’ambito delle arti figurative. Infatti l’artiglieria ellenistica poteva contare, come si è visto, su macchine di diverso «calibro» e gittata con effetti diversi al momento in cui veniva colpito l’obiettivo, ma la principale carat-teristica delle catapulte era quella di produrre un tiro retti-lineo, mentre soltanto i monagkònes lanciavano i proiettili seguendo una traiettoria parabolica. Questo fatto è determinante in ambito architettonico militare per la presa di coscienza delle nozioni di «fiancheggiamento» e di «tiro radente», poiché la moltiplicazione delle torri lungo le cortine murarie, la complicazione delle planimetrie delle porte, l’invenzione dei tracciati a denti di sega o a cremagliera favorivano notevolmente l’utilizzo delle artiglierie per la copertura reciproca fra opere affiancate e per la di-fesa del terreno antistante la fortificazione, così come lo scavo di più fossati, la realizzazione di svariati generi di antemurale o di camere di tiro all’interno delle cortine e delle torri rivolte verso il fronte di attacco presupponevano l’utilizzo delle artiglierie a tiro rettilineo radente il terreno76.
ottimale delle mura e della loro edificazione nel Libro V, la cui restituzione è comunque discussa in sede filologica77. È importante notare innanzitutto che Filone nei suoi scritti dimostra una consapevolezza acquisita del divario esistente fra le nozioni di architettura militare a lui contemporanee e da lui professate e quelle del passato, che vengono riunite sotto la significativa espressione di teixopoi¤a érxa¤a78. L’autore, che, come si è detto, era un meccanico di formazione e non un architetto, raccomanda tuttavia un principio che accomunava i moderni costruttori di fortificazioni a quelli appartenenti alla teichopoiìa archaìa, cioè l’adeguamento delle opere alla natura del sito, conoscendone preliminarmente l’orografia. Infatti i vari tipi di tracciato descritti nell’opera, a meandro, a semicerchi, a denti di sega, a doppia cortina, a cremagliera79, potevano recingere in maniera ottimale città che sorgevano rispettivamente in pianura, in regioni sinuose, in località che presentavano sporgenze e rientranze naturali del suolo e in piazze con tre lati da difendere; infine l’antico sistema di fortificazione secondo Filone era comunque adatto alle città di forma circolare. È bene adattare i sistemi di fortificazione prendendo in considerazione la natura dei luoghi; alcuni si conformano a questo altri a quello, come il tracciato a meandro alla pianura; i sistemi a semicerchi e a denti di sega quando il terreno che bisogna chiudere è sinuoso; il profilo doppio quando ci sono salienti e rientranze naturali dove si deve fondare la città; l’impianto a cortine oblique nei siti triangolari e il sistema antico per le località circolari80
Un tema più volte toccato da Filone è quello della difesa avanzata rispetto alla linea delle mura, poiché la realizzazione di opere antistanti ad esse rendevano difficoltoso o impedivano lo scavo delle mine, l’approccio delle macchine d’assalto e la sistemazione in batteria dei petroboli ad una distanza utile per colpire la cinta urbana. Bisogna soprattutto mettere grande impegno nella costruzione degli antemurali, dei fossati e delle palizzate; infatti ci si impadronisce facilmente delle mura con i litoboli e le mine. A ciò dunque bisogna dare importanza, che gli antemurali e le palizzate siano più forti possibile e altrettanto più numerosi e profondi i fossati; quando infatti queste disposizioni siano ben assunte, la città non dovrebbe subire nulla di terribile81
Filone di Bisanzio e la nuova teichopiìa
La prima operazione da compiere per portare in avanti le linee di resistenza era lo scavo del fossato, che doveva es-
Intorno alla metà del III sec. a.C. i concetti di fiancheggiamento e di tiro radente pervasero gli scritti di Filone di Bisanzio, assumendo il valore di nozioni aprioristiche per l’edificazione delle mura urbane. Filone era uno studioso di meccanica, vissuto nel III sec. a.C., la cui opera fu in gran parte dedicata alle istruzioni per realizzare macchine di vario genere, fra cui gastraphètai e catapulte, alle quali è dedicato il Libro IV della Sintassi Meccanica. Una sezione dell’opera ha come oggetto l’utilizzo delle macchine da guerra per la difesa delle città durante gli assedi: tale argomento portò Filone a trattare della disposizione
77
In questa sede si fa riferimento all’edizione del Libro V della Sintassi Meccanica presente in GARLAN 1974. Per le notizie storiche su Filone di Bisanzio e le questioni filologiche di ricomposizione del Libro V si rimanda a GARLAN 1974, pp. 281-288; REPELLINI 1993, pp. 338-342. 78 Nel Paragrafo 59 della prima parte del Libro V Filone tratta della disposizione delle torri quadrate con angolo saliente rivolto verso il fronte d’attacco e afferma che è buona norma ristrutturare le torri secondo tale disposizione nelle fortificazioni «costruite all’antica», §n ta¤w érxa¤aiw teixopoi¤aiw (infra p. 14 nota n. 94); d’altro canto l’autore nel Paragrafo 5 afferma che non si presentano inconvenienti nella scelta di edificare le torri circolari o quadrate «come ora vengono costruite», sper nÊn ÙikodomoÊntai (Sintassi Meccanica [1974], V, A, 5), sottintendendo evidentemente un divario esistente fra la vecchia e la nuova architettura militare. 79 infra p. 13 note n. 110, 111, 114, 115, 116. 80 Sintassi Meccanica (1974), V, A, 84. 81 Sintassi Meccanica (1974), V, A, 82-83.
73
MARSDEN 1969, pp. 116-163; ADAM 1982, pp. 105-111. SCONFIENZA-ZANNONI 1998, pp. 66-72. FARA 1989, pp. 81-82; TZONIS-LEFAIVRE 1989; FARA 1993, p. 5, pp. 15-19. 76 Per esemplificazioni sull’argomento derivanti da indagini archeologiche e relativa bibliografia SCONFIENZA-ZANNONI 1998, pp. 68-71. 74 75
12
sere asciutto e in comunicazione tramite gallerie con il corpo di piazza, per poterlo liberare dai materiali gettati all’interno dai nemici, che tentavano così di colmarlo; fra il fossato e le mura era necessario realizzare delle palizzate ben fissate e difficili da svellere. Ma la soluzione migliore secondo Filone era l’apertura di tre fossati paralleli con linee di palizzate fra l’uno e l’altro, che impedissero la posa in batteria dei petroboli nemici.
Il principio complementare al tiro radente è quello del fiancheggiamento per cui le opere sporgenti dalla linea perimetrale delle mura permettevano un tiro parallelo ad essa, dall’alto verso il basso, garantendo la difesa del terreno antistante le cortine. Filone dimostrò di esserne perfettamente consapevole, quando descrisse il tracciato a doppia cortina, le cui torri pentagonali avanzate permettevano di colpire con i petroboli gli assalitori sui fianchi scoperti, sia che essi avanzassero in galleria sia allo scoperto, con le protezioni d’approccio e le arieti.
I fossati scavati, se il luogo non è umido, sono tenuti asciutti e dotati di mine nei luoghi adatti, in modo che, quando si tenta di riempirli, i materiali buttati dentro, sia di giorno sia di notte, possono essere portati di nuovo in superficie dagli assediati all’interno. Le palizzate all’esterno del fossato, che costeggia in estensione la fortificazione, sono tutte elevate verticalmente lungo ‹…›, affinché la palizzata sia difficile da raggiungere e svellere […] 82
Quando infatti vengono sistemati gli schermi protettivi o avanzate le macchine d’assalto, o ancora si costruiscono i camminamenti coperti , è facile, colpendoli con i litoboli e le arieti, sconvolgere gli uni e rovesciare le altre; così pure è agevole sterminare i minatori e quelli che stanno sotto i ripari; inoltre è facile bloccare gli arieti, catturandoli con i lacci, e impadronirsene; bisognerà colpire sul fianco scoperto quelli che avanzano verso le mura e facilmente i difensori faranno delle sortite e di nuovo senza pericolo attueranno le ritirate, evitando di offrire ai nemici il fianco scoperto86
In tutti i sistemi di fortificazione non si scavano meno di tre fossati; di essi il primo deve star distante dalle mura un pletro, il secondo quaranta cubiti, il terzo a distanza uguale rispetto al secondo. A metà degli spazzi intermedi, su una larghezza di ventotto cubiti bisogna conficcare dei pali, fare delle trincee e piantarvi delle siepi spinose, perché i nemici non abbiano spazio per mettere in batteria un petrobolo da un talento, qualora si fossero impadroniti del primo fossato83
Filone toccò inoltre l’argomento del fiancheggiamento, parlando della difesa reciproca delle torri, le quali potevano assumere varie forme, circolare, quadrangolare, poligonale, purché si adattassero bene alla natura del sito e riuscissero a difendersi l’una con l’altra per mezzo del tiro delle macchine posizionate sui loro fianchi, per colpire gli assalitori in azione sul terreno antistante la cortina mediana.
L’insistenza sulla difesa avanzata è motivata dal fatto che grazie ad essa si potevano utilizzare le artiglierie con tiro radente il terreno, realizzando opere antemurali più basse delle fortificazioni urbane, i proteichìsmata. Essi consentivano di colpire il nemico non più solo dall’alto, secondo i principi della difesa piombante proprii della teichopoiìa archaìa, ma da punti protetti in trincea (ypògeioi), oppure a livello del suolo antistante le mura o poco più in alto. L’integrazione fra le macchine operanti su torri e cammini di ronda con quelle degli antemurali creava una copertura a tappeto del terreno che gli attaccanti dovevano percorrere al momento dell’assalto
In secondo luogo bisogna costruire le torri secondo l’opportunità dei luoghi, alcune rotonde all’esterno e all’interno con una faccia quale apparirebbe se si taglia in due un cilindro in direzione perpendicolare alla base; altre invece di forma esagona, pentagona e tetragona, edificandole in modo che presentino un solo angolo saliente, affinché si proteggano a vicenda scagliando le armi da lancio dai muri di fiancheggiamento sulle macchine d’assalto avanzanti, affinché non patiscano alcun danno pur essendo prese di mira dagli arieti e dai petroboli87
Ai piedi delle mura e degli antemurali vengono apprestate delle batterie per le macchine da lancio più grandi e numerose possibile; alcune di esse sono a filo del terreno, altre sotterranee per avere un’ampia area di tiro, perché i tiratori non siano feriti e colpiscano i loro avversari senza rivelarsi e, quando i nemici sono prossimi, i serventi alle catapulte non diventino inutili non potendo inclinare le loro armi84
Tale reazione, come si è detto, avviene servendosi delle artiglierie installate sulle torri, che mirano ai fianchi dei nemici grazie alle finestre delle camere di tiro, ma anche utilizzando arcieri in ogni postazione e i pezzi in batteria lungo le cortine che colpiscono frontalmente:
Taluni proteichìsmata erano predisposti infine per difendere lo zoccolo delle fondazioni emergente dal terreno, al di sopra del quale si innalzava l’elevato delle fortificazioni, imbragando soprattutto gli angoli delle torri e delle opere sporgenti, per fornire una protezione ai difensori che vi operavano al di sopra e impedire lo scavo delle mura da parte degli assalitori.
Bisogna inoltre che ci siano delle finestre per il tiro delle catapulte e dei petroboli nelle mura delle torri, nelle quali le batterie saranno installate su un terrapieno, affinché, quando avanzano le macchine d’assalto, sia che esse approccino perpendicolarmente qualcuna delle cortine, sia che si volgano contro qualche torre sporgente, le torri si proteggano a vicenda operando insieme, grazie al tiro dei litoboli dai muri di fiancheggiamento, nei quali le finestre sono state realizzate come abbiamo detto. ‹…› gli arcieri, alcuni in posizione di fiancheggiamento, altri di fronte, stando all’esterno in strette postazioni, per colpire quelli che si avvicinano e bruciare gli schermi d’approccio e le macchine, senza subire essi medesimi nulla di dannoso88
Ai piedi di tutti i baluardi e di tutte le torri bisogna costruire, a ridosso degli angoli, dei muri che si adattano alle punte degli stessi angoli, affinché abbiano una postazione protetta coloro i quali li difendono; e intorno a questi apprestamenti bisogna realizzare un antemurale e una palizzata, perché i nemici, se cade l’antemurale ed essi si posizionano su di esso, non possano minare le fortificazioni facendo avanzare gli schermi di protezione85
La centralità del concetto di fiancheggiamento e dell’interazione fra le macchine da lancio e le strutture difensive è evidente se si considera che essa ricorre in modo analogo nel quinto capitolo del Libro I del De Architectura di Vitruvio, dedicato ai precetti per l’edificazione delle mura urbane. L’ingegnere romano, simile a Filone per la formazione meccanica, è certamente debitore nei confronti
82
Sintassi Meccanica (1974), V, A, 36-37. Sintassi Meccanica (1974), V, A, 69-70. 84 Sintassi Meccanica (1974), V, A, 32. 85 Sintassi Meccanica (1974), V, A, 67-68. 83
86
Sintassi Meccanica (1974), V, A, 50-52. Sintassi Meccanica (1974), V, A, 2-3. 88 Sintassi Meccanica (1974), V, A, 21-22. 87
13
dello scienziato greco89 tanto da aver assimilato quei precetti ispiratori in materia di architettura militare, per cui affermava che le torri di un circuito difensivo dovevano essere sporgenti, per colpire sul fianco gli assalitori, e alla distanza di un tiro di freccia, per garantire la copertura reciproca.
ché intorno all’angolo saliente, massiccio e robusto, il tiro dei litoboli sia deviato e non faccia crollare la torre95
La disposizione di un angolo saliente della torre verso l’esterno permetteva infatti, come dice lo stesso Filone, di far rimbalzare sui lati obliqui i proiettili dei petroboli che avrebbero provocato danni assai più gravi battendo su muri ortogonali alla linea di tiro. Ma il vantaggio maggiore era dovuto al fatto che sia le torri pentagonali sia quelle quadrangolari, ruotate con un angolo verso il fronte d’attacco, potevano essere difese dal tiro delle macchine poste sulle cortine e quindi avvalersi del principio del fiancheggiamento per tutto il perimetro del loro corpo di fabbrica, così come esse garantivano la protezione alle cortine stesse. In questo modo nel pensiero di Filone di Bisanzio il concetto di copertura reciproca fra tutte le strutture fortificate che concorrono alla creazione di un sistema difensivo risulta completo di ogni suo elemento.
Dunque le torri devono essere costruite sporgenti verso l’esterno, affinché il nemico, quando si voglia avvicinare alle mura durante un assalto, sia colpito con i proiettili delle armi da lancio, provenienti dalle torri, sui fianchi scoperti sia a destra sia a sinistra. Sembra che si debba curare soprattutto che non ci sia un facile accesso per attaccare le mura, ma bisogna tracciare la fortificazione intorno a precipizi e progettarla in modo che i percorsi che conducono alle porte non siano diretti, ma da sinistra. Infatti così facendo, il lato destro di chi avanza, non protetto dallo scudo, sarà quello più vicino alle mura […]90 Gli intervalli fra le torri devono essere fatti in modo che non vi sia una distanza maggiore, fra l’una e l’altra, rispetto al tiro di una freccia in modo che, se qualcuna di esse è assaltata, i nemici siano respinti con gli scorpioni e il tiro di altri proiettili dalle torri che si troveranno a destra e a sinistra […]91
Fortificazione ellenica e innovazioni ellenistiche
Ma tornando a Filone è ancor più significativo un breve passo in cui egli raccomanda di realizzare qualsiasi fortificazione in modo che non possa mai essere presa fra due punti di tiro.
Resta quindi da illustrare quali sono le innovazioni tecniche e morfologiche, documentate dai resti archeologici, che vennero apportate alle fortificazioni dagli architetti e dagli ingegneri militari ellenistici, ma è necessario preliminarmente chiarire la concezione funzionale delle mura nel mondo greco.
Bisogna stare ben attenti, in tutti i sistemi di fortificazione, che le mura in nessun settore siano costruite sotto due punti di tiro92
È evidente che, qualora fosse capitato il contrario, si sarebbe interrotto il sistema di copertura reciproca fra le opere difensive, poiché l’esposizione a due punti di tiro significava che uno di essi non rientrava nell’area d’azione delle artiglierie della piazza ed era stato trascurato durante l’edificazione delle mura.
La città greca nasce come aggregazione di abitazioni intorno ad un centro egemone di attrazione per la vita relazionale e le pratiche cultuali degli abitanti di un determinato territorio. Nella funzione centripeta di questi punti di convergenza si identifica il fatto peculiare della genesi della pòlis, ossia l’origine dell’agorà, lo spazio pubblico comune a tutti i polìtai che qualificava la città in quanto tale e faceva sì che un agglomerato di semplici kòmai potesse essere definito pòlis96. Ne consegue che, in seguito alla definizione degli spazi pubblici dedicati alla vita politica e commerciale e all’isolamento di quelli religiosi, in cui la comunità da sempre collocava per tradizione le dimore degli dei, lo sviluppo di una città greca fosse il prodotto dell’ampliamento dello spazio privato, quello riservato all’impianto delle abitazioni dei polìtai e collegato agli spazi pubblici e religiosi tramite gli assi viari, generalmente coincidenti con antichi percorsi della viabilità territoriale. Pertanto le mura non erano pensate e realizzate prima della nascita della città, in quanto limite fisico dello spazio urbano ed elemento distintivo e separatore fra chòra e pòlis, tanto meno esse racchiudevano uno spazio esclusivamente militare, ma dal momento in cui erano edificate svolgevano una funzione di protezione e limite per l’abitato in connessione al loro impiego militare97. Gli studiosi moderni98 hanno tentato di isolare il momento
Completa il quadro filoniano la soluzione che il meccanico greco propone per un problema importante, ovvero la difesa delle opere sporgenti. Le torri aggettanti dalla linea delle mura garantivano il fiancheggiamento reciproco e la difesa della cortina intermedia, ma le loro facce esterne erano alla mercé delle macchine d’assalto e dell’artiglieria nemica. Filone suggerisce di elevare torri pentagonali, oppure di costruire davanti alle torri quadrangolari una punta triangolare, o ancora, per le ristrutturazioni di fortificazioni più antiche, di posizionare la torre quadrangolare con un angolo rivolto verso il fronte d’attacco. A metà delle cortine si costruiscono torri o baluardi pentagonali secondo che i luoghi siano adatti93 Nelle fortificazioni del sistema antico bisogna far sporgere le torri dalla parte di un solo angolo, e costruire le cortine come sono state strutturate a Rodi94 Davanti alle torri quadrate bisogna costruirne delle altre triangolari, aderenti alle prime e robuste, quasi in forma di triangolo equilatero, affin-
95
Sintassi Meccanica (1974), V, A, 61. MARTIN 1974, pp. 30-47; GRECO-TORELLI 1983, pp. 65-93; MARTIN 1984, pp. 135-137; MARTIN 1987a, pp. 89-94; MARTIN 1987b; MARTIN 1987C; BENEVOLO 1993, pp. 49-97. 97 GARLAN 1974, pp. 87-92; MARTIN 1974, pp. 37, 189-192; MARTIN 1987d, p. 584. 98 WINTER 1971, pp. 289-302; GARLAN 1974, pp. 90-92; MARTIN 1974, pp. 191-192; SNODGRASS 1986. 96
89
FLEURY 1990, p. XCIX. De Architectura (1990), I, V, 2. De Architectura (1990), I, V, 4. 92 Sintassi Meccanica (1974), V, A, 85. 93 Sintassi Meccanica (1974), V, A, 48. 94 Sintassi meccanica (1974), V, A, 59. 90 91
14
storico in cui le città greche si sono dotate di mura e, se per la Ionia d’Asia sembra che il primo grande sviluppo della fortificazione poliadica risalga alla seconda metà o fine del VI sec. a.C., a causa delle minacce incombenti del Regno di Lidia e dell’Impero Persiano, in Grecia e nelle colonie d’Occidente la documentazione in merito è ricca di testimonianze risalenti all’alto e pieno arcaismo99.
Dunque la funzione principale delle mura urbane nel mondo greco era quella di garantire la sicurezza dei cittadini che all’interno del circuito fortificato potevano difendere se stessi e i proprii beni. A questa funzione primaria si collega quella squisitamente militare di garantire una difesa efficace con un contingente di uomini ridotto, ma ben impiegato, rispetto a quello degli attaccanti. D’altro canto le mura urbane fornivano sempre un rifugio sicuro in caso di sconfitta campale e garantivano la possibilità di fronteggiare il nemico al momento in cui fosse necessario un cambiamento di strategia, che costringesse ad operare in difesa. Emerge inoltre una funzione politica che è ben rappresentata dal caso dell’opposizione di Sparta all’edificazione delle mura di Atene all’indomani della Seconda Guerra Persiana, occasione in cui la realizzazione di un’opera fortificata assunse uno specifico valore per l’indirizzo scelto da una pòlis nell’ambito della politica internazionale102.
Tuttavia non sembra che la nascita delle mura sia stata soltanto motivata da una possibile minaccia esterna, per quanto le prime testimonianze, trovandosi in ambiente coloniale, potrebbero indurre a tali conclusioni. In realtà la necessità di protezione nacque quando le comunità urbane raggiunsero uno sviluppo tale per cui le riserve produttive e la ricchezza dei singoli polìtai, derivanti dalla fiorente attività agricola nelle chòrai e dai conseguenti commerci, toccò un livello di gran lunga superiore alla soddisfazione delle immediate necessità di vita100. Cosicché la fortificazione urbana sorse come difesa di una comunità attiva che, secondo i princìpi della strategia tradizionale, doveva difendere il territorio quale fonte di sostentamento e benessere, ma anche la città come luogo di raccolta dei beni e di svolgimento della vita quotidiana stessa. In questa prospettiva si comprende il motivo per cui dall’età classica in avanti nel mondo ellenico le mura urbane divennero un elemento qualificante la città, ma anche un simbolo inequivocabile di civiltà; inoltre l’edificazione delle mura da questo momento in avanti rappresentava un’operazione preliminare alla fondazione di una nuova città, come accadde nel 444 a.C. per la colonia panellenica di Thurii sul sito dell’antica Sibari101.
Infine esiste ancora un’ultima, ma non meno significativa funzione, che è quella urbanistica. Le fortificazioni di una città delimitavano in generale l’area all’interno della quale sorgevano gli edifici pubblici e privati, ma i circuiti murari non ritagliavano il territorio urbanizzato, anzi seguivano percorsi generalmente più ampi, lasciando estesi spazi aperti fra se stessi e l’abitato; ciò avveniva perché la fortificazione ellenica, proprio per il fatto che non nasceva come atto preliminare alla fondazione, ma ne era una conseguenza motivata da ragioni difensive, seguiva una regola generale e duratura nel tempo che era l’adeguamento alla natura del sito, ovvero il circuito murario si estendeva inglobando un’area più ampia dell’abitato per fortificare tutti quei settori del terreno extraurbano che strategicamente dovevano essere controllati dai difensori103. In ordine a questo principio i tratti di mura, le corti-
99
GARLAN 1974, p. 91; in Occidente si possono ricordare per esempio le mura di Naxos, Leontini e Casmene (VII-VI sec. a.C.; CASTAGNOLIFRACCARO 1963, p. 259 con bibliografia riferita alle indagini archeologiche; RIZZA 2000) i resti di un tratto di fortificazione a Gela, in mattoni crudi su fondazioni lapidee, risalente all’inizio del VII sec. a.C. (MARTIN 1974, p. 192, p. 197) e altri rinvenimenti simili sempre di VII sec. a.C. a Policoro, ricondotti alle opere difensive dell’antica Siris (HAENSEL 1973, pp. 416, 418-420, 492; ADAMESTEANU-DILTHEY 1978, pp. 525-526; GUARDUCCI 1978, p. 280; ADAMESTEANU 1980, pp. 7475, 81-84.; GUZZO 1982, p. 327; GRECO 1993, p. 41). In merito al tema della forti-ficazione arcaica in Occidente anche SCONFIENZA 2003. 100 Sul rapporto fra la strutturazione della città e lo sfruttamento del territorio, con alcune considerazioni sull’aspetto difensivo MARTIN 1987d. 101 GARLAN 1974, p. 96. La documentazione letteraria, con in testa Tucidide, a partire dal V sec. a.C. testimonia questa identificazione delle mura con un’immagine di civiltà e viceversa la loro assenza con una prova di barbarie (GARLAN 1974, pp. 92-97); un esempio per tutti sembra esauriente e lo si ritrova negli Uccelli di Aristofane, quando il Primo Messaggero porta la notizia ad uno dei protagonisti, Pisetero, che la costruzione della città degli uccelli procede spedita ed è stata già ultimata la prima grande impresa, cioè il possente muro difensivo:
vizio di ronda, come prescriverà circa mezzo secolo dopo Enea Tattico (supra p. 9 note n. 49, 50): Pr.Mess. – […] I pellicani erano abilissimi carpentieri, a colpi d’ascia hanno lavorato le porte con i loro becchi: e facevano un baccano di scuri come in un cantiere navale. Adesso il muro è fornito per intero di porte e di chiavistelli. Tutt’intorno ci sono le sentinelle, si fanno ispezioni e ronde con la campana, hanno sistemato dappertutto posti di guardia e falò sulle torri […] (trad. Dario Del Corno; Uccelli [1987], vv. 1154-1162). 102
DUCREY 1986, pp. 136-141; per la questione delle mura di Atene e l’opposizione spartana supra p. 3 nota n. 8. 103 Questa norma essenziale nella storia dell’architettura militare fu l’assunto di partenza che ispirò le realizzazioni di uno dei più famosi ingegneri militari moderni, Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-1707), che sosteneva in seguito ad una lunga pratica in materia di fortificazioni che «l’art de fortifier ne consiste pas dans des règles et des systèmes, mais uniquement dans le bon sens et dans l’expérience», poiché soltanto questa capacità costante di rapportarsi al terreno poteva permettere di adeguare alle località il sistema difensivo più adatto, per «tirer tous les avantages de la situation» (FAUCHERRE 1991, pp. 56-58; BLANCHARD 1996, pp. 387-396). Ma il fatto più significativo e carico di suggestione è che tale norma fu professata con altrettanta convinzione quasi venti secoli prima di Vauban da Filone di Bisanzio, quando in un passo del Li-bro V della Sintassi Meccanica afferma che ogni opera fortificata assu-me andamento saliente o rientrante, flesso o rettilineo in obbedienza alla natura dei luoghi in cui essa viene edificata:
Pr.Mess. – Il tuo muro è costruito per intero. Pis. – Che bella notizia ! Pr.Mess. – È opera grandiosa, un vero splendore ! Immaginati: sopra potrebbero incrociarsi Prossenide di Vantonia e Teagene con due carri tirati da cavalli grandi come quello di Troia, e riuscirebbero a passare: tanto è largo ! Pis. – Eracle ! Pr. Mess. – Ed è alto cento braccia, l’ho misurato io. Pis. – Poseidon, che mole ! E chi l’ha costruito un colosso simile ? Pr.Mess. – Gli uccelli, nessun altro […] (trad. Dario Del Corno; Uccelli [1987], vv. 1123-1133).
t«n d¢ teix°vn èpãntvn afl §ky°seiw ka‹ §gkl¤seiw ka‹ tå §pikãmpia ka‹ a¤ r¤ai èrmottÒntvw to›w Ípãrxousi tÒpoiw lambãnontai.
I costruttori sono le più svariate razze di uccelli e ad opera ultimata, completa di porte e torri, sono già stati istituiti i turni di guardia e il ser-
15
ne, costituivano delle spezzate poligonali, che formavano salienti ad angolo ottuso, ed erano prive inizialmente di torri o opere sporgenti; queste ultime comparvero a partire dalla fine del VI sec. a.C. in alcuni punti di convergenza delle spezzate. Dopo l’edificazione della cinta poliadica potevano essere realizzati inoltre dei lunghi tratti di mura interni al circuito, i diateichìsmata104, che ne collegavano due estremi per ridurre l’area da difendere e creare una successione di ostacoli al nemico che fosse riuscito ad impadronirsi di un settore delle fortificazioni105.
giare circuiti difensivi progressivamente sempre più ridotti109. I circuiti murari con la seconda metà del IV sec. a.C. e l’inizio del III sec. a.C. assunsero profili nuovi che favorivano il fiancheggiamento fra i successivi tratti di cortina. Esisteva il tracciato cosiddetto «a cremagliera», di probabile origine macedone110, le cui componenti erano costituite da tratti di cortina paralleli, collegati l’uno all’altro da fianchi quasi ortogonali ad essi, per generare una serie di salienti che si fiancheggiavano in successione. Questo tracciato si evolse in età ellenistica nel tipo «a cremagliera bastionata» con l’aggiunta di torri al culmine di ogni saliente, per aumentare il volume di tiro e l’effetto di copertura. Un altro profilo diffuso era quello delle cortine «a denti di sega», che seguiva un andamento a zig-zag e si adattava molto bene alle variazioni orografiche del sito111. Altri tracciati, «a semicerchio», «a meandro», «a doppia cortina», particolarmente efficaci per l’installazione delle artiglierie difensive, furono descritti da Filone di Bisanzio, ma solo i primi due trovano riscontro in esempi reali, che sono rispettivamente le fortificazioni di Telesia in Campania112 e di Kydna di Licia in Turchia113. Il profilo «a semicerchio» presentava tratti concavi di cortina fra una torre e l’altra114, quello «a meandro» era costituito da avancorpi dotati di torri sugli angoli che sporgevano dalla linea del tracciato murario115, quello «a doppia cortina» presentava tratti murari intercalati da torri pentagonali e strutturati su due livelli, l’inferiore dei quali era anche il più esterno116. È rilevante notare ancora che le cortine in età ellenistica vennero realizzate con strutturazioni complesse a doppi cammini di ronda sovrapposti e casematte per alloggiare più pezzi d’artiglieria, non solo al livello superiore del cammino principale, ma anche a livelli inferiori per attuare il tiro radente117. Infine dal IV sec. a.C. i tracciati delle fortificazioni urbane vennero difesi talvolta da fossati artificiali, là dove la natura del terreno non provvedeva già con crepacci o scoscendimenti inaccessibili; precedentemente il fossato poteva risultare dall’opera di cava del materiale costruttivo per le mura stesse, ma con lo sviluppo della pratica dell’assalto il fossato venne realizzato con vera e propria funzione d’osta-
Le caratteristiche appena descritte delle fortificazioni elleniche qualificarono l’architettura militare greca fino alla fine del V sec. a.C.; a partire dal secolo successivo comparvero le innovazioni conseguenti alla diffusione della «stratégie nouvelle», destinate a durare ed evolversi per tutta l’età ellenistica106. I circuiti fortificati continuarono a seguire la regola dell’adeguamento alla natura del sito ampliando ulteriormente l’area racchiusa e tenendo presente la necessità di raggiungere un terreno esterno alle mura, disagevole per l’azione delle macchine d’assedio107. Si tratta di quel tipo di fortificazione che gli archeologi tedeschi hanno battezzato con il nome di «Geländemauern», diffusosi già nel periodo della Pentecontetia e della Seconda Guerra del Peloponneso, ma particolarmente sviluppato a partire dal IV sec. a.C., quando lunghi circuiti murari, come per esempio quello di Siracusa, che avvolgeva un settore extraurbano comprendente tutta la collina dell’Epipole108, inglobavano ampie porzioni della chòra in ordine al cambiamento di strategia difensiva. Infatti la «stratégie nouvelle», che prevedeva la difesa di parti specifiche del territorio, quali per esempio le frontiere, indusse a fortificare anche settori importanti dal punto di vista produttivo e a creare una successione di ostacoli, come i diateichìsmata interni alla «Geländemauern», man mano che ci si avvicinava all’abitato, per ritardare lo scontro e allontanarlo il più possibile dalla città, il che significava anche privale(Sintassi Meccanica [1974], V, A, 30). GARLAN 1974, pp. 189-190; MARTIN 1974, p. 194; SOKOLICEK 2003. 105 Trattano in generale l’argomento delle fortificazioni arcaiche e classiche VON GERKAN 1924, pp. 17-19; CASTAGNOLI-FRACCARO 1963, p. 254; LAWRENCE 1967, pp. 230-232; LUGLI 1970, pp. 858-859; WINTER 1971, pp. 3-46, pp. 101-110, pp. 126-139, pp. 152-163, pp. 205-216; MARTIN 1974, pp. 192-203; ADAM 1982, pp. 8-13, pp. 19-35 passim, pp. 46-57 passim, pp. 77-78; GARLAN 1985a, pp. 164-167; BENEVOLO 1993, p. 99. 106 L’argomento è già stato oggetto di studio con citazione di esempi e bibliografia in SCONFIENZA-ZANNONI 1998, pp. 58-65; un’esauriente trattazione storico-critica che sintetizza in un unico quadro gli avvenimenti e le innovazioni ingegneristiche e architettoniche militari si trova in WINTER 1971, pp. 311-333. 107 WINTER 1971, pp. 111-125; GRECO-TORELLI 1983, p.255. 108 La collina dell’Epipole, sovrastante Siracusa, cinta da mura fin dalla fine del V sec. a.C., cioé durante i primi anni delle guerre fra Dionisio I e Cartagine, divenne sede di una delle più famose opere fortificate dell’antichità, il castello Eurialo, che venne completato alla fine del IV sec. a.C. per proteggere la grande porta a tenaglia aperta del Trìpylon, unico varco delle mura rivolto verso l’interno della regione iblea. Dalla ricca bibliografia sulla fortezza siracusana si citano le opere in cui sono specificate le fasi di costruzione e la cronologia relativa all’occupazione dell’Epipole con la «Geländemauern»: KRISCHEN 1941, pp. 25-28; GENTILI 1959; WINTER 1963; GARLAN 1974, pp. 186-188; ADAM 1982, pp. 248-251; MERTENS 1990; TRÉZINY 1996, pp. 347-350; MERTENS 2002. 104
109
VON GERKAN 1924, pp. 110-114; WINTER 1971, pp. 110-114; pp. 304-307; GARLAN 1983, pp. 157-158; TRÉZINY 2004, p. 595. 110 È stata proposta una cronologia precisa fra il 340 e il 260 a.C. facendo riferimento al caso emblematico delle mura di Samico di Trifilia (GARLAN 1974, pp. 246-250; ADAM 1982, pp. 66-67). 111 Per le cortine delle fortificazioni ellenistiche e i vari generi di tracciato esistono trattazioni e numerosi esempi individuati in tutto il mondo greco in WINTER 1971, pp. 140-151; GARLAN 1974, pp. 244-246; MARTIN 1974, p. 196; ADAM 1982, p. 66, pp. 68-71, pp. 179-180, p. 185, p. 188, p. 211, p. 217, p. 226, p. 228, p. 230, p. 232, p. 235, p. 244, pp. 248-251. 112 SOMMELLA 1988, pp. 131-132; GROS 1998, p. 36.. 113 ADAM 1982, pp. 68-69. 114 Sintassi Meccanica (1974), V, A, 39-43; WINTER 1971, p. 117; GARLAN 1974, p. 357. 115 Sintassi Meccanica (1974), V, A, 84; WINTER 1971, pp. 116-117. 116 Sintassi Meccanica (1974), V, A, 45-54; GARLAN 1974, p. 359. Nell’opera di Filone compaiono anche le descrizioni dei tracciati «a denti di sega» e «a cremagliera» (Sintassi Meccanica [1974], V, A, 44, 55-58). 117 È una situazione non molto diffusa e gli esempi più noti sono a Perge (MARSDEN 1969, p. 122), Sidé (MARSDEN 1969, pp. 122-124) e Rodi (GARLAN 1974, p. 347, p. 348).
16
colo, per impedire l’approccio delle macchine e bloccare gli assalitori alla portata di tiro delle batterie difensive118.
mente alloggiate in torri a due piani dotate di thyrìdes, come la est della Porta d’Arcadia122. È inoltre opportuno ricordare che le ricerche sul terreno hanno permesso di individuare tre esempi, due torri a Tithorea di Focide e la A di Aigosthena, dotate di camere di tiro inferiori al cammino di ronda con feritoie per l’azione di catapulte a dardi, che documentano l’applicazione del tiro radente al terreno anche nell’ambito di questi manufatti123.
Certamente le più importanti innovazioni tecniche apportate alle fortificazioni durante il periodo ellenistico e legate all’introduzione delle artiglierie riguardano le torri e le porte. I pýrgoi, ossia le torri, a partire dal IV sec. a.C. aumentarono visibilmente di numero rispetto alle epoche precedenti, ovviamente in risposta alla diffusione della strategia d’assalto per moltiplicare gli ordini di tiro dalle mura, dominare da posizioni più elevate gli attaccanti e ridurre il più possibile la lunghezza dei tratti di cortina attaccabili dall’ariete. Ma una motivazione ancor più importante, data dal profilo aggettante delle torri rispetto alla linea delle mura, è quella connessa alla diffusione dei princìpi di fiancheggiamento e copertura reciproca. A riprova di ciò si può notare che è proprio in conseguenza all’aumento delle torri per tali finalità che i tratti di cortina fra una torre e l’altra non vennero più semplicemente definiti teìchoi, ma mesopýrgoi, termine specifico che segnala la preminenza della torre rispetto al tratto di mura ordinario.
Le nuove forme di combattimento e strategia difensiva determinarono anche conseguenze sulle tecniche costruìtive delle torri e delle cortine. Innanzitutto si diffonde la muratura ad émplekton, che permetteva il miglior assorbimento degli urti dell’ariete e dei proiettili pesanti, essendo costituita da due paramenti paralleli, generalmente in opera isodoma di grandi blocchi lapidei, e collegati da muri ortogonali interni, i diatoni, che creavano un’incatenatura cadenzata lungo lo sviluppo delle strutture e ripartivano l’émplekton in successive camere di riempimento. Questo genere di opera, anche detta «muratura a cassoni» viene oggi datata a partire dal V sec. a.C. con pieno sviluppo nel IV124. Soprattutto nel caso delle torri circolari e semicircolari si introdusse l’uso della realizzazione dei paramenti murari in blocchi con taglio trapezoidale, il cui assemblaggio garantiva una migliore resistenza alle arieti e ai proiettili sulle superfici d’urto125. Progredisce infine l’edificazione autonoma delle struttura della torre rispetto a quella della cortina, per evitare il collasso di entrambe, qualora una delle due fosse crollata126. Infine la necessità di costruire ballatoi adeguati al sostegno di pesanti artiglierie determinò l’ispessimento dei muri perimetrali delle torri che si assottigliavano tuttavia salendo verso l’alto in corrispondenza di riseghe alla quota dei ballatoi per determinarne il piano d’appoggio127.
Le forme di torre più diffuse dal IV sec. a.C. erano la quadrangolare e la semicircolare, evoluzione della circolare che continuò ad essere utilizzata e apprezzata per la sua capacità di tiro. Nei secoli successivi furono anche realizzate torri dal profilo più complesso, sempre in obbedienza ad un miglior adeguamento alla natura del sito o al fiancheggiamento reciproco, come i tipi a ferro di cavallo, pentagonale ed esagonale, la cui smussatura degli spigoli poteva ovviare meglio all’azione dell’ariete119. L’aspetto delle torri ellenistiche era caratterizzato dalla presenza di ampie aperture sulle facce esterne, a livelli coincidenti e sovrastanti il cammino di ronda, denominate thyrìdes, che erano l’unico indizio esteriore di una complessa strutturazione all’interno di magazzini per le munizioni e camere di tiro, realizzate per l’alloggiamento di grandi macchine petrobole e di catapulte a dardi120. A tal proposito sono divenute ormai dei classici nell’ambito degli studi di architettura militare greca le torri della cinta di Messene, poiché esemplificano lo sviluppo formale di questi manufatti, pensati per l’alloggiamento delle artiglierie, a partire dall’epoca dei pezzi a pretorsione, come una torre del fronte occidentale con feritoie allargate121, fino all’introduzione delle grandi catapulte, presumibil-
122
MARSDEN 1969, pp. 129-133; ADAM 1982, p. 50. MARSDEN 1969, pp. 133-135; ADAM 1982, p. 50. 124 TOMLINSON 1961; WINTER 1971, pp. 135-137; ADAM 1982, pp. 2425, 27-35; KARLSSON 1992, pp. 67-70; BRACONI 2001; TRÉZINY 2004, pp. 604-606. Il Garlan (1974, pp. 342-343) commentando un passo di Filone (Sintassi Meccanica [1974], V, A, 13), in cui si consiglia di realizzare i diatoni con travi in legno ricorda che l’unico esempio noto nel mondo greco è un tratto delle mura di Istria fra fine IV e III sec a.C. 125 MARSDEN 1969, pp. 126-139 passim; GARLAN 1974, p. 363 126 Un esempio famoso è quello della torre B di Halos (ADAM 1982, p. 58), la cui struttura dalle fondazioni a tutto l’elevato è completamente autonoma da quelle delle cortine a lei agganciate. D’altro canto questo accorgimento tecnico rappresenta una norma ormai assodata e fondamentale in Vitruvio, che ancora una volta si presenta come il prodotto culturale dell’Ellenismo in materia di ingegneria militare. 123
118 GARLAN 1974, pp. 190-191; ADAM 1982, pp. 112-115. Filone di Bisanzio tratta l’argomento dei fossati teorizzandone lo scavo di tre successivi davanti alle mura e sottolineandone quindi l’importanza per la difesa (supra p. 13 note n. 82, 83), ma già Enea Tattico raccomanda lo scavo di fossati profondi per poter intercettare le gallerie nemiche (Poliorcetica [1967], XXXVII, 1-5) 119 La trattazione sull’evoluzione dei tipi di torre dal IV sec. a.C. alla fine dell’età ellenistica, corredata di numerosi esempi ai quali si rimanda come documentazione archeologica sull’argomento, si trova in MARSDEN 1969, pp. 126-163; LUGLI 1970, pp. 859-861; WINTER 1971, 164203; GARLAN 1974, pp. 193-196, pp. 257-268; MARTIN 1974, pp. 202203; LAWRENCE 1979, pp. 383-391; ADAM 1982, pp. 46-65, pp. 105111; OBER 1987; KARLSSON 1992; OBER 1992; WINTER 1997. 120 L’argomento dell’alloggiamento dei pezzi e le indicazioni sulle thyrìdes sono spesso toccati da Filone di Bisanzio, come per esempio nei passi citati precedentemente (supra p. 13 note n. 87, 88). 121 La torre è stata datata al 369 a.C.; MARSDEN 1969, pp. 127-129; ADAM 1982, pp. 46-48.
[…]Al livello della parte inferiore delle torri bisogna anche dividere il muro in intervalli tanto grandi quanto lo saranno le torri in modo che nei settori interni delle torri i cammini di ronda siano fatti di travi lignei senza assicurazioni in ferro; infatti se il nemico avrà occupato una certa parte del muro, i difensori lo separeranno e, se opereranno rapidamente, non si permetterà che i nemici penetrino altre parti delle torri e del muro, a meno di voler precipitare. (De Architectura [1990], I, V, 4). 127 Un esempio significativo è quello di una torre ellenistica semicircolare delle mura di Hipponion in Calabria, il cui spessore delle fondazioni (m. 3,50 ca.) lascia presumere lo sviluppo in altezza di tre piani (MARSDEN 1969, p. 154). In generale sulle opere delle mura di Hipponion BYVANK 1914, pp. 155-167; ORSI 1921, pp. 473-476; SÄFLUND 1935, pp. 87-107; AUMÜLLER 1994.
17
Le porte128 rappresentarono fin dall’età delle cittadelle micenee un punto critico per l’economia difensiva di un centro fortificato, poiché costituivano in definitiva un varco che, per quanto necessario, veniva aperto di proposito attraverso le mura. La localizzazione delle porte generalmente era il prodotto dell’integrazione di più esigenze concorrenti di ordine difensivo e urbanistico. Infatti la natura del sito della porta e del terreno immediatamente fuori le mura avrebbe dovuto essere favorevole all’impianto di una struttura fortificata, disagevole all’accesso esterno, compatibilmente con la viabilità, e agevole per i collegamenti con l’abitato. D’altro canto la porta, elemento limitaneo dell’area urbana e punto di collegamento fra pòlis e chòra, doveva rapportarsi in modo funzionale agli assi viari che uscivano dall’abitato, per collegarsi alle strade e agli itinerari della regione in cui sorgeva la città, o mettersi in relazione ai porti, se la città si affacciava sul mare. Le scelte attuate nel corso dei secoli avevano tenuto conto di questi parametri, ma considerando l’aspetto prettamente difensivo, specifico di questa sede, è possibile notare che le porte urbiche fino al V sec. a.C. utilizzarono generalmente la conformazione cosiddetta «scea» per far fronte nel modo migliore alle più diverse condizioni topografiche locali. La porta scea infatti, non aprendo un varco attraverso le cortine, ma ponendosi nel punto di collegamento sfalsato fra due tratti di mura paralleli, costringeva sempre, indipendentemente dalla natura del sito, ad un percorso di accesso che lasciava scoperto il fianco destro non protetto dallo scudo.
gato, intermedia fra l’interno e l’esterno della cinta, e alla copertura reciproca delle opere che fortificavano quest’area. Nei casi come quello del Trìpylon di Siracusa130, datato al IV sec. a.C., fu realizzato un apprestamento «a tenaglia aperta», con l’assunzione di un profilo fortemente strombato verso l’interno dei due lati del corridoio. Nell’ambito invece di un’ampia casistica, diffusa in tutte le regioni del mondo ellenistico, che culmina per esempio con la porta sud di Pergamo131, si documenta l’evoluzione delle porte a tenaglia nel tipo «a cortile». Si tratta di una struttura che nasceva dall’avvicinamento delle torri più esterne del corridoio coperto, tanto da posizionare un primo varco d’accesso fra di esse e un secondo al fondo dell’area occupata dal vecchio corridoio, ora trasformato in cortile chiuso, sporgente verso l’interno della cinta. Esempi di questo tipo sono la Porta di Arcadia a Messene132 la porta di Istmia a Corinto133, la principale ovest di Assos134, la porta di Elettra a Tebe135. Il modello a cortile è quello che riscosse poi maggiore fortuna e rappresenta l’eredità principale lasciata dall’Ellenismo all’architettura militare romana, che da esso derivò il tipo di porta a cavaedium, con la coppia di torri esterne allineate alla successione di quelle della cinta e l’arx interna al circuito fortificato136. Ma ancor più interessante è notare che nelle fortificazioni romane il messaggio presente nell’enfasi architettonica delle porte, immagini della città stessa e della maiestas urbis, trovava riscontro nella valorizzazione monumentale di intento propagandistico che in tutto il mondo ellenistico veniva conferita dai sovrani e dalle magistrature poliadiche alle fortificazioni, e in particolare alle porte, in quanto simboli di civiltà e sicurezza137.
Nel IV sec. a.C. la moltiplicazione delle torri lungo i circuiti difensivi interessò in modo particolare anche le porte, dal momento che la torre era il manufatto che offriva un miglior controllo del terreno dall’alto e permetteva di attuare una difesa di fiancheggiamento grazie all’introduzione delle artiglierie. A godere di tali innovazioni furono immediatamente le porte scee che, mantenendo la loro planimetria tradizionale, si trasformarono nel tipo «a copertura» con l’allungamento dei corridoi di accesso e l’aggiunta di torri presso l’estremità esterna del varco e davanti ad esso. L’esempio classico di tali evoluzioni è costituito dalle porte di Mantinea129, fra le quali tuttavia la porta A rappresentava una tipologia nuova «a tenaglia», derivante dal sistema «a corridoio», evolutosi parallelamente alla porta scea. In questo genere di porta il varco si apriva attraverso un tratto di cortina posto al fondo di un corridoio che era generato da un ripiegamento interno delle mura rispetto alla linea del tracciato. La porta presso l’accesso esterno del corridoio era armata di torri che potevano dominare il terreno antistante e il percorso fino al varco arretrato, fiancheggiarsi a vicenda e coprire i tratti di cortina adiacenti.
Un ultimo tipo di porta, elaborato in epoca ellenistica a partire dal III sec. a.C. e culminante all’inizio del II sec. a.C., era la cosiddetta «Kammertor», un’opera poderosa costituita generalmente da un unico torrione, nel basamento del quale si apriva il varco di accesso138. Si tratta praticamente di un tipo simile alla porta a cortile, ma le torri frontali e le strutture retrostanti si fondevano in un unico corpo di fabbrica, che copriva il cortile e poteva permettere la posa in batteria di pesanti litoboli sul piano al livello del cammino di ronda e su altri superiori. Esempi famosi sono la porta ovest di Eretria139 e la principale di Sidé140, ma la diffusione di questo tipo toccò regioni lontane del mondo ellenizzato come dimostrano la porta di Syllion in Panfilia141 e quella della fortezza di Patraios sul Bosforo Cimmerio142.
130
supra p. 16 nota n. 108. WINTER 1971, pp. 224-225, p. 227; MARTIN 1974, pp. 136-137; ADAM 1982, pp. 90-92. 132 WINTER 1971, p. 217; ADAM 1982, p. 90. 133 WINTER 1971, pp. 224, 227. 134 WINTER 1971, p. 224. 135 WINTER 1971, p. 229. 136 BRANDS 1988, pp. 16-29; GROS 1998, pp. 37-38. 137 MARTIN 1974, pp. 196-203; GRECO-TORELLI 1983, p. 355. 138 WINTER 1971, pp. 180-188, pp. 232-233; BRANDS 1988, pp. 29-33. 139 SCHEFOLD 1968, p. 281; WINTER 1971, p. 186; KRAUSE 1972, pp. 50-74. 140 MANSEL 1963, pp. 36-40; WINTER 1971, p. 183.. 141 WINTER 1971, pp. 165, 232. 142 TOLSTIKOV 1986, p. 176. 131
Durante l’età ellenistica l’evoluzione delle porte prese le mosse dai tipi a corridoio e a copertura ed era finalizzata alla creazione di un’area di controllo e di passaggio obbli128
Per l’evoluzione, la strategia difensiva e la documentazione delle porte in età ellenistica a partire dal IV sec. a.C. WINTER 1971, pp. 217233; GARLAN 1974, pp. 196-198; LAWRENCE 1979, pp. 327-334; ADAM 1982, pp. 77-92, 99-104; ADAM 1992. 129 ADAM 1982, pp. 83-89.
18
Chiudono infine la rassegna delle evoluzioni tecniche le trasformazioni delle postierle e la nascita degli antemurali. Le postierle, presenti fin dall’età arcaica nelle fortificazioni delle pòleis, a partire dal IV sec. a.C. si multiplicarono e si evolsero con opere esterne di protezione per favorire le azioni di disturbo dei difensori fuori dalle mura. Esse erano generalmente aperte nei tratti di cortina presso le torri, che permettevano l’uscita con il fianco destro scoperto rivolto verso le mura143. Gli antemurali costituivano una categoria eterogenea di opere, realizzate all’esterno della linea di cinta, che comprendeva i fossati, le palizzate e le piattaforme, fatte in muratura, fra le mura e i fossati per l’installazione delle artiglierie a tiro radente, che oggi vengono denominate proteichìsmata, utilizzando il termine filoniano144. Il Winter ha classificato queste opere e ne ha proposto un ordinamento cronologico che comprende una prima fase (375 ca. - fine IV sec. a.C.), in cui gli antemurali erano costituiti soprattutto da fossati e palizzate che servivano a rallentare l’attacco nemico e a costringere gli assalitori a stazionare nell’area di tiro delle artiglierie della piazza. Seguono una seconda fase (III sec. a.C.), caratterizzata dalla presenza delle opere della prima, integrate dalla realizzazione dei proteichìsmata per l’artiglieria operante sul piano di campagna, e una terza ed ultima fase (II e I sec. a.C.), nella quale si assiste allo sviluppo monumenta-le delle strutture della seconda per l’utilizzo in difesa dei pesanti petroboli dell’epoca, impiegati anche dagli assedianti durante gli assalti generali145.
143
WINTER 1971, pp. 234-268; pp. 254-256, pp. 353-355; LAWRENCE 1979, pp. 338-342; ADAM 1982, pp. 93-98. 144 WINTER 1971, pp. 269-286; GARLAN 1974, pp. 250-257; LAWRENCE 1979, pp. 275-282; ADAM 1982, p. 111. 145 WINTER 1971, pp. 285-286.
19
20
CAPITOLO 2
Le vicende storico-militari della Magna Grecia fra IV e III sec. a.C.
Prima di affrontare l’analisi delle testimonianze di architettura militare risalenti all’età ellenistica, che l’archeologia ha potuto restituire in alcune città della Magna Grecia, è necessario considerare brevemente il quadro storico dell’Italia meridionale fra il IV sec. a.C. e la Seconda Guerra Punica, l’intervallo di tempo corrispondente al periodo di nostro interesse, in cui il mondo greco d’occidente, italiota e siceliota, fu coinvolto in avvenimenti bellici frequenti tali da motivare una notevole attività fortificatoria1.
le di quella Achea, ma ora con una specifica funzione antitalica e sostenuta anche da Siracusa. Vi facevano parte oltre a Crotone e Caulonia, Thurii, Metaponto e Velia e la sede fu posta, secondo la migliore tradizione ellenica, presso il santuario di Hera Lacinia a Capo Co-lonna. Le guerre dionigiane La prima metà del IV sec. a.C. è caratterizzata dall’instancabile attività militare di Siracusa e di Dionisio I. Dopo aver affrontato una guerra decennale (409-397 a.C.) contro Cartagine, in seguito alla quale impose la sua egemonia in Sicilia, il tiranno, pur non riuscendo a cacciare definitivamente i Punici, volse il suo interesse al controllo dello stretto di Messina e mise in movimento la macchina delle alleanze. Così, mentre Taranto rimase inattiva, Locri fornì immediatamente ai Siracusani le basi logistiche per la guerra in Italia meridionale e partecipò all’assedio di Reggio del 390 a.C. I Reggini dal canto loro ebbero l’appoggio della Lega Italiota, che si oppose all’espansionismo dionigiano, ma, pur essendo stata sventata la caduta di Reggio, il tiranno con l’appoggio dei Lucani tenne impegnate le forze della Lega nell’entroterra calabrese.
Le Leghe Achea e Italiota Le vicende storiche della fine del V sec. a.C. avevano rinsaldato il già forte vincolo d’alleanza fra Siracusa e Locri, in seguito alla disfatta ateniese in Sicilia del 415-414 a.C, ed era nata un’intesa fra le due pòleis e Taranto, l’altra potente colonia dorica, che dopo aver superato il confronto territoriale con i Messapi manteneva il controllo della rotta d’occidente, grazie alla fondazione di Eraclea nel 433 a.C. e alla pace raggiunta con la colonia panellenica di Thurii. Intorno al 413 a.C. nacque la Lega Achea, le cui principali esponenti erano Crotone e Caulonia, con l’intento di far fronte comune alla politica espansionistica siracusana, mirante ormai all’egemonia in occidente. L’unica città ancora potente e intenzionata ad opporsi all’espansionismo dorico era Reggio, già comunque impegnata contro i Locresi fin dai tempi della Guerra del Peloponneso, essendo alleata di Atene.
La controffensiva fu attuata da Thurii nel 389 a.C., che attaccò con successo il Lucani e li inseguì in direzione di Laos per liberare la città, ma l’armata thurina fu massacrata in una stretta gola della Lucania interna. Forte del rovescio nemico, Dionisio I investì Caulonia nello stesso anno e riuscì a battere un’imponente armata della Lega Italiota nel 389 a.C., ora guidata da Crotone, sull’Elleporo, fra Skylletion e Caulonia, che di lì a poco dovette capitolare. La colonia achea fu rasa al suolo e il suo territorio donato da Dionisio alla fedele Locri, che ottenne anche il controllo di Hipponion sul Tirreno.
Accanto al coinvolgimento nella dinamica delle lotte egemoniche le città della Magna Grecia dovettero cominciare a considerare anche la minaccia delle popolazioni italiche, almeno dal 425 a.C., quando i Sanniti conquistarono Cuma, la più antica colonia magnogreca, e Dicearchia nel golfo di Napoli. L’antesignana della grecità contro gli Italici, in particolare i Lucani, fu Thurii, ma a nulla valse l’impegno per evitare che sempre in quegli anni cadessero in mano lucana le più importanti colonie tirreniche, ovvero Poseidonia, Laos, Pixunte e Skydros. Si salvò solo Velia, che rimase fino alla conquista romana arroccata all’interno delle sue poderose mura. Pertanto sullo scorcio del V sec. a.C. nacque la Lega Italiota, evoluzione forma-
Siracusa riuscì in tal modo a completare l’accerchiamento di Reggio e impose ad essa un pesante tributo, ma già nel 388 a.C., poiché la colonia calcidese non poteva far fronte alla richiesta siracusana, Dionisio I sferrò l’attacco definitivo e conquistò Reggio, vendendo schiavi i cittadini che non potevano riscattarsi autonomamente. Lo scacco subito non fermò l’intraprendenza della Lega Italiota che, per scardinare il potere siracusano, ben saldo ora sui due capi dello stretto, nel 383 a.C., sempre sotto la guida di Crotone, si alleò con Cartagine e mosse guerra a Siracusa e alle sue alleate. Tuttavia la questione si risolse rapidamente quando nello stesso anno Dionisio I, sempre contando sulla fondamentale base locrese, attaccò direttamente Crotone, mettendo prima a sacco l’Heraion di
1 Per le notizie storiche qui presentate CAMERA-FABIETTI 1969, pp. 76122; CASSOLA-CRACCO RUGGINI 1982, pp. 34-45; GUZZO 1982, pp. 149-169; PUGLIESE CARRATELLI 1983, pp. 67-95; LOMBARDO 1987a; LOMBARDO 1987B, pp. 247-258; BETTALLI 2004; COPPOLA 2004; FRISONE 2004; GIANGIULIO 2004; MELE 2004; NAFISSI 2004. Si segnala inoltre l’intero volume degli Atti del Convegno di Taranto 2003 (Alessandro il Molosso e i “Condottieri”in Magna Grecia, ACT XLIII, TarantoCosenza 2003, Napoli 2004), di recentissima pubblicazione e dedicati interamente al tema dello scontro fra Italici e Italioti sul teatro della Magna Grecia di seconda metà IV sec. a. C.
21
tenti di un tempo, come Taranto e Siracusa non avevano più le risorse militari e umane per colpire i Lucani e i Brezii nelle loro stesse sedi. D’altro canto le genti italiche avevano appreso dal mondo italiota non solo i tratti fondamentali della civilizzazione ellenica, ma anche le tecnologie militari avanzate e l’arte della poliorcetica. Pertanto le antiche colonie greche dovettero passare ad una strategia difensiva ormai ordinaria e far conto soprattutto sulle proprie fortificazioni per sventare attacchi improvvisi com’era capitato ad Eraclea.
Capo Lacinio e poi impadronendosi della colonia achea, che rimase presidiata dai Siracusani fino al 378 a.C. L’avanzata degli Italici Il nuovo assetto politico dunque vedeva ormai tutte le città ostili a Siracusa o sottomesse o impossibilitate all’azione, e da questa nuova situazione derivò un periodo di relativa calma, in cui si trovavano a contatto l’area di influenza tarantina a nord e quella siracusana a sud. I rapporti fra le due città egemoni furono ottimi grazie alla volontà di Dionisio I di dedicarsi al consolidamento del potere raggiunto e soprattutto all’abilità politica e all’autorevolezza di Archita, un personaggio che, rieletto per ben sei volte stratego, seppe dare a Taranto e a tutte le città italiote quel periodo di pace che permise di raccogliere le forze per far fronte alla sempre più incalzante minaccia dei Lucani, ai quali si unirono, intorno alla metà del secolo, i Brezii, un altro popolo di stirpe sabellica.
Gli ultimi decenni del IV sec. a.C. non registrarono particolari eventi bellici, anche perché le genti sabelliche erano impegnate in guerra contro Roma, un nemico ben più tenace che le città greche. Tuttavia Taranto capì fin dal 314 a.C., anno della deduzione delle colonie latine di Arpi, Lucera e Canusio, che la nuova minaccia proveniva da Roma, vittoriosa in Lucania e in Daunia, cosicché chiamò in Italia un altro condottiero greco, lo spartano Cleonimo, che invece di affrontare i Romani e i Lucani, stipulando la pace di sua iniziativa, diresse i suoi trentamila uomini all’occupazione di Metaponto, che aveva lasciato in balia dei Lucani, e da lì a Corcira. Quando tornò a Taranto fu cacciato dalla cittadinanza, ma il problema dell’avanzata italica rimaneva irrisolto.
In seguito alla morte di Dionisio I, nel 367 a.C., e alla cacciata di suo figlio Dionisio II da Siracusa, nel 356 a.C., la città di Locri, che ospitò l’esule, si impegnò nella rifondazione di Caulonia intorno alla metà del secolo, ma nel 346 a.C. l’insurrezione che causò l’allontanamento da Locri di Dionisio II portò al potere un governo democratico, che ruppe la secolare alleanza con Siracusa determinando l’incrinazione della sua egemonia nel settore meridionale della Magna Grecia.
Intervenne allora in aiuto degli Italioti il tiranno di Siracusa Agatocle, che, sebbene avesse riportato una serie di successi iniziali, fu sconfitto nel 298 a.C. all’assedio della città brezia di Ethai. La reazione siracusana nel 295 a.C. fu la spedizione di Stilpone che avrebbe dovuto devastare lungo le coste ioniche e nell’interno i territori occupati dai Brezii, ma in realtà venne occupata Crotone e poi da lì Hipponion, togliendola agli Italici.
Nella seconda metà del IV sec. a.C. il fulcro della politica magnogreca si spostò verso l’area tarantina e thurina, lasciando le città della zona meridionale, a partire da Crotone, sempre più impegnate nella difesa dall’espansionismo dei Brezii. Fin dai tempi di Archita, Taranto si era messa a capo della Lega Italiota, trasferendo la sede dal santuario di Hera Lacinia ad Eraclea di Lucania, ma, quando venne a mancare il valente stratego, la città dorica cercò in Grecia uomini capaci di sostituirlo e, nel 342 a.C., dovendo far fronte in prima persona alla minaccia dei Lucani e dei Messapi, la cittadinanza tarantina chiamò in Italia Archidamo di Sparta, che si batté valorosamente, ma cadde a Manduria nel 338 a.C.
La guerra di Pirro Si giunge così al III sec. a.C., momento in cui Roma, dopo le guerre sannitiche, si volse alla conquista dell’Italia meridionale. I Romani avevano fatto la loro comparsa già nel 327 a.C., quando grazie all’appoggio dell’aristocrazia ellenica conquistarono Neapolis, tenuta dai Sanniti, in conseguenza all’offensiva condotta da questi ultimi contro le colonie dell’ager Campanus. Da quella data in poi Roma iniziò ad intrattenere una fiorente attività diplomatica con le pòleis magnogreche, che condusse per esempio al foedus stipulato con Locri nel 285 a.C., poiché i Greci d’occidente, soprattutto dopo la morte di Agatocle nel 289 a.C., vedevano in Roma il possibile alleato potente, capace di battere i popoli Italici della Lucania e della Calabria, così come aveva dimostrato di saper fare nel Sannio. Pertanto esisteva un trattato anche fra Roma e Taranto, la cui data della stipula non è ben definita, ma era chiara la clausola basilare che vietava ai Romani la navigazione a nord di Capo Colonna.
Dopo poco tempo i Lucani lanciarono una seconda offensiva, riuscirono a conquistare Eraclea e a minacciare così direttamente il territorio di Metaponto e indirettamente quello di Taranto, incuneandosi per giunta fra le due pòleis e Thurii. Per porre rimedio ad una situazione tanto critica giunse in Italia Alessandro il Molosso, re dell’Epiro e zio di Alessandro Magno, nel 334 a.C., lo stesso anno in cui il Macedone dava inizio alla sua avventura orientale. Ma il Molosso ebbe meno fortuna del nipote, poiché, pur riuscendo a liberare Eraclea e addirittura Poseidonia, conquistando Cosenza, la capitale della confederazione brezia, e tenendo gli Italici in scacco per un certo periodo di tempo, cadde in battaglia all’Acheronte nel 331 a.C., durante un’offensiva contro i Brezi.
Nel 281 a.C. ebbe inizio la guerra tarantina, quella che determinò la sottomissione a Roma di buona parte delle pòleis italiote, segnando la fine della loro autonomia. In quell’anno Thurii divenne l’obiettivo di un’ennesima offensiva italica, portata avanti da Lucani e Brezii coalizza-
Con la morte di Alessandro il Molosso inizia il periodo più critico per le città magnogreche, infatti le pòleis po-
22
difesa, in previsione di possibili offensive puniche in Italia Meridionale.
ti. Per evitare l’occupazione, la città greca chiese l’aiuto di Roma, che, violando la clausola del trattato con Taranto, inviò le sue forze nella Sibaritide, sconfisse gli Italici e lasciò presidi anche a Crotone e Locri. La risposta di Taranto non tardò, quando nello stesso anno vennero distrutte alcune navi romane al largo del Mar Grande, in conseguenza alla perseveranza romana nella violazione del trattato. L’armata tarantina infine occupò Thurii espellendo il governo aristocratico filoromano. La reazione di Roma, in seguito al fallimento delle trattative diplomatiche, fu pesante e il territorio di Taranto, invaso, fu messo a ferro e fuoco. È a questo punto che, chiamato dai Tarantini, fece il suo ingresso sulla scena della guerra Pirro, un altro re d’Epiro, che, come il Molosso, sperava di estendere i suoi domini in occidente. Il potente esercito epirota, composto di tutti i reparti ordinari e specializzati dell’epoca, compresi gli squadroni di elefanti da guerra, portò in Italia l’immagine di un’armata ellenistica «moderna» e delle sue potenzialità. Questo fatto non si era più verificato dai tempi degli interventi di Agatocle, che come il suo predecessore Dionisio I aveva potenziato l’armata siracusana, soprattutto dal punto di vista meccanico, con l’utilizzo di pesanti artiglierie neurobalistiche.
L’evento che concluse tragicamente il III sec. a.C. fu la guerra annibalica, denominazione con cui si è soliti indicare quella fase della Seconda Guerra Punica, successiva alla battaglia di Canne del 216 a.C., che vide il coinvolgimento nel conflitto delle città italiote e la trasformazione dei loro possedimenti in terreno di guerra. È noto che la seconda grande guerra fra Roma e Cartagine scoppiò nel 218 a.C. e l’anno successivo Annibale al comando di un potente esercito cartaginese condotto in Italia dalla Spagna, aveva già sconfitto i Romani alle battaglie del Ticino, della Trebbia e sul Lago Trasimeno. Il disastro romano di Canne nel 216 a.C. determinò il passaggio dalla parte punica delle genti sannite, lucane e brezzie, desiderose di riottenere l’autonomia da Roma, seguite immediatamente da Capua. Non tutte le aristocrazie delle pòleis italiote alleate di Roma onorarono il foedus, andando contro il dissenso dei corpi sociali inferiori, anche durante l’attuazione della strategia di guerriglia e d’attesa portata avanti da Fabio Massimo. Seguendo l’esempio di Siracusa del 214 a.C., Taranto aprì le sue porte ad Annibale nel 213 a.C. e da lì a poco il condottiero cartaginese fissò il suo quartier generale a Metaponto. La stasi delle operazione militari ad ampio raggio fu interrotta dalla riconquista romana di Taranto nel 209 a.C., durante il proconsolato di Publio Cornelio Scipione, grazie alla resistenza opposta dal presidio romano, arroccatosi sull’acropoli fin dall’occupazione punica di quattro anni prima.
Sta di fatto che l’avanzata di Pirro, nonostante le dubbie vittorie di Eraclea nel 280 a.C. e Ascoli nel 279 a.C., penetrò nel cuore della Magna Grecia, con l’occupazione di Reggio e di Locri, che aveva abbandonato l’alleanza romana, e si estese alla Sicilia, dove Roma seppe tuttavia reagire indirettamente, opponendo agli Epiroti i Cartaginesi, suoi nuovi alleati. L’assenza di Pirro permise ai Romani dal 278 a.C., con il foedus di Eraclea, di recuperare le posizioni perdute grazie alla riconferma delle alleanze con le pòleis campane e con quelle arresesi agli invasori e tramite la riconquista di Locri e Crotone nel 277 a.C. Tuttavia già nel 276 a.C. Pirro tentò una controffensiva in Italia, ma venne battuto in Calabria dai mercenari campani, che si erano stanziati nell’entroterra reggino, dopo il congedo dal servizio siracusano ai tempi di Agatocle. Il re riparò a Locri fino all’anno successivo, quando l’esercito romano comandato da Manio Curio Dentato lo sconfisse definitivamente alla battaglia di Benevento.
Fu soprattutto la sconfitta di Asdrubale, fratello di Annibale, proveniente dalla Spagna con un’armata di soccorso, alla battaglia del Metauro nel 207 a. C., che costrinse i Cartaginesi a ripiegare verso la punta dello stivale, dove Reggio era già comunque controllata saldamente dai Romani. Il caposaldo della resistenza cartaginese divenne allora Locri, che si era consegnata ad Annibale fin dal 216 a.C. esiliando gli aristocratici filoromani e permettendo la conquista di Crotone nel 215 a.C. Nel 205 a.C. l’armata di Scipione, proveniente da Reggio, riconquistò Locri e l’anno seguente Annibale lasciò l’Italia, richiamato a Cartagine dall’offensiva portata dai Romani in terra d’Africa.
Nel 273 a.C. Roma concluse l’isolamento di Taranto con la deduzione della colonia latina di Paestum, assicurandosi così il controllo dell’ultimo corridoio della Lucania interna aperto fra lo Ionio e il Tirreno, e nel 272 a.C. il presidio epirota di Taranto consegnò la città all’esercito romano, piuttosto che permettere l’ingresso di una minacciosa flotta cartaginese presentatasi davanti al porto.
Alla conclusione della Seconda Guerra Punica nel 202 a.C., dopo la battaglia di Zama, le città italiote federate di Roma videro ridotta di molto la loro autonomia, se non la perdita definitiva della libertà e la loro trasformazione in municipia, come avvenne a Metaponto. Ebbe così inizio la seconda fase della romanizzazione della Magna Grecia, che a poco a poco introdusse giuridicamente le regioni delle antiche apoikìai nel contesto dell’Italia romana.
La guerra annibalica Le vicende della Prima Guerra Punica, che condusse Roma fra il 264 a.C. e il 241 a.C. alla conquista della Sicilia, non interessarono direttamente le città italiote e i loro territori, ma esse furono soltanto impegnate nel rifornimento di forze navali per i Romani, che si trovarono per la prima volta ad affrontare un potente stato ellenistico talassocratico quale era Cartagine. Furono comunque anni in cui le città della Magna Grecia dovettero provvedere alla loro
23
24
PARTE SECONDA L’architettura militare tardo classica e ellenistica nelle città della Magna Grecia
stema fortificato urbano e territoriale, che viene indicato come la principale ragione dell’autonomia conservata durante i difficili secoli precedenti l’ingresso pacifico nell’Italia romana, la seconda per gli imponenti resti monumentali e la loro collocazione storica nel periodo di maggior sviluppo della poliorcetica ellenistica.
Dopo aver passato in rassegna le vicende storiche della Magna Grecia fra IV e fine III sec. a.C., si può intraprendere l’esame delle testimonianze archeologiche relative alle fortificazioni urbane realizzate in questo periodo. L’indagine è stata condotta su otto città scelte in base all’importanza storica rivestita nel periodo in esame e all’entità della documentazione edita e disponibile. Sebbene il numero sia certamente integrabile con lo studio di altre città, ugualmente importanti nella storia della Magna Grecia, ma non presenti in questa sede, le otto scelte appaiono le più significative nei limiti cronologici della ricerca ed esemplari anche per le assenti, nonché per il contesto generale in merito alla tematica affrontata.
Per le città qui non presenti, ossia Cuma, Heraclea di Lucania, Hipponion, Neapolis, Reggio, si rimanda a SCONFIENZA 2003, dove sono analizzate le caratteristiche delle loro opere difensive, nell’ambito di considerazioni generali sulle fortificazioni magnogreche, ed è segnalata per ciascuna di esse la bibliografia specifica.
Per ciascuna delle otto città si è tentato di ricostruire l’aspetto e il funzionamento del sistema difensivo a partire dal IV sec. a.C., mettendo in luce le preesistenze e la natura degli interventi attuati durante l’età tardo classica ed ellenistica, per integrare o anche ricostruire le componenti del sistema stesso. Le pòleis prese in esame sono ordinate secondo un criterio geografico, seguendo da nord a sud il periplo della costa ionica della Magna Grecia per risalire da sud a nord la costa tirrenica oltre lo stretto di Messina. La prima città studiata è Taranto, le cui testimonianze, per quanto ridotte, riescono ad illustrare sommariamente l’assetto difensivo di quella che fu l’antesignana della grecità d’occidente, proprio quando essa attraversò il momento di crisi peggiore e la conquista romana. Seguono Metaponto, che in epoca ellenistica, accanto a Taranto, affrontò le lotte contro i popoli italici e le vicende tragiche della guerra annibalica, e Castiglione di Paludi, un centro di fondazione recente, la cui attribuzione è ancora discussa, ma che dalla seconda metà del IV sec. a.C. rappresenta perfettamente il tipo di insediamento fortificato utilizzato dalle genti italiche dell’interno, per opporsi alle pòleis italiote della costa. Vengono poi altre due protagoniste della storia magnogreca del IV sec. a.C., Crotone e Caulonia, entrambe vittime dell’espansionismo dionigiano, e ad esse fa seguito Locri Epizefiri, la principale alleata di Siracusa che si misurò in campo avverso con le due precedenti. Tutte e tre le città inoltre documentano singolari sistemi di fortificazione, riconducibili a parallele e coeve interpretazioni della problematica difensiva, nel periodo che interessa la ricerca. Infine sulla costa tirrenica sono state oggetto di studio Velia e Paestum, la prima a causa del suo particolare si-
25
26
CAPITOLO
1
Taranto
strategico2. L’acropoli stessa era naturalmente difesa grazie alla sua estremità orientale, corrispondente ad un istmo depresso e invaso dalla marea, prima ancora che i Tarantini, in un momento imprecisato dell’età arcaica separassero la città dalla terraferma aprendo un fossato attraverso l’istmo, che venne trasformato nell’attuale canale navigabile dagli Aragonesi nel 1480. L’eccezionale posizione strategica della cosiddetta città vecchia infatti non passò inosservata nei tempi moderni, quando, fra il 1490 e il 1491 presso il limite sud-orientale fu edificato il castello, che nel XVI secolo trasformò Taranto nella più importante piazzaforte marittima ionica del Vicereame di Napoli3.
L’antica colonia di Sparta fu una delle più illustri protagoniste della storia della Magna Grecia, in particolare nell’epoca che va dalla prima metà del V sec. a.C. fino alla Seconda Guerra Punica, quando assunse a poco a poco un ruolo egemonico nell’ambito dei rapporti fra le pòleis d’occidente e di quelli con le genti italiche, accanto alla corinzia Siracusa. Essa rappresentò poi un baluardo nei confronti dell’avanzata romana per divenire in seguito una delle piazzeforti nevralgiche della resistenza di Roma stessa contro i Cartaginesi. Risulta quindi che il periodo di maggior coinvolgimento di Taranto nelle vicende politico-militari della Magna Grecia corrisponde circa a quello di nostro interesse, certamente per l’arco di tempo che comprende il IV e il III sec. a.C., ossia l’età di Archita, quella delle lotte con i popoli italici e della venuta dei condottieri stranieri fino alla campagna di Pirro, contestale al primo scontro con Roma, e infine la guerra annibalica1. L’importanza del ruolo assunto da Taranto in queste vicende giustifica l’interesse per la ri-strutturazione del suo sistema difensivo in età ellenistica, ma purtroppo lo stato della ricerca archeologica, pur avendo restituito dati sufficienti per la definizione del circuito murario greco, è fortemente vincolato all’insistenza della città moderna sul sito di quella antica e dall’ab-bandono già in età romana di buona parte dell’abitato greco e delle mura andate così in rovina. Pertanto, se non si può riferire con assoluta certezza la situazione planimetrica generale e di alcuni settori specifici importanti, poco o nulla si può dire sull’aspetto in elevato delle mura di IV e III sec. a.C.
Tornando alla colonia spartana, lo storico Livio, fonte discussa, ma tanto importante per la ricostruzione delle fortificazioni taratine4, descrive le difese dell’acropoli al momento dell’assedio cartaginese del 213 a.C., che corrispondevano ancora a quelle della città arcaica, previe eventuali ristrutturazioni nel corso dei secoli raramente documentate. L’autore riferisce che il fronte orientale, affacciato verso la città nuova, era difeso da mura in opera quadrata, di cui sono stati individuati i resti in alcuni interventi archeologici5 e che è possibile ricondurre all’inizio del VI sec. a.C., momento in cui si avvia la monumentalizzazione dell’acropoli. Verosimilmente questa potrebbe anche essere la data dell’apertura del fossato antistante, che separa la fortificazione dalla terraferma, individuato di recente da saggi archeologici nell’area del castello aragonese6, e dell’edificazione di una porta e di un ponte a cavallo del fossato, la cui esistenza ancora in epoca ellenistica è documentata dal testo liviano. Sempre attingendo dallo storico latino, si comprende che i lati occidentale, meridionale e settentrionale erano difesi dalla natura orografica della penisola, che a partire dall’istmo, saliva in direzione ovest limitata da prealtis rupibus; attualmente esse non sono più visibili per la presenza degli edifici urbani lungo la costa del Mar Grande e per una possente ricarica di terreno, gettata lungo i limiti settentrionali della Città Vecchia in età aragonese, per collegare
Le fortificazioni tarantine Il sistema difensivo di Taranto era caratterizzato dalla compresenza di due cinte fortificate distinte, quella dell’acropoli, corrispondente all’attuale Città Vecchia e in antico al sito della ktìsis laconica del 706 a.C., e quella dell’ampliamento sulla penisola ad est dell’acropoli, a partire dalla metà del V sec. a.C. § L’acropoli
2
SCHMIEDT 1967; WINTER 1971, p. 21; GRECO 1985, pp. 348-350. Francesco di Giorgio Martini progettò il castello e diresse i lavori del cantiere Alessandro Zuccaretto (FARA 1989, pp. 26-28; RUSSO 1989, pp. 106-111). 4 Ab urbe condita (1958), XXV, 11, 1. Nel 1970 il Lo Porto (1971a, pp. 358-359) negava la precisione dei passi liviani dedicati alla descrizione delle fortificazioni di Taranto e soprattutto a quello in cui si parla dell’acropoli, mentre Emanuele Greco (1981b, pp. 153-154), riprendendo la lettura di Livio, accanto a quella rinnovata di altre fonti come Strabone, riabilita pienamente la credibilità dello storico latino. 5 Presso Palazzo delli Ponti e il Pendio la Riccia (DELL’AGLIO 1996a, p. 80; LIPPOLIS 1997b, p. 532; LIPPOLIS 2002, p. 134). 6 MATTIOLI 1998; ANDREASSI 2000, pp. 790-791. Il fossato greco sembra che sia stato utilizzato anche per la realizzazione di quello del castello aragonese e l’ampliamento di quest’ultimo determinò la nascita dell’attuale canale navigabile (LIPPOLIS 1981, pp. 90-91; LIPPOLIS 1997a, pp. 47-48; LIPPOLIS 2002, p. 134).
La cosiddetta acropoli di Taranto corrisponde all’estremità della penisola che divide le acque esterne del golfo omonimo, denominato Mar Grande, da quelle di una laguna interna, il Mar Piccolo, che rappresenta fin dall’antichità un porto naturale perfetto, dal punto di vista
3
1
Per le vicende storiche di Taranto WUILLEUMIER 1939 ; DE GRASSI 1966, pp. 603-605; GRECO 1981a, pp. 177-182; LIPPOLIS 1981, pp. 7783; GUZZO 1982, pp. 49-51, pp. 108-169 passim; GRECO-TORELLI 1983, pp. 177-179; PUGLIESE CARRATELLI 1983 passim; CORDANO 1985, pp. 318-323 ; GIANGIULIO 1987 passim; LOMBARDO 1987a passim; GRECO 1993, pp. 49-54, pp. 284-309; LIPPOLIS 1997a, pp. 39-41; DE JULIIS 2000, pp. 9-34; MELE 2002; MOGGI 2002.
27
la quota dell’abitato alle sponde insabbiate del Mar Piccolo.
Il fronte orientale, quello più nominato dalle fonti e indagato dagli archeologi, è stato datato nel suo primo impianto alla metà del V sec. a.C. grazie all’analisi paleografica dei segni di cava e di cantiere rinvenuti su numerosi blocchi lapidei emersi fin dagli scavi dell’800. Esso era costituito da due lunghi segmenti murari, che presso la Salina Piccola convergevano per formare un angolo saliente, dedotto, e non portato alla luce, dall’andamento dei due segmenti indagati archeologicamente in più punti dagli scavi soprattutto del Viola e del Lo Porto.
Alcuni interventi della Soprintendenza Archeologica in occasione di lavori pubblici e di cantieri privati hanno permesso di documentare l’esistenza di tratti di fortificazione lungo i margini antichi dell’acropoli, pertinenti al fronte del Mar Piccolo e databili al V-IV sec. a.C.7, e alcuni resti delle mura prospicienti il Mar Grande8. Pertanto si può ipotizzare che, almeno dal IV sec. a.C. in poi una cerchia muraria, forse discontinua, chiudesse la palaìpolis e questo assetto difensivo, secondo il racconto di Polibio9, impedì ad Annibale di prendere d’assalto l’acropoli e lo costrinse a creare una controvallazione con fossato e palizzate, secondo i criteri della strategia ossidionale preellenistica, per bloccare la guarnigione romana di Marco Livio Macato, che riuscì a resistere fino al 209 a.C., quando Quinto Fabio Massimo riconquistò Taranto10.
Le fonti letterarie e in particolare Polibio collocano su questo fronte la discussa porta Temenide, attraverso la quale nel 213 a.C. entrarono Annibale e l’esercito cartaginese grazie alla complicità del popolo tarantino, cogliendo di sorpresa la guarnigione romana e il suo comandante12. Le indagini su questo lato della fortificazione hanno inoltre permesso di illustrarne con precisione la tecnica costruttiva. La struttura difensiva spessa in media 2,60 metri, era costituita da due paramenti allineati in opera quadrata, composti da blocchi in calcare, talvolta in puddinga, collegati a intervalli generalmente regolari da diatoni, che servivano come giunti elastici fra le due facciaviste e che suddividevano in sezioni consecutive un émplekton interno di materiale eterogeneo, terra e ciottoli13.
§ La città nuova Intorno alla metà del V sec. a.C. la città di Taranto si espanse lungo la penisola ad oriente dell’acropoli su di un’area assai ampia, che fu racchiusa da una cinta fortificata nuova. Le ragioni di tale espansione sembrano motivate da una concomitanza di avvenimenti, quali la pesante sconfitta subita dall’esercito di Taranto ad opera dei Messapi nel 473 a.C., che determinò una grave crisi dell’aristocrazia militare, residente nell’acropoli, al punto da giustificare una trasformazione democratica del governo della città e un massiccio inurbamento degli abitanti dei villaggi della chòra, fra il 480 e il 470 a.C., conseguente forse al cambio di rotta della politica governativa. Sta di fatto che l’area destinata ai nuovi quartieri si estendeva per circa 500 ettari e le mura seguivano un perimetro superiore ai 10 chilometri, cingendo l’abitato lungo il Mar Piccolo a nord, dal fossato dell’acropoli fino a Collepasso, a sud lungo il Mar Grande fino alla Torre di Ayala presso Montegranaro, mentre ad est delimitavano la città entro il sito della Salina Piccola11.
Il fronte settentrionale affacciava sul Mar Piccolo e alcuni tratti furono indagati dal Viola nell’800, rivelando una tecnica caratterizzata da una cortina semplice in blocchi senza émplekton. È rilevante l’assetto del tratto fortificato affacciato sul porto, indagato presso il vecchio Arsenale, che presentava un accesso al bacino portuale, esterno alle opere difensive, costituito da due varchi monumentali con scalinate, per colmare la differenza di quota fra i moli e l’interno della città14. 12
infra pp. 30, 31. Per le indagini sul fronte orientale VIOLA 1881, pp. 390-391; WUILLEUMIER 1939, pp. 241-242; STAZIO 1965, pp. 163-164; LO PORTO 1969, pp. 200-203; LO PORTO 1971a, pp. 363-364; LO PORTO 1974, pp. 421-422; LO PORTO 1978, p. 498; COCCHIARO 1981, p. 54; DE JULIIS 1981, 355-357; GRECO 1981a, pp. 186-187; DELL’AGLIO-MARUGGI 1987, p. 129; DELL’AGLIO 1988, pp. 133-134; LO PORTO 1992, pp. 818; LIPPOLIS 2002, pp. 153-154; TRÉZINY 2004 p. 615. Le indagini condotte in questo tratto di mura a Masseria del Carmine nel 1980 hanno permesso di chiarire l’ordine delle fasi costruttive della struttura muraria: veniva posto in opera dapprima il paramento esterno, allettato sull’argilla del cavo di fondazione, alla faccia interna di tale paramento erano addossati ad intervalli regolari i diatoni di divisione dell’émplekton e poi come ultima fase era edificato il paramento interno in appoggio alle testate dei diatoni (DE JULIIS 1981, p. 356). Tratti di mura sono stati rinvenuti nella zona di Collepasso, in località Solito-Cavisea, in via Venezia, via Cesare Battisti ex-casino Spagnoletti e in altri siti indicati dal Viola attualmente inglobati nel tessuto urbano moderno. Infine in un saggio del 1988 in via Cesare Battisti è emersa contigua alla linea delle mura un’area rettangolare in cui aveva sede anticamente una struttura sporgente, forse una torre, completamente spogliata (DELL’AGLIO 1988, p. 134). 14 Sul fronte nord VIOLA 1881, pp. 392-393; WUILLEUMIER 1939, pp. 241-242; SCHMIEDT 1967, pp. 34-35; LO PORTO 1971a, pp. 372-373; LIPPOLIS 1981, pp. 105-106; D’ANGELA-LIPPOLIS 1989, pp. 21-29; LIPPOLIS 1997a, p. 142; LIPPOLIS 1997b, pp. 533-534; LIPPOLIS 2002, p. 143. Sono state inoltre condotte alcune indagini nell’area della Scuola di Addestramento Reclute dell’Aviazione Militare che hanno individuato una struttura in carparo parallela alla linea di costa; l’area è ceratamente ricca di resti di for-tificazione, ma insondabile a causa della presenza della zona militare (DELL’AGLIO 1988, pp. 134-135). 13
7 Si tratta di una poderosa struttura in opera quadrata su tre assise venuta alla luce in Largo San Martino (FAVIA 1988, p. 119; GUZZO 1989, p. 572; LIPPOLIS 1997b, p. 532; LIPPOLIS 2002, p. 133) e di un setto in opera quadrata in Via Cava-Salita San Martino alle spalle di San Domenico (DELL’AGLIO 1996b, pp. 84-86; ANDREASSI 1997, pp. 533-534) 8 Si tratta di strutture difensive in blocchi lapidei emersi durante la sistemazione del lungomare Vittorio Emanuele II (PUCCI 1993, pp. 143-144; ANDREASSI 1994, p. 768; LIPPOLIS-D’ANGELA 1996, p. 26). 9 Storie (1982), VIII, 35. 10 Sulle fortificazioni dell’acropoli VIOLA 1881, pp. 377-378; WUILLEUMIER 1939, pp. 239-242; DE GRASSI 1966, p. 605; LO PORTO 1971a, pp. 350-360; MARTIN 1971, pp. 321-322; PORSIA-SCIONTI 1989, pp. 6-8; LO PORTO 1992, p. 8; LIPPOLIS 1997b, p. 532; LIPPOLIS-D’ANGELA 1996; LIPPOLIS 2002, pp. 130-136, 153. 11 Sulle ragioni politiche interne ed esterne per l’ampliamento della città nuova DE GRASSI 1966, p. 604; CORDANO 1974-76; NENCI 1976; PORSIA-SCIONTI 1989, p. 8; GRECO 1981b; GRECO 1993, pp. 284-292; LIPPOLIS 1997b, p. 533. Sulle fortificazioni della città nuova VIOLA 1881, pp. 390-395; WUILLEUMIER 1939, pp. 241-246; DE GRASSI 1966, pp. 605-606; LO PORTO 1971a, pp. 362-365; LO PORTO 1971b, p. 534; MARTIN 1971, pp. 322-324; GRECO 1981b, pp. 150-156; LIPPOLIS 1981, pp. 83-85; PORSIA-SCIONTI 1989, pp. 8-10; LO PORTO 1992, p. 8; ANDREASSI 1996, pp. 748-749; LIPPOLIS 1997a, pp. 42-44; LIPPOLIS 1997b, p. 533. Recentemente su tutto l’impianto tarantino DE JULIIS 2000, pp. 52-58; LIPPOLIS 2002, pp. 132-135, 143-144, 152-155, 157158.
28
Il fronte meridionale difendeva tutta la linea di costa prospiciente il Mar Grande a partire dal raccordo con il lato orientale delle mura presso la Torre di Ayala. Le ricognizioni del Viola non avevano individuato strutture conservate in situ, ma una notevole quantità di blocchi lapidei rivoltati lungo la linea di costa. Tuttavia recenti indagini hanno permesso di individuare strutture pertinenti alla fortificazione di questo lato della città greca lungo corso Vittorio Emanuele III, comprese le tracce di una torre, per ora unica testimonianza a Taranto di tali manufatti15.
tura alla seconda metà del VI sec. a.C., contraddicendo la più comune datazione alla metà del secolo successivo. D’altro canto è sicuramente vero che il completamento del sistema può essersi sviluppato a lungo nel tempo, per almeno un secolo, ma soprattutto, in questa sede, preme far notare che questo rialzo cronologico collocherebbe la nascita di una «Geländemauern» tarantina circa negli stessi anni in cui essa vedeva la luce in numerose altre colonie magnogreche18. Questioni interpretative
Datazione dell’impianto difensivo A proposito dell’aspetto assunto dalle fortificazioni fra il IV sec. a.C. e la guerra annibalica si può immediatamente rilevare che la monumentalizzazione degli accessi al porto risponde alla concezione tipica dell’epoca che individuava nella porta urbica l’immagine della città potente e cosmopolita, quale fu effettivamente Taranto fin dai tempi di Archita, e d’altro canto tali ingressi costituivano l’apertura ideale e la presentazione ufficiale di Taranto al resto del mondo conosciuto.
La datazione del circuito fortificato, verificata archeologicamente solo per il fronte orientale, è stata estesa anche a quello settentrionale e meridionale, cosicché la critica attuale è concorde nel collocare l’edificazione delle mura della città nuova intorno al 450-430 a.C. Per quanto concerne il secolo successivo e l’età ellenistica non è dato sapere se furono operati rifacimenti e di quale genere essi fossero, a causa della perdita completa degli elevati, sebbene gli scavi del Lo Porto, lungo il fronte orientale e specialmente a Masseria del Carmine, abbiano permesso di isolare una fase di rifacimenti successiva all’impianto di V sec. a.C., caratterizzata da una muratura sommaria, composta di materiali raccolti rapidamente e non certo posti in opera con la perizia usata in precedenza.
§ La Geländemauern Ma tornando al fronte orientale, è possibile individuare alcuni caratteri che, pur in mancanza di dati archeologici rilevanti e verificati su ampia scala, permettono di dare un posto alle fortificazioni tarantine nell’ambito dell’architettura militare tardo classica ed ellenistica. Osservando il circuito fortificato urbano si coglie immediatamente il rispetto della norma all’adeguamento alla natura del sito lungo le coste dei due mari, ma ancor più là dove il fronte orientale disegna il grande saliente presso la Salina Piccola, che risulta tale per la necessità di chiudere il circuito proprio in concomitanza di questa depressione e di quella di Pianura Erbarca, sfruttando a favore della difesa la natura del terreno lagunare, unica risorsa su un fronte assolutamente piatto e privo di altre possibilità protettive. Perciò la scelta della «Geländemauern» alla metà del V sec. a.C., epoca in cui questo tipo di circuito inizia a diffondersi, è pienamente giustificata, offre a Taranto una soluzione strategicamente moderna per una buona protezione sul fronte più pericoloso e pone i presupposti per l’aggiornamento della difesa nei periodi successivi. In questa prospettiva è assolutamente condivisibile l’opinione del Greco19, che interpreta l’ampiezza del grande circuito non tanto in ragione di un progetto preventivo per l’ampliamento dell’abitato, ma soprattutto, come si è detto, per ragioni strategiche; prova ne è che la necropoli tarantina fu collocata, con gran stupore di Polibio20, all’interno del circuito fra le mura e l’abitato, contravvenendo, in ragione di un vantaggio difensivo, alle usuali norme di partizione urbanistica invalse nel mondo greco21.
Il Lo Porto alla luce di questi risultati proponeva di datare al 272 a.C., sulla scorta di Livio, l’abbattimento delle mura di V sec. a.C. ad opera dei Romani, che vollero infliggere così una dura punizione a Taranto, schieratasi con Pirro già dal 275 a.C. durante la sua spedizione in Magna Grecia. Poco prima o in occasione della guerra annibalica la città, sede di una guarnigione romana, si sarebbe rimunita di fortificazioni rapidamente, sfruttando come assise per l’elevato in materiale eterogeneo le antiche fondazioni delle mura di V sec. a.C.16. Il Greco, tornando ad esaminare la testimonianza delle fonti letterarie, preoccupandosi di verificare sugli epitomatori e su Zonara le affermazioni di Livio, per altro riferite ad un libro ormai perso di Ab urbe condita, orienta la sua opinione riguardo alla data di distruzione delle mura più antiche verso l’anno 209 a.C., quando Taranto fu riconquistata da Fabio Massimo e fu punita con tale provvedimento per aver dato man forte ai Cartaginesi, fermo restando che le tracce di rifacimenti individuate dal Lo Porto documentano comunque fasi di intervento ricostruttivo verosimilmente risalenti al periodo ellenistico17. È infine degna di menzione la considerazione recente del Lippolis sulla data dell’impianto originario delle mura orientali, che in contrada Carmine parrebbe risalire addirti15
Sul fronte sud VIOLA 1881, p. 392; ANDREASSI 1995, p. 801. In particolare per la torre DE JULIIS 1983, pp. 504-505. 16 LO PORTO 1971a, pp. 365-366. Una fase di rifacimenti è stata pure documentata dalla presenza di blocchi in carparo e non più in tufo locale nelle indagini del 1980 a Masseria del Carmine (DE JULIIS 1981, p. 357). 17 GRECO 1981b, pp. 153-154; la stessa opinione è ribadita dal Gullini (1983, pp. 258-259).
18
LIPPOLIS 2002, pp. 154-155, 157-158; TRÉZINY 2004 pp. 614-617. GRECO 1981b, pp. 151-152. Storie (1982), VIII, 28 21 Sulla localizzazione delle necropoli all’interno delle mura DE GRASSI 1966, p. 606; LO PORTO 1971a, pp. 379-383; MARTIN 1971, pp. 322325; GRECO 1981b, p. 151; LIPPOLIS 1987; PORSIA-SCIONTI 1989, p. 10; LIPPOLIS 1994; LIPPOLIS 1997b, pp. 533, 535-536. 19 20
29
§ La tecnica costruttiva
bra di trovarsi di fronte ad un’opera solo risultante dall’asportazione dal sottosuolo del materiale utilizzato per costruire le mura, ma anche concepita con funzione strategica e perciò la datazione complessiva potrebbe effettivamente scendere alla seconda metà del IV sec. a.C. Si configurerebbe così un incremento difensivo delle fortificazioni orientali secondo la funzione tipica del fossato-ostacolo dell’epoca; non solo, ma fra IV e III sec. a.C. questo settore delle mura di Taranto presentava già una successione scalata di opere difensive che richiama le concezioni filoniane di poco posteriori26, poiché il fossato era frapposto alle mura e alla zona acquitrinosa di Salina Piccola e Pianura Erbarca, rendeva impraticabile il terreno mediano e usava la salina stessa quasi come un secondo fossato esterno, che causava un approccio ancor più arduo. Annibale nel 213 a.C. preferì infatti entrare in città con l’aiuto degli esponenti del partito antiromano, piuttosto che sferrare un assalto generale a questo fronte di terra, unico praticabile dalla sua armata.
Immediatamente accanto a queste considerazioni topografiche sembra rilevante segnalare la scelta della tecnica costruttiva ad émplekton, che dimostra nel V sec. a.C. una particolare preoccupazione ingegneristica per l’assetto statico delle mura, poiché i due paramenti, collegati dai diatoni e contenenti il riempimento, costituiscono una struttura elastica che si adatta bene alla natura della zona depressa delle saline, ma che in seguito, dal IV sec. a.C. in poi, rappresenta la miglior soluzione per resistere ai colpi delle macchine da guerra22. § Il fossato orientale Altro elemento da prendere in considerazione è il fossato del fronte orientale indagato nell’800 dal Viola e poi oggetto di alcuni interventi della Soprintendenza23. Il Viola poté compiere una ricognizione sul terreno non ancora urbanizzato, seguendo la traccia di una lunga depressione, denominata «Canalone» e colmatasi col passare dei secoli, che andava dalla costa del Mar Piccolo a quella del Mar Grande. Fu il saliente disegnato sul terreno dal «Canalone» che indusse l’archeologo a ricostruire l’andamento delle mura descritto sopra e resta a tutt’oggi l’unico indizio di tale percorso. Inoltre fu l’individuazione di questo fossato permise di segnare fin da allora il limite orientale della città. Durante le sue ricerche il Viola non individuò materiali datanti sul fondo del fossato, a causa dell’emergenza dell’acqua di falda, ma poté comunque documentare con alcuni saggi che l’andamento preordinato dell’opera fece sì che venisse tagliato qualunque strato di terreno lungo la direzione stabilita. Queste osservazioni sembrano confermate dagli interventi degli anni ’80 del secolo scorso lungo il tratto fra la Salina Piccola e la Torre di Ayala. Il fossato taglia ogni strato che incontra, compresi i banchi di tufo, ma proprio presso la torre, nell’ultimo strato di riempimento poggiante sul fondo argilloso, sono venuti alla luce alcuni frammenti ceramici riconducibili alla fine del IV sec. a.C., data che gli archeologi ritengono propria della realizzazione dell’opera24. Non si è verificata l’estensione di tale datazione a tutto il percorso del «Canalone», che potrebbe essere stato aperto altrove in epoche precedenti, ma non oltre la metà del V sec. a.C.; risultano inoltre tagliati dal fossato i banchi di tufo locale, lo stesso mate-riale usato nelle mura di V sec. a.C. a Masseria del Carmine25, ed è comunque sicuro che il fronte orientale in epoca ellenistica si presentava munito di fossato.
Infine a proposito di quanto detto è suggestivo rilevare che ad Heraclea di Lucania, città fondata con il concorso di Taranto e Thurii nel 433. a.C., sia documentato l’’unico caso in Magna Grecia di fossato doppio, datato al III sec. a.C., che illustra in una città, rientrata rapidamente nell’ambito dell’influenza tarantina già nel IV sec. a.C., una sensibilità particolare per le opere difensive esterne, analoga a quella dell’antica colonia dorica27. § La porta Temenide Nello stesso passo di Polibio, dedicato all’occupazione cartaginese di Taranto, si racconta che Annibale entrò in città con i suoi uomini attraverso la porta Temenide28. Sull’ubicazione precisa di questa porta, che si trovava comunque lungo il fronte orientale delle mura, si sono moltiplicate le dissertazioni degli studiosi, fin dai tempi delle ricerche del Viola, per il fatto che la soluzione del problema determina diverse interpretazioni riguardo dell’assetto urbanistico di Taranto greca, coincidendo il sito della porta con l’origine di una delle tre plateìai principali, denominate Soteìra, Batheìa, Plateìa. Non si ritiene opportuno in questa sede approfondire la problematica urbanistica dell’identificazione delle strade, per la quale si rimanda alla bibliografia relativa29, ma è comunque significativo rilevare che dalla fonte letteraria risulta evidente il rapporto organico fra le componenti della città e le sue fortificazioni, come emerge dagli scritti di Enea Tattico30. I Cartaginesi infatti, dopo la conquista della porta Temenide, percorrono uno degli assi viari principali e giungono
Considerando poi il genere di taglio operato e il terreno asportato, in base ai dati sia del Viola sia recenti, non sem-
26
supra pp. 12-13. LO PORTO 1961, p. 140; QUILICI 1967, p. 174; NEUTSCH, p. 115; NEUTSCH, p. 762; GIARDINO 1998, p. 189; GIARDINO 1999, p. 325. Si tratta inoltre dell’unico caso magnogreco che richiami la norma filoniana dei tre fossati (supra p. 13). 28 Sulla porta Temenide VIOLA 1881, p. 393-395; WUILLEUMIER 1939, p. 243; STAZIO 1965, pp. 154-160, 163-164; LO PORTO 1971a, p. 372; GRECO 1981b, p. 152; PORSIA-SCIONTI 1989, pp. 9-10. 29 VIOLA 1881, p. 395-396; WUILLEUMIER 1939, pp. 244-246; STAZIO 1965, pp. 160-161, 163-164; DE GRASSI 1966, p. 606; LO PORTO 1971a, pp. 365-372; MARTIN 1971, pp. 326-327; GRECO 1981b, p. 153; LIPPOLIS 1981, pp. 91-93; PORSIA-SCIONTI 1989, pp. 10-11; LIPPOLIS 1997a, pp. 49-50; LIPPOLIS 1997b, p. 533; LIPPOLIS 2002. 30 supra pp. 8-9. 27
22
supra p. 17. VIOLA 1881, pp. 390-391; WUILLEUMIER 1939, p. 242 ; LO PORTO 1971a, pp. 363-364; DE JULIIS 1984, p. 423; PORSIA-SCIONTI 1989, p. 9. 24 DE JULIIS 1983, p. 505. Il Viola (1881, p. 390) riporta un’ampiezza di circa 11 metri e una profondità di 3,50 metri. Le indagini recenti hanno documentato un’ampiezza di 19 metri, ma una profondità ridotta a 2 metri (DE JULIIS 1983, p. 505). 25 DE JULIIS 1981, p. 355. Pertanto prima dei rinvenimenti datanti il Garlan (1974, p. 150) colloca cronologicamente il fossato nella seconda metà del V sec. a.C. 23
30
immediatamente nell’agorà; trattandosi inoltre di un successo degli assalitori echeggia anche quella osservazione di Aristotele, in cui si sconsigliava l’estensione degli impianti urbanistici regolari all’intero tessuto cittadino, per non agevolare l’avanzata di un esercito nemico dilagante all’interno delle mura fino al cuore dirigenziale della città31.
dentale, con andamento est-ovest e nord/est-sud/ovest. Nel tratto di cortina est-ovest, poco prima del cambiamento direzionale delle mura, si apre un grande varco con percorso nord-sud, la pỳle, il cui lato occidentale è difeso da un fianco con medesimo andamento e collegato al successivo tratto di cortina nord/est-sud/ovest; attraverso questo fianco fu realizzata una postierla, la rhinopỳle, con percorso ortogonale a quello del varco principale, associando così nella medesima opera i due tipi di apertura37.
Le indagini condotte dal Lo Porto hanno portato all’individuazione di una porta attraverso le mura di Masseria del Carmine32, la cui planimetria, accennata e non pubblicata graficamente, corrisponderebbe ad un semplice varco attraverso la cortina muraria non riconducibile alle tipologie più complesse di età ellenistica. D’altro canto è verosimile pensare che a Taranto anche la fortificazione del V sec. a.C. fosse dotata di aperture d’accesso meno elaborate di quelle cronologicamente successive. Nulla infine ci permette di associare a quest’opera la porta Temenide di Polibio.
La proposta suggestiva e comunque credibile del Martin conforta pertanto l’ipotesi che le fortificazioni di Taranto in epoca ellenistica siano state interessate da rifacimenti importanti e che il fatto riguardi in modo specifico il fronte orientale, non solo protetto da un sistema difensivo scalato, come si è detto precedentemente, ma anche da una poderosa struttura d’ingresso. § Il diateìchisma urbano Lo stesso studioso ha poi affrontato un’ultima problematica che chiude le considerazioni relative alle mura di Taranto in età ellenistica. Il Martin38 sottolinea che nel racconto di Polibio, relativo sempre all’assedio del 213 a.C., quando si narra che Annibale spostò nel Mar Grande le navi alla fonda nel Mar Piccolo via terra, attraverso la città lungo una plateìa
A proposito dell’argomento vale la pena ricordare l’interpretazione proposta dal Martin al Convegno di Taranto del 1970, poiché si orienta verso una datazione della porta Temenide in età ellenistica. Il testo di Polibio racconta che dopo l’ingresso di Annibale attraverso la porta in questione ne fu aperta un’altra poco distante e più piccola, una rhinopỳle, attraverso la quale irruppe un altro contingente cartaginese33. Gli archeologi hanno generalmente interpretato il testo pensando ad una seconda struttura di dimensioni minori rispetto alla porta Temenide34, mentre il Martin legge il testo di Polibio considerando la porta anonima una postierla della Temenide. Infatti essa viene definita dall’autore =inopÊlh, cioè «postierla», ben diversamente rispetto alla porta Temenide che non solo è una pÊlh, ma è nominata al plurale come avviene comunemente in Greco e in Latino (pÊlai, fores-ium) per le grandi porte urbiche con chiusura a due battenti. Di conseguenza lo studioso francese afferma che il fronte orientale non aveva che una sola porta, grande e monumentale e, pur in mancanza di dati concreti rilevati sul terreno, la differenziazione fra pỳlai e rhinopỳle lascia intendere una complessa struttura, che associando i due tipi di apertura può far pensare ad una produzione di età ellenistica, poiché risale a quel momento storico l’utilizzo diffuso di postierle in concomitanza a grandi strutture difensive35.
tØn Ípãrxousan m¢n §ntÚw toË diateix¤smatow, f°rousan d¢ parå tÚ diate¤xisma §k toË lim°now efiw tØn ¶jv yãlattan39,
si fa chiaramente riferimento ad una struttura difensiva, un diateìchisma, che delimita un’area della città attraversata dalla strada seguita per il transito delle navi. Si tratta probabilmente di «un mur isolé pour barrer un passage, un isthme, un éperon» in un contesto di «secteurs fortifiés isolés, defendant telle ou telle partie du rivaile plus accessible ou plus exposé, en liaison plus ou moins directe avec le port» che potrebbe corrispondere bene al settore nord-est delle mura della città nuova, nella zona di Collepasso, all’incontro fra le mura del fronte orientale e di quello settentrionale. A proposito di questo tema, il Greco40 esprime un’opinione diversa, facendo corrispondere al diateìchisma polibiano il fronte orientale dell’acropoli e il suo fossato che, se da un lato denota l’uso di una terminologia tecnica ben nota da parte di un autore dell’epoca ellenistica per descrivere le fortificazioni taratine alla giunzione fra le difese dell’acropoli e della città nuova, dall’altro lancia un raggio di luce sulla possibile interpretazione che gli antichi davano a questo sistema fortificato unitario, tale nel III sec. a.C., ma distinto da sempre in due principali settori difensivi grazie ad un’opera contemporaneamente di cesura e collegamento. Più recentemente il Lippolis ripro-
Una possibile immagine reale di quanto ipotizza il Martin è offerta dalla Porta Marina Sud di Velia, per la quale si rimanda alla descrizione presente nel capitolo dedicato alle fortificazioni della colonia di Focea36, oppure la porta principale della cinta ellenistica di Saint-Blaise nell’entroterra di Massalia, datata al II sec. a.C. La struttura è caratterizzata da un poderoso corpo di fabbrica derivante dalla congiunzione di due tratti di cortina del fronte occi31
37
supra p. 6. STAZIO 1965, pp. 163-164; LO PORTO 1969, pp. 200-202; LO PORTO 1971a, p. 372; LO PORTO 1974, p. 422; LO PORTO 1978, p. 498; LIPPOLIS 1981, p. 93. 33 Storie (1982), VIII, 25, 28-29. 34 VIOLA 1881, p. 394; WUILLEUMIER 1939, p. 244 ; STAZIO 1965, p. 164; LO PORTO 1971a, p. 372; PORSIA-SCIONTI 1989, p. 10. 35 MARTIN 1971, pp. 322-323. 36 infra p. 73.
BOULOUMIE-FINKER 1986. MARTIN 1971, p. 323. D’altro canto il Martin nota che la coesistenza all’interno del circuito murario dell’abitato e delle necropoli poteva indurre a considerare le mura del fronte orientale non come un limite perentorio della pòlis, ma piuttosto una linea di semplice protezione esterna più confacente alla concezione di un diateìchisma che a quella di un teìchos vero e proprio (MARTIN 1971, pp. 323-326). 39 Storie (1982), VIII, 34. 40 GRECO 1981b, p. 154, p. 154 nota n. 64.
32
38
31
pone una collocazione del diateìchisma più ad est, lungo una direttrice che collega la zona dei porti al Mar Grande e ritiene che l’opera, almeno in età ellenistica, svolgesse una funzione di separazione fra l’abitato e le necropoli contenute all’interno del fronte orientale41. In conclusione è possibile pensare che il sistema di fortificazioni di Taranto in età ellenistica avesse raggiunto uno sviluppo e un aspetto tali da contribuire con gli altri monumenti urbani a determinare il giudizio di Strabone42, quando afferma che, ancora ai suoi tempi, la città romana summ°nei m°geyow éjiolÒgou pÒlevw §kpllhroËn. Ma d’altro canto è lo stesso geografo che, dopo aver presentato il sito della città, basso, sul livello del mare e di poco rialzato presso l’acropoli, testimonia l’ampiezza del circuito delle fortificazioni elleniche ancora apprezzabile, tÚ m¢n oÔn palaiÚn te›xow kÊklon ¶xei m°gan,dando un’immagine tangibile di quell’unico e grande sistema, che comprendeva le difese dell’acropoli e della città nuova e che fu descritto a episodi da Polibio e da Livio sullo sfondo dei loro racconti storici.
41
LIPPOLIS 1987; LIPPOLIS 1994; LIPPOLIS-GARRAFFO-NAFISSI 1995, p. 32. Tale posizione del diateìchisma potrebbe essere avvalorata dal rinvenimento sempre in zona di un muro d’età romana che separava ad est la colonia Neptunia dalla sua necropoli (LIPPOLIS 1981, p. 89). 42 Geografia (1967), VI, 3, 1.
32
CAPITOLO
2
Metaponto
senza farvi sosta, non potendo richiedere ufficialmente ospitalità alla cittadinanza1.
Lungo la costa del golfo di Taranto, a sud della colonia laconica, nel ventennio compreso fra il 650 e il 630 a.C. sorse una nuova città ad opera di un gruppo di coloni provenienti dall’Acaia, chiamati in Occidente dalla potente Sibari, che voleva opporre un sicuro baluardo contro l’espansionismo dorico e impedire che Taranto controllasse la fertile pianura compresa fra il Bradano e il Basento. La colonia, che prese il nome di Metapòntion, visse una fiorente stagione fra il tardo Arcaismo, dopo la distruzione di Siris (540 a.C. ca.) e la fine del dominio di Sibari (510 a.C.), e la metà del V sec. a.C. grazie allo sfruttamento del proprio territorio e di quello antico sirita, compreso fra l’Agri e il Sinni. Nel periodo fra il 450 e il 350 a.C. Metaponto attraversò una forte crisi economica ed ecologica, dovendo far fronte ad una trasformazione dell’assetto idrogeologico del sito, forse dovuto anche all’intervento troppo assiduo dell’uomo, che comportò un notevole aumento del livello della falda freatica, con il conseguente rischio di impaludamento non soltanto delle aree agrarie territoriali, ma anche dello stesso abitato. I cittadini fecero fronte al problema, ristrutturando gli apprestamenti idraulici della chòra e ritracciando con nuove opere di drenaggio l’intero impianto urbano definito fin dalla metà del VI sec. a.C.
L’impianto difensivo metapontino L’ultimo periodo di vita della colonia achea alla luce degli eventi storici riveste un notevole interesse per quanto concerne il tema dell’architettura militare, sebbene le testimonianze archeologiche, di indubbio valore scientifico, non riescano a colpo d’occhio, come nei casi di Locri, Velia o Paestum, a renderne ragione. La situazione richiama quella di Taranto e anche a Metaponto è stata l’assiduità dei ricercatori che ha riportato alla luce, con rilevamenti aerofotografici e saggi di scavo, quanto le spoliazioni degli anni precedenti e successivi alla bonifica agraria del 1950 avevano definitivamente cancellato. È stato possibile quindi ricostruire l’andamento generale del circuito delle mura urbane e fornire un’idea del loro aspetto durante l’età ellenistica, quale si impresse ancora nel ricordo di Pausania, quando il periegheta del II sec. d.C. ricordava che ai suoi tempi di Metaponto non restavano che il teatro e le mura, §p'§moË d¢ ˜ti mØ y°atron ka‹ per¤boloi te¤xouw êllo §le¤peto oÈd¢n Metapont¤ou2.
A partire dalla metà del IV sec. a.C. la città tornò a vivere un periodo di ricchezza, che si caratterizza non tanto per i monumenti templari, come accadde in età arcaica, ma per la realizzazione di opere pubbliche di notevole impegno, quali un’ulteriore ristrutturazione dell’impianto urbano con un nuovo sistema di canalizzazioni fognarie e forse un impianto di distribuzione d’acqua potabile, la trasformazione in teatro dell’antico ekklesiastérion, in un contesto di totale riqualificazione dell’area settentrionale dedicata all’agorà e al santuario di Apollo, e infine la realizzazione della cinta fortificata. Quest’ultima opera, come per molte altre città della Magna Grecia, fiorenti durante il IV sec. a.C., è indice tuttavia di una sicurezza precaria, minacciata dalla pressione delle popolazioni italiche, i Lucani e i Brezii, che proprio in questo periodo iniziavano a insistere lungo i confini interni delle chòrai coloniali. Metaponto visse accanto a Taranto le vicende legate alla venuta dei condottieri stranieri, fino alla fine della guerra di Pirro, quando nel 272 a.C. divenne sede di un presidio militare romano. Ma fu la guerra annibalica che segnò la fine della decadenza con la perdita completa dell’autonomia nel 207 a.C., come punizione attuata da Roma per la defezione ai Cartaginesi avvenuta nel 212 a.C. Pertanto gli théoroi del santuario di Delfi, che intrapresero un viaggio in Magna Grecia e Sicilia nella primavera del 198 o 194 a.C., superarono Metaponto
§ Datazione Il perimetro della città seguiva l’andamento dei limiti di un rialzo naturale del terreno, inclinato da ovest verso est e compreso fra il Bradano e del Basento, che anticamente
1
Per le vicende storiche e urbanistiche di Metaponto CASTAGNOLI 1959; SCHMIEDT-CHEVALLIER 1959, pp. 993-996, 1026-1030; SCHMIEDT-CHEVALLIER 1960, pp. 14-15; ADAMESTEANU 1967, pp. 3-16 passim; SCHMIEDT 1967, pp. 29-32; ADAMESTEANU 1970; LO PORTO 1966; SCHMIEDT 1968-69, pp. 402-403; SCHMIEDT 1970a, tav. LXXI; D’ANDRIA 1976, p. 541; GRECO 1981a, pp. 132-139; ADAMESTEANU 1982, p. 309; GUZZO 1982, pp. 51-52, 108-169 passim; 341-347; GRECO-TORELLI 1983, pp. 199-205; PUGLIESE CARRATELLI 1983 passim; CORDANO 1985, pp. 316-317; GRECO 1985, pp. 346-348; GIANGIULIO 1987 passim; LOMBARDO 1987a passim; ADAMESTEANU-SICILIANO-SUELI MILANEZZI 1992, pp. 68-69; GRECO 1993, pp. 43-44, 145-156, 234238; GRECO-MERTENS 1996, pp. 248-249; DE SIENA 1998 passim e pp. 161-170; MERTENS 1998; DE SIENA 1999; MERTENS 1999; RUSSI 1999, pp. 494-502, 510-511; SMALL 1999, pp. 563-564, 569-571; DE JULIIS 2001, pp. 13-71; DE SIENA 2001. 2 Periégesis (1999), VI, 19, 11. Presentano notizie generali sulle fortificazioni di Metaponto LACAVA 1891, pp. 64-68, 126-127; SCHMIEDTCHEVALLIER 1959, pp. 1014-1026; SCHMIEDT-CHEVALLIER 1960, pp. 19-21; ADAMESTEANU 1967, p. 8; SCHMIEDT 1967, p. 57, tav. LXXI; ADAMESTEANU 1973a, pp. 18-22, 28-31; ADAMESTEANU 1974a, p. 166; ADAMESTEANU 1974b, p. 7; Metaponto I 1975, pp. 242-246; GIANNOTTA 1980, pp. 20-21; GRECO 1981a, p. 149; GUZZO 1982, p. 341; GRECO-TORELLI 1983, p. 200; MERTENS 1995, p. 642; DE SIENA 1999, passim; MERTENS 1999, pp. 278-279; DE JULIIS 2001, pp. 129-133; DE SIENA 2001, passim.
33
seguivano un corso diverso da quello attuale3. La definizione della linea perimetrale urbana fu segnata fin dall’età arcaica da un teìchos che, realizzato entro la metà del VI sec. a.C., contemporaneamente alla definizione del primo impianto urbano, diede in seguito la direzione al circuito delle mura ellenistiche. Esso era costituito da un muro in lastre d’arenaria, frammenti informi di puddinga e di calcare conchiglifero, regolarizzato in facciavista, che conteneva alle spalle un terrapieno, creando una struttura ad aggere con funzione limitanea più che effettivamente difensiva. Fu probabilmente sostituito, nella seconda metà del IV sec. a.C., con mura di maggiore impegno architettonico, per far fronte sia agli innalzamenti dell’acqua di falda sia alla minaccia lucana4. Dopo il 350 a.C. furono elevate le nuove mura con poderose fondazioni in blocchi lapidei, che sfruttavano sempre i margini del salto di quota fra l’area interna del terrazzo urbano e la pianura esterna, nonché i corsi e i meandri acquitrinosi del Bradano e del Basento, come difese naturali sui lati nord e sud. Approssimando una coincidenza fra la disposizione urbanistica di Metaponto e l’orientamento astronomico è possibile distinguere quattro fronti quanti sono i punti cardinali e tentare per ciascuno di essi una sintesi dei dati noti per la fase di epoca ellenistica.
fortificazioni metapontine; anzi essa rappresenta probabilmente l’unica testimonianza del persorso più orientale del fronte nord, che collegava in linea retta alle difese del fronte di mare il tratto rientrante, arretrato presso il santuario di Apollo5. Questa parte centrale del fronte nord, che il Lacava6 ricostruiva con andamento obliquo fino al congiungimento con il fronte occidentale, fu invece definita con un profilo semicircolare rientrante verso l’interno della città, seguendo il percorso moderno del canale di Santa Pelagina, fin dagli studi aerofotografici del Castagnoli e di Schmiedt e Chevallier7. D’altro canto gli straripamenti frequenti del Bradano, che anticamente disegnava sul terreno un’ansa concava simile a quella ricostruita per le mura, rendevano acquitrinoso e disagi-vole il terreno fra la città e il corso del fiume, elevando notevolmente la capacità difensiva del fronte nord8. Recentemente il De Siena ha potuto apportare un’ultima correzione al percorso murario, indagando il tratto di teìchos arcaico presso l’angolo nord-ovest del tempio ionico, poiché ha individuato un tratto del muro che proprio in questo punto piegava in direzione obliqua verso il Bradano e l’avancorpo nord-orientale del fronte settentrionale, anziché dirigersi lungo il canale moderno, come ricostruivano gli studiosi precedenti, fino alla zona del teatro, per poi svoltare bruscamente verso nord-est9.
§ Il fronte settentrionale Tale andamento complessivo del fronte nord nei settori orientale e centrale, presso le aree pubbliche, può essere considerato proprio anche della fortificazione di età tardo classica ed ellenistica, ma, escludendo il tratto portato alla luce dal Lacava, nulla si conosce di altre strutture se non la configurazione dello sbocco del grande canale, che fiancheggia ad ovest il santuario di Apollo. Il collettore, che svolgeva una funzione centrale nell’impianto di drenaggio urbano della seconda metà del IV sec. a.C., necessitava certamente di uno sfogo adeguato, aperto verso il fossato e costituito da un varco bipartito, con al centro un robusto sostegno di due blocchi lapidei sovrapposti per lungo, che sorreggevano altri due blocchi affiancati sui lati minori nel centro del pilone10. Un manufatto così composto, e realizzato con materiali tanto robusti, presuppone la necessità di sostenere una struttura muraria di peso e ingombro notevoli, quali potevano essere effettivamente le mura in età ellenistica, coeve d’altro canto dell’impianto di drenaggio11.
Il fronte settentrionale guardava verso il Bradano, confine fra la chòra metapontina e quella tarantina, e delimitava la fascia della città dedicata in gran parte agli impianti religiosi e civili, il santuario di Apollo Licio e l’agorà nel settore orientale, e al kerameìkos in quello occidentale. Presso la masseria Sansone, il Lacava aprì un saggio per verificare la presenza di fortificazioni nel settore est del fronte settentrionale, dove egli riteneva che si concludesse l’abitato urbano, e rinvenne una struttura in blocchi lapidei, su uno dei quali individuò alcune lettere greche incise, che indussero a datare l’opera all’età arcaica. Negli anni ’70 del secolo scorso l’Adamesteanu preferì spiegare la presenza del blocco iscritto come materiale di riempiego, alla luce delle indagini che stava conducendo in altre zone del circuito murario, e ritenne che la struttura rinvenuta nell’800 appartenesse alla fase ellenistica delle 3
Sulla situazione idrogeologica e la natura del sito di Metaponto LACAVA 1891, pp. 65-68; SCHMIEDT-CHEVALLIER 1959, pp. 994-996; SCHMIEDT-CHEVALLIER 1960, pp. 15-18; ADAMESTEANU 1967, pp. 38; SCHMIEDT 1967, p. 32; SCHMIEDT 1970a, p. 57, tav. LXXI; CHEVALLIER-ROUILLARD 1971, p. 311; ADAMESTEANU 1974b, p. 7; Metaponto I 1975, pp. 242-246; GIANNOTTA 1980, pp. 17-18; MERTENS 1998, p.
Il tratto occidentale del fronte nord ha restituito invece nel corso del tempo diverse testimonianze della fortificazione ellenistica. Il Lacava aveva già individuato in zona segmenti di fortificazione in blocchi lapidei parallelepipe-
126. 4 Il teìchos arcaico è stato individuato in più punti del circuito perimetrale. Il De Siena (1998, pp. 142-151) ne ha portato in luce alcuni tratti sul fronte nord a ovest del grande canale di drenaggio ellenistico presso il terrapieno moderno che contiene la Menasciola di Santa Pelagina, all’interno del témenos di Apollo Licio presso l’angolo nord-ovest del tempio ionico, e nel cosiddetto saggio C/86/91 presso la zona del quartiere ceramico poco distante dal saggio compiuto in proprietà demaniale negli anni ’70 (infra p. 35 nota n. 13), dove un intervento sempre recente (DE SIENA 1998, p. 148) ha rinvenuto tracce del muro arcaico crollato. Altri tratti del teìchos arcaico sono stati individuati nelle fasi più antiche delle mura del fronte ovest presso la Porta Settembrini (BOTTINI 1991, p. 561; BOTTINI 1992, pp. 391-392; DE SIENA 1998, p. 149; MERTENS 1998, pp. 123-126) e ad esso possono essere ricondotti i rinvenimenti della cinta muraria scavata negli anni ’70 lungo il fronte di sud-ovest nelle proprietà Favale e Mantice (infra p. 35 nota n. 20; DE SIENA 1998, p. 149).
5
LACAVA 1891, p. 126. Il Lo Porto (1966, pp. 137-138) discutendo sulla paleografia delle lettere iscritte propose una datazione della struttura alla metà del V sec. a.C., ipotizzandone la realizzazione in concomitanza alle ristrutturazioni urbanistiche coeve; si parla inoltre di questo tratto in SCHMIEDT-CHEVALLIER 1959, pp. 1024-1025. Per le considerazioni dell’Adamesteanu sulla datazione e l’interpretazione dei resti individuati dal Lacava ADAMESTEANU 1974a, pp. 156-157; Metaponto I 1975, p. 246. 6 LACAVA 1891, p. 18 fig. 2. 7 CASTAGNOLI 1959, pp. 50-51; SCHMIEDT-CHEVALLIER 1959, pp. 1017-1019; SCHMIEDT-CHEVALLIER 1960, p. 20. 8 BOTTINI 1986, p. 468 9 DE SIENA 1998, pp. 146-147. 10 SCONFIENZA 1996, p. 47. 11 DE SIENA 1998, p. 147.
34
di12, ma le più importanti scoperte furono fatte all’inizio degli anni ’70, quando in due saggi separati emersero tratti appartenenti alla stessa cortina. Nel primo venne alla luce una struttura il cui spessore ricostruito era di circa 3 metri; di essa si conservavano, in maniera discontinua, tratti di un paramento esterno e di uno interno, composti in prevalenza da blocchi di reimpiego, ma sempre si poté verificare o dedurre che il paramento esterno si fondava ad una quota inferiore rispetto a quello interno, per una differenza variante fra 1 o 1,50 metri. I primi due filari inferiori del paramento esterno in blocchi di tufo furono ricondotti al V sec. a.C., mentre quelli superiori in blocchi di puddinga e calcare reimpiegato risultavano il prodotto di un rifacimento corrispondente al momento in cui Metaponto fu dotata dell’ultima cinta fortificata, ovvero nella seconda metà del IV sec. a.C.13. La datazione dell’ultimo intervento risultò inoltre confermata dalla presenza di una cloaca del tipo a spalle lapidee e copertura, appartenente al sistema di drenaggio ellenistico e relativa alla penultima plateìa nord-sud verso il fronte ovest14.
per le alluvioni del Bradano. Tuttavia il primo impianto di un fronte difensivo sembra già riconducibile al V sec. a.C., come dimostrano le fondazioni del paramento esterno della cortina, che secondo la proposta del De Siena seguiva il tracciato del teìchos arcaico anche in questa zona. La presenza di un battuto di età arcaica16, appartenente alla plateìa che attraversa la porta nord, al di sotto di quello ellenistico, lascia dunque presupporre che anche il teìchos fosse interrotto nella zona della porta e che quest’ultima ricalchi in epoca più recente un antico punto di collegamento con la chòra17. § Il fronte occidentale Il fronte occidentale delle mura di Metaponto è quello che meglio esemplifica la continuità di percorso dall’età arcaica all’ellenismo. La fotografia aerea ha permesso fin dalle prime ricerche sulla colonia achea, di confermare l’impressione già del Lacava, che questo fronte si attestasse lungo il margine del terrazzo su cui sorgeva la colonia, bordato dal corso della Menasciola di Santa Pelagina18. Anticamente questo limite occidentale andava dal Bradano al Basento e chiudeva l’area dell’apoikìa achea; in seguito durante il VI sec. a.C. fu segnato dal teìchos ad aggere, sostituito poi dalle mura della seconda metà del IV sec. a.C.19. Le indagini archeologiche degli anni ’70, svolte a poca distanza dall’angolo dei fronti ovest e sud, nelle proprietà Favale e Mantice20, hanno portato alla luce un lungo tratto di fortificazioni, conservato soltanto in fondazione, che era costituito da un paramento esterno in blocchi di carparo, ben sbozzati e provenienti tutti dalla stessa cava, che hanno fatto escludere agli studiosi la provenienza da una spoliazione, ma hanno avvalorato piuttosto una prima destinazione specifica per le mura. Al paramento esterno si legavano in successione e paralleli fra loro alcuni diatoni, che dovevano agganciare verso l’interno del perimetro difensivo un secondo paramento completamente spogliato, ma di certo fondato ad una quota superiore rispetto a quello esterno, in modo da creare una struttura a cassoni larga circa 2,80/3 metri e colmata con émplekton. Al di sopra dei blocchi di calcare gli archeologi rinvennero un potente strato di argilla con piccoli frammenti di paglia rimescolati, che permise di ipotizzare un elevato in mattoni crudi, e lungo il percorso della struttura, in corrispondenza ad una lieve rientranza, fu individuata una postierla con varco sceo. In conseguenza al rinvenimento dello strato di mattoni crudi e alla presenza di alcune lettere in alfabeto acheo arcaico incise sui blocchi di calcare non reimpiegati, ma anche per via della presenza di una stipe votiva extra muros, con materiale datato fra VII e IV sec. a.C., che si addossava alle fondazioni del paramento esterno, l’Adamesteanu ha fissato una cronologia alta, collocando le fortificazioni di
Il secondo saggio, aperto ad ovest del primo in proprietà Lacava, restituì un tratto della stessa cortina a due paramenti, i cui resti, sempre della seconda metà del IV sec. a.C., erano frammentari e difficili da porre in relazione. In corrispondenza dell’ultima plateìa occidentale nordsud vennero alla luce le tracce delle fondazioni di una porta. La struttura della cortina, come nel tratto più ad est, richiama certamente la tecnica ad émplekton, documentata a Metaponto nel periodo ellenistico anche lungo il fronte di mare, forse in condizioni archeologicamente migliori, mentre l’indagine ha potuto ricostruire con precisione l’aspetto e la cronologia della porta, denominata Tarantina; si trattava di un semplice varco attraverso le mura privo di torri o di opere sporgenti per il fiancheggiamento, che fu ad un certo punto ristretto per l’elevazione all’interno del passaggio carrabile, di un muro leggermente inclinato rispetto allo stipite est e convergente verso lo stipite ovest, così da portare la luce del varco da 6 metri circa a 2,50. La datazione della Porta Tarantina è stata fissata nella seconda metà del IV sec. a.C., contemporaneamente alla formazione dell’ultimo battuto stradale della plateìa nord-sud, che usciva attraverso il varco e che era fiancheggiata da una cloaca, la cui struttura nel tratto di attraversamento delle mura veniva a far parte del corpo di fabbrica della porta15. Le indagini hanno permesso di concludere dunque che le fortificazioni nord-occidentali furono ampiamente ristrutturate dopo il 350 a.C. e determinarono un valido argine 12
LACAVA 1891, pp. 65-68; CASTAGNOLI 1959, p. 49; LO PORTO 1966, pp. 137-138. 13 ADAMESTEANU 1973a, pp. 25-26; ADAMESTEANU 1973b, p. 323; ADAMESTEANU 1974a, pp. 159-160; Metaponto I 1975, pp. 246-252; GIANNOTTA 1980, p. 22; ADAMESTEANU 1987, p. 15. 14 SCONFIENZA 1996, pp. 34-35, 46-47. 15 Purtroppo non è stato possibile porre in relazione il battuto inferiore della plateìa con la prima fase del varco e dedurre così la coincidenza della seconda fase ristretta con il secondo battuto, poiché sembrava inconciliabile la grande presenza di materiale di reimpiego nella struttura originaria della porta con la datazione alla prima metà del VI sec. a.C. del primo battuto. Sul saggio della porta nord ADAMESTEANU 1973a, p. 26; ADAMESTEANU 1973b, p. 323; ADAMESTEANU 1974a, pp. 160-161; Metaponto I 1975, pp. 252-257, 355-356; D’ANDRIA 1978, p. 411; GIANNOTTA 1980, pp. 22-23.
16
Metaponto I 1975, p. 257. Già negli anni’70 si presupponeva comunque una posizione arretrata della porta arcaica rispetto a quella ellenistica (Metaponto I 1975, pp. 355-356). 18 LACAVA 1891, pp. 65-68; SCHMIEDT-CHEVALIER 1959, pp. 10141017; SCHMIEDT-CHEVALIER 1960, pp. 19-20 ; LO PORTO 1966, p. 137. 19 supra p. 34 nota n. 4. 20 ADAMESTEANU 1973a, pp. 24, 28; ADAMESTEANU 1973b, pp. 322323; ADAMESTEANU 1974a, pp. 162-163; Metaponto I 1975, pp. 257262; GIANNOTTA 1980, pp. 21-22. 17
35
questo settore nel VI sec. a.C.21. Il De Siena più recentemente ha proposto che le mura degli scavi Favale e Mantice siano resti del teìchos arcaico che conteneva l’aggere interno22. Alla luce dei risultati pubblicati sembra che, almeno in questo settore, non vi sia traccia di un autonomo rifacimento delle mura in epoca ellenistica, pur tenendo conto della frequente attività di spoliazione e dei lavori svolti per la bonifica agricola. Perciò si può pensare che le mura arcaiche abbiano continuato a svolgere la loro funzione anche nei secoli successivi, essendo comunque oggetto di rifacimenti, quale può essere la struttura a cassone, che sembra indiziata dai diatoni, ma che è stata comunque solo ipotizzata e non rinvenuta interamente. D’altro canto gli scavi successivi sul fronte est in proprietà Le Penne hanno restituito una prima fase delle mura di fronte al mare, caratterizzate dalla presenza di un solo paramento con diatoni ortogonali per una miglior aderenza al terreno e datate al V sec. a.C.23. Si può dunque ipotizzare che presso l’angolo nord-ovest delle mura il paramento esterno contenesse in età arcaica l’aggere del teìchos, sfruttando già i diatoni immorsati lungo il bordo del terrazzo urbano e che in seguito, come avvenne appunto sul fronte di mare, la muratura sia stata integrata con un paramento interno e un émplekton.
torri quadrate al posto di quelle più antiche25. Il settore della Porta Settembrini, alla luce di questi rinvenimenti, sembra effettivamente confermare l’impressione che si evince dai risultati delle ricerche presso l’angolo sud-ovest, per cui l’intero fronte occidentale in età ellenistica corrisponde ad una impegnativa ristrutturazione della fortificazione arcaica, che prevede non solo il rifacimento di tratti, o forse completo, dell’antico teìchos, ma anche l’inserzione di complessi difensivi adeguati alle nuove tattiche poliorcetiche, senza tuttavia sconvolgere il tracciato e l’assetto strutturale delle preesistenze. § Il fronte meridionale Riguardo al fronte sud preme richiamare subito l’attenzione sul fatto che lungo lo sviluppo delle sue mura si apriva la porta simmetrica alla Tarantina, localizzata nell’attuale proprietà Lazzazzera, presso la testata meridionale dell’ultima plateìa occidentale con andamento nordsud. Essa metteva in comunicazione l’abitato con la parte basentana della chòra, così come faceva la Tarantina per la parte bradanica, ma purtroppo la sua struttura fu completamente distrutta da un intervento nel secondo dopoguerra per l’edificazione di una casa rustica, tanto da non poter più assolutamente ricavare alcun dato archeologico26. Il tracciato del fronte sud fu per lungo tempo ricostruito dagli studiosi con un’ampio rientrante, quasi simmetrico a quello del fronte nord27, ma attualmente si prende in considerazione anche un possibile percorso rettilineo, come già aveva proposto il Lacava, che collegherebbe l’angolo sud-ovest del circuito con il limite meridionale dell’ansa, disegnata dalle mura presso il raccordo con il fronte di mare, per dare spazio alle strutture del porto-canale28. L’ultima ricostruzione infatti tiene conto delle tracce di invasione delle acque del Basento, che possono aver contribuito con le spoliazioni in epoche successive a cancellare le tracce della fortificazione in un punto in cui il terrazzo urbano tende a deprimersi, a poca distanza dal corso del fiume29.
Presso l’angolo nord-ovest delle fortificazioni, lungo lo sviluppo iniziale del fronte occidentale, un rialzo del terreno celava la più importante porta delle mura di Metaponto, denominata Settembrini dal nome della proprietà in cui fu rinvenuta24. La porta si ergeva presso la testata occidentale della plateìa principale est-ovest, che lungo il suo sviluppo, fin dai tempi della fondazione, separava dall’abitato l’area sacra ad Apollo e l’agorà e, grazie alla Porta Settembrini, metteva in collegamento il centro dell’impianto urbano con la chòra. Lo scavo ha permesso di ricondurre il complesso fortificato alla fase della ricostruzione ellenistica delle mura. La porta è caratterizzata da due fasi costruttive, le quali insistono sul teìchos della seconda metà del VI sec. a.C., che era attraversato in questo settore dal prolungamento della plateìa est-ovest, marginata da due strutture parallele per il contenimento della carreggiata. Intorno alla metà del V sec. a.C. a causa del primo innalzamento dell’acqua di falda venne rifatto il muro di contenimento dell’aggere, utilizzando blocchi di puddinga e carparo assemblati lungo filari unici sovrapposti. Ad un secolo più tardi si deve collocare la prima fase architettonica della porta, quando un varco ampio quasi 5 metri, aperto attraverso l’aggere, venne fortificato con due torri quadrate rinforzate da ulteriori terrapieni. Infine negli anni fra la fine del IV e l’inizio del III sec. a.C. il complesso fu ancora irrobustito con la realizzazione di un fossato esterno, nuove protezioni e rinforzi dell’aggere dunario, e un’altra trasformazione architettonica della porta, il cui ampio varco venne ristretto e bipartito con un setto murario centrale e difeso da due poderose
Poco lontano dal dubbioso tratto a rientrante si trova il sito della proprietà Grieco-Lazzazzera, in cui negli anni ’70 sono venuti alla luce cospicui resti di fortificazione, fondati su una duna sabbiosa che tornava anticamente a 25
LATTANZI 1982a, p. 277; ADAMESTEANU 1982, p. 309; ADAMESTEA1987; BOTTINI 1991, p. 561; BOTTINI 1992, pp. 391-392; MERTENS 1998, pp. 127-132; DE SIENA 2001, pp. 36-37; DE SIENA 2002, p. 34. 26 ADAMESTEANU 1987, p. 15. L’unica traccia di strutture riconducibili alla seconda metà del IV sec. a.C. è costituita dalla cloaca rinvenuta durante gli scavi del Lo Porto in questa proprietà, che per scaricare le acque nel fossato attraversava le mura proprio al di sotto della masseria, ma nulla si può dire sulla datazione e sull’aspetto della fortificazione (LO PORTO 1966, pp. 148-149; ADAMESTEANU 1974a, pp. 157-158). 27 LACAVA 1891, p. 18 fig. 2; CASTAGNOLI 1959, fig. 1; SCHMIEDTCHEVALLIER 1959, p. 1026 e fig. 18; SCHMIEDT 1967, fig. a p. 31; SCHMIEDT 1970a, tav. LXXI. 28 GRECO-MERTENS 1996, fig. a p. 248; MERTENS 1999, fig. 17. 29 Le tracce di straripamento delle acque del Basento sono state rilevate tramite la fotografia aerea che evidenzia la depressione a metà del tracciato meridionale limitata dall’ampia curva forse dotata di mura (SCHMIEDT-CHEVALLIER 1959, p. 1026; SCHMIEDT-CHEVALLIER 1960, p. 21; SCHMIEDT 1970a, tav. LXXI; LO PORTO 1966, p. 138; LININGTON 1974, fig. a p. 1; Metaponto I 1975, p. 243); il Mertens esprime invece il dubbio di forti danneggiamenti alle mura sud ad opera del fiume in un momento storico imprecisabile (NAVA 1997, p. 462, fig. 1; MERTENS 1998, p. 126; MERTENS 1999, pp. 278-279 e fig. 17). NU
21 L’archeologo ha pubblicato il materiale della stipe, importante per la datazione relativa delle mura, in Metaponto I 1975, pp. 262-289. 22 supra p. 34 nota n. 4. 23 infra p. 37 nota n. 34. Considerazioni sulla datazione e sull’evoluzione della muratura a speroni in relazione a quella ad émplekton sono state recentemente sviluppate in TRÉZINY 2004, pp. 604-606. 24 LACAVA 1891, p. 64; Metaponto I 1975, p. 243
36
salire di quota rispetto al terreno più ad ovest, evidentemente per una modificazione geologica della superficie terrestre, ai limiti del terrazzo occupato dalla città, in prossimità della foce del Basento e della spiaggia costiera. Le mura di proprietà Grieco erano dotate di una piccola torre quadrata nel tratto prossimo al raccordo con l’ansa di sud-est e presentavano una struttura fondata nella sabbia a doppio paramento, di cui si poté soltanto rilevare la composizione di quello esterno in grandi blocchi parallelepipedi di puddinga e di calcare reimpiegato, proveniente forse dal santuario urbano. Le mura, appartenenti alla fase dei rifacimenti operati fra la fine del IV e l’inizio del III sec. a.C., apparvero crollate dall’alto della duna sabbiosa verso una quota inferiore che doveva corrispondere o al fondo del fossato o al livello del terreno circostante, lambito dall’ultimo corso del Basento prima della foce, a riprova della diversa morfologia geografica del settore in epoca antica30.
que così una struttura a cassone larga 3,25 metri, riempita con émplekton, che innalzava il cammino di ronda rispetto alla fase precedente. Alla fine del IV sec. a.C. e durante la prima metà del III sec. a.C. venne realizzato un terzo muro parallelo alla struttura descritta dalla parte interna verso la città sempre in conseguenza alla precarietà statica causata dall’aumento dell’acqua di falda34. Il fronte di mare è purtroppo il meno noto, ma anche quello che, stando ai risultati della fotografia aerea, doveva presentare anticamente delle interessanti soluzioni per il rapporto intercorrente fra le fortificazioni e le strutture portuali. Queste ultime si trovavano probabilmente presso l’angolo sud-orientale dell’area urbana e tramite un canale, individuato dalle fotografie aeree, erano collegate alle foci del Basento, dove si trovava il bacino per le navi alla fonda35. Fin dalla ricostruzione del Lacava, sulle piante di Metaponto si può notare che il raccordo dei fronti meridionale e orientale è rappresentato con una linea spezzata, che disegna sul terreno un rientrante a forma di trapezio privo di base maggiore; esso potrebbe ef-fettivamente seguire il margine del terrazzo urbano e delimitare un’area portuale extra muros, alla quale, nella pianta dello Schmiedt e del Chevallier, conduce il canale navigabile con direzione ovest-est, allineato circa al limite settentrionale del trapezio, in modo da interrompere le fortificazioni del fronte di mare36. Tuttavia la possibilità di ricostruire, tramite la fotografia aerea, il percorso delle mura non permette di restituire il reale assetto della fortificazione in questo punto tanto delicato, dove la natura paludosa delle foci del Basento poteva risultare decisamente favorevole per una buona difesa, ma dove era comunque necessario aprire dei collegamenti attraverso le mura per gli scali navali, senza compromettere la sicurezza del settore.
§ Il fronte orientale Passando al fronte est si rileva che il Lacava presso la ferrovia Taranto - Reggio Calabria rinvenne alcuni blocchi parallelepipedi che non volle ricondurre a strutture difensive, ma a «fondazioni di antiche case»31. Nel 1935 il Pesce condusse dei saggi nella zona e, trovando tratti di strutture composte da blocchi lapidei, ritenne tuttavia di trovarsi in presenza di resti di tombe32, mentre lo Schmiedt e lo Chevallier analizzando i risultati della fotografia aerea, proposero che tali strutture appartenessero al fronte delle mura prospicienti il mare, in corrispondenza del cordone dunario che separa il terrazzo urbano dalla spiaggia33. Le più importanti scoperte relative a questo fronte si sono verificate negli anni ’80 del secolo scorso, quando le indagini condotte dalla Soprintendenza Archeologica della Basilicata hanno messo in luce, negli scavi in proprietà Valente e Le Penne, un tratto di cortina attraversata da un canale di scarico e dotata di torre circolare, compresa all’interno delle murature, ma autonoma strutturalmente.
§ Il fossato Completa il quadro del sistema difensivo tardo classico ed ellenistico la presenza di un grande fossato che già nel IV sec. a.C. circondava probabilmente il complesso della cinta urbana ad una distanza media di 12 metri rispetto alla linea delle mura37. La situazione idrografica della pianura metapontina giustifica la proposta dell’Adamesteanu, fondata comunque sui dati del rilevamento aerofotografico, secondo la quale il fossato era allagato tramite un canale che, partendo dal Basento presso San Biagio e attraversando la pianura lungo le falde delle colline di Pizzica e Givoni, raggiungeva l’opera difensiva presso l’angolo sud-ovest, a poca distanza dal terreno occupato extra muros dal santuario arcaico di proprietà Favale. È
È stato possibile identificare una prima fase della struttura difensiva, datata alla seconda metà del V sec. a.C., che era caratterizzata da un muro con fondazione in blocchi di puddinga ed elevato in carparo completamente spogliato, fornito di contrafforti ortogonali e paralleli fra loro, utili forse per un miglior assetto statico lungo il terreno del cordone dunario prospiciente la spiaggia. Un secolo dopo, contestualmente all’aumento dell’acqua di falda e ai rifacimenti dell’impianto urbano, di quello di drenaggio e della cinta muraria, la struttura del fronte orientale si rinforzò con l’aggiunta di un secondo muro di blocchi reimpiegati che, essendo parallelo al primo più antico, svolgeva la funzione di paramento interno. Ad esso si collegavano i contrafforti del V sec. a.C., che assunsero l’aspetto e la funzione di veri e propri diatoni, e nac-
34
BOTTINI 1983a, pp. 466-467; BOTTINI 1983b, p. 20; BOTTINI 1985, p. 509; BOTTINI 1986, p. 468. 35 L’Adamesteanu (1978, p. 43) ricorda che negli anni ’80 del XIX secolo, ai tempi del Lenormant, erano ancora visibili i muri paralleli che proteggevano i lati del canale. Sul porto-canale SCHMIEDT 1964, p. 57; SCHMIEDT-CHEVALLIER 1959, pp. 995-996; LO PORTO 1966, p. 138; SCHMIEDT 1967, p. 32; ADAMESTEANU 1973a, pp. 31-32; ADAMESTEANU 1974b, p. 7; ADAMESTEANU 1978, pp. 43-44; GIANNOTTA 1980, pp. 43-44. 36 LACAVA 1891, p. 18 fig. 2; CASTAGNOLI 1959, fig. 1; SCHMIEDTCHEVALLIER 1959, p. 1026 e fig. 18; SCHMIEDT 1967, fig. a p. 31; SCHMIEDT 1970a, tav. LXXI; GRECO-MERTENS 1996, fig. a p. 248; MERTENS 1999, fig. 17. 37 Il fossato è stato rilevato lungo tutti i lati tranne che a sud (ADAMESTEANU 1974a, p. 166).
30
ADAMESTEANU 1973a, p. 28; ADAMESTEANU 1973b, pp. 321-322; ADAMESTEANU 1974a, p. 165; ADAMESTEANU 1974b, p. 7; Metaponto I 1975, pp. 289-294; GIANNOTTA 1980, pp. 23-24. 31 LACAVA 1891, p. 127. 32 PESCE 1936. 33 SCHMIEDT-CHEVALLIER 1959, p. 1026; SCHMIEDT-CHEVALLIER 1960, p. 20; SESTIERI 1961, p. 1096.
37
stato ipotizzato inoltre un secondo canale nella zona nord, che doveva svolgere la stessa funzione allacciando al corso del Bradano il fossato. Quest’ultimo si collegava infine al canale del porto nel settore sud-orientale del sistema difensivo e poteva così scaricare le proprie acque direttamente verso il mare. La necessità di questo sistema di circolazione idrica era motivato non solo dal rischio di stagnazione dell’acqua nel fossato, ma anche dal fatto che in esso scaricavano tutte le cloache delle plateìai urbane e il grande canale di drenaggio parallelo al témenos occidentale del santuario di Apollo Licio38.
ragion d’essere, in quanto nella vasta pianura metapontina l’unico sito lievemente dominante è quello appunto scelto per l’apoikìa, e nessuna particolare conformazione del terreno intorno ad esso può offrire un vantaggio strategico difensivo, essendo inglobata nel circuito fortificato. La ricostruzione delle mura durante la seconda metà del IV sec. a.C. non poté dunque far altro che imbragare i margini del terrazzo fra i due fiumi, seguire obbedendo alle direttrici predeterminate fin dall’età arcaica. Una situazione simile è quella di un’altra famosa colonia achea, Poseidonia, che sorge nel cuore della piana del Sele su un banco roccioso prospiciente il mare, delimitato e bordeggiato dalle mura41.
L’indagine condotta presso le mura del kerameìkos sul fronte nord, studiando i percorsi delle due cloache rinvenute, ha permesso di verificare che tali strutture proseguivano oltre le mura attraverso il terreno interposto fra il paramento esterno e il fossato, per raggiungere il bordo di quest’ultimo e scaricarvi all’interno le acque, in modo da allontanarle con sicurezza dall’abitato e dalle fondazioni delle fortificazioni39.
§ La tecnica costruttiva Accanto alle considerazioni precedenti risulta significativo rilevare alcuni particolari delle tecniche costruttive42. Le mura tardo classiche e ellenistiche sui lati nord, est e sud furono realizzate con la muratura a cassone composta da due paramenti in blocchi lapidei, generalmente di reimpiego, collegati da diatoni e contenenti un émplekton secondo una tecnica tipica del tardo classicismo e di tutto l’ellenismo.
Questioni interpretative Alla luce dei dati raccolti il sistema fortificato di Metaponto in età ellenistica rappresenta un importante esempio di conservazione delle preesistenze quali elementi vincolanti la genesi del nuovo apparato difensivo.
Tuttavia gli scavi dell’Adamesteanu sul fronte ovest, in proprietà Mantice e Favale, sembrano far risalire al VI sec. a.C. tale tecnica, almeno per il sito in esame43, ma si può pensare che l’utilizzo dei doppi paramenti riguardi forse solo le fondazioni, dal momento che esse già allora avvolgevano con il paramento esterno il margine del terrazzo urbano. L’elevato infatti ricostruito dall’Adamesteanu per l’età arcaica è in mattoni crudi, mentre è noto, per esempio dallo scavo in proprietà Le Penne lungo il fronte di mare, che l’elevato ellenistico era effettivamente del tipo a cassone con émplekton. Infine il fatto che le fortificazioni avessero paramenti in grandi blocchi è comprovato dal crollo rinvenuto in proprietà GriecoLazzazzera che ha permesso di ricostruire un elevato di almeno cinque filari al momento del collasso della struttura. È tuttavia necessario ricordare che l’Adamesteanu propose anche per l’età ellenistica un elevato in crudo44, prima dei rinvenimenti di proprietà Le Penne risalenti agli anni ’80, ma comunque la tecnica a cassone non era utilizzata lungo tutto il circuito se effettivamente il fronte ovest ancora nel periodo delle ultime ristrutturazioni, fra IV e III sec. a.C., si configurava come un aggere rinforzato e armato con un nuovo paramento già dopo il 350 a.C.
§ La fase arcaica Il teìchos arcaico non solo impone il percorso alle mura di età ellenistica, né soltanto costituisce in alcuni settori, come sul fronte settentrionale, il corpo di fabbrica stesso delle mura, ristrutturato a partire dal 350 a.C., ma segna il limite urbano che già durante il VI sec. a.C. obbediva alla norma dell’adeguamento alla natura del suolo, perpetrandone nel tempo il rispetto. Infatti in numerosi luoghi sondati lungo il perimetro murario, sia in età arcaica sia in età classica ed ellenistica, i doppi paramenti delle mura immorsavano il salto di quota che separa il terrazzo cittadino dalla campagna circostante, tranne che in proprietà Grieco, dove le mura salivano su una duna sabbiosa, o lungo il fronte occidentale, in cui il teìchos e le sue ristrutturazioni si attestavano sul bordo del terrazzo, davanti alla Menasciola di Santa Pelagina. Dunque a Metaponto l’adeguamento delle mura alla natura del terreno non è una caratteristica specifica della fase ellenistica, analogamente a Taranto, Crotone, Caulonia, Locri40, ma è motiva dalla scelta originaria del sito fra il Bradano e il Basento, il mare e il limite occidentale del terrazzo fra i due fiumi. Questa condizione di partenza è la ragione per cui le mura ellenistiche non si svilupparono seguendo il diffuso sistema della «Geländemauern», che non avrebbe avuto
Un’ultima interessante notazione sulle tecniche costruttive riguarda il paramento esterno delle mura di proprietà Mantice e Favale, del quale l’Adamesteanu trovò le testate ortogonali dei diatoni, le «catene», ma non il corrispondente paramento interno. Se quest’ultimo mancasse veramente, la prima fase di impianto del paramento esterno,
38 Sul fossato, i suoi collegamenti con il Bradano, il Basento e il porto e il rapporto con il sistema di drenaggio urbano ADAMESTEANU 1973a, pp. 30-31; ADAMESTEANU 1974a, pp. 166-168; ADAMESTEANU 1974b, p. 7; ADAMESTEANU 1975, pp. 247-248, 251-252; ADAMESTEANU 1978, pp. 372-373; GIANNOTTA 1980, p. 23; BOTTINI 1986, p. 468; BOTTINI 1991, p. 561; BOTTINI 1992, pp. 391-392; SCONFIENZA 1996, p. 48; DE SIENA 1999, p. 232. 39 supra pp. 35 nota n. 13, 35 nota n. 15. 40 supra p. 29; infra pp. 47, 54, 57-58.
41
infra p. 83. Sui materiali da costruzione utilizzati a Metaponto MERTENS 1998, pp. 121-122. 43 L’archeologo documentò il rinvenimento di frammenti di coppe ioniche B 2 all’interno dell’émplekton del tratto di mura in proprietà Mantice (ADAMESTEANU 1973b, p. 323; ADAMESTEANU 1974c, p. 163). 44 ADAMESTEANU 1974a, p. 166; ADAMESTEANU 1974c, p. 446. 42
38
dotato di diatoni e risalente alla metà del VI sec. a.C., potrebbe essere confrontato ad un tratto del fronte di mare delle mura di Caulonia, individuato dall’Orsi e databile al V sec. a.C., che presentava una successione di speroni interni per l’aggancio della struttura con la balza dunaria fra il sito urbano e la spiaggia45, similmente alla serie di diatoni del paramento metapontino, che armerebbero una opera di imbragatura lungo il bordo occidentale del terrazzo urbano.
ricondotta ad un tipo di porta datato alla seconda metà del IV sec. a.C., con semplice ripiegamento degli stipiti verso l’interno, in modo da fiancheggiare il varco e creare una sorta di piccolo cortile a corridoio prima dell’ingresso vero e proprio posto sul fondo53. § Le mura e il drenaggio urbano Una caratteristica delle fortificazioni ellenistiche di Metaponto è la presenza frequente degli scarichi fognari, realizzati attraverso la tessitura muraria delle cortine o delle porte, che conducevano nel fossato le acque drenate dall’abitato. Sono noti quattro scarichi, due lungo il fronte nord, uno su quello sud e uno sul fronte est. Generalmente si tratta di varchi ampi quanto il bacino di scorrimento della struttura idraulica, trattandosi comunque di possibili accessi attraverso il sistema difensivo. La presenza di questi apprestamenti è contestuale e strettamente unita all’edificazione delle mura in età ellenistica, poiché queste furono realizzate in occasione delle grandi ristrutturazioni urbanistiche della seconda metà del IV sec. a.C., dovute all’innalzamento dell’acqua di falda54.
§ Le torri e le porte di Metaponto Le prospezioni aeree e le indagini archeologiche hanno restituito pochissimi dati sulle torri. Sono note la torretta quadrata di proprietà Grieco-Lazzazzera e la torre circolare di proprietà Le Penne. La prima appartiene sicuramente alle ricostruzioni delle mura in epoca ellenistica, la seconda di datazione incerta è compresa nelle strutture murarie del V e della seconda metà del IV sec. a.C. A causa della mancanza di dati non è possibile dire se esistessero torri a cadenze regolari lungo il circuito o se fossero in posizioni strategiche, sebbene la torretta di proprietà Grieco sembri opportunamente posta presso la testa-ta meridionale del rientrante delle mura portuali, presso l’angolo sud-est della cinta.
Le mura si ergevano dunque come un argine difensivo non solo per le mi-nacce nemiche, ma anche per il rischio di allagamento proveniente dalle alluvioni del Bradano e del Basento; esse tuttavia necessitavano di appositi sfoghi per le acque di falda, emergenti spontaneamente in città e canalizzate dalle cloache, onde evitare un effetto a diga presso i margini dell’abitato. In tal modo presso i limiti dell’impianto urbanistico, per il miglior funzionamento del medesimo, venivano a coincidere le funzioni del sistema di drenaggio con quelle non solo eminentemente difensive del sistema di fortificazione.
Le torri erano comunque una componente fondamentale della struttura della Porta Settembrini, che nelle sue due fasi costruttive di epoca tardo classica ed ellenistica si configurava secondo un tipo a varco semplice attraverso le mura, armato con poderose opere sporgenti. Il sistema di fiancheggiamento era semplificato nell’interazione fra le due torri, per la difesa del terreno davanti alla porta e i tratti di cortina limitrofi, in concomitanza ad un aumento della pesantezza delle strutture e del loro armamento, almeno a partire dalla fine del IV sec. a.C. La tipologia della Porta Settembrini trova numerosi confronti nel mondo greco e grecizzato già a partire dal V sec. a.C.; come esempi si possono ricordare innanzitutto la porta di Aulon a Caulonia46, la porta di Etioneia al Pireo47, la sud di Thorikos48, la sud-ovest di Phigalia49, quella della città bassa di Ramnunte50, a Mileto la famosa Porta dei Leoni, con le due poderose torri esagonali51, e la fase di fine V sec. a.C. della Porta Sacra52.
Lo scarico delle acque urbane nel fossato porta a ricordarne il dato dell’allagamento che risulta una possibile soluzione per attuare una strategia di difesa avanzata contro l’assalto nemico. Certamente l’acqua corrente nel fossato agevolava lo smaltimento delle acque drenate dall’abitato verso il mare attraverso il canale del porto, la cui mancanza di dati archeologici verificati sul terreno risulta ancora una grave carenza per la conoscenza completa del sistema difensivo di Metaponto. § I momenti finali
Tornando a Metaponto è ignota la porta che fortificava la testata orientale della plateìa principale est-ovest, simmetrica rispetto alla Porta Settembrini, così come nulla è possibile dire sulla struttura della porta localizzata lungo il fronte sud e speculare alla Tarantina. Quest’ultima era costituita da un varco semplice, senza difese sporgenti, probabilmente tale in conseguenza alla elevata inagibilità del terreno esterno al fronte nord, difeso da un ampio e profondo tratto del fossato urbano e dalle depressioni paludose della sponda destra del Bradano. Può essere
Le mura ellenistiche rimasero in funzione fino alla guerra tarantina, momento in cui fu insediato a Metaponto il primo presidio romano e al quale la critica recente riconduce il primo impianto del Castrum romano55. Negli anni fra il 280 e il 272 a.C. dunque le difese urbane di Metaponto potevano contare sulla cinta di età ellenistica, da poco ultimata in ogni sua parte, la cui operatività fu inte53 Si tratta di un tipo semplice a cortile definito «Vorhoftor», molto frequente nelle fortificazioni ad aggere (BRANDS 1988, pp. 17-19). 54 L’organicità del piano di ristrutturazione urbanistica della seconda metà di IV sec. a.C. è illustrato in MERTENS 1998, pp. 137-138; MERTENS 1999, pp. 276-284. 55 DE SIENA 1990; MERTENS 1999, pp. 284-285. Precedentemente era invalsa l’opinione che il Castrum fosse stato realizzato alla fine del III sec. a.C. dopo la guerra annibalica, quando Metaponto perse definitivamente la sua autonomia (D’ANDRIA 1976, p. 541; GIANNOTTA 1980, pp. 52, 57-60).
45
infra pp. 53-54. infra pp. 52, 56. 47 ADAM 1982, p. 78; 48 ADAM 1982, pp. 78, 209. 49 ADAM 1982, pp. 78, 180. 50 ADAM 1982, pp. 78, 211 51 GARLAN 1974, p. 258; ADAM 1982, p. 78 52 LAWRENCE 1967, p. 234. 46
39
grata sul fronte nord dalla trasformazione del teatro in una sorta di fortezza con tutti gli ingressi ostruiti, dominante a sud e ovest la grande spianata dell’agorà intra muros e ad est e nord il grande rientrante di fronte al Bradano56. Dopo il 272 a.C. nella parte orientale della città greca in prossimità del fronte di mare, per accogliere una guarnigione romana permanente, fu edificato il Castrum, la cui pianta quadrilatera era segnata esternamente da un fossato, colmato poi in epoca imperiale, e da una cinta fortificata che utilizzava blocchi di reimpiego provenienti dall’abitato e dal santuario urbano57. È forse da ricercare nella presenza di queste due cinte fortificate, la prima delle quali cadde in disarmo dopo la seconda guerra punica, il motivo per cui Pausania nel II sec. d.C. utilizzò il termine per¤boloi al plurale per indicare i circuiti delle mura di Metaponto, entrambi ormai destituiti di ogni valore strategico.
56
MERTENS 1999, pp. 284-285. Sul Castrum romano di Metaponto ADAMESTEANU 1965, pp. 182184; LO PORTO 1966, p. 140; ADAMESTEANU 1967, p. 9; ADAMESTEANU 1974b, p. 7; D’ANDRIA 1976; D’ANDRIA 1977, pp. 856-857; GIARDINO 1978; GIANNOTTA 1980, pp. 25, 37, 56-60; LATTANZI 1980, pp. 404-406; LATTANZI 1982a, pp. 277-278; DE SIENA 1990; DE SIENA 1999, p. 342; MERTENS 1999, p. 292; SMALL 1999, p. 570; DE SIENA 2001, pp. 38-39. 57
40
CAPITOLO
3
Castiglione di Paludi
za torre semicircolare e l’altra nella parte terminale del tratto di cortina, che difende il lato nord del saliente estremo sul fronte est, localizzato immediatamente a sud della porta principale1.
Il sito di Castiglione di Paludi si trova alla distanza di circa 8 chilometri dal mare, su un colle nel settore sudorientale del territorio di Sibari-Thurii. L’altura appartiene ai primi contrafforti della Sila ed è fiancheggiata ad est dal torrente Coséria e ad ovest dal torrente Scarmaci, essendo così protetta naturalmente da due profonde vallate e dalla ripida dorsale declinante a nord verso il mare. L’unico accesso agevole è localizzato a mezza costa, lungo l’estremità sud-ovest dell’altura.
La datazione del circuito fortificato nella seconda metà del IV sec. a.C. è stata dedotta in base alle caratteristiche architettoniche delle strutture difensive e alle risultanze di saggi condotti all’interno della porta principale e del fronte nord-est2. È possibile esaminare dunque alcuni punti significativi del sistema difensivo di Castiglione di Paludi che confermano decisamente la presenza dei nuovi principi della teichopoiìa alto ellenistica.
Le indagini archeologiche nel sito hanno avuto inizio nel 1949, quando le imponenti emergenze delle mura hanno richiamato l’attenzione degli studiosi. La cinta fortificata di Castiglione di Paludi, sebbene non sia conservata completamente e non totalmente indagata, risulta davvero degna di attenzione a causa della permanenza di un elevato considerevole in blocchi isodomi di arenaria e per via di alcune soluzioni strategico-difensive pienamente coerenti alla tradizione architettonica militare ellenistica.
§ La porta a cortile In ragione delle caratteristiche planimetriche e costruttive bisogna considerare come primo argomento la fortificazione delle due porte note lungo il fronte orientale. La porta principale si trova al fondo di una rientranza, che le mura compiono fiancheggiando il margine interno di un piccolo pianoro, il quale raccorda la strada corrente lungo la dorsale nord-est con una valletta che conduce alla parte centrale dello spazio interno alle mura. La struttura è stata subito ricondotta dagli archeologi al tipo a cortile3, poiché presenta un primo varco esterno attraverso un muro che limita ad est una camera a cielo aperto rettangolare, la cui uscita si trova nel muro di fondo parallelo al primo. Il percorso di attraversamento è pertanto ortogonale alla linea delle mura e non parallelo, come nei tipi della porta scea e a copertura; tuttavia i due varchi del cortile sono sfalsati, trovandosi quello esterno presso l’angolo sud-est e quello interno presso l’angolo nord-ovest, così da evitare che le aperture siano in asse e rendere disagevole il transito attraverso la struttura con un percorso a doppia squadra o diagonale. All’esterno l’ingresso è difeso dalle due torri circolari descritte sopra, la cui disposizione permette di dominare l’intero pianoro da nord e di fiancheggiare le mura del settore. La torre settentrionale, divisa dalla porta da un ridotto tratto di cortina copre a 180° il terreno antistante l’ingresso e fiancheggia i tratti di mura
L’impianto difensivo Il circuito murario segue i margini del colle in obbedienza alla regola dell’adeguamento al suolo, sfruttando l’andamento delle curve di livello a favore del fiancheggiamento reciproco fra i successivi tratti di cortina, com’è ben visibile lungo il fronte est e per tutto il tracciato verificato ed ipotizzato. La conservazione dell’elevato è decisamente apprezzabile, ma purtroppo non è tale da aver mantenuto integri tratti del cammino di ronda, al quale si accedeva tramite rampe di scale parallele alle cortine e verificate archeologicamente. Le indagini hanno inoltre riportato alla luce ben quattro torri nella porzione di circuito che va dalla porta principale all’estremità settentrionale, il che lascia ipotizzare la presenza di numerosi altri manufatti simili lungo tutta la cinta nei punti strategicamente convenienti. Le prime due torri di perimetro circolare appartengono al sistema della porta principale, sporgono dalla linea difensiva soltanto per una porzione della circonferenza totale e sono realizzate in opera isodoma come le cortine, ma con una prevalenza di blocchi disposti di testa in ciascun filare, per ispessire la muratura e agevolare la definizione del profilo circolare.
1 Le notizie principali riguardanti il sito, la cinta muraria, le torri, le postierle e le porte di Castiglione di Paludi, raccolte progressivamente man mano che procedevano le indagini archeologiche si trovano in IACOPI 1949; IACOPI 1950; IACOPI 1953; PROCOPIO 1954; VAN BUREN 1954, pp. 326-327; PROCOPIO 1956, p. 173; DE FRANCISCIS 1962, p. 220; ROGLIANO 1962, p. 10; FOTI 1974a, p. 386; FOTI 1974b; GUZZO 1975, pp. 99-104; SABBIONE 1979, p. 372; GRECO 1981a, pp. 121-122; GUZZO 1982, p. 298; LATTANZI 1982b, p. 220; CAVAGNARO VANONI 1985, p. 554; LATTANZI 1985b, pp. 143-144; GUZZO 1986, pp. 203-204; GUZZO 1987, pp. 136-137; GRECO 1993, p. 282; TRÉZINY 2004, pp. 618-619. 2 PROCOPIO 1954; PROCOPIO 1956; FOTI 1974a, p. 386; FOTI 1974b; GUZZO 1979, pp. 372-374; SABBIONE 1979, p. 372; GRECO 1981a, p. 121; GUZZO 1982, p. 298; LATTANZI 1985b, p. 144; LATTANZI 1986, p. 430; PAGANO 1986, p. 92; GUZZO 1987, p. 137; GRECO 1993, p. 282. 3 IACOPI 1950; IACOPI 1953; PROCOPIO 1954; VAN BUREN 1954, p. 326; SABBIONE 1979, p. 372; PAGANO 1986, p. 95.
Presso l’estremità nord del circuito murario, punto in cui il pianoro si rastrema per poi collegarsi al ripido scoscendimento settentrionale, si trova la terza torre con profilo semicircolare agganciato sulle estremità alle cortine mentre, poco distante presso il margine occidentale del limite nord, sono stati rinvenuti i resti di una torre quadrata, con uno dei lati rivolto verso il fronte di attacco. Sono documentate inoltre due postierle, una poco più a sud della ter-
41
est-ovest, nei quali essa è inglobata, mentre la torre meridionale fa da raccordo strutturale fra il cortile della porta e il tratto di mura nord-sud che limitano ad ovest il pianoro di accesso, in modo da fiancheggiare direttamente il varco esterno e tutta la cortina meridionale.
più che si individuano per l’opera in esame un confronto di IV sec. a.C. a Gortina di Arcadia nella porta B14 e uno illustre nella conformazione a tenaglia aperta della porta del Trìpylon a Siracusa, il cui primo impianto è ricondotto all’età di Timoleonte, precisamente agli anni fra il 350 e il 325 a.C.15. Si ricorda infine che in Magna Grecia esiste ancora un confronto rappresentato dalla fase ellenistica di Porta Calenda a Neapolis, dotata inoltre di una struttura a cortile per difendere meglio il varco d’ingresso16.
La posizione della torre nord rappresenta una variante allo schema tipo delle porte a cortile, non essendo allineata alla torre sud per chiudere il varco nel mezzo4, ma ciò dimostra ancora una volta che domina sul modello generale il principio dell’adeguamento alla natura del sito, rendendo plasmabile il modello stesso. È possibile proporre come confronti circa coevi la porta del lago a Stinfalo5, la D di Mantinea6 e la porta a cortile dell’acropoli di Kastraki7, che hanno in comune con quella di Castiglione le torri circolari e la disposizione di una di esse non a diretto contatto con il varco d’accesso, ma tali opere sono ancora del tipo a copertura avendo il varco sceo, per quanto quella di Kastraki sia lievemente ruotata verso nord rispetto all’andamento est-ovest della cortina occidentale. Un confronto invece dell’inizio del IV sec. a.C., con due torri semicircolari sulla fronte, è la Porta di Istmia a Corinto, mentre un ultimo ancor più calzante, data la vicinanza geografica, è costituito dalla Porta Marina di contrada Casa Bianca a Thurii, raro documento delle difese della colonia panellenica, datato alla fine del IV sec. a.C. e armato di torre circolare8.
§ Cortine e fiancheggiamento La presenza sistematica dell’applicazione delle leggi del fiancheggiamento lungo il tracciato è palese innanzitutto nei tratti murari prossimi alle porte. Infatti il pianoro di accesso alla porta principale è dominato a sud dal tratto di mura est-ovest del saliente estremo del fronte est, che sul versante meridionale della valletta d’accesso difende il terreno più distante dal sistema della porta. Non a caso in questo settore, presso il raccordo fra il tratto murario nord-sud e quello est-ovest, è stata realizzata una delle due rampe d’accesso al cammino di ronda, individuate dai ricercatori, per agevolare l’impiego di uomini nella difesa dei due tratti. Inoltre all’estremità orientale del tratto murario est-ovest si apre una postierla, che permette di intervenire alle spalle di un assalitore impegnato nell’attacco alla porta. Scendendo al sito della porta a tenaglia, si può notare al culmine del suo corno settentrionale la presenza di un tratto rettilineo di mura, raccordato, ma esterno al circuito che costituisce una sorta di proteìchisma per sbarrare il terreno a nord della porta e per dominare l’intero imbuto della struttura, esterno al varco d’accesso.
§ La porta a tenaglia La seconda porta individuata a Castiglione di Paludi appartiene sempre al fronte orientale ed è collocata a sud della principale9. È costituita da un solo varco aperto nella parte interna di una profonda opera a tenaglia strombata, generata dalla convergenza di due tratti di mura rispettivamente con andamento nord/est-sud/ovest e nord/ovest-sud/est. La porta era in comunicazione con la dorsale sud-orientale ed era posizionata ad est della zona urbana in cui sorgeva il teatro.
Infine il settore nord-est del fronte orientale, a settentrione della porta principale, presenta un raccordo fra due tratti di cortina paralleli e sfalsati, in corrispondenza dell’altra rampa d’accesso al cammino di ronda, portata alla luce nel 1956, in modo che il disassamento permetta all’interno del circuito la collocazione della rampa e all’esterno una sporgenza per fiancheggiare il tratto di mura a nord, che segue una curvatura prima di raggiungere il terreno dominato dalla torre semicircolare dell’estremità settentrionale. La difesa di questo settore è completata dall’apertura di una postierla immediatamente a sud della torre semicircolare.
Si tratta di un esempio notevole di porta a tenaglia aperta, notata dal Winter10 nella sua opera dedicata all’architettura militare greca e tale da indurre lo studioso a collocarla cronologicamente in un periodo successivo alla metà del IV sec. a.C., indicando come confronti le più famose porte di Tindari11 e Leontini12 e definendola genericamente ellenistica; recentemente è stato inoltre dimostrato che la piccola cinta di Colle San Mauro a Lentini risale al IV sec. a.C.13. Le considerazioni del Winter comunque non vietano di estendere anche alla porta a tenaglia la datazione generica alla seconda metà del IV sec. a.C. assegnata all’intero circuito murario di Castiglione di Paludi, tanto
§ La tenaglia settentrionale Merita infine attenzione l’assetto della difesa dell’estremità nord del circuito, che accanto alle osservazioni precedenti contribuisce notevolmente a dimostrare l’applicazione di principi «moderni» nella realizzazione di queste fortificazioni. Nel settore in esame la torre semicircolare orientale e la quadrata occidentale sono collegate da due cortine convergenti ad angolo rientrante così da determi-
4
supra p. 18. WINTER 1971, p. 217 6 WINTER 1971, pp. 216-217; ADAM 1982, pp. 78, 83, 177. 7 ADAM 1983, pp. 90-91. 8 WINTER 1971, pp. 224, 227; CARANDO 1999, in cui segue bibliografia pregressa; TRÉZINY 2004, p. 619. 9 PROCOPIO 1954; PAGANO 1986, p. 96. 10 WINTER 1971, p. 119 nota n. 44. 11 WINTER 1971, pp. 222, 224; ADAM 1982, p. 85; CAVALIERI 1998, pp. 192, 197-198. 12 WINTER 1971, p. 224; ADAM 1982, pp. 85-86. 13 RIZZA 2000. 5
14
WINTER 1971, p. 212; MARTIN 1974, p. 197; ADAM 1982, pp. 85, 179. 15 supra p. 16 nota n. 108; inoltre: WINTER 1971, pp. 179, 224; ADAM 1982, pp. 85-86. 16 GABRICI 1951, coll. 605-606; JOHANNOWSKY 1960; GRECO 1986a, p. 198; DE CARO 1999, pp. 835-836.
42
nare una tenaglia, i cui corni sono armati dalle torri stesse. Con il termine «tenaglia» si intende appunto una composizione ad angolo rientrante, particolarmente adatta alla difesa di alture e a fortificazioni di montagna, che occupa la sommità di un acrocoro con la parte interna ed estende lungo le dorsali le sue estremità, i corni17. La tenaglia, teorizzata e classificata dagli architetti militari moderni, era nota già nel IV sec. a.C. e in età ellenistica, basta infatti pensare agli andamenti delle cinte a denti di sega o a cremagliera che non sono altro se non profili tanagliati a copertura reciproca18, ma essa come opera singola svolge anche la funzione descritta sopra per la difesa dei colli, delle dorsali e dei limiti delle posizioni d’altura. A questo proposito rappresentano dei buoni esempi generali e dei validi confronti per la tenaglia di Castiglione di Paludi l’estremità nord del proteìchisma, databile nella seconda metà del IV sec. a.C., che protegge la grande batteria a due torri delle mura di Gorìtsa nel golfo di Vòlos in Tessaglia19, la cinta piccola di Gortina d’Arcadia20, realizzata fra III e II sec. a.C., il fronte sud-ovest della cinta del IV sec. a.C. di Ramnunte21, il fronte ovest della fortezza di Gyphtokastro in Attica22, un tratto delle mura orientali di Agrigento a sud-ovest della porta I23, tutte tenaglie o profili tanagliati delle cortine, usati per difendere la dorsale o la sommità di un’altura.
tificazione, diffusasi durante l’Ellenismo a partire dal IV sec. a.C.25. Questioni interpretative Il sito di Castiglione di Paludi rappresenta dunque una piazzaforte localizzata strategicamente lungo la valle del torrente Coséria, che è una via importante di penetrazione dalla pianura litoranea ionica all’interno del massiccio silano. § Datazione La datazione delle mura alla seconda metà del IV sec. a.C. colloca la valorizzazione strategica del sito nel periodo del maggior contrasto fra le popolazioni italiche, stanziate in Calabria e Basilicata, e le città greche della costa, fra le quali non è possibile non prendere in considerazione Thurii, per la sua collocazione geografica a poca distanza dalla montagna di Castiglione. Le indagini e gli studi degli archeologi sul popolamento e sui centri della Sibaritide hanno permesso di identificare in Castiglione di Paludi una località frequentata fino alla fine dell’VIII sec. a.C. da genti locali, che evidentemente vennero meno in seguito alla fondazione della potente colonia achea26. Pertanto la fase di insediamento corrispondente all’edificazione delle mura ha restituito sul pianoro tracce di abitato e i resti di un teatro in soluzione di continuità rispetto all’età arcaica, poiché tali documentazioni non insistono su livelli più antichi27.
§ La tecnica costruttiva La tecnica costruttiva delle mura di Castiglione di Paludi consiste, come già accennato, nella consueta opera isodoma di blocchi lapidei parallelepipedi. Tuttavia indagini archeologiche più accurate24 hanno verificato che la struttura è a doppio paramento con émplekton interno certamente diviso da diatoni. È possibile notare inoltre che la spessa muratura delle torri circolari lascia presumere la posa in batteria di macchine da guerra pesanti e rende le opere piuttosto autonome rispetto alla tessitura delle cortine, sebbene si leghi ad esse, secondo la caratteristica ricerca di autonomia strutturale fra le componenti della for-
§ La piazzaforte brezia Il pianoro sembra abitato con una certa sistematicità solo dalla seconda metà del IV sec. a.C., sebbene tracce di una minima presenza umana risalenti al passaggio fra VI e V sec. a.C. siano state individuate presso il bordo del pianoro, sondando le mura di nord-est28. In seguito all’abbandono dell’ipotesi dello Iacopi, di far corrispondere il centro fortificato alla cosiddetta quarta Sibari, ovvero Sibari sul Traente, che la tradizione storica indica come una delle città fondate dai Sibariti superstiti e dai loro discendenti, dopo la distruzione della pòlis achea nel 510 a.C., il sito di Castiglione di Paludi è stato considerato un importante centro brezio, dotato di fortificazioni e dominante dall’alto la chòra di Thurii.
17
Per la definizione dell’opera a tenaglia HOGG 1982, p. 251; FAUCHERRE 1991, p. 108; HERMANN 1992, p. 192; CASSI RAMELLI 1996, p. 460; DUFFY 1996, p. 225. Nell’ambito degli studi di architettura militare antica viene utilizzato il termine moderno per definire le opere che presentano la conformazione descritta nel testo e lo si applica anche per le porte a tenaglia aperta, dal momento che esse si aprono effettivamente all’interno di un rientrante formato da due tratti di mura convergenti. L’utilizzo della tenaglia divenne nel corso dei secoli la soluzione migliore per la difesa delle dorsali e delle posizioni in quota, come dimostrano numerosi esempi di opere difensive, permanenti o campali, realizzate nei secoli XVII e XVIII sulle Alpi Occidentali ai confini fra i Regni di Francia e di Sardegna e unica fra tutte vale la pena di ricordare la fortezza di Montmélian in Savoia nella valle dell’Isére, composta da una successione per quote di sole opere a tenaglia (per queste opere e la biblicografia relativa si rimanda a SCONFIENZA 1999, pp. 102-109). 18 supra p. 16. 19 BAKHUIZEN 1986, pp. 319-320; BAKHUIZEN e A. 1992, pp. 105-107, 149-155. 20 WINTER 1971, p. 123; MARTIN 1974, p. 192; ADAM 1982, p. 179. 21 ADAM 1982, p. 211. 22 All’interno del corno sud della tenaglia si apre la porta occidentale (ADAM 1982, p. 217) 23 WINTER 1971, p. 224. 24 Si tratta di scoperte conseguenti all’intervento di consolidamento delle mura di sud-est che illustrano la presenza di un paramento interno fondato sul banco roccioso (LATTANZI 1994, 741), mentre lungo tutto lo sviluppo del circuito è ben visibile soltanto il paramento esterno.
Questa identificazione è invalsa fin dal 1961, quando il De Franciscis criticò quella dello Iacopi e propose l’interpretazione della presenza brezia, che per altro lo Iacopi stesso non negava, vedendo nei Brezii del IV sec. a.C. i
25
supra p. 17. DE LA GENIERE 1970, p. 625; GUZZO 1975; DE LA GENIERE 1978a, p. 337; DE LA GENIERE 1978b, p. 261; GUZZO 1982, p. 298; GRECO 1993, p. 27. 27 SABBIONE 1979, p. 373; FOTI 1981, p. 305; LATTANZI 1982b, pp. 219-220; LATTANZI 1983, pp. 572-573; LATTANZI 1985b, p. 144; LATTANZI 1986, p. 430; LATTANZI 1988, p. 649; LATTANZI 1990, p. 582; TODISCO 1990, pp. 145-146; LATTANZI 1991, p. 584; LATTANZI 1992, pp. 421-422; LATTANZI 1994, pp. 741-742. 28 FOTI 1974a, p. 386; LATTANZI 1985b, pp. 143-144; LATTANZI 1986, p. 430. 26
43
conquistatori della quarta Sibari29. Tutta la critica successiva è concorde nel conside-rare Castiglione una piazzaforte, che i Brezii mantennero a partire dalla seconda metà del IV sec. a.C. fino alla fine del III sec. a.C. e ad accomunarla ad altri siti montani della Calabria, fortificati dalle genti indigene durante le lotte con i Greci e la conquista romana30.
nel cuore della problematica e tentare di identificare i committenti, pare piuttosto verosimile che le fortificazioni di Castiglione di Paludi, da un punto di vista tecnico, possano essere attribuite all’intervento di ingegneri greci o ellenicamente formati in materia di poliorcetica e architettura militare. Certamente la loro presenza è chiara in termini progettuali, ma le tecniche costruttive delle porte e delle torri, anche se la struttura delle cortine non è archeologicamente verificata, possono indurre ad immaninare l’intervento fisico e attivo di queste maestranze sui cantieri di costruzione. Pertanto il prodotto finale di tali interventi ha determinato la nascita di uno dei più importanti documenti di architettura militare in Magna Grecia durante l’Ellenismo e degno di essere rilevato nella presente rassegna.
§ Alessandro il Molosso Un’opinione diversa, appoggiata dal Todisco, è quella espressa dal Pagano che, ritenendo inverosimile l’utilizzo di una tecnica ingegneristica tanto avanzata, quale risulta alla base della costruzione della cinta di Castiglione, propone di motivare la nascita della piazzaforte in conseguenza alla presenza di Alessandro il Molosso in Italia meridionale, proprio negli anni in cui è datata l’edificazione delle mura, fra il 333 e il 331 a.C., e precisamente nel momento in cui egli volle trasferire la sede della Lega Italiota da Eraclea a Thurii e forse creare un centro ben difeso per le riunioni annuali della lega stessa nel territorio della colonia panellenica. In seguito, secondo il Pagano, dopo la morte del Molosso, i Brezii conquistarono la fortezza trasformandola in un’arma potente contro i Greci della pianura costiera e mantenendo il controllo degli accessi alle montagne della Sila31. Le fortificazioni di Castiglione di Paludi potrebbero così essere il risultato di una collaborazione fra le maestranze architettoniche thurine e gli ingegneri militari epiroti dello zio di Alessandro Magno, aggiornati sulle novità tecnologiche delle artiglierie neurobalistiche, che stanno alla base dei calcoli di fian-cheggiamento e copertura per la realizzazione di numero-se componenti della cinta in esame. D’altro canto è pur vero che, come ha ben dimostrato il Tréziny32 per i centri fortificati lucani in Basilicata, le genti indigene potevano far riferimento a maestranze greche specializzate nell’edificazione delle mura, disposte ad offrire sul mercato le loro competenze certamente aggiornate in materia di armamenti nuovi e nozioni balistiche, che vincolavano la disposizione delle opere difensive. Il problema delle fortificazioni indigene nell’Italia meridionale durante il IV sec. a.C. e l’alto ellenismo è certamente un argomento di vasto respiro e contestuale alle ricerche svolte in questa sede, tuttavia, senza addentrarsi 29
IACOPI 1949; IACOPI 1952 ; VAN BUREN 1954, pp. 326-327; ZANOTTI BIANCO 1955, pp. 271-272; ZANOTTI BIANCO 1957, pp. 17-18; DE FRANCISCIS 1962, p. 221; MAIURI 1962, pp. 92-93. Si può inoltre ricordare la proposta del Rogliano (1962) di identificare il sito di Castiglione di Paludi con l’antica Petelia. 30 GUZZO 1978, pp. 472-473; SABBIONE 1979, p. 373; GUZZO 1982, pp. 298-299; GUZZO 1984, p. 311; GUZZO 1986, pp. 203-204; LOMBARDO 1989, p. 261; GRECO 1993, pp. 282-283. Alla fine del IV sec. a.C. in Basilicata furono realizzati numerosi circuiti fortificati da parte delle genti lucane in lotta con le città costiere ed i condottieri chiamati da Taranto (ADAMESTEANU 1974d, pp. 190-201; TRÉZINY 1983; BARBERIS 1999; BARRA BAGNASCO 1999b; DE GENNARO 2004). In Calabria esiste una situazione simile, pur essendo meno ricca la documentazione e meno complesse le strutture difensive rispetto a Castiglione (GUZZO 1982, pp. 137-138, 295; GUZZO 1986; LATTANZI 1986, pp. 429-430; LOMBARDO 1989, p. 261; LATTANZI 1991, p. 584; DE SENSI SESTITO 2004). 31 PAGANO 1986, pp. 96-99; TODISCO 1990, p. 145; TRÉZINY 2004, p. 622. 32 TRÉZINY 1983; TRÉZINY 1986, pp. 191-198.
44
CAPITOLO
4
Crotone
La moderna città di Crotone sorge in un sito che nel passato fu sempre considerato strategicamente importante, come dimostra il castello dominante la città vecchia, edificato nel 1541 per trasformare il borgo di Cotrone nella piazzaforte marittima più importante, dopo Taranto, lungo la costa ionica del Vicereame di Napoli1.
ni durante il IV e III sec. a.C., periodo di nostro precipuo interesse, e avanzare delle ipotesi sulle difese precedenti4. Dopo la conquista siracusana del 389 a.C. ed il ritorno all’autonomia nel 378 a.C., Crotone visse un secondo periodo di fioritura, durante il quale il sistema difensivo forzato da Dionisio I fu ristrutturato. Una prima immagine ricostruttiva di esso fu abbozzata dal Byvank, che, come tutti gli studiosi successivi, proponeva un percorso collinare a ovest dell’abitato, fornendo tuttavia notizie sull’esistenza di torri e tratti murari, mai più identificati sul terreno, soprattutto a nord dell’Esaro. Il tracciato nel tratto fra il fiume e la collina di Vigna Nuova formava un rientrante per superare il salto di quota e poi si dirigeva a sud-est verso la collina del castello, dove lo studioso collocava l’acropoli, seguendo un percorso in pianura rettilineo ai piedi delle colline, che chiudono la piana crotoniate a sud5. La ricostruzione del tratto sud-orientale proposta dal Byvank non pare accettabile per le ovvie ragioni strategiche di dominio, esercitabile dall’alto dei colli sguarniti, sulle fortificazioni situate in pianura e per i risultati delle ricerche successive, che hanno individuato strutture difensive sul sistema collinare di sud-ovest.
La rocca su cui sorge il castello spagnolo, come si dirà oltre, era inglobata nella cinta dell’antica Kròton, la colonia achea fondata a sud di Sibari per il controllo della porzione meridionale del golfo di Taranto, proprio nella piana costiera poco più a nord del castello, lungo la rada in cui si trovano le foci dell’Esaro. Ad ovest la pianura è limitata da un sistema di colline dall’altezza variante che a nord del fiume è costituito dai rilievi di Vigna Nuova e Batteria, mentre a sud inclina verso il mare limitando la pianura con il colle più alto di Santa Lucia e termina nella rocca del castello. La storia della pòlis è costellata di eventi bellici, che, se in età arcaica la contrapposero a Siris, Sibari e Locri e la condussero al primato fra le colonie magnogreche dopo la venuta di Pitagora, dall’inizio del IV sec. a.C. segnarono il rapporto conflittuale con Dionisio I di Siracusa, lo scontro con le popolazioni italiche e il declino del III sec. a.C. attraverso la guerra di Pirro e la venuta di Annibale, fino alla deduzione della colonia romana nel 194 a.C. Sono dunque gli avvenimenti di questi anni, talvolta funesti come i sacchi di Dionisio I e di Agatocle o la conquista cartaginese, che stanno alla base della realizzazione di un’ampia cinta muraria, che chiudeva tutto l’abitato seguendo la dorsale delle colline dell’entroterra2.
§ I fronti orientale e occidentale La più recente e accreditata ricostruzione del circuito innanzitutto nulla può dire sulla situazione del fronte orientale, non essendo stata ritrovata alcuna testimonianza archeologica di opere difensive che dovevano comunque esistere in analogia a tutte le pòleis di Magna Grecia e Sicilia prospicienti il mare. Il fronte occidentale di terra, con la sua propaggine meridionale volta verso est segue un percorso che archeologicamente inizia ad essere documentato dalla collina di Santa Lucia. Il tratto, che da Santa Lucia chiude verso est il circuito, non è stato individuato, ma è presumibile che scenda verso il mare, chiudendo all’interno dell’area murata la collina del castello spagnolo. Il sito di Santa Lucia costituisce il punto più alto di tutto il sistema collinare crotoniate, raggiungendo un’altezza di 130 metri s.l.m.; su di esso furono condotte alcune indagini nel 1983 dal
L’impianto difensivo tardo classico La documentazione archeologica relativa alle mura di Crotone è purtroppo inversamente proporzionale all’estensione che esse raggiunsero anticamente, 12 miglia, come testimonia Livio3, ovvero più di 13 chilometri, e all’importanza politica della città. Tuttavia si può ricostruire buona parte del tracciato seguito dalle fortificazio-
1
Il castello fu progettato da Gian Giacomo dell’Acaja su commissione di don Pedro di Toledo (FARA 1989, pp. 31-32; RUSSO 1989, pp. 112117). Sul valore strategico del sito SCHMIEDT 1967, pp. 16-17; WINTER 1971, p. 20; GRECO 1985, pp. 341-342. 2 Per la storia di Crotone in generale e delle vicende dalla fine del V sec. a.C. alla conquista romana CRISTOFANI 1970, p. 269; GRECO 1981a, pp. 98-102; GUZZO 1982, pp. 47-48, 102-103, 108-169 passim; GRECO-TORELLI 1983, pp. 171-173; PUGLIESE CARRATELLI 1983 passim; CORDANO 1985, p. 312; GIANGIULIO 1987 passim; GIANGIULIO-SABBIONE 1987, pp. 475-479; LOMBARDO 1987a passim; SEVERINO 1988, pp. 323; Crotone 1993; GRECO 1993, pp. 46-47, 264. 3 Ab urbe condita (1958), XXIV, 2, 3.
4
Sulle mura di Crotone BYVANK 1914; CRISTOFANI 1970, p. 269; FOTI 1975, pp. 302-303; SABBIONE 1976, pp. 583-587; CAVAGNARO VANONI-LININGTON 1977, pp. 679, 682; SABBIONE 1977, pp. 898-899; ARDOVINO 1979, pp. 376-377; GRECO 1981a, p. 102; LININGTON 1982, pp. 254-255; GUZZO 1982, p. 286; GRECO-TORELLI 1983, p. 173; GULLINI 1983, p. 260; LATTANZI 1984a, pp. 98, 100-103; SPADEA 1984, pp. 132-134, 142-144, 158-162; TRÉZINY 1984a; GRECO 1985, p. 342; GIANGIULIO-SABBIONE 1987, pp. 490-496 passim, 499; SEVERINO 1988, pp. 15-16; BORELLO 1993; SPADEA 1993; SPADEA 1994, pp. 333335. 5 BYVANK 1914.
45
Tréziny, che portarono alla luce i resti di un tratto di mura a sbarramento, presumibilmente con andamento a cremagliera, datato al terzo quarto del IV sec. a.C. La struttura delle opere indagate, che è quella tipica di età ellenistica, a doppio paramento in blocchi calcarei squadrati con émplekton interno e diatoni, fu oggetto di estese spoliazioni verosimilmente intorno al 1541, quando i cantieri del castello vicereale utilizzarono i blocchi di calcare per la produzione di calce, come sembrano testimoniare i rinvenimenti di due fosse per la produzione del legante, presso i tratti di fortificazione greca portati alla luce6.
zione del problema. Purtroppo il settore non ha restituito tratti di fortificazione, che possano illustrare in maniera definitiva la strada scelta dagli ingegneri crotoniati, se non due strutture segnalate dall’Orsi e dal Byvank fra il 1910 e il 1912. Il tratto individuato dall’Orsi, e riportato alla luce nel 1978 dall’Ardovino, è localizzato sulla sponda destra dell’Esaro e presenta, presso l’interruzione di fronte al fiume tracce strutturali che l’Orsi aveva ritenuto pertinenti ad un ponte o ad un qualche sistema di attraversamento del letto fluviale11. Forse un sistema di grate chiudeva il varco o i varchi aperti nella struttura inferiore delle mura a cavallo del fiume, per lasciare libero corso alle acque; potrebbe essere una soluzione diversa, a causa dell’ampia area pianeggiante da difendere, rispetto a quella dei lunghi muri d’argine locresi, che incanalavano in stretti varchi fortificati le acque correnti nei valloni a monte dell’abitato12. I resti segnalati dal Byvank si trovavano nello stesso settore, in località Polveriera, non più rilevati in seguito e quindi non confrontabili con le altre strutture difensive, ma datati dallo studioso tedesco alla fine del IV sec. a.C.13. Lo Spadea infine segnalava nel 1994 l’individuazione di «alcune significative tracce» di mura presso la stazione ferroviaria nella valle attraversata dall’Esaro14.
Scendendo lungo la dorsale da Santa Lucia, le mura puntavano in direzione nord su contrada Carrara. Di questo tratto fu individuata una porzione affiorante ancora nei pressi dell’altura di Santa Lucia, realizzata con le stesse tecniche costruttive suddette7, ma nulla alla Carrara che pure doveva essere un luogo fortificato, trovandosi sulla linea di dorsale fra Santa Lucia e il Cimone Rapignese. Tuttavia il fatto più interessante è che sulle alture della Carrara è documentata una necropoli in uso fra VII sec. a.C. e III sec. a.C., quindi in rapporto con il circuito murario del IV sec. a.C. e forse inglobata in esse, secondo il rispetto degli imperativi strategici e difensivi che già si è rilevato, in maniera ben più evidente, nel caso di Taranto8. Nel 1978 fu rinvenuto un resto di fortificazione presso il Cimone Rapignese, ossia il primo tratto della dorsale collinare a sud dell’Esaro, che digrada verso il fiume a partire da Santa Lucia; si individuavano così le tracce di un percorso diverso da quello in pianura ipotizzato dal Byvank, che seguiva invece un più logico percorso d’altura a sud dell’abitato cittadino9.
Salendo lungo la dorsale collinare a nord del Papaniciaro, il cui attraversamento fortificato è assolutamente ignoto, né è possibile dire se ricalcasse quello che pare intravedersi per il superamento dell’Esaro, si giunge al sito di Vigna Nuova. Questo tratto del circuito fortificato, a nord-ovest dell’Esaro, coincide abbastanza con le descrizioni del Byvank, sebbene non si sia trovata traccia delle torri di cui egli parla. Le indagini a Vigna Nuova iniziate nel 1975 hanno restituito lungo le pendici della collina tratti di fortificazione realizzati con la solita tecnica ad émplekton, che induce a collocarli cronologicamente nel IV sec. a.C., tuttavia si è rilevato che i paramenti murari esterni sono realizzati in modo meno regolare che nelle altre località indagate, essendo i blocchi appena sbozzati e collocati in opera con giunture a linee spezzate. Inoltre nel 1978 si verificò che le mura di Vigna Nuova aggiravano la collina, senza scalarne la sommità, che manteneva la sua posizione a dominio del terreno esterno alle fortificazioni, e si dirigevano così a sud-est verso il torrente Papaniciaro e a nord attraverso la pianura che separa Vigna Nuova dalla collina di Batteria15.
Il sistema collinare di Crotone presenta un ampio varco in corrispondenza del passaggio dell’Esaro, infatti il corso del fiume passa ai piedi del Cimone Rapignese e delimita a sud un’area pianeggiante che a settentrione è bordata da un altro corso d’acqua, il Papaniciaro, oltre il quale i rilievi collinari tornano a salire per raggiungere il sito di Vigna Nuova. Questo cuneo pianeggiante, verso il quale si dirigono i corsi dei due torrenti, determina una gravosa ipoteca sul sistema difensivo crotoniate dell’entroterra, poiché non solo riporta ad una quota inferiore il percorso delle mura rispetto ai tratti collinari, ma costringe ad integrare la necessità difensiva con il problema del deflusso dei corsi d’acqua verso valle. La complessità del rapporto fra difesa e drenaggio caratterizza altre città della Magna Grecia, come per esempio Locri e Velia10, che associano all’impianto urbano, definito nelle pianure costiere, un sistema difensivo sulle alture retrostanti attraversate da corsi d’acqua, ma a Crotone sembra di rilevare la più sfavorevole conformazione geografica preliminare alla solu-
Quest’ultima altura è costituita da due rilievi successivi sui quali il Byvank riproduceva il percorso delle mura, ma non è stato possibile verificare la presenza di strutture difensive poiché, come riferiva il Sabbione nel 1975, «la collina più ampia, in località Batteria, è stata completa-
6 FOTI 1975, p. 303; SABBIONE 1976, p. 585; SABBIONE 1977, pp. 898899; LATTANZI 1984a, pp. 100, 114; SPADEA 1984, pp.159, 161; TRÉZINY 1984a, pp. 594-597; GIANGIULIO-SABBIONE 1987, pp. 491, 496, 499; SPADEA 1994, pp. 333, 334. 7 TRÉZINY 1984a, p. 594. 8 supra p. 29. La questione risulta particolarmente complessa in conseuena alla mancanza di dati e di rinvenimenti consistenti di strutture dienive; su località Carrara FOTI 1975, p. 304; ARDOVINO 1979, p. 376; LATTANZI 1984a, p. 101; SPADEA 1984, p. 159; SPADEA 1994, p. 333. 9 ARDOVINO 1979, p. 376; SPADEA 1984, p. 159; SPADEA 1994, p. 333. 10 infra pp. 65-73.
11
ORSI 1912b, p. 64; LATTANZI 1984a, p. 98; SPADEA 1984, p. 160; GIANGIULIO-SABBIONE 1987, p. 490; SPADEA 1994, p. 333. 12 infra pp. 61-62. 13 BYVANK 1914, p. 150 nota n. 1; SPADEA 1984, p. 160; GIANGIULIOSABBIONE 1987, p. 490. 14 SPADEA 1994, p. 333 15 FOTI 1975, pp. 303-304; SABBIONE 1976, pp. 586-587; SABBIONE 1977, pp. 899, 911; ARDOVINO 1979, p. 377; LATTANZI 1984a, p. 102; SPADEA 1984, p. 160; GIANGIULIO-SABBIONE 1987, pp. 493, 499; BORELLO 1993; SPADEA 1994, p. 333.
46
mente trasformata da imponenti sbancamenti pochi anni or sono, con la totale sparizione di ogni eventuale rudere»16.
cratici. Le mura dell’acropoli facevano già forse parte del sistema difensivo di età classica, ma non è possibile attualmente sapere se esse furono oggetto di ristrutturazione.
§ Il fronte settentrionale La questione si complica ulteriormente passando al problema centrale che è quello dell’identificazione dell’acropoli con una delle alture fortificate precedentemente descritte. Qui le opinioni degli studiosi si dividono in base all’interpretazione del testo di Livio, fra la proposta del Sabbione19, che identifica l’acropoli con la collina di Santa Lucia, caratterizzata da un situ vergente in agrum, e quella dello Spadea, che situa l’arx liviana presso la collina del castello spagnolo, escludendo altri due possibili siti, quali Santa Lucia e Batteria, che mostrano le aversas rupes, ma nessuna delle due è imminens mari, come il rilievo del castello20. Consegue dalle due diverse identicicazioni che, se l’acropoli corrispondeva alla collina di Santa Lucia, le sue difese devono essere ricondotte al IV sec. a.C. e possono aver avuto una fase precedente, secondo quanto ha concluso il Tréziny nel 198321, mentre nell’altro caso la datazione non è verificabile a causa dell’insistenza del castello sul sito presunto.
Le indagini della Soprintendenza archeologica del 1976 e le prospezioni della fondazione Lerici, nello stesso anno e nel 1981, hanno permesso di individuare il limite settentrionale dell’abitato dell’antica Crotone in contrada Pertusola, un’area che avrebbe dovuto essere destinata all’impianto di uno stabilimento della Montedison proprio a valle della collina di Batteria. Tale confine sembra attestarsi lungo il corso del fosso San Silvestro, un moderno canale di drenaggio con direzione monte-mare scavato all’interno del riempimento sedimentario di un’antica depressione, che doveva garantire una qualche difesa per il fronte settentrionale della città e oltre la quale sono state rinvenute le tombe della necropoli di contrada Vela. In questo settore non è nota alcuna evidenza archeologica delle mura, ma si può presumere che esse, dopo aver raggiunto il limite settentrionale della collina di Batteria scendessero volgendosi verso la pianura con andamento est-ovest e fiancheggiassero la depressione, la cui natura non è dato sapere se fosse artificiale o naturale, ma sicuramente funzionante come un ampio fossato per la difesa dell’unico fronte del tutto scoperto sulla pianura costiera17.
§ Le fasi più antiche Il problema della cronologia delle mura di Crotone è stato affrontato dallo Spadea che, sostenuto dal Tréziny22, ha proposto la presenza di due fasi precedenti a quella ricondotta al IV sec. a.C., ovvero una di età arcaica e una seconda di età classica. Lo studioso ritiene che già a partire dalla fine del VII sec. a.C. i Crotoniati avessero compreso il valore strategico delle alture che circondano l’area urbana a ovest e a sud, ma egli nega la possibilità che nel VI sec. a.C. esistesse già un circuito murario completo come sembra verosimile proporre per l’età ellenistica, essendo troppo esteso e difficile da controllare interamente per le risorse umane di una pòlis arcaica. È più probabile che le difese delle alture con elevato in mattoni crudi costituissero dei nuclei isolati, posti però a governo di punti dell’entroterra deboli per natura, come può essere la valle dell’Esaro fra Vigna Nuova e il Cimone Rapignese, o strategicamente rilevanti come Santa Lucia a sud e Batteria a nord23. Il grande potere raggiunto da Crotone dopo la sconfitta di Sibari nel 510 a.C. trasforma la colonia achea, all’inizio del V sec. a.C., in un centro di grande attività edilizia con molta manodopera servile a disposizione, reclutata fra le file dei vinti, e tecnici lapicidi per l’utilizzo del calcare, sia nei cantieri templari sia in quelli di opere pubbliche, fra le quali lo Spadea conta anche il primo impianto del grande circuito murario, che ingloba-
§ L’acropoli Conclude la descrizione del sistema difensivo ellenistico la questione dell’acropoli che Livio menziona a proposito della secessione intercorsa fra i polìtai crotoniati, quando nel 216 a.C. con la venuta di Annibale il popolo consegnò la città ai Cartaginesi, mentre gli aristocratici fedeli a Roma si ritirarono sull’arx Crotonis: Ma la rocca di Crotone, da un a parte a strapiombo sul mare, dall’altra rivolta verso la pianura, era anticamente munita dalla natura del sito, ma poi fu anche cinta da un muro dalla parte dove atraverso il dirupo opposto era stata conquistata con l’inganno da Dionisio, tiranno di Sicilia18
Dalla descrizione si evince chiaramente che l’acropoli sorgeva su un’altura scoscesa e naturalmente difesa, che fu conquistata per dolum da Dionisio I, essendo già quindi muro cincta, e che la fortificazione, forzata nel 389 a.C., doveva ancora essere in funzione alla fine del III sec. a.C. in modo da offrire un rifugio sicuro agli aristo16
SABBIONE 1976, p. 586; ancora su Batteria: FOTI 1975, pp. 303-304; SABBIONE 1977, p. 899; SPADEA 1984, pp. 160, 161; SPADEA 1994, p. 333. 17 CAVAGNARO VANONI-LININGTON 1977, pp. 679, 682; SABBIONE 1977, pp. 911-917, in particolare p. 914; LININGTON 1982, pp. 253-255; LATTANZI 1984a, pp. 102-103; SPADEA 1984, p. 160; GIANGIULIO-SABBIONE 1987, pp. 493-494, 495; SPADEA 1994, pp. 333-334. 18 Ab urbe condita (1958), XXIV, 2, 2-5. Si riporta il testo latino per una verifica diretta:
19
SABBIONE 1977, p. 899; LATTANZI 1984a, p. 100; SPADEA 1984, p. 161; TRÉZINY 1984a, p. 596. SPADEA 1984, pp. 160-162. 21 TRÉZINY 1984a, p. 596. Tuttavia continua a non essere possibile un’identificazione precisa della cronologia del murus liviano, poiché l’autore dopo aver nominato le caratteristiche naturali della difesa dell’acropoli dice solo che postea et muro cincta est, un’indicazione generica che non permette di collegare questo postea ad un momento preciso. Pertanto, se era l’acropoli di Crotone, Santa Lucia fu oggetto di interventi sicuramente prima del IV sec. a.C. 22 TRÉZINY 1984a, p. 597. 23 SPADEA 1984, pp. 132-134. 20
Sed arx Crotonis una parte imminens mari, altera vergente in agrum situ tantum naturali quondam munita, postea et muro cincta est, qua per aversas rupes ab Dionysio Siciliae tiranno per dolum fuerat capta.
47
va in sé tutte le difese sulle alture, più antiche e ora ristrutturate24.
di individuare eventuali diateichìsmata che, condividendo pienamente l’opinione del Tréziny27, sembra impossibile escludere nell’ambito di una «Geländemauern» tanto ampia e che avrebbero potuto opportunamente ridurre l’area da difendere e collegare le aree urbane centrali alle più importanti difese sommitali.
Questioni interpretative La ricerca archeologica a Crotone in materia di fortificazioni non è stata certamente fortunata come in altre città, le cui mura si conservano in migliori condizioni, tuttavia, almeno per l’età ellenistica, come si è visto gran parte del tracciato è stato ricostruito, sebbene rimanga del tutto ipotetica, secondo quanto afferma lo Spadea stesso, la ricostruzione dell’elevato in mattoni crudi su fondazioni in blocchi lapidei e coronamento sommitale in tegole di cotto25.
§ I capisaldi d’altura Un dato archeologicamente rilevante è l’andamento a cremagliera del tratto di fortificazione ellenistica, individuato a Santa Lucia, che ha indotto a paragonare questo sito ad un centro difensivo avanzato e strategicamente atonomo come il castello Eurialo di Siracusa28. D’altro canto, se effettivamente dal punto di vista concettuale il sito e la fortificazione testimoniano a favore di una tale interpretazione, è opportuno rilevare che il semplice risultato delle indagini, già di per sé, ci conduce nel cuore delle innovazioni degli ingegneri militari alto ellenistici, restituendoci un tratto di percorso a cremagliera, che sfrutta l’andamento tanagliato a coperture reciproche per difendere una dorsale, secondo l’abituale utilizzo di tali schemi nei siti d’altura29.
L’archeologia ha infine permesso di verificare anche a Crotone, in particolare a Santa Lucia e a Vigna Nuova, l’utilizzo della tecnica costruttiva a cassoni, con doppio paramento, émplekton e diatoni, nei tratti riconducibili alle fortificazioni realizzate nella seconda metà del IV sec. a.C., a conferma della diffusione in Magna Grecia di tali sistemi di edificazione, particolarmente adatti all’assorbimento degli urti delle macchine da lancio.
Altre considerazioni importanti si potrebbero fare se fosse noto l’andamento delle mura attraverso la valle dell’Esaro fra Cimone Rapignese e Vigna Nuova, per quanto, osservando le ricostruzioni del tracciato presso il superamento del corso del Papaniciaro, sembra di notare il vertice di un angolo rientrante alla congiunzione del tratto murario, proveniente dal piano, con quello che sale lungo la collina; si veniva così a creare un fiancheggiamento dall’alto verso il punto debole, in cui le acque attraversavano la fortificazione, ed era sfruttato, ancora una volta, un profilo a tenaglia per la protezione di una dorsale. Rappresentano infine due gravi perdite la mancanza di notizie sulle fortificazioni di Batteria, che a nord-ovest del circuito costituiva il perno della difesa, come Santa Lucia nel settore sud-est, e l’assenza completa di dati e di riferimenti cronologici per le strutture del fronte nord, unico aperto sulla pianura costiera e possibile obiettivo di un assalto nemico da terra.
§ La Geländemauern Si rileva in primo luogo che ancora una volta regna sovrana la norma dell’adeguamento alla natura del sito. Essa impone la scelta strategica e unica possibile di difendere la catena di colline a occidente dell’abitato con una «Geländemauern» amplissima. Come già si è rilevato, la geografia del sito è meno favorevole rispetto ad altri casi in cui è risultata necessaria l’estensione della cinta muraria alle alture immediatamente retrostanti il territorio urbanizzato, soprattutto a causa dello sviluppo orizzontale e parallelo alla linea di costa del sistema collinare. Tuttavia la scelta di identificare fin dall’età arcaica i punti chiave della difesa verso l’entroterra sui livelli sommitali di Santa Lucia, Vigna Nuova, Batteria rivela da parte dei Crotoniati una capacità di sfruttamento notevole delle pur difficili condizioni ambientali. La realizzazione della «Geländemauern» all’inizio del V sec. a.C., oltre a collocarsi cronologicamente in un’età precoce per questo genere di realizzazioni26, si presenta come logica conseguenza del sistema difensivo arcaico, collegando i punti nodali, che tali continuano ad essere, con i tratti di mura lungo le dorsali. A maggior ragione la fase ellenistica deve essere valutata alla luce di queste preesistenze, ma la mancanza di notizie, sia scritte sia derivanti dall’indagine archeologica, relative a torri o porte, impedisce alla ricerca attuale di evidenziare le trasformazioni qualitative del sistema difensivo in relazione alle nuove strategie belliche, che Crotone dovette conoscere in seguito alle vicende vissute fra l’assedio di Dionisio I e la conquista romana. Inoltre la continuità di vita attraverso i secoli ha forse compromesso per sempre la possibilità
In particolare, sul fronte nord, la presenza della depressione naturale o artificiale, esterna alla presunta linea di fortificazioni, lascia intravedere un sistema ad ostacoli che associava alle mura un’opera avanzata o un vantaggio della morfologia del sito, ma non emerge nulla di più, a differenza per esempio del caso del fronte orientale delle mura di Taranto, simile, dal punto di vista topografico e strategico, a questo settentrionale di Crotone, ma la cui discontinuità di documentazione archeologica è bene integrata dalle notizie delle fonti storiche30.
27
TRÉZINY 1984a, p. 597; TRÉZINY 2004, pp. 601-602. SPADEA 1984, p. 161 Per l’utilizzo delle tenaglie e dei profili tanagliati in tali frangenti si rimanda alla trattazione svolta nella parte dedicata a Castiglione di Paludi (supra pp. 42-43). 30 supra p. 28. 28 29
24
SPADEA 1984, pp. 134, 142-144. SPADEA 1984, p. 159. 26 supra p. 16. 25
48
CAPITOLO
5
Caulonia
di Caulonia venne meno e iniziò la fase di abbandono del sito, già quasi conclusa nei primi secoli dell’impero1.
Le vicende storiche della Magna Grecia hanno riservato a Caulonia un ruolo secondario nell’ambito della grande politica internazionale, che tuttavia rappresenta il motivo essenziale della sua funzione di piazzaforte operante in un territorio ad alta rilevanza strategica. Cronologicamente Caulonia fu l’ultima delle fondazioni achee localizzate lungo la costa ionica della Calabria. Sorse infatti all’inizio del VII sec. a.C. nella fascia territoriale frapposta alle chòrai di Crotone e Locri. Le due pòleis allora rivali, prima di giungere alla famosa battaglia della Sagra (550 a.C. ca.), fiume che segnava il confine meridionale del territorio di Caulonia, furono a lungo in concorrenza e si fronteggiarono anche sul piano egemonico territoriale fondando numerose subcolonie, quali Hipponion, Medma, Matauros locresi e Skylletion achea. Caulonia a sud di questa ultima rappresenta l’estremo avamposto crotoniate prima dell’area locrese e, pur godendo di un discreto benessere durante tutta l’età arcaica e classica, rivestì comunque un ruolo di subordine rispetto a Crotone, la città achea egemone.
Le fortificazioni cauloniati La storia di Caulonia illustra chiaramente l’importanza strategica del sito urbano che Paolo Orsi identificò nella fascia costiera fra Punta Stilo e Monasterace Marina, precisamente nell’area chiusa da un circuito murario comprendente le località denominate regione Cuturi, regione Castellone, regione Corelli e valle Campana. Dominano queste contrade l’altura del faro di Punta Stilo, presso la quale l’Orsi riteneva che si fossero insediati i primi coloni, un colle a monte di valle Campana denominato sempre dall’Orsi Colle A e poco più ad est l’altura della Piazzetta2. § Datazione La zona collinare costituì come nel caso di molte altre città magnogreche il perno della difesa di terra e fu essa a restituire gran parte delle testimonianze archeologiche riguardanti la fortificazione urbana, che l’Orsi volle datare all’età arcaica3. La recente critica, basandosi su nuovi dati di scavo, smentisce le affermazioni dell’archeologo roveretano e propende a datare alla metà del IV sec. a.C. le strutture già rinvenute nelle campagne 1912-1915. Nel 1935 il Säflund4 per primo confutò la datazione alta delle mura rinvenute dall’Orsi, a causa della presenza di intonaco utilizzato come paramento degli elevati, e propose la fine del III sec. a.C., in piena età ellenistica, datazione condivisa dal Lugli, dallo Schmiedt e dal Chevallier, dal Winter e dal Lawrence5. La Tomasello, in seguito alle indagini archeologiche sul fronte orientale presso il tempio dorico, contestò le obiezioni dei precedenti studiosi proponendo almeno per la zona indagata una datazione fra il 550 a.C. e il 450 a.C.6. Infine gli anni compresi fra il 1982 e il 1988 videro a Caulonia l’intervento combinato della Soprintendenza Archeologica della Calabria e del-
Si riferirà oltre delle poche notizie relative alla fortificazione cauloniate di VI e V sec. a.C., ma si può rilevare fin d’ora che l’esistenza della città era legata ad un motivo eminentemente militare, che determinò l’edificazione di mura anche nei secoli precedenti al periodo di nostro interesse e causò il coinvolgimento drammatico di Caulonia nella guerra fra Siracusa e Crotone, durante il primo ventennio del IV sec. a.C. L’anno 389 a.C. segnò la fine dell’esistenza della colonia achea, che venne conquistata e messa a sacco dall’esercito di Dionisio I, seguendo il destino della stessa Crotone e del santuario di Hera Lacinia. Ma, mentre a Crotone Dionisio lasciò un presidio militare, a Caulonia il tiranno decise di radere al suolo le mura e l’abitato e di deportare a Siracusa i cittadini; infine donò il territorio cauloniate a Locri, l’antica rivale degli Achei e sua fedele alleata. Prima del 346 a.C., probabilmente per iniziativa di Dionisio II, figlio di Dionisio I ed esule a Locri, il sito dell’antica colonia achea fu ricolonizzato dai Locresi per creare questa volta una piazzaforte rivolta verso Crotone, che nel frattempo, dal 378 a.C., aveva acquisito nuovo vigore. Così Caulonia divenne per la seconda volta l’avamposto di una potente pòlis di antica fondazione, alla quale interessava valorizzare le potenzialità militari e strategiche del sito tramite l’edificazione di mura adeguate alle nuove tecniche della poliorcetica. La rinata piazzaforte, dotata di un funzionale impianto urbano ad assi ortogonali, prosperò nell’ambito della fioritura locrese del IV e III sec. a.C., anche se fu occupata dai Campani nel 280 a.C. Dopo la conquista cartaginese del 209 a.C. e durante l’età romana, la funzione militare
1 Per le vicende storiche di Caulonia ORSI 1916, coll. 703-706, 766-778; ARIAS 1959, pp. 443-444; SCHMIEDT 1967, p. 9; TOMASELLO 1972, pp. 633-637; GRECO 1981a, pp. 99-100; GUZZO 1982, pp. 102-103, 108169 passim; GRECO-TORELLI 1983, p. 173; PUGLIESE CARRATELLI 1983 passim; CORDANO 1985, pp. 312-316; IANNELLI 1985, pp. 28-30; IANNELLI–RIZZI 1985, pp. 281-283; GIANGIULIO 1987 passim; LOMBARDO 1987a passim; TRÉZINY 1988, pp. 205, 211; IANNELLI 1989, p. XIII; IANNELLI 1992, pp. 191-192; GRECO 1993, pp. 47, 59. 2 ORSI 1916, coll. 699-703, 709. 3 ORSI 1916, coll. 766-778; TRÉZINY 1989a, p. 7. 4 SÄFLUND 1935, pp. 103-107. 5 LUGLI 1957, p. 290; SCHMIEDT-CHEVALLIER 1959, pp. 363-366; SCHMIEDT-CHEVALLIER 1960, pp. 9-10; WINTER 1971, pp. 95, 148; LAWRENCE 1979, pp. 209, 341, 365, 458. 6 TOMASELLO 1972, pp. 631-632.
49
l’École Française de Rome, i cui ricercatori in seguito a scavi stratigrafici riuscirono a fissare la datazione delle mura rinvenute dall’Orsi agli anni fra il 350 e il 346 a.C. e individuarono anche le fasi precedenti il sistema ellenistico7. In questa sede è dunque di primario interesse illustrare l’assetto difensivo assunto dalle fortificazioni di Caulonia dopo la distruzione del 389 a.C., al momento in cui i Locresi trasformarono l’antica colonia achea nel loro principale avamposto settentrionale8.
sperone ortogonale al muro rivolto verso il fronte di attacco, che non svolgeva la funzione di sostegno per il ballatoio del piano alla quota del cammino di ronda, ma serviva come rinforzo per il muro esterno dai colpi delle macchine da guerra14. La tessitura muraria della torre è realizzata secondo la tecnica tipica delle mura di Caulonia, più volte segnalata dall’Orsi e da lui definita arcaica15. Due paramenti paralleli contengono un nucleo di filari successivi composti da ciottoli di fiume, frammenti lapidei e laterizi, compattati da malta di terra, il cosiddetto «tajo», e divisi da orizzonti di tegole spezzate che ad intervalli formano i piani di posa. In facciavista i paramenti realizzati con la stessa tecnica del nucleo presentano ciottoli spaccati, per ottenere una superficie piana e le tegole sono sostituite da lastre di scisto, che svolgono la stessa funzione di regolarizzazione e permettono l’adesione di uno strato di intonaco bianco, steso su tutta la parete, con funzione impermeabilizzante. Le strutture sporgenti di alto valore difensivo come la torre D, o per esempio quelle delle porte scavate dall’Orsi, presentavano dei robusti rinforzi d’angolo realizzati in blocchi di calcare o arenaria di grandi dimensioni e con bugne in facciavista. Infine è rilevante, presso il raccordo est fra la torre e la cortina, la presenza attraverso la muratura di quest’ultima di un varco per lo scarico delle acque, verosimilmente chiuso in antico da grate di ferro.
§ Il fronte settentrionale L’area urbanizzata era anticamente limitata a nord da una scarpata formata dall’erosione compiuta dalla fiumara Assi lungo la sua sponda destra9. Notando questa particolare conformazione, l’Orsi intuì la localizzazione del fronte settentrionale delle mura urbane lungo il ciglione della scarpata e ritenne che essa fosse foderata da un muro a terrazza, di cui rinvenne alcuni resti in corrispondenza di prominenze del ciglione10. Il fronte nord però fu quello meno indagato nelle campagne del 1912-1915, ma fra il 1982 e il 1985 è stato oggetto degli interventi della missione dell’École Française, che hanno permesso di ricostruire con maggior precisione l’aspetto delle fortificazioni e la loro vicenda storica. È risultato innanzitutto che i resti di terrazzamento, notati dall’Orsi lungo il ciglione della scarpata, erano in realtà i crolli di alcune torri sporgenti rispetto la linea delle mura, elevate a distanze regolari di circa 70-75 metri, per creare un sistema di opere a copertura reciproca. Sono stati individuati cinque punti in cui verosimilmente sorgevano in antico altrettante torri, denominate B, C, D, E, F, e di queste una, la D, è stata scavata completamente con i relativi tratti di cortina limitrofi11. La torre D12 è un imponente monumento largo 10,20 metri e sporgente per 11 metri verso l’esterno, paragonabile alle torri III e VII scavate dall’Orsi. Presenta un ingresso alla gola che immette in una camera con funzione di magazzino, in quota con il piano di vita antico13; all’interno della camera sporge uno
Lo scavo della torre D ha permesso di datare la struttura e l’intero fronte nord alla metà del IV sec. a.C., ma l’analisi della tecnica costruttiva, calcolando la quantità di tegole reimpiegate nella tessitura muraria di un tratto campione della cortina di questo settore, ha portato alla conclusione che il materiale utilizzato poteva soltanto provenire dalle demolizioni della Neapolis Settentrionale, successiva alla conquista siracusana del 389 a.C., fornendo così una prova ulteriore della corretta riconduzione delle mura di Caulonia all’età ellenistica16. Presso l’angolo nord-est del fronte settentrionale le indagini dell’Ecole Française hanno tentato di individuare il sito di una porta, che presumibilmente doveva esistere in relazione al percorso della plateìa principale dell’impianto urbano della rifondazione locrese, con andamento da nord a sud parallelo al mare17. Sebbene abbia riportato alla luce parte della plateìa e le abitazioni ad essa allineate, lo scavo non ha restituito avanzi della fortificazione a causa dell’azione distruttiva della fiumara Assi, ma è co-
7
TRÉZINY 1984b, pp. 181-182; TRÉZINY 1984c, p. 551; IANNELLI-TRÉZINY 1985, p. 572; TRÉZINY 1988, p. 210; TRÉZINY 1989a, p. 7; TRÉZINY 1989b, p. 13; TRÉZINY 1989d, p. 157. 8 Trattazioni generali sulle mura di Caulonia si trovano in ORSI 1916, coll. 766-778; ARIAS 1959, p. 54; ZANOTTI BIANCO 1955, pp. 263-264; ZANOTTI BIANCO 1957, pp. 9-10; SCHMIEDT-CHEVALIER 1959, pp. 353-366; SCHMIEDT-CHEVALIER 1960, pp. 5-10; SCHMIEDT 1967, p. 9; SCHMIEDT 1970a, p. 62, tav. LXIX; WINTER 1971, pp. 95, 148; LAWRENCE 1979, pp. 209, 341, 365, 458; TRÉZINY 1988, pp. 209-210; IANNELLI 1989, pp. XIII-XIV; TRÉZINY 1989c; GRECO 1981a, p. 106; GUZZO 1982, pp. 282-283; GRECO-TORELLI 1983, p. 173; GRECO 1985, p. 346; IANNELLI 1992, pp. 195-200. 9 Sul fronte settentrionale ORSI 1916, coll. 708-712; SCHMIEDT-CHEVALLIER 1959, pp. 353-358; SCHMIEDT-CHEVALLIER 1960, pp. 5-6; TRÉZINY 1984b, p. 179; TRÉZINY 1984c, pp. 550-551; TRÉZINY 1989a, p. 9; TRÉZINY 1989c, pp. 143-144; IANNELLI 1992, pp. 198-200 10 ORSI 1916, coll. 708-711.
14
L’Orsi (1916, coll. 721-723), studiando la struttura della torre III, aveva proposto l’interpretazione di uno sperone identico a questo, appunto come sostegno del ballatoio, ma il TRÉZINY (1989b, p. 21) poté individuare nella tessitura muraria della torre D le sedi di alloggiamento dei travi che sostenevano il ballatoio e facevano da tiranti per i muri stessi, accorgimento raccomandato anche da Filone di Bisanzio (Sintassi Meccanica [1974], V, A, 13). L’archeologo francese ha dunque proposto come interpretazione dello sperone quella di rinforzo strutturale che effettivamente può rappresentare una soluzione alternativa al problema della protezione delle torri quadrangolari che Filone diceva di risolvere posizionandole con uno spigolo rivolto verso il fronte di attacco (supra pp. 12 nota n. 78, 14). 15 ORSI 1916, coll. 708, 710, 711, 716, 718, 724, 728, 733, 735, 736738, 741, 750, 753, 754, 755, 758, 759, 760, 774-778. 16 TRÉZINY 1988, p. 210; TRÉZINY 1989b, pp. 19-20. 17 IANNELLI 1985; IANNELLI-RIZZI 1985; IANNELLI-TRÉZINY 1985; LATTANZI 1985a; TRÉZINY 1988, p. 208; TRÉZINY 1989d, p. 155.
11 La torre E è soltanto ipotizzata poiché la distanza fra D ed F risulta di 150 metri, tale dunque da poter consentire l’inserimento di una torre alla distanza di circa 70 metri rispetto alle altre due (TRÉZINY 1989c, p. 144). 12 TRÉZINY 1984b, pp. 180-182; TRÉZINY 1984c, p. 550; IANNELLITRÉZINY 1985, p. 572; TRÉZINY 1989b, pp. 19-23; TRÉZINY 1989c, pp. 132-137, 143, 150-152. 13 Sulle funzioni delle camere inferiori delle torri WINTER 1971, pp. 162, 180; LAWRENCE 1979, pp. 391-393.
50
munque necessario ipotizzare l’esistenza di una porta fortificata, probabilmente con torri come la D o quelle della Porta di Aulon, poiché l’asse viario principale di Caulonia doveva attraversare sicuramente il sistema difensivo per potersi congiungere alla strada che si dirige verso Crotone18.
porta fortificata difesa da due torri, le numero I e II, rispettivamente a pianta trapezoidale, con la base maggiore rivolta verso l’esterno (8,40×5,80 metri), e quadrangolare (7,40×7,45 metri). La prima era in muratura piena e collegata alla cortina proveniente da settentrione presso l’angolo nord-est, la seconda aveva una camera inferiore a livello del suolo, con accesso alla gola e si collegava alle mura che procedevano oltre presso l’angolo sud-est. L’interturrio era costituito da due muri convergenti ad angolo rientrante retto e attraverso quello proveniente dalla torre I, si apriva un varco originariamente ampio circa 2,60 metri, ridotto poi a postierla. Dall’angolo sud-ovest della torre I, infine, si protendeva un muro di sbarramento, un proteìchisma, che chiudeva per circa due terzi lo spazio più interno del rientrante della porta23. La tecnica costruttiva utilizzata in tutto il settore è la stessa descritta per il fronte nord, ma nello spigolo interno del rientrante l’Orsi individuò il primo di una serie di manufatti, da lui denominati «banchette», coerenti alla muratura della fortificazione e caratterizzati da un piano in tegole, che fu interpretato come sedile del posto di guardia24. Dal momento che queste «banchette» si trovano generalmente in corrispondenza di torri e ispessimenti della muratura delle cortine, il Tréziny ha proposto, con verosimiglianza, che costituiscano la pedata del primo gradino delle rampe scalari d’accesso ai cammini di ronda e che quindi furono opportunamente collocate presso punti nevralgici del sistema difensivo25.
Completa il quadro del sistema del fronte settentrionale la ricostruzione della difesa dell’angolo nord-ovest. Questo è il solo punto in cui l’Orsi approfondì l’indagine del settore e venne alla luce una sorta di «bastione», costituito da un tratto curvilineo raccordato al fronte nord-ovest da un fianco rientrante, che permetteva di prendere d’infilata il terreno antistante alla cortina successiva. Prima e dopo il fianco vennero alla luce due postierle e fu anche ripulito quello che l’Orsi definì il muro di terrazzamento del bastione, lungo il limite della scarpata sull’Assi19. Il Tréziny, alla luce dei risultati ottenuti con lo scavo della torre D e con le ricognizioni per individuare le altre torri del fronte nord, ha proposto di integrare questa struttura rinvenuta dall’Orsi con una torre, denominata A, che si agganciava al tratto iniziale del fronte nord-ovest, prima del fianco rientrante, prolungandone l’andamento con il proprio lato meridionale. La ricostruzione si fonda sulla corretta lettura del terrazzamento antistante l’opera come crollo della torre stessa, per analogia alle situazioni delle torri B, C, F, e sulla presenza di due postierle, una delle quali, la più settentrionale, è in realtà l’ingresso alla torre come nel caso della D e di tutte le altre rinvenute dall’Orsi20. Pertanto la presenza di una postierla subito dopo una torre risulta perfettamente in sintonia con la tradizionale sistemazione di questi varchi nelle fortificazioni di età ellenistica21.
Il tratto di mura che collega la porta di nord-ovest con il Colle A presentava un tratto di pianura molto spesso (in media 5,50 metri), i cui paramenti erano costituiti da due veri e proprii muri già di per sé realizzati con la solita tecnica costruttiva, per il fatto che, secondo l’Orsi, questo era il settore più esposto ad un possibile assalto nemico con macchine da lancio e arieti. Il tratto successivo posizionato sulla dorsale nord del Colle A, lungo le convessità delle curve di livello, riduceva sensibilmente lo spessore della muratura (circa 2,30 metri), in relazione alla natura del terreno su cui si appoggiavano le fondazioni e in ragione di un pericolo minore di assalti frontali26.
§ Il fronte nord-occidentale Il sistema difensivo di Caulonia in età tardo classica ed ellenistica disegnava sul terreno un quadrilatero irregolare, i cui lati est e nord erano quasi perpendicolari fra loro, mentre il settore occidentale, indagato dall’Orsi, era costituito da due segmenti con andamento nord/est-sud/ovest e nord/ovest-sud/est, convergenti presso il Colle A, un acrocoro dominante la sella che mette in collegamento il vallone Bernardo, limite sud-occidentale della città, con una valle anonima discendente verso il vecchio cimitero di Monasterace, a nord-ovest della regione Cuturi.
L’Orsi individuò circa a metà di questo tratto di dorsale una postierla, che, non essendo associata ad alcuna strut23
ORSI 1916, coll. 712-717; SCHMIEDT-CHEVALLIER 1959, p. 358; SCHMIEDT-CHEVALLIER 1960, p. 6; TRÉZINY 1989c, pp. 137, 141, 145149. 24 ORSI 1916, col. 716. 25 TRÉZINY 1989c, p. 141. D’altro canto l’indagine nella torre D ha permesso di chiarire che il ballatoio delle torri alla quota dei cammini di ronda, sorretto dai travi che erano alloggiati nelle sedi rinvenute dagli archeologi francesi all’interno delle murature dei fianchi della torre, copriva totalmente la camera inferiore e non solo una mezza porzione come poteva far intendere l’interpretazione dello sperone interno quale sostegno del ballatoio. Dunque, anche se poteva esserci un collegamento fra il magazzino inferiore e la camera di tiro superiore, l’accesso principale a quest’ultima avveniva dal cammino di ronda e quindi necessariamente le rampe scalari per il suo raggiungimento dovevano trovarsi presso le torri, così come sembra dimostrare il costante ispessimento della muratura delle cortine limitrofe, anche dove non si è conservata traccia del primo gradino della rampa, come per esempio nella cortina ad ovest della torre D o sul lato interno del fianco rientrante del bastione A (TRÉZINY 1989c, p. 143). 26 ORSI 1916, coll. 717-720
Il primo tratto delle difese occidentali, venendo da nord, collega il settore del bastione A al Colle A, attraversando la pianura sul limite nord-ovest di regione Cuturi e salendo poi la dorsale fino alla sommità del Colle A22. A poca distanza dal bastione A, presso una casa isolata nella campagna, denominata Quaranta, l’Orsi mise in luce una 18
IANNELLI-TRÉZINY 1986; COLLIN BOUFFIER-IANNELLI-TRÉZINY 1987; LATTANZI 1989, p. 559; COLLIN BOUFFIER-IANNELLI-TRÉZINY 1989, p. 538; TRÉZINY 1989c, p. 149; TRÉZINY 1989d, p. 156. 19 ORSI 1916, coll. 711-712; SCHMIEDT-CHEVALLIER 1959, p. 358; SCHMIEDT-CHEVALLIER 1960, p. 6. 20 TRÉZINY 1989c, p. 143. 21 supra p. 18. 22 Sul tratto di nord-ovest ORSI 1916, coll. 712-724; SCHMIEDT-CHEVALLIER 1959, pp. 358-360; SCHMIEDT-CHEVALLIER 1960, pp. 6-7
51
tura sporgente, potrebbe corrispondere piuttosto all’ingresso di una torre andata perduta27. D’altro canto senza una torre in questo punto il settore nord-occidentale del sistema sarebbe stato sguarnito per un lungo tratto, fra la porta di nord-ovest e il Colle A, perciò, posto che siano i Locresi ad aver realizzato il sistema difensivo tardo classico, nulla vieta di pensare che lungo questa dorsale sia stata realizzata un’unica torre di avvistamento, con funzione di centro organizzativo per le mura limitrofe, come la torre Marzano del fronte settentrionale di Locri28.
tando così lo assetto difensivo del fronte nord-occidentale31. § Il fronte sud-occidentale Scendendo dal Colle A verso la valle Campana iniziava la sezione sud-ovest del sistema difensivo tardo classico-ellenistico, che si attestava lungo la dorsale sinistra del vallone Bernardo, fino al sito della torre X, da cui partiva un segmento in pianura, che, inclinando sensibilmente verso est, limitava a sud la Neapolis meridionale fino al congiungimento con il fronte di mare32.
Le difese del Colle A, una stretta area pianeggiante lunga 54 metri e larga da 24 a 73 metri s.l.m., sono costituite da due torri di medie dimensioni, denominate dall’Orsi IV a nord (8,15×6,80 metri) e V a sud (8,30×6,80 metri), con camera inferiore ed ingresso alla gola, e da una cortina mediana rettilinea, le cui testate presso le torri si ispessiscono per alloggiare due rampe scalari simmetriche, utilizzando sempre la ormai nota tecnica costruttiva cauloniate. Il terrazzo governa i valloni Bernardo e del cimitero e domina a vista tutta l’area dell’abitato dal fronte nord fino a quello sud e dal fronte di mare fino alla Neapolis occidentale29.
Il primo tratto di questo lungo fronte congiungeva le difese del Colle A alla sella aperta fra il vallone Bernardo e la valle Campana, un punto strategicamente delicato nel quale si apriva una grande porta fortificata, che l’Orsi denominò di Aulon. A monte della porta si rinvenne una torre, la numero VI, quadrata, con ingresso alla gola distante circa 144 metri dalla V. Poco prima di essa le mura creavano una sorta di avancorpo interno, che ne ispessiva la larghezza, ed era forse la sede di due rampe scalari simmetriche, per l’accesso al cammino di ronda, in un punto orograficamente più favorevole all’impianto.
§ La Neapolis occidentale
La porta di Aulon33 era costituita da due torri parallele e da un varco che l’Orsi non poté definire precisamente, trovando soltanto un’interruzione di 7 metri nella muratura dell’interturrio, che fu spiegata con l’attività di spoliazione dei grandi blocchi lapidei degli stipiti, attuata dai contadini del luogo. La torre a monte della porta, denominata VII, aveva grandi dimensioni (9,60×11,00 metri) con murature poderose, cantonali in blocchi bugnati di arenaria conchiglifera e ingresso alla gola. Il manufatto può essere infatti ricondotto al tipo delle torri D e III e svolgeva la funzione di principale opera difensiva del complesso, dominando il terreno antistante il varco e a 180° la dorsale del vallone Bernardo prossima alla sella. La torre VIII era di dimensioni minori (9,20×8,20 metri), priva di accesso e di rinforzi lapidei sugli spigoli; svolgeva una funzione d’appoggio alla VII e fiancheggiava il varco della porta, trovandosi su un rilievo del terreno in ascesa verso il colle della Piazzetta, a sud del terrazzo d’ingresso esterno. Infine l’accesso alle torri e al cammino di ronda del complesso della porta era situato presso l’allacciamento della cortina nord con la torre VII, dove la muratura si ispessiva per accogliere la rampa scalare.
La zona della città a nord-ovest della regione Cuturi fu denominata dall’Orsi Neapolis occidentale, poiché egli rinvenne un braccio di mura, spesso 3,75 metri e realizzato con la solita tecnica, che dal limite settentrionale del Colle A scendeva lungo il ripidissimo fianco destro del vallone del cimitero per scomparire a metà circa del pendio e riemergere in pianura, presso il cimitero stesso nel punto in cui la fortificazione era dotata di una grande e robusta torre, la numero III, assai simile alla D del fronte nord, sia per le dimensioni (10,05×10,20 metri) sia per la presenza dello sperone di rinforzo interno. In questo settore è stata inoltre ipotizzata la presenza di una porta poiché la torre III è circa situata in allineamento alle strutture della porta di nord-ovest, presso Casa Quaranta, e, date le sue dimensioni, poteva appartenere ad un complesso fortificato d’accesso alla Neapolis occidentale30. Le mura proseguivano oltre la torre verso nord in direzione della fiumara Assi, ma l’Orsi ne rinvenne soltanto un tratto lungo 12 metri oltre il quale cessava ogni traccia. Verosimilmente la fortificazione, raggiunto il limite del ciglione sulla fiumara, volgeva ad est, per collegarsi alle mura di contrada Quaranta fra il bastione A e la porta di nord-ovest, creando un circuito ampliato, rispetto a quello che chiude a occidente la Neapolis settentrionale, e comple-
31
Tale ipotesi di tracciato sostenuta dall’Orsi (1916, col. 723) è ancor oggi la più credibile, ma comunque non verificabile a causa dell’azione erosiva dell’Assi lungo il ciglione che ha condannato alla distruzione i resti del tratto settentrionale di questo settore. È inoltre verosimile l’idea sempre dell’Orsi che, in un momento storico imprecisato, un’alluvione, discesa dal vallone del cimitero, abbia dilavato il ciglione nord dandole la conformazione ad arco presentata sui rilievi del Carta e che abbia così spazzato i resti del tratto est-ovest, ma anche quelli della parte inferiore della dorsale del vallone e quelli presso la torre III, oggetto per altro di frequenti spoliazioni da parte della popolazione locale. Sulla fortificazione della Neapolis occidentale ORSI 1916, coll. 723-724; SCHMIEDTCHEVALLIER 1959, pp. 360-361; SCHMIEDT-CHEVALLIER 1960, p. 7; TRÉZINY 1989d, pp. 156-157; TRÉZINY 2004, pp. 597-598. 32 Sul fronte sud-occidentale ORSI 1916, coll. 726-751; SCHMIEDT-CHEVALLIER 1959, pp. 362-363; SCHMIEDT-CHEVALLIER 1960, p. 8. 33 ORSI 1916, coll. 726-730; SCHMIEDT-CHEVALLIER 1959, p. 362; SCHMIEDT-CHEVALLIER 1960, p. 8; TRÉZINY 1989c, p. 149.
27
TRÉZINY 1989c, p. 150. Previo comunque il problema della datazione di torre Marzano alla fase tardoarcaica o a quella della fine del IV sec. a.C., per cui tale manufatto potrebbe essere o un modello di riferimento per Caulonia o il prodotto di esperienze maturate a Caulonia e messe a frutto a Locri (infra p. 62). 29 Si può ricordare che l’Orsi rinvenne all’interno della camera inferiore tracce della pavimentazione in mattoni quadrati legati con malta di fango e una feritoia in pietra lavica con apertura strombata, caduta evidentemente dalla sua sede nella muratura della torre. Sul Colle A ORSI 1916, coll. 724-726; SCHMIEDT-CHEVALLIER 1959, pp. 361-362; SCHMIEDT-CHEVALLIER 1960, p. 7; TRÉZINY 1989c, pp. 141, 144. 30 TRÉZINY 1989c, p. 149. 28
52
Dopo aver superato la porta di Aulon, le mura del fronte sud-ovest risalivano fino alla quota di 70 metri s.l.m., per raggiungere la vetta piana di un altro colle, denominato Piazzetta e anticamente Castellone, lungo 110 metri e largo al massimo 3534. Le mura perimetrali, realizzate anche qui, come nei tratti precedenti, secondo la solita tecnica cauloniate e spesse in media 2,85 metri, non presentavano torri per un lungo tratto, fino quasi al punto medio del segmento che fiancheggiava a sud la Piazzetta, dove sorgeva la torre IX, quadrata come le altre finora descritte. Poco prima del punto in cui le mura affrontavano la discesa dalla Piazzetta verso la regione Corelli formando un angolo rientrante ottuso, l’Orsi rinvenne due postierle, distanti l’una dall’altra 12 metri e separate da un un tratto di cortina più spesso (circa 4,00 metri) rispetto alla norma del settore. Anche in questo caso l’anomalia delle due postierle ravvicinate è spiegata dal Tréziny con la presenza di una torre andata perduta, la cosiddetta IX bis, il cui accesso alla camera inferiore corrispondeva alla postierla prossima all’angolo rientrante, mentre quella più a monte era un varco vero e proprio attraverso le mura, protetto dal corpo dell’opera sporgente. Infine lo spessore maggiore del tratto di cortina si spiega con la solita presenza di rampe scalari per il cammino di ronda e la camera superiore della torre35. Il sistema difensivo della Piazzetta era completato da una cinta muraria, che terrazzava l’andamento naturale dei margini nord ed est dell’altopiano e che si raccordava alle mura perimetrali urbane appoggiandosi ad esse, dunque in un momento successivo. È interessante notare che l’estremità orientale della cinta interna difendeva uno sperone roccioso dominante la Neapolis meridionale tramite un avancorpo rastremato con fronte saliente e fianco sud a profilo tanagliato.
Completa il quadro del sistema difensivo ellenistico sudoccidentale un lungo tratto di muro rinvenuto dall’Orsi, spesso 3,50 metri, realizzato con la solita tecnica muraria e con fondazioni a gradoni per meglio agganciarsi al terreno in pendio. Esso infatti correva perpendicolare alla linea di costa attraverso la piana fra le regioni Corelli e Castellone e, giunto alle falde di uno sperone roccioso a 65 metri s.l.m., antistante quello orientale della Piazzetta, ne scalava il dirupo per proseguire in direzione del secondo, al quale anticamente si collegava. Fin dai tempi del rinvenimento l’Orsi ne verificò l’estensione a valle, trovandolo interrotto da un gruppo di abitazioni d’età ellenistica in proprietà Guarnaccia. L’archeologo vide nella struttura la più antica fortificazione di Caulonia, che chiudeva a sud il nucleo originario della città, ampliatasi poi sempre in età arcaica nella Neapolis meridionale, a sua volta chiusa dal tratto di mura descritto fra la torre X e la XI39. Attualmente anche questo braccio di mura viene ricondotto dal Tréziny all’età ellenistica, escludendo una possibile datazione nel V sec. a.C., a causa dell’abbondante presenza di tegole come nella tessitura delle opere del fronte nord; lo studioso ritiene piuttosto che il muro potesse riprendere il percorso di una struttura più antica e limitare in origine verso sud la rinfondazione locrese, che in seguito si espanse fino al corso del torrente Bernardo40. § Il fronte orientale Il sistema difensivo di Caulonia era completato ad est da un fronte di mura rivolte verso il mare, le cui testimonianze sono discontinue e frammentarie, ma soprattutto ricondotte alla fase precedente la distruzione del 389 a.C. Pertanto la fortificazione di età tardo classica ed ellenistica rimane sconosciuta o non è possibile affermare, ma soltanto supporre che essa corrispondesse ad un reimpiego di quella di età classica, distrutta dai Siracusani e riedificata dai Locresi prima del 346 a.C. Si può dire con sicurezza che il fronte di mare esisteva ed aveva una sua continuità lungo il cordone dunario, che separa il tratto estremo della pianura costiera dalla spiaggia, come già sosteneva e l’Orsi41 e come hanno confermato le prospezioni della Fondazione Lerici del 1988, verificando la presenza delle strutture difensive dall’angolo nord-est del circuito fino all’area sacra del tempio dorico e oltre42.
Dopo la torre IX bis le mura di cinta scendevano lungo la dorsale conica che separa il vallone Bernardo dalla regione Corelli, con uno spessore medio di 3,15 metri, fino alla torre X, della quale l’Orsi rinvenne soltanto una traccia informe36. Il tratto conclusivo del fronte sud-occidentale correva sulla sinistra del torrente Bernardo, aveva spessore maggiore rispetto al tratto precedente (3,48/3,55 metri) e collegava la torre X alla XI di piccole dimensioni (3,30×3,00 metri) e con paramento esterno in blocchi di tufo, per volgere poi decisamente verso est in direzione del mare37. L’Orsi intravide ancora prima dell’argine della ferrovia i resti di una struttura sporgente che egli definì torre XII, ma che non poté indagare. Nel 1988 fu attuato un intervento in questo settore, nell’area compresa fra la ferrovia e la statale ionica 106, che mise in luce le tracce di una porta, una delle più importanti di Caulonia, in quanto corrispondeva al varco attraverso le mura meridionali, per il quale la grande plateìa nord-sud dell’impianto ellenistico si collegava alla strada di Locri38.
La situazione archeologica del fronte di mare permette di introdurre il tema delle fasi costruttive delle mura precedenti l’età ellenistica e corrispondenti alle difese della colonia achea. Sul fronte est l’Orsi intervenne presso il tempio dorico, portando alla luce, da notevoli profondità, resti di fortificazione lungo il cordone dunario, realizzati con la solita tecnica a paramenti in ciottoli e malta di fango, fra cui un tratto con avanzi di demolizioni al di sopra della cresta di rasatura, interpretate come tracce di spoliazioni moderne, che avevano interessato anche il tempio dorico. Fu rinvenuto inoltre un tratto con una successione
34
ORSI 1916, 731-735; SCHMIEDT-CHEVALLIER 1959, pp. 361-362; SCHMIEDT-CHEVALLIER 1960, p. 7; LATTANZI 1984b. 35 ORSI 1916, coll. 741-742; TRÉZINY 1989c, pp. 143, 144 36 ORSI 1916, col. 732. 37 ORSI 1916, coll. 748-750. 38 ORSI 1916, col. 751; IANNELLI 1989, p. XIV; TRÉZINY 1989d, p. 156.
39 ORSI 1916, coll. 736-740; SCHMIEDT-CHEVALLIER 1959, p. 363; SCHMIEDT-CHEVALLIER 1960, p. 9. 40 TRÉZINY 1989d, p. 157; TRÉZINY 2004, pp. 596-597. 41 Sul fronte di mare ORSI 1916, col. 753; SCHMIEDT-CHEVALLIER 1959, p. 363; SCHMIEDT-CHEVALLIER 1960, p. 8. 42 IANNELLI 1989, p. XIV.
53
di speroni interni, immersi nella duna sabbiosa e una struttura che l’Orsi interpretò come un varco d’accesso, con soglia in lastroni e stipiti in blocchi lapidei, e denominò Porta Marina. Come nei casi precedenti le strutture furono datate all’età arcaica43.
la metà del IV sec. a.C., distrutta dopo l’assedio Siracusano, ma essa segnò il percorso delle mura successive. Sembra inoltre che si possa ricostruire nello stesso modo la fortificazione del tratto di nord-ovest presso, Casa Quaranta, dove la fase ellenistica si configurerebbe come una integrazione delle preesistenze classiche nel sito della porta, in particolare nella struttura della torre I, e di quelle arcaiche nel tratto di mura a sud, caratterizzato dal notevole spessore di 5,50 metri50. Infine sempre durante lo scavo della torre D, al di sotto della cortina di V sec. a.C. è apparso ancora un muro in ciottoli separato dalla struttura superiore da uno strato di argilla bruna, ricondotto al VI sec.a.C. e interpretato come resto della cinta arcaica in mattoni crudi su zoccolo di fondazione in muratura di pietrame, ristrutturata nella prima metà del V sec.a.C., quando ebbe inizio la fase di vita della cinta classica51.
A sud del tempio dorico furono condotti alcuni interventi nel 1960, rimasti inediti44, e poi fra il 1970 e il 1971 altri scavi portarono alla luce un tratto di mura, che proseguiva quello indagato dall’Orsi ed era caratterizzato dalla presenza di una porta, datata alla metà del VI sec. a.C., priva di torri, con varco d’accesso obliquo rispetto alla linea delle mura e fiancheggiata da due setti paralleli, obliqui anch’essi, determinanti un impianto di tipo sceo45. Alla luce dei risultati degli scavi stratigrafici compiuti dall’École Française presso la torre D, il Tréziny ha proposto una rilettura delle scoperte dell’Orsi e della Tomasello, relative al fronte di mare. Innanzitutto indica una datazione al 450 a.C. circa per la porta individuata nel 1970-1971, riconducendola alla fase delle fortificazioni di età classica, così come ritiene si debbano considerare e datare i resti portati alla luce dall’Orsi con le loro tracce di distruzione, che non sembrano derivanti da spoliazioni, ma piuttosto conseguenti alle demolizioni siracusane del 389 a.C.46. Inoltre la Porta Marina dell’Orsi non era probabilmente un varco attraverso le mura, ma in base agli scavi del 1988, sembra che si tratti della testata di una via urbana monte-mare, di cui si conservano gli spigoli degli isolati che la comprendono47. Infine il Tréziny solleva dubbi sull’interpretazione del Winter e del Lawrence48, relativa al muro con gli speroni, come testimonianza di una cortina realizzata secondo una tecnica successiva al 350 a.C., pensando piuttosto che la funzione di terrazzamento, svolta dalla struttura già nel V sec. a.C., possa motivare la presenza dei setti murari paralleli con funzione di contrafforti, che si immorsavano nel terreno sabbioso del cordone dunario49.
Questioni interpretative Il caso di Caulonia rappresenta senza dubbio un esempio di alto valore documentario per l’architettura militare in Magna Grecia, sia in relazione alla definizione del circuito sia alle caratteristiche delle singole strutture e della loro funzionalità operativa. § La Geländemauern Il circuito delle difese urbane, per quanto dotato di opere che obbediscono ai criteri della nuova teichopoiìa, dimostra quanto le preesistenze e i loro percorsi avessero peso nei piani di ristrutturazione durante i secoli IV e III a.C., come ha chiaramente illustrato il Tréziny per il fronte nord e parte di quello nord-occidentale, o come si può presumere per gran parte del percorso collinare. D’altro canto emerge chiaramente lo stesso peso della fortificazione arcaica e classica nei casi di Taranto, Metaponto, Crotone, Locri, Velia52. Sta di fatto che anche a Caulonia si assiste alla realizzazione di una «Geländemauern» che, probabilmente già durante la fase classica di V sec. a.C., obbedisce alla norma fondamentale dell’adeguamento alla natura orografica del sito in cui sorge la città. Senza dubbio questo principio noto agli ingegneri achei della prima metà del V sec. a.C. era parte di un patrimonio ormai acquisito e concretamente sperimentato in madrepatria dai Locresi, che riedificarono le mura di Caulonia attestando il fronte settentrionale sul ciglione della fiumara Assi e collegando i capisaldi della difesa d’altura, il Colle A e la Piazzetta, con i tratti di cortina lungo le dorsali di questi colli. In ogni punto critico o dominante fu situata un’opera adeguata, come la Porta di Aulon nella sella di valle Campana, le torri quadrate sul Colle A, quelle elevate nei punti di variazione del percorso murario e l’intero sistema difensivo intra muros della Piazzet-
§ La fase di età classica La colonia achea dunque era dotata di una cinta difensiva i cui resti più cospicui sembrano emergere lungo il fronte di mare, ma gli scavi presso la torre D hanno permesso di definire la cronologia di queste fortificazioni, databili nel pieno V sec. a.C., grazie all’individuazione di un tratto di cortina con varco di scarico per le acque, realizzato nella stessa tecnica delle mura scoperte dall’Orsi e dalla Tomasello sul fronte est, che ha fatto da appoggio alle fondazioni delle strutture di età ellenistica. Il rinvenimento dimostra che anche il fronte nord aveva una fase precedente
43
ORSI 1916, coll. 751-762. TRÉZINY 1989a, p. 5; IANNELLI 1992, p. 196. 45 TOMASELLO 1972, pp. 565, 583-585, 593, 597, 609, 616, 622-633; TRÉZINY 1989c, p. 131; IANNELLI 1992, p. 196. 46 TRÉZINY 1989c, pp. 131-132, 149 47 TRÉZINY 1989c, pp. 132 e nota n. 13, 149 48 WINTER 1971, p. 95; LAWRENCE 1979, p. 365. 49 TRÉZINY 1989c, p. 145. Le considerazioni dell’autore in merito a queste opere con muratura a speroni risultano attualmente confermate (supra p. 36 nota 23). 44
50 TRÉZINY 1984b, pp. 181-182; TRÉZINY 1989b, pp. 13, 23; IANNELLITRÉZINY 1985, p. 572; LATTANZI 1989, p. 560; TRÉZINY 1989c, pp. 129-132, 145, 148; TRÉZINY 1989d, p. 156. 51 IANNELLI-TRÉZINY 1985, p. 572; TRÉZINY 1989b, pp. 13, 23-25; TRÉZINY 1989c, p. 129. 52 supra pp. 29, 33-34, 47; infra pp. 57-58, 69-70.
54
ta, che riproduce anche profili tanagliati, particolarmente adeguati alle fortificazioni d’altura53.
media fra loro 70 o 75 metri, una lunghezza inadeguata a pezzi leggeri, che potevano essere invece utilizzati sulle torri di medie e piccole dimensioni, ravvicinate e operanti sistematicamente fra di loro o con una torre grande, come sul Colle A, presso la Porta di Aulon o lungo le mura della Piazzetta57.
Ma la «Geländemauern» cauloniate del IV sec. a.C. presenta elementi che la inseriscono pienamente nel nuovo tipo di fortificazione, ovvero gli ampliamenti della cinta delle cosiddette Neapoleis occidentale e meridionale. Davanti al fronte di nord-ovest, corrispondente ad una parte del sistema difensivo di età classica ristrutturato, il circuito della Neapolis occidentale, con la sua poderosa torre III e la probabile porta corrispondente, chiudeva un’area che forse non era destinata ad abitato54, ma solo a terreno inframurario, per sopravanzare una nuova linea difensiva in un settore che già l’Orsi riconosceva come il fronte d’attacco più agevole, per un nemico che volesse intraprendere l’investimento di Caulonia55. In tal modo tutto il fronte di nord-ovest si trasformava in un lungo diateìchisma, dotato di porta, che collegava al Colle A il sistema difensivo della Neapolis settentrionale. Quest’ultima veniva però a trovarsi in una posizione più sicura di retrofronte e garantiva contemporaneamente una seconda linea di difesa.
§ Le porte di Caulonia Il fiancheggiamento e la copertura reciproca sono i principi dominanti anche nella definizione dei sistemi difensivi delle porte individuate dall’Orsi. È necessario premettere che costituisce senza dubbio una grave perdita la mancanza di dati relativi alle porte dei fronti settenarionale e meridionale attraverso le quali usciva dalla città la plateìa principale nord-sud, su cui si attestava tutto l’impianto urbano della rifondazione locrese58. Dovevano essere le due porte più importanti di Caulonia e il loro sistema difensivo era certamente adeguato alla funzione e alla vulnerabilità maggiore dei due fronti, dove esse si aprivano. Solo un’immagine suggestiva, senza ri-scontro reale, può indurre a pensare che gli architetti locresi avessero in mente uno schema simile alla Porta di Afrodite o a quella di Parapezza a Locri59.
Nella porzione meridionale della città si attuò la stessa operazione, al momento in cui venne edificato il tratto estremo sud fra le torri X e XI e il collegamento, mai portato in luce, con il fronte di mare. Infatti il lungo braccio di mura, che scendeva dallo sperone est della Piazzetta fino alle case ellenistiche di proprietà Guarnaccia, fu realizzato intorno al 350 a.C. come limite meridionale della rifondazione locrese, seguendo il probabile tracciato delle mura achee, ma si trasformò praticamente in un diateìchisma dopo l’ampliamento dell’abitato verso sud nella regione Corelli, che addirittura interruppe la struttura difensiva interna, limitandone le potenzialità difensive nel tratto di pianura.
Restano le testimonianze della porta di nord-ovest, della Porta di Aulon e di quella ipotizzata presso la torre III. La prima e la terza sembrano allineate lungo la prosecuzione del penultimo asse viario settentrionale, fra quelli con andamento est-ovest ipotizzati nella ricostruzione dell’impianto urbanistico della rifondazione locrese60. La porta di Casa Quaranta era il risultato di un adeguamento alle fortificazioni preesistenti di un modello ellenistico a corridoio o a tenaglia, con torri esterne, corrispondenti alla I, più antica e riadattata, e alla II, quadrata e del tutto simile a quelle realizzate lungo la cinta del IV sec. a.C. Il prodotto finale della ristrutturazione era un profilo a tenaglia compreso fra le due torri sui corni e disposto obliquamente rispetto all’andamento delle cortine nord e sud61. Il modello di confronto può essere rappresentato dalla porta A di Mantinea62, dalla Grande Porta a Stratos di Acarnania63, dalla fase ellenistica della Porta Sacra a Mileto64, o dalle porte della Pnice65 e del Dipylon66 di Atene e da quella ellenistica del fronte orientale di Massalia, con il corridoio d’accesso chiuso fra due avancorpi dotati di torri quadrate67.
§ Torri e fiancheggiamento Se la strategia della difesa avanzata sembra dunque ben presente nella definizione del sistema fortificato ellenistico, anche il principio del fiancheggiamento reciproco fra le opere sporgenti è attuato con regolarità sul fronte turrito settentrionale e nel primo tratto di quello nord-occidentale, fra la torre A e la porta di Casa Quaranta. Lungo le dorsali, come nota il Tréziny56, non sempre è rispettata una distanza fra le torri a cadenza regolare, ma esse assumono dimensioni e posizioni adeguate alla natura del terreno o in concomitanza a postierle, per poter fiancheggiare i tratti di cortina meno protetti dagli scoscendimenti. Inoltre la presenza di grandi torri che occupano un’area di circa 100 metri quadrati e sono dotate di poderose murature, come la D, la III e la VII, induce a pensare all’utilizzo di armamenti pesanti nei punti di maggior vulnerabilità, come i fronti nord e nord-ovest e la sella della Porta di Aulon. D’altro canto la presenza di artiglierie pesanti sembra confermato dal fatto che queste torri distano in
57
Il problema è analizzato dal Tréziny (1989c, pp. 143-144) presentando in ordine i rapporti fra le dimensioni delle torri e le loro distanze, dopo aver classificato tutte le torri in base alle loro misure areali (TRÉZINY 1989c, pp. 137-141). 58 supra p. 50 nota n. 17. 59 infra pp. 58, 60, 63. 60 IANNELLI 1985; IANNELLI-RIZZI 1985; TRÉZINY 1988, pp. 207-209; TRÉZINY 1989d, p. 155; già in SCHMIEDT-CHEVALLIER 1959 p. 358 e SCHMIEDT-CHEVALLIER 1960, pp. 6-7 si dà notizia di questo asse viario individuato con la fotografia aerea. 61 supra p. 18; TRÉZINY 1989c, pp. 145-149. 62 supra p. 18 nota n. 129. 63 ADAM 1982, p. 228. 64 LAWRENCE 1967, p. 234. 65 WINTER 1971, pp. 224-225. 66 ADAM 1982, p. 85. 67 HALIER 1986, pp. 255-256; TRÉZINY 1989c, p. 147.
53
Sulle tenaglie supra pp 42-43. TRÉZINY1989d, p. 156. 55 ORSI 1916, coll. 717-718. 56 TRÉZINY 1989c, p. 144. 54
55
La porta presunta presso la torre III, attraverso il braccio di mura più ad ovest, potrebbe ripetere lo schema della Porta di Aulon a causa della similitudine esistente fra la torre III e la VII sia in termini dimensionali, sia per la posizione sulla destra rispetto al varco d’accesso.
§ La tecnica costruttiva Merita un’ultima notazione la tecnica costruttiva. Sebbene ritenesse di datare all’età arcaica le mura, l’Orsi notò che la struttura a paramenti esterni e nucleo in ciottoli, tegole e tajo non era null’altro se non quella dei muri ad émplekton, che a Caulonia assumeva questa particolare conformazione per la mancanza di buona pietra da taglio, a differenza per esempio della disponibilità di materiali presenti a Locri71. È chiaro che l’assenza di arenaria o calcare impose una grave ipoteca anche quando furono riedificate le mura dopo il 389 a.C. e, in analogia alle strutture delle fasi precedenti, gli ingegneri locresi riutilizzarono la tecnica tradizionale cauloniate. Come ha ben notato il Tréziny, essi potevano fare affidamento su una grande quantità di materiale ricavabile dalle rovine della città distrutta dai Siracusani72, ma introdussero anche la novità dei rinforzi in blocchi lapidei per gli angoli di buona parte delle opere sporgenti, obbedendo a ragioni di ordine statico e protettivo. La tecnica utilizzata permetteva l’elevazione di torri, che potevano raggiungere notevoli dimensioni e sopportare il peso delle artiglierie difensive, ma, secondo quanto già notava l’Orsi, segnalando la mancanza di torri circolari73, essa imponeva la scelta della forma quadrangolare e probabilmente anche la disposizione di una faccia piana della torre rivolta verso il fronte d’attacco, rendendo necessari non solo i rinforzi degli spigoli, ma anche gli speroni interni, come nelle torri D e III74.
La Porta di Aulon, soltanto scavata dall’Orsi, corrisponde ad un tipo semplice caratterizzato da un varco aperto ortogonalmente attraverso la cortina muraria rettilinea, ma protetto da una torre poderosa, la numero VII, sul lato destro e da una torre minore, la VIII, sul lato sinistro, predisposta alla sola difesa del terrazzo d’accesso. Questo tipo di schema sostituisce alla complicazione dell’impianto a tenaglia o a cortile la pesantezza delle opere difensive, che, potendo alloggiare artiglierie di grande calibro e alta portata, attuavano un massiccio tiro di fiancheggiamento davanti al varco e su tutto il terreno esterno prossimo ad esso. Si trovano esempi frequenti nelle fortificazioni elleniche, per i quali si rimanda alla parte dedicata alla Porta Settembrini di Metaponto68. Verso la Porta di Aulon si dirigeva un asse viario est-ovest, che sembrerebbe più importante di quelli a lui paralleli, in ragione delle dimensioni, superiori certamente ai 4 metri di larghezza media delle altre strade, ma soltanto intuibili nelle fotografie aeree del 1959. Questa plateìa scendeva dalla sella di valle Campana, seguendo la concavità delle curve di livello, giungeva in pianura nel cuore dell’abitato di regione Castellone e intercettava perpendicolarmente la plateìa principale nord-sud, proprio davanti all’area sacra del tempio dorico, in modo da porre in collegamento diretto il fulcro del sistema urbanistico con la Porta di Aulon69. Questo rapporto fra impianto e fortificazione elegge la Porta di Aulon ad un rango di particolare importanza, pari o di poco inferiore a quello delle presunte porte dei fronti nord e sud, probabilmente perché essa metteva in collegamento l’abitato con una via proveniente dalla zona interna della chòra, di cui l’Orsi intravide il percorso di mezza costa, nell’ultimo tratto prima del terrazzo della porta e attraverso la sella, che divide il vallone Bernardo da quello del cimitero sotto il dominio delle fortificazioni del Colle A 70.
§ La funzionalità del sistema In conclusione è opportuno notare che la ricostruzione del sistema difensivo di Caulonia, in epoca ellenistica, sembra tenere conto non solo della necessità di un rapporto funzionale fra impianto urbano e fortificazioni, ma anche dell’efficacia di un elevato numero di torri e porte, operanti in relazione reciproca nell’ambito del sistema difensivo. Si ha cioè l’impressione che gli ingegneri locresi non solo abbiano recuperato la «Geländemauern» achea, facendo le opportune modifiche e integrazioni per un miglioramento strategico, ma che si siano impegnati in una impresa di edificazione ex novo, correggendo quelle lacune che la stessa cinta di Locri poteva avere o che aveva colmato con il passare degli anni e con le trasformazioni della strategia difensiva, come per esempio lo scarso numero di torri lungo il circuito urbano. In questa prospettiva il circuito murario tardo classico-ellenistico di Caulonia diviene un documento prezioso di per sé, ma anche testimonianza dell’evoluzione di un’arte fortificatoria antica proveniente dall’area locrese, che in questa piazzaforte tentò di concentrare tutto il proprio bagaglio di esperienze.
In questo modo si spiega anche la funzione squisitamente difensiva delle porte di Casa Quaranta e della torre III. Esse sono allineate su un asse viario ordinario, poiché il collegamento con la chòra non fu realizzato presso il fronte nord-ovest in pianura, necessitante di un avanzamento rinforzato delle difese, piuttosto che di un’apertura ad alta frequenza di passaggio e collegata ad assi urbani egemoni. Si preferì invece un percorso attraverso i valloni extramuranei, totalmente dominato dalle fortificazioni occidentali, trasformando un punto naturalmente debole, come la sella di valle Campana in un passaggio obbligato attraverso poderose opere difensive.
71
ORSI 1916, coll. 774-778. supra p. 50 nota n. 16. 73 ORSI 1916, coll. 771-772. 74 supra p. 50 nota n. 14.
68
72
supra pp. 36, 39. 69 SCHMIEDT-CHEVALLIER 1959, p. 368; TRÉZINY 1989d, p. 156. 70 ORSI 1916, coll. 729-730.
56
CAPITOLO
6
Locri Epizefiri
L’antica Lòkroi Epizephỳrioi venne fondata da coloni greci provenienti dalla Locride Opunzia e Ozolia alla fine dell’VIII sec. a.C., lungo la costa ionica meridionale della Calabria. Dopo un primo periodo di stanziamento presso il Capo Zefirio, come ricorda Strabone1, i Locresi si spostarono nella vicina pianura a valle della rocca di Gerace, poco più a sud dell’attuale città di Locri, e fondarono la nuova pòlis presso un pendio denominato Esòpis.
mettendola a ferro e fuoco e devastando anche il celebre Persephoneìon, tanto da impedire la ripresa della vita urbana precedente, riorganizzata in municipium dopo l’89 a.C.2. Il sistema difensivo locrese Le vicende storiche, dalla fine del V sec. a.C. fino alla fine del III sec. a.C., dimostrano chiaramente anche per Locri quanto fu frequente il coinvolgimento in episodi bellici e di conseguenza l’importanza della presenza di un buon apparato difensivo3.
È nota la fortuna e il potere raggiunto dalla città in età arcaica, soprattutto dopo la vittoriosa guerra contro Crotone conclusasi con la disfatta degli Achei alla Sagra intorno al 550 a.C. L’ampia espansione territoriale locrese verso il Tirreno, con la fondazione delle subcolonie di Medma, Matauros e Hipponion, portò ad un prolungato conflitto di interessi con Reggio, colonia calcidese, confinante ad ovest con la chòra di Locri, e ad un sempre più stretto legame con Siracusa, tradizionalmente alleata di Locri fin dall’epoca della fondazione. La colonia rientrò così per tutto il V sec. a.C. nell’ambito della politica dorica d’occidente, le cui fila erano tirate da Sparta e Siracusa, e si oppose alla spedizione ateniese del 415-414 a.C. Ma è soprattutto nel IV sec. a.C. che Locri rappresentò per i Siracusani, non solo la tradizionale corrispondente politica e commerciale nel continente, ma una vera e propria piazzaforte di retrofronte durante la guerra fra Dionisio I e la Lega Italiota, tanto che dopo la battaglia dell’Elleporo, nel 389 a.C., il tiranno donò ai Locresi il territorio di Caulonia, caduta e rasa al suolo nello stesso anno. Pertanto l’area di controllo locrese si espanse a nord del vecchio confine sulla Sagra e la città visse un altro periodo di grande fioritura economica e culturale, pur in seguito al cambiamento della direzione politica aristocratica, che dopo la cacciata di Dionisio II, nel 346 a.C., si aprì ad un regime più democratico, e nonostante la minaccia incombente dei Brezii, proveniente dai territori interni d’Aspromonte, che determinò un riavvicinamento a Siracusa e alla politica di Agatocle.
§ Il circuito arcaico La situazione locrese in epoca ellenistica sembra diversa rispetto a quella delle pòleis qui analizzate, compresa Paestum. Infatti, mentre negli altri casi le fasi di questo periodo appaiono come ristrutturazioni sostanziali, se non rifacimenti ex novo delle difese più antiche, che lasciano spesso come eredità l’andamento generale o parziale del circuito, a Locri si continua a mantenere in funzione il sistema difensivo di età arcaica, la cui creazione è ricondotta alla seconda metà del VI sec. a.C.4. Il fatto è archeologicamente dimostrato per l’intero fronte di mare e per i tratti in pianura dei fronti nord e sud, invece per il circuito dell’entroterra si può solo pensare che i principali caposaldi siano stati fissati comunque nello stesso periodo, come può suggerire la fase più antica del torrione di Castellace5. Pertanto l’analisi delle fortificazioni ellenistiche di Locri equivale in buona parte alla presentazione del sistema difensivo urbano più antico, tenendo conto che, anche in 2 Per le vicende storiche di Locri OLDFATHER 1927; GROSSO 1951; ZANCANI MONTUORO 1961, pp. 668-669; BARILLARO 1964a passim; DE FRANCISCIS 1971, pp. 14-17; TURANO 1973; NIUTTA 1977, pp. 268271; GRECO 1981a, pp. 80-84; GUZZO 1982, pp. 53-55, 103-105; 108169 passim; GRECO-TORELLI 1983, pp. 192-194; PUGLIESE CARRATELLI 1983 passim; CORDANO 1985, pp. 321-328; GRECO 1985, pp. 350-357; GIANGIULIO 1987 passim; LOMBARDO 1987a passim; COSTAMAGNA-SABBIONE 1990, pp. 31-42; ARIAS-PARRA 1991, 193-195; GRECO 1993, pp. 54-63, 272. 3 In generale sulle mura di Locri DE FRANCISCIS 1959a, pp. 34-36; ZANCANI MONTUORO 1961, pp. 670-671; LISSI 1962, pp. 110-111 note n. 4 e 5; BARILLARO 1964a passim; TURANO 1970, pp. 150-153 passim, 155-156; SCHMIEDT 1970a, tav. LXVIII; DE FRANCISCIS 1971, pp. 3744; DE FRANCISCIS 1972, pp. 163-169; FOTI 1977, pp. 346-349; BARRA BAGNASCO 1977b, p. 376; GUZZO 1982, p. 276; GRECO-TORELLI 1983, p. 194; BARRA BAGNASCO 1983, pp. 1-2; COSTAMAGNA-SABBIONE 1990, pp. 49-53; ARIAS-PARRA 1991, pp. 204, 207; GRECO 1993, p. 273; BORELLI 1995, p. 401; BARRA BAGNASCO 1996a; BARRA BAGNASCO 1999a; BARRA BAGNASCO 2000. 4 BARRA BAGNASCO 1996a, pp. 270-273; BARRA BAGNASCO 2000, p. 11. 5 infra p. 61 nota n. 32.
Il III sec. a.C. rappresenta per Locri un periodo di lenta, ma inesorabile decadenza a causa del difficile e alterno rapporto con Roma, insieme alla quale la città greca strinse un’alleanza intorno al 285 a.C. per far fronte ai Brezii. Tuttavia la venuta di Pirro determinò la defezione di Locri e la sua sottomissione a Roma dopo il 272 a.C., che comportò l’impegno delle forze navali locresi a fianco di quelle romane, durante la Prima Guerra Punica e lo schieramento con la città laziale alla vigilia della guerra annibalica. Nel 216 a.C., dopo il disastro di Canne, la città passò ai Cartaginesi ribellandosi al governo aristocratico filoromano, ma nel 205 a.C. Scipione riconquistò Locri, 1
Geografia (1967), VI, 1, 7.
57
materia di tecniche costruttive, non si rilevano variazioni significative rispetto all’età arcaica, poiché, al posto della diffusissima muratura a cassoni ed émplekton, continua ad essere utilizzata quella dell’elevato in mattoni crudi su un basamento in blocchi di calcarenite arenacea, per filari alterni di testa e di taglio, profondamente fondato e con un paramento esterno di blocchi di calcare in opera isodoma. Anzi molto spesso le fondazioni delle fasi più recenti coincidono direttamente con quelle arcaiche, perciò si può pensare che le ristrutturazioni ellenistiche riguardino soprattutto l’elevato e gli adeguamenti alle nuove tecniche poliorcetiche6.
bacino portuale, operante fin dal VI sec. a.C., con strutture di fiancheggiamento prominenti verso il mare, che giustificava la presenza della zona emporica più a sud e richiedeva un collegamento agevole e contemporaneamente ben difeso con l’interno della città9. Dunque le mura di questo fronte, anche in epoca altoellenistica, non assunsero l’aspetto di una fortificazione con precipua finalità difensiva, poiché la presenza delle strutture esterne ne vanificava l’efficacia strategica: esse segnavano semplicemente un limite fra l’interno e l’esterno della città, offrendo a chi giungeva per mare l’immagine della pòlis in vista di una funzione propagandistica di potere e benessere, tipica delle fortificazioni del periodo in esame10.
§ Il fronte di mare Un messaggio simile era certamente quello determinato dall’imponenza delle torri della Porta di Afrodite, che delimitavano un ampio varco, attraverso il quale usciva la principale plateìa est-ovest che collegava il santuario di Afrodite extraurbano con la parte più interna della città11. La torre settentrionale è ipotizzata in base ai pochi resti ancora rinvenuti, mentre quella meridionale, sporgente verso l’interno della città, è una struttura molto ampia (13 × 10 metri), conservata in fondazione e solidale alla cortina di età arcaica, tanto da far presupporre che il varco avesse già nella seconda metà del VI sec. a.C. una difesa articolata e che tale fu mantenuta fino alla metà del III sec. a.C., quando la situazione stratigrafica sembra collocare l’obliterazione della rasatura. La porta si trovava all’estremità nord della rientranza che le mura seguivano in contrada Centocamere per rispettare la presenza più ad est della Stoà ad U, infatti un breve tratto di cortina dopo la torre nord, con andamento est ovest, si collegava a quello proveniente da Marasà Sud presso un angolo armato di rinfianco. Oltre il raccordo, presso il sacello del santuario di Afrodite prossimo alle mura, si apriva un secondo varco destinato al passaggio delle acque, provenienti dalla zona collinare della città, anch’esso datato alla seconda metà del VI sec. a.C., che era fornito di un lungo muro in blocchi di calcarenite arenacea, spesso 1,90 metri e ortogonale al suo stipite nord e alle mura, per fiancheggiare il bacino portuale ed evitarne l’insabiamento con i detriti trasportati dall’acqua defluente12.
L’illustrazione del sistema difensivo ellenistico può prendere le mosse dal fronte orientale di mare, che è stato ampiamente indagato dagli anni ’70 del secolo scorso fino ad ora dalle missioni dell’Università di Torino. Lungo questo tratto di mura si possono individuare tutti i periodi di costruzione, ma soprattutto è l’unico che permette di isolare dalla metà del IV sec. a.C. alcune ristrutturazioni e un importante rifacimento probabilmente nella seconda metà del III sec. a.C. L’intero fronte era costituito da una cortina realizzata secondo la tecnica costruttiva descritta sopra e datata alla metà del VI sec. a.C., generalmente spogliata dei paramenti in calcare. Il percorso delle mura seguiva un andamento rettilineo parallelo alla linea di costa, tranne che in un breve tratto in cui rientrava leggermente verso monte per dar spazio a costruzioni esterne, e, attraversando le attuali contrade di Centocamere e Marasà, collegava le estremità orientali dei fronti nord e sud senza un apparato di opere sporgenti a cadenza varia o regolare. Il fronte di mare presentava una successione di quattro varchi noti da nord a sud, corrispondenti alla Porta Portuense, alla Porta di Afrodite, al Propileo monumentale e al cosiddetto varco con postierla, tutti datati all’epoca della costruzione della cortina. La motivazione di tale assetto è conseguente alla presenza di una serie di strutture extraurbane con destinazione religiosa e profana, in vita fra l’età arcaica e il III sec. a.C., collocate lungo la fascia litoranea fra le mura e la spiaggia, anticamente più arretrata. Si tratta, partendo da sud in contrada Centocamere, di un esteso quartiere emporico, costituito da edifici di servizio ad oìkoi successivi, autonomi o addirittura addossati al paramento esterno delle mura7, e di un santuario dedicato al culto di Afrodite con un settore occupato dalla Stoà ad U, poco oltre il quartiere emporico, e un’area sacra a ridosso delle mura, già in contrada Marasà Sud, costituita da un sacello, in epoca arcaica e classica, e da un Adònion, la cosiddetta Casa dei Leoni, in vita fino alla metà del III sec. a.C.8. Segue salendo verso nord l’ampio
LATTANZI 1990, pp. 589-590; BARRA BAGNASCO 1996a, p. 271; per il settore a ridosso delle mura BARRA BAGNASCO 1992a; BARRA BAGNASCO 1994a, p. 749; BARRA BAGNASCO 1994b; BARRA BAGNASCO 1996a, p. 267; BARRA BAGNASCO 1999a, p. 14-15; BARRA BAGNASCO 2000, pp. 22-23 9 BARRA BAGNASCO 1996a, pp. 258-260; BARRA BAGNASCO 1999a, in cui si fa riferimento a tutta la bibliografia precedente riguardante la localizzazione dei porti di Locri; BARRA BAGNASCO 2000, pp. 23-24. 10 supra pp. 15, 18. 11 Sull’urbanistica di Locri Epizefiri, l’articolazione delle plateìai e degli isolati e la topografia generale ZANCANI MONTUORO 1961, pp. 670672; BARILLARO 1964a passim; BARILLARO 1964b passim; TURANO 1970 passim; SCHMIEDT 1968-69, p. 405; SCHMIEDT 1970a, pp. 58-59; BARRA BAGNASCO 1977b; FOTI 1977; BARRA BAGNASCO 1978; BARRA BAGNASCO 1983, pp. 4-14; BARRA BAGNASCO 1984; BARRA BAGNASCO 1985, pp. 185-194; COSTAMAGNA-SABBIONE 1990, pp. 43-45; ARIAS-PARRA 1991, pp. 207-209; BORELLI 1995, pp. 400; BARRA BAGNASCO 1996a; BARRA BAGNASCO 1999a; BARRA BAGNASCO 2000; BARRA BAGNASCO 2002. 12 Sul complesso e le fasi della Porta di Afrodite BARRA BAGNASCO 1986, pp. 432-437; BARRA BAGNASCO 1987, pp. 716-717; BARRA BAGNASCO 1988, pp. 658-659; BARRA BAGNASCO 1991, pp. 607-608, 610-613; BARRA BAGNASCO 1992b, pp. 436-441; BARRA BAGNASCO
6 Sulla tecnica costruttiva delle mura locresi DE FRANCISCIS 1971, pp. 40-44; BARRA BAGNASCO 1996a, pp. 240-241, 244, 253-254, 270; BARRA BAGNASCO 2000, pp. 11-12. 7 BARRA BAGNASCO 1977a, pp. 3-29; BARRA BAGNASCO 1978, pp. 1417; BARRA BAGNASCO 2000, pp. 27-28. 8 Sul santuario di Afrodite fuori le mura e per il settore della Stoà ad U BARRA BAGNASCO 1977a, pp. 46-49; GULLINI 1980, pp. 111-127; GULLINI 1983, pp. 223-226; COSTAMAGNA-SABBIONE 1990, pp 211-217;
58
Proseguendo lungo le mura verso nord, oltre il rinfianco del varco descritto, la cortina non presentava variazioni di percorso e, a circa 200 metri di distanza dalla Porta di Afrodite, si apriva quella denominata Portuense, un semplice varco attraverso la cortina con soglia in calcare e privo di torri o altre opere difensive. In prossimità dello stipite sud della porta si agganciava, solidale alla tessitura della cortina, un lungo muro, spesso 2 metri, con andamento monte-mare, realizzato nella seconda metà del VI sec. a.C., contestualmente alle mura e alla porta, per fiancheggiare a nord il bacino portuale. La funzione dell’opera dunque, come nel caso del rinfianco meridionale, era sia difensiva sia funzionale agli apprestamenti d’approdo e alla protezione dai venti avversi nelle manovre d’ingresso o d’uscita dal porto. Esso impediva anche l’insabbiamento del bacino da parte di un corso d’acqua che usciva dalla città attraverso un grande varco bipartito in blocchi di calcare, aperto a ridosso dello stipite nord della Porta Portuense. È rilevante il fatto che i due muri portuali seguissero un andamento parallelo all’orientamento urbanistico degli assi viari monte-mare, cosa che conferma la loro origine nella seconda metà del VI sec. a.C., quando fu appunto tracciato l’impianto viario di Locri13. Questo settore del fronte di mare fu oggetto di una ristrutturazione nella prima metà del IV sec. a.C., modificando in parte l’aspetto che manteneva intatto dall’età arcaica. La cortina fu raddoppiata lungo la fronte interna, sempre utilizzando la stessa tecnica costruttiva, in modo da raggiungere uno spessore di 4,60 metri rispetto ai 2,40 precedenti. Così pure accadde al tratto portuale monte-mare che, con l’aggiunta di un secondo muro, arrivò ad uno spessore di 6 metri. La Porta Portuense venne ampliata quasi del doppio e la sua soglia risollevata alla quota del nuovo battuto della strada, che fin dall’età arcaica usciva dalla città fiancheggiata dal canale e costeggiava il muro portuale. Infine il grande varco per il passaggio canalizzato del corso d’acqua fu ristrutturato sempre con una poderosa opera di blocchi calcarei e un muro di spina centrale14.
ne realizzato già nella seconda metà del VI sec. a.C. un ampio varco di collegamento fra la città e il quartiere emporico a sud del santuario di Afrodite. Alla fine del secolo esso fu trasformato in un Propileo monumentale, un dipylon, restituito con un allineamento di tre colonne a metà del varco, fondato su una piattaforma di calcare, gradinata verso l’esterno per colmare il salto di quota fra la città e la zona emporica. La struttura, senza alcuna funzione difensiva, era ancora tale nel IV sec. a.C., quando le fu addossata presso il fianco sud una rampa scalare, verosimilmente necessaria per raggiungere il cammino di ronda16. Scendendo ancora verso sud di circa 80 metri, le mura erano attraversate da un ultimo varco, che presentava una struttura simile a quella della Porta Portuense. Intorno all’ultimo quarto del VI sec. a.C. risale un complesso fondato su una piattaforma in blocchi di calcare solidale alle fondazioni delle mura, che era costituito da un passaggio carraio, fiancheggiato a sud da un varco bipartito per l’attraversamento di un corso d’acqua interno alla città. Nella prima metà del IV sec. a.C. questo settore delle mura cambiò aspetto, poiché il passaggio carraio fu chiuso e alla tampognatura fu addossata l’estremità sud della serie di oìkoi emporici, aderenti alla fronte esterna delle mura; il varco bipartito fu ristretto ad una sola luce con stipiti in calcare, per assolvere all’unica funzione di deflusso delle acque canalizzate a monte17.
Passando alla fortificazione di contrada Centocamere a sud della Porta di Afrodite, come per la porzione a settentrione, l’aspetto nel IV sec. a.C. non differiva molto da quello assunto fin dall’età arcaica. Il tratto di cortina, che si collegava alla grande torre sud della Porta di Afrodite, in prossimità dell’angolo sud-ovest della Stoà ad U, piegava ad est per ricollegarsi alle mura che procedevano verso meridione, perfettamente allineate a quelle di Marasà Sud15. A meno di 150 metri, attraverso la cortina, ven-
È chiaro dunque che, ancora per tutto il IV sec. a.C. e probabilmente nella prima metà del III, il fronte di mare dal punto di vista difensivo si presentava assolutamente sguarnito e permeabile a causa delle numerose aperture e della carenza di strutture sporgenti dalla linea delle mura, per attuare anche solo un elementare fiaccheggiamento del terreno esterno. Tuttavia la chiusura simultanea di tutte le porte tranne quella di Afrodite, intorno alla metà del III sec. a.C., e l’abbattimento dell’Adònion presso le mura di Marasà Sud, della Stoà ad U e del quartiere emporico a Centocamere, già all’inizio del secolo, rappresentano certamente un cambiamento di rotta e un tentativo di trasformare il fronte di mare in un’opera con vere e proprie finalità strategiche e difensive. Perciò l’aspetto delle fortificazioni in questo momento cambiò moltissimo, non tanto esteriormente, visto che si continuò a mantenere la solità tecnica dell’elevato in mattone crudo, ma in termini contestuali, in conseguenza al «guasto» delle strutture extramuranee e al messaggio immediato di arroccamento e chiusura, comunicato dalla lunga cortina uniforme, dominante un litorale ormai desolato18. A partire dall’angolo
1993; BARRA BAGNASCO 1994a, pp. 747-751; BARRA BAGNASCO 1995; BARRA BAGNASCO 1996a, pp. 247, 260-265, 267-268, 272; BARRA BAGNASCO 2000, p. 22. 13 supra p. 58 nota n. 11. 14 Sul complesso della Porta Portuense BARRA BAGNASCO 1996a, p. 259; BARRA BAGNASCO 1996b; BARRA BAGNASCO 1997; LATTANZI 1997, pp. 505-506; BARRA BAGNASCO 1999a, pp. 4-8; LATTANZI 1999a, p. 914; BARRA BAGNASCO 2000, pp. 13-22 15 Questo è il tratto di fortificazione del fronte orientale indagato per primo negli anni ’50 e ricondotto ad età alto arcaica (LISSI 1962, pp. 11011), ma le indagini della missione di Torino negli anni ’70 e con l’estensione al tratto di Marasà Sud negli anni ’80 hanno permesso di collocarlo cronologicamente nella seconda metà del VI sec. a.C. (BARRA BAGNASCO 1973, pp. 358-359; BARRA BAGNASCO 1977a, pp. 29-41; BARRA BAGNASCO 1977b, p. 402; BARRA BAGNASCO 1986, pp. 435-
436; BARRA BAGNASCO 1987, pp. 716-717; BARRA BAGNASCO 1991, pp. 608-610; BARRA BAGNASCO 1996a, pp. 253-255, 271). 16 BARRA BAGNASCO 1971, p. 518; BARRA BAGNASCO 1977a, pp. 4246; BARRA BAGNASCO 1996a, pp. 256-258; BARRA BAGNASCO 2000, p. 24. 17 BARRA BAGNASCO 1973, pp. 356-357; BARRA BAGNASCO 1977a, pp. 34-41; BARRA BAGNASCO 1978, p. 12; BARRA BAGNASCO 1996a, p. 255; LATTANZI 1999b, p. 747; BARRA BAGNASCO 2000, pp. 24-27. 18 BARRA BAGNASCO 1996a, pp. 267, 272. Colpisce in particolare la simultaneità delle distruzioni extramuranee, in quanto richiama alla mente una delle norme attuate dagli ingegneri militari moderni, che prescrivevano la totale ripulitura del terreno circostante una piazzaforte, preliminarmente all’edificazione delle difese per impedire, come già pensarono i Locresi del III sec. a.C., all’assediante di sfruttare come opere difensive eventuali edifici prossimi alle mura, ma soprattutto per garantire l’assoluto governo della campagna da parte delle artiglierie della piazza
59
nord-est del circuito difensivo urbano, in località Parapezza Est, si possono seguire le diverse trasformazioni che modificarono l’aspetto del fronte di mare, rilevando la nascita già all’inizio del III sec. a.C. di una poderosa torre quadrangolare (circa 9,60 × 9,60 metri) a rinforzo dello spigolo19. Essa fu concepita per fiancheggiare l’ultimo tratto del fronte nord e quello del fronte orientale fino almeno al grande varco presso la Porta Portuense, che, in ragione della sua funzione fondamentale di drenaggio urbano, continuò a rimanere aperto per tutto il III sec. a.C., facendo affidamento evidentemente su un sistema di paratie, che già sembra si incassassero in apposite sedi fin dal rifacimento di IV sec. a.C. Non ebbe destino analogo la Porta Portuense che, presumibilmente alla metà del III sec. a.C., fu ostruita con un’inzeppatura di blocchi di calcarenite, determinando così l’interruzione del fluido collegamento fra la città e la zona del santuario di Marasà con il porto, che pure cadde in disarmo. La fortificazione procedeva fino alla Porta di Afrodite, mantenendo lo stesso percorso e la stessa struttura delle fasi precedenti, previ ovviamente possibili rifacimenti dell’elevato o integrazioni lungo il cammino di ronda per le belostàseis, dato che fin dal IV sec. a.C. il raddoppiamento dello spessore poteva permettere l’installazione di artiglierie di medio calibro.
opera che colmasse il vuoto fra le fortificazioni più antiche21.
Nel settore della Porta di Afrodite si rilevano le maggiori trasformazioni morfologiche, attuate dopo la distruzione dei complessi extraurbani. Infatti l’intera struttura della porta arcaica e classica fu abbandonata e rasa al suolo poco prima della metà del III sec. a.C. e si mantenne soltanto il varco più a nord, destinato nei secoli precedenti al passaggio delle acque, come apertura per lo sbocco verso l’esterno della grande plateìa est-ovest, proveniente da monte e per il necessario drenaggio. Tale varco fu ristretto, abbandonando l’ampia luce di 7,10 metri, e fu inoltre armato con due torri quadrate (5,90 × 6,00 metri), realizzate con blocchi di calcarenite arenacea e di calcare riempiegato, sporgenti dalle mura, per fiancheggiare le cortine limitrofe e dominare il terreno antistante20. Pertanto l’avanzamento della Porta di Afrodite fu compiuto contestualmente all’abbandono del tratto di mura arcaiche che rientrava verso monte, per rispettare l’ingombro della Stoà ad U, demolita anch’essa nella prima metà del III sec. a.C. Il nuovo segmento di cortina collegava il sito della porta con il braccio arcaico delle mura di Centocamere più a sud, riprendendo l’allineamento alle mura di Marasà; esso fu però realizzato con una tecnica costruttiva del tutto diversa rispetto a quella arcaica, poiché comprendeva una fondazione ampia 4 metri, in ciottoli e materiale eterogeneo, assemblato con maggior cura presso le estremità, e un elevato in mattone crudo, integrato probabilmente da legname, per ottenere rapidamente una
I fronti meridionale, settentrionale e occidentale si presentano meno complessi in età ellenistica rispetto a quello appena esaminato quanto a ristrutturazioni, ma comunque sono stati meno indagati. Il fronte sud è anch’esso ricondotto, come impianto, alla seconda metà del VI sec. a.C.23 e si può presumere che, a partire dalla prima metà del IV sec. a.C., lungo le cortine siano state realizzate delle ristrutturazioni per adeguare le opere alle nuove tecniche difensive. Primo fra tutti gli interventi è l’elevazione di una torre d’angolo presso il raccordo con il fronte di mare, analoga a quella dello spigolo nord-est del circuito e ipotizzata a causa della conformazione del terreno, più alto in quel settore rispetto al piano di campagna24. Il fronte sud corre parallelo alla fiumara di Portigliola, ma attualmente è coperto dalla strada provinciale, che conduce al paese omonimo. Tuttavia negli anni ‘60 e poi nel 1992 e 1993 fu indagato in contrada Quote San Francesco il tratto presso l’incrocio fra la strada di Portigliola e il dromo, un asse viario moderno, parallelo alla linea di costa, che ricalca il percorso della principale plateìa nord-sud dell’impianto urbano di Locri Epizefiri, posizionata al confine fra l’abitato in pianura e le aree urbane presenti sui primi pendii delle alture dell’entroterra25.
Infine a Centocamere venne demolito e chiuso definitivamente l’indifendibile Propileo monumentale, mentre il varco più a sud fu mantenuto fino alla fine del III sec. a.C., come quello presso la Porta Portuense, per l’irrinunciabile funzione di smaltimento delle acque. Le mura arcaiche di Centocamere furono conservate tali e quali, ma come quelle di Marasà Sud ricevettero l’integrazione di un rinforzo interno, elevato in mattone crudo e limitato da un cordolo in spezzoni di calcare, per raggiungere uno spessore finale di 4 metri circa, che può di nuovo far presupporre, come nei tratti precedenti, la sistemazione di batterie lungo il cammino di ronda22. Alla luce di tutti questi interventi risalta ancor meglio la trasformazione della Porta di Afrodite, mantenuta per una necessaria comunicazione con il mare, ma concepita ormai agli antipodi della fase arcaica. Tanto era infatti imponente e magniloquente il complesso ancora in funzione durante il IV sec. a.C., quanto dalla metà del III sec. a.C. esso era semplice e militarmente austero, unica variante lungo l’uniformità costante del nuovo fronte di mare. § Il fronte meridionale
A Quote San Francesco è emerso un complesso costituito da una porta, difesa da una robusta torre quadrangolare, e da un varco ampio 4 metri per lo scarico delle acque all’esterno delle mura. Tutte le strutture sono realizzate con la solita tecnica locrese della muratura piena, in blocchi di calcarenite arenacea, assemblati in opera isodoma e
(LAMBERINI 1988, pp. 219-239; BONARDI 1995, pp. 60-62). Questo fatto tuttavia può far riflettere sulla possibilità che a Locri il «guasto» sia stato operato in vista di un utilizzo efficace e massiccio delle artiglierie neurobalistiche lungo il fronte di mare, le cui cortine furono in questa epoca notevolmente ispessite. 19 COSTAMAGNA-SABBIONE 1990, p. 184; LATTANZI 1990, pp. 589-591; LATTANZI 1991, pp. 598; LATTANZI 1994, p. 732; BARRA BAGNASCO 1996a, p. 244; LATTANZI 1996, pp. 677-678. 20 supra p. 58 nota n. 12.
21 BARRA BAGNASCO 1994a, pp. 745-747; BARRA BAGNASCO 1996a, pp. 267-270. 22 BARRA BAGNASCO 1977a, p. 36; BARRA BAGNASCO 1996a, p. 265 23 BARRA BAGNASCO 1996a, p. 271. 24 BARRA BAGNASCO 1996a, p. 244. 25 supra p. 58 nota n. 11.
60
terra, della città di Locri30. Sul colle di Castellace, da cui si gode di un’ampia visuale a 360° sulla fascia costiera e verso l’entroterra montuoso, le indagini archeologiche hanno portato all’individuazione di una poderosa opera difensiva, costituita da un torrione (circa 13,00 × 11,00 metri) con muri di fondazione assai spessi (4,50 metri), realizzato secondo la solita tecnica costruttiva e datato nel corso del VI sec. a.C., a riprova della presenza di opere difensive su questo fronte già in età arcaica. La struttura, che era disposta con gli spigoli orientati secondo i punti cardinali, per occupare nel modo migliore la sommità dell’altura, presentava già nella prima fase il vertice nord rivolto verso il fronte d’attacco. Venivano così anticipati precocemente i dettami filoniani31, rispettati anche dalla struttura edificata in loco all’inizio del III sec. a.C., quando lungo il lato nord-est della torre arcaica fu aggiunta una seconda torre quadrangolare (circa 6,00 × 8,00 metri), con i muri perimetrali più sottili, ma solidali a quelli dell’opera più antica. Infine la cortina, che si raccordava alla torre arcaica presso l’estremità ovest, formava uno spigolo con angolo rientrante, utile al fiancheggiamento, ed era realizzata con la stessa tecnica dell’opera principale. La cortina orientale invece, che scendeva verso la gola del vallone Milligri, spessa circa 3 metri, era realizzata con una tecnica ad émplekton fra due spessi paramenti di blocchi in calcarenite, posti in opera di testa, e risulta coeva della torre arcaica, essendo ad essa solidale32. Per quanto concerne l’età ellenistica è interessante l’inserimento della seconda torre, perché fa pensare ad una sostituzione dell’opera più antica, che tuttavia non dev’essere stata completamente demolita, ma, forse ribassata. Si venne a costituire così una sorta di castellum, solidale con la nuova torre; esso grazie alle sue poderose murature, costituiva una sede ottimale per una belostàsis di petroboli pesanti, che operavano a quota inferiore in associazione con macchine di medio calibro a dardi, collocate più in alto sulla torre ellenistica. Tale ipotesi potrebbe trovare conferma anche nella localizzazione topografica del colle di Castellace, parzialmente defilato rispetto alle cime di Abbadessa e Mannella, che erano addirittura in grado di difendersi reciprocamente a vista.
con paramenti, marginali e stipiti in blocchi di calcare. La porta, una delle principali di Locri, poiché difendeva il punto di collegamento del dromo con la viabilità della chòra meridionale a partire almeno dal IV sec. a.C., era probabilmente del tipo a cortile, con torri sporgenti rispetto alla linea delle mura. Tuttavia l’esistenza della torre a monte non è verificata, ma la sua assenza avrebbe potuto essere supplita dal ripiegamento verso sud della cortina, che, seguendo la natura del terreno, poco più ad ovest della porta, iniziava a percorrere il tratto d’altura per raggiungere la cima del colle di Castellace. La torre orientale invece svolgeva una necessaria e dupplice funzione di fiancheggiamento, governando ad ovest il terreno antistante il varco carraio della porta e ad est il varco per le acque. Quest’ultimo, in analogia a quelli visti lungo il fronte di mare, essendo coerente con la struttura delle mura, esisteva già probabilmente nella seconda metà del VI sec. a.C. ed era dotato di una spalla esterna legata obliquamente allo stipite orientale, per evitare il deflusso delle acque lungo le fondazioni della cortina26. È verosimile che, date le dimensioni dell’apprestamento e l’ampio utilizzo del calcare, fuoriuscisse in questo punto un abbondante corso d’acqua discendente dal vallone Stranghilò, sottostante il colle di Castellace, che, incanalato a pochi metri di distanza dalle mura del fronte sud, determinava una sorta di fossato naturale per l’impedimento dell’approccio delle macchine da guerra27. § Il sistema fortificato delle alture Dopo la porta di Quote San Francesco, come si è detto, le mura del fronte sud iniziavano a scalare i declivi dapprima dolci e poi più aspri fino alla cima del colle di Castellace. In verità il circuito difensivo locrese esteso sulle colline a monte del dromo può essere considerato in modo unitario, poiché, rispetto agli andamenti rettilinei dei fronti di pianura, domina l’adeguamento alla natura dei pendii e le cortine sud e nord costituiscono semplicemente due bracci con andamento monte-mare, che furono realizzati per collegare alle fortificazioni dell’abitato a valle i capisaldi della difesa d’altura. Tutto l’ampio settore fu indagato dall’Orsi con sondaggi isolati fin dalle sue prime campagne locresi del biennio 1890-1891, e ricostruito nella prima pianta dei rinvenimenti, redatta a cura dello stesso archeologo nel 191028. Certamente per l’epoca ellenistica si può presupporre l’esistenza del sistema completo e operante alla perfezione, tuttavia l’impianto originario, almeno nei suoi capisaldi principali, è ricondotto all’età arcaica, fra la metà e la fine del VI sec. a.C., come i fronti di pianura29.
Il collegamento fra Castellace e Abbadessa era costituito da due bracci di mura che, seguendo le curve di livello dei ripidi pendii delimitanti la gola del vallone Milligri, convergevano sul fondo del vallone stesso in un punto in cui si apriva un varco realizzato in poderosa opera isodoma di blocchi in calcarenite arenacea e calcare, secondo un impianto complesso con percorso a squadra. Si tratta di un’opera di sbarramento che, come nel caso analogo del vallone Saitta, secondo l’opinione dell’Orsi33, serviva da porta di collegamento con l’esterno e l’entroterra dell’Aspromonte, ma anche, e soprattutto, per irreggimentare le acque provenienti dalle sorgenti a monte della linea difensiva e discendenti lungo il vallone Milligri fino in cit-
I settori principali della difesa interna locrese erano costituiti dalle cime di tre colli allineati, denominati Castellace, Abbadessa e Mannella. Le fortificazioni elevate su queste alture e le opere di collegamento attraverso i valloni che le separano costituivano il fronte occidentale, o di
30
In generale su questo settore del sistema difensivo FOTI 1977, p. 347; BARRA BAGNASCO 1996a, pp. 242, 249. 31 supra pp. 12 nota n. 78, 14. 32 DE FRANCISCIS 1959b; VAN BUREN 1961, p. 382; FOTI 1977, p. 347; COSTAMAGNA-SABBIONE 1990, pp. 269-272; BARRA BAGNASCO 1996a, p. 243. 33 infra p. 62 nota n. 35.
26
Per il complesso e le fasi della porta di Quote San Francesco FOTI 1977, p. 347; COSTAMAGNA-SABBIONE 1990, pp. 264-268; BARRA BAGNASCO 1996a, pp. 243, 246-247, 252-253. 27 BARRA BAGNASCO 1996a, p. 248. 28 ORSI 1910. 29 BARRA BAGNASCO 1996a, p. 272
61
tà. Per questo motivo l’opera, certamente funzionante in età ellenistica, era caratterizzata da un varco a baionetta, capace di rompere l’irruenza delle acque durante i periodi di piena34.
dimostra la funzionalità con l’applicazione delle leggi del fiancheggiamento e della difesa avanzata e conferma, proprio a Locri, l’efficacia della scelta di una difesa simile per i siti d’altura e di dorsale38.
Le difese del colle di Abbadessa sono meno note, ma è documentata la presenza di una torre quadrata già evidentemente scoperta dall’Orsi e che si può certamente considerare operativa in epoca ellenistica35. Meglio conosciute sono invece le strutture difensive dello sbarramento del vallone Saitta, compreso fra le vette di Abbadessa e Mannella. Come nel vallone Milligri, anche qui le strutture furono realizzate in opera isodoma con abbondante impiego di calcare, per meglio far fronte alla violenza delle acque in piena; constavano di un varco rastremato, sul quale convergevano i bracci di mura discendenti dai due colli, e di un lungo muro d’argine, spesso 2,45 metri, come le mura arcaiche, ortogonale allo stipite nord del varco, che, oltre ad irreggimentare le acque a monte dell’ingresso in città, faceva da terrazzamento all’area sacra, dove fu identificato dall’Orsi il celebre Persephoneìon di Locri Epizefiri36. Si può presupporre che l’assetto della fortificazione, risalente probabilmente ad epoche precedenti, fosse tale anche in età ellenistica, dal momento che è nota la distruzione del santuario di Persefone nel 205 a.C. Il varco del vallone Saitta era collegato alla vetta della Mannella tramite un braccio di mura che saliva la ripida dorsale ed era probabilmente realizzato con un impiego di materiale minore rispetto agli altri tratti, in relazione alla natura del terreno. Sul colle le fortificazioni erano costituite da una torre rotonda, che l’Orsi scavò nel 1891, e già nel 1902 era quasi completamente scomparsa; essa è riconducibile per tipologia ad un’epoca più recente rispetto a quella di definizione del primo tracciato, presumibilmente al IV sec. a.C. o alla fine dello stesso, durante le ristrutturazioni che verosimilmente interessarono anche un luogo importante come il colle della Mannella, dominante il Persephoneìon e sede di un santuario di Athena37.
§ Il fronte settentrionale Immediatamente ad est della torre rotonda le mura iniziavano il percorso discendente verso valle per raccordarsi al tratto di pianura del fronte nord presso il dromo, così come avveniva lungo il fronte sud, ma in località Marzano, a poca distanza dalla sommità del colle, probabilmente in età ellenistica, fra IV e III sec. a.C., le mura, che in questa zona si presentavano spesse circa 2,50 metri, come quelle arcaiche, ma realizzate secondo la tecnica a paramenti ed émplekton collegati da diatoni a distanze regolari, furono armate con una poderosa torre rettangolare (circa 9,00 × 8,00 metri). Essa era realizzata in blocchi di calcarenite arenacea con paramenti in calcare e ancor oggi presenta la camera inferiore vuota; non è dato sapere, se tale essa fosse anche in antico, visto che la struttura fu utilizzata come casa rustica, ma, in mancanza di dati di scavo esaurienti, l’opera e le cortine limitrofe presentano delle caratteristiche che le farebbero collocare fra i tipi ellenistici, per quanto le ripuliture degli anni’50 documentino rinvenimenti in fondazione, non ben precisati, di ceramica arcaica e le grandi dimensioni a Locri siano comuni già in quell’epoca, come dimostrano le torri della Porta di Afrodite e di Castellace39. Il circuito murario proseguiva scendendo verso mare per giungere al pianoro di contrada Caruso, dove già l’Orsi portò alla luce un tratto di cortina che delimitava l’area affacciantesi sul vallone di Polisà. La zona era inoltre protetta da un grande rientrante a tenaglia, che le mura descrivevano a monte del pianoro, seguendo le concavità del pendio similmente al settore mediano del fronte d’altura sud. Circa nel mezzo delle mura di Piani Caruso si apriva una porta a semplice varco, per collegare la città al santuario rupestre delle Ninfe, il quale, essendo frequentato dal V al II sec. a.C., dimostra che l’apprestamento doveva essere perfettamente funzionante in età ellenistica. Infine le indagini svolte nel settore durante gli anni ’40 del secolo scorso hanno portato all’individuazione di un muro di contenimento interno al circuito urbano, che terrazzava il pianoro in direzione nord-sud, svolgendo forse anche una funzione difensiva40.
Infine il sistema difensivo del fronte occidentale, considerato nel complesso, permette di notare un aspetto particolare, infatti i due varchi, posizionati sul fondo dei valloni Milligri e Saitta, costituiscono i vertici dei rientranti di due grandiose tenaglie, i cui corni sono fortificati dalle tre torri edificate sui rispettivi colli, utilizzando quella mediana di Abbadessa come opera funzionante per entrambe. Il sistema, già impostato in età arcaica, dimostra che la natura dell’entroterra locrese indusse in maniera istintiva l’applicazione dello schema tanagliato, ma evidentemente il suo mantenimento fino all’età ellenistica ne
A valle del pianoro di Caruso, in contrada Pirettina, poco a più a nord del tempio di Marafioti, le mura presentavano un ulteriore varco realizzato per la fuoriuscita del corso d’acqua discendente dal vallone Saitta41, che circa in quel punto, davanti alla fronte esterna delle fortificazioni,
34
FOTI 1977, p. 347; LATTANZI 1982b, p. 232; COSTAMAGNA-SABBIO1990, p. 49. 35 ORSI 1902, p. 41; OLDFATHER 1927; ZANCANI MONTUORO 1961, p. 670; BARILLARO 1964a, p. 7-8; BARRA BAGNASCO 1996a, p. 243. 36 ORSI 1909b, pp. 406-410; ARIAS 1946a, p. 74; FOTI 1977, pp. 353354. Sul Persephoneìon della Mannella ORSI 1909a, pp. 321-322; ORSI 1909b, pp. 410-418; ORSI 1911, pp. 67-75; ARIAS 1946a, pp. 76-78; ZANCANI MONTUORO 1959; DE FRANCISCIS 1971, pp. 75-99; COSTAMAGNA-SABBIONE 1990, pp. 278-283. 37 ORSI 1902, pp. 41-42; COSTAMAGNA-SABBIONE 1990, pp. 275-277; BARRA BAGNASCO 1996a, p. 244. Sull’Athenaìon della Mannella ORSI 1909a, pp. 322-323; ORSI 1911, pp. 62-67; ZANCANI MONTUORO 1959; DE FRANCISCIS 1971, pp. 81-82; COSTAMAGNA-SABBIONE 1990, p. 273 NE
38
Sugli schemi tanagliati supra pp. 42-43. È probabile che anche in località Marzano, come a valle, le mura siano state impiantate in età arcaica e poi abbiano subito dei rifacimenti a partire dalla fine del IV sec. a.C. Su torre Marzano DE FRANCISCIS 1959b; COSTAMAGNA-SABBIONE 1990, pp. 273-275; BARRA BAGNASCO 1996a, p. 244; TRÉZINY 2004 p. 611. 40 infra p. 66 nota n. 68; BARRA BAGNASCO 1996a, p. 249. Sul santuario di Grotta Caruso ARIAS 1946b; COSTABILE 1991. 41 COSTABILE 1992, p. 37; BARRA BAGNASCO 1996a, p. 250. 39
62
incontrava le acque del vallone Polisà, creando un torrente abbastanza ampio, sfruttato come difesa avanzata dal fronte settentrionale lungo il tratto di pianura, analogamente alla fiumarella discendente dal vallone Stranghilò, lungo il fronte sud. Il corso d’acqua infatti, seguendo circa il percorso dell’attuale strada di collegamento fra l’Antiquarium e l’area archeologica del teatro, scendeva fino alla costa per sfociare in mare e anticamente impose al fronte nord del circuito murario la direzione inclinata verso sud, discordante con l’orientamento degli assi viari42.
est per collegarsi a una lunga ed ampia plateìa nord-sud, l’ultima ad est prima del fronte di mare, che, attraversando le contrade Marasà e Centocamere, collegava il santuario del tempio ionico con la principale plateìa nordsud, diretta al santuario di Afrodite fuori le mura, e verosimilmente proseguiva fino all’incontro del fronte meridionale, dove è stata ipotizzata la presenza di una porta simmetrica a quella di Parapezza48. Questioni interpretative
Presso l’incrocio fra il dromo e il ramo settentrionale delle fortificazioni discendenti dalla Mannella, è ipotizzata, perché non ancora rinvenuta, l’esistenza di una porta simmetrica a quella del fronte sud di Quote San Francesco, che doveva svolgere un’analoga funzione, mettendo in collegamento la città con la parte settentrionale della sua chòra in direzione di Caulonia, e verosimilmente in età ellenistica era fortificata con un’opera a cortile adeguata alla sua importanza43.
L’impianto difensivo locrese a causa delle sue caratteristiche planimetriche e costruttive stimola parecchie osservazioni § La Geländemauern Il sistema difensivo di Locri Epizefiri, durante tutte le sue fasi di vita, rappresenta un mirabile esempio di «Geländemauern», non solo per l’estesissima area occupata (230 ettari in un perimetro di 7,5 chilometri), la notevole capacità di sfruttamento della natura del terreno da difendere e la felice integrazione fra le difese di pianura e quelle d’altura, ma per il fatto che rappresenta una delle più antiche applicazioni di questo genere di circuito, ben prima dei termini cronologici tradizionali per esso definiti49. Dunque fra il IV sec. a.C. e l’epoca ellenistica i Locresi non appresero altrove la nozione di «Geländemauern», battendo sul tempo addirittura i loro alleati Siracusani, che chiusero l’Epipole con un circuito simile soltanto alla fine del V sec. a.C.50 e, non a caso, elessero Locri a loro principale alleata e base militare per le operazioni contro la Lega Italiota.
Il lungo tratto rettilineo che collegava la porta nord con la torre di Parapezza Est fu realizzato anch’esso durante la seconda metà del VI sec. a.C., come hanno dimostrato le indagini archeologiche condotte presso i cavi di fondazione delle mura in località Parapezza44 e San Cono45. Durante l’età ellenistica in conseguenza al mantenimento della solita tecnica costruttiva, sia per le fondazioni sia per l’elevato, è verosimile, come per gli altri fronti, che anche quello settentrionale non avesse cambiato il suo aspetto esteriore, tuttavia il tratto più ad oriente, che costeggiava il témenos del tempio ionico di Marasà, risulta essere stato ispessito fino a circa 4 metri, come accadde lungo il fronte di mare, probabilmente verso la fine del IV sec. a.C. o l’inizio del successivo, in modo da far ipotizzare un elevato rilavorato in età ellenistica e forse dotato di belostàseis46.
§ La teichopoiìa locrese Colpisce piuttosto, in seno ad una tradizione difensiva così ben radicata, la mancanza di un’applicazione altrettanto precoce dei precetti della nuova teichopoiìa fin dall’inizio del IV sec. a.C. Tenendo conto che furono i Locresi, intorno alla metà del IV sec. a.C., a riedificare le mura di Caulonia, con una ricca serie di torri sporgenti dalla linea difensiva lungo tutti i fronti del circuito, sembra strano rilevare la nascita di tali opere a Locri per la maggior parte alla fine dello stesso secolo, se si escludono i casi delle torri della Porta di Afrodite, di Castellace e forse di Abbadessa. Tuttavia le tabelle bronzee rinvenute nella teca del santuario di Zeus51 documentano chiaramente nel periodo a cavallo fra IV e III sec. a.C. una notevole attività di ristrutturazione delle mura, la famosa pyrgopiìa, espressione che, sebbene debba essere intesa in termini generali, allude specificamente alla costruzione di torri, quali possono essere quelle di Parapezza, presso la porta e presso l’angolo nord-est del circuito, quelle delle porte
Infine sempre nella stessa località le mura erano attraversate da un’altra porta, la cosiddetta Porta di Parapezza, che fu già realizzata contestualmente all’edificazione delle mura arcaiche, come le altre simili, con stipiti e platea in calcare. In epoca ellenistica tuttavia subì un vistoso rifacimento con la realizzazione presso lo stipite occidentale di una grande torre di forma ellittica, databile alla fine del IV-inizio del III sec. a.C., che sporgeva verso l’esterno con tutto il suo corpo di fabbrica e si raccordava alle mura tramite un avancorpo, mentre poco più ad ovest fu realizzata una rampa scalare ortogonale alle mura, per l’accesso al cammino di ronda e al complesso della porta47. L’orientamento del varco inoltre non risultava perpendicolare alla linea delle mura, ma inclinato verso sud42
BARRA BAGNASCO 1996a, pp. 248, 251 nota n. 52. BARRA BAGNASCO 1996a, p. 250. 44 FOTI 1977, pp. 348-349; BARRA BAGNASCO 1996a, p. 271 45 FOTI 1978, pp. 454-457. 46 COSTAMAGNA-SABBIONE 1990, pp. 184-185; BARRA BAGNASCO 1996a, p. 265 nota n. 103. 47 DE FRANCISCIS 1955, p. 154; DE FRANCISCIS 1956; VAN BUREN 1958, p. 421; SABBIONE 1977, p. 894; GULLINI 1980, p. 110; COSTAMAGNA-SABBIONE 1990, pp. 184-186; BARRA BAGNASCO 1996a, pp. 244, 250-251; LATTANZI 1996, pp. 679-680; TRÉZINY 2004, p. 620. 43
48
supra p. 58 nota n. 11 e inoltre BARRA BAGNASCO 1996a, pp. 247, 251. Per l’ipotesi della porta simmetrica a quella di Parapezza BARRA BAGNASCO 1996a, p. 253. 49 supra p. 16. 50 supra p. 16 nota n. 108. 51 DE FRANCISCIS 1972, pp. 126-127, 163-169; COSTABILE 1992, pp. 152-170; BARRA BAGNASCO 1996a, p. 270
63
nord e sud del dromo, la torre dell’angolo sud-est del circuito, quella circolare della Mannella e forse torre Marzano. D’altro canto si è già rilevato che i Locresi per tutto il IV sec. a.C. non sentirono la necessità di trasformare in maniera più difendibile il fronte di mare, pur attraversando la prima metà del secolo in guerra costante al fianco di Siracusa. Ma è probabile che proprio la magniloquenza del fronte di mare contenga in sé parte della risposta alla constatazione precedente, poiché Locri, sentendosi ben protetta sul fronte di terra dalla sua antica «Geländemauern», confidava evidentemente di più su una strategia offensiva, operante in special modo sul mare, facendosi forte della flotta siracusana e della sua, che potè ancora fornire ai Romani delle navi nel 264 a.C. per affrontare i Cartaginesi nel Mediterraneo. Una simile strategia può d’altro canto essere suggerita dalla presenza del porto così a ridosso della città, collegato direttamente con il settore urbano settentrionale dedicato ai santuari, e comunque ben difeso dalle due opere murarie che, definendone il bacino, operavano come dei veri e proprii proteìchismata per la difesa avanzata del litorale e dell’ingresso dal mare. Infine potrebbe comprovare questa interpretazione la spedizione siracusana contro Reggio, voluta dai Locresi e partita da Locri durante la guerra contro la Lega Italiota, poco prima della battaglia dell’Elleporo52.
San Francesco appartiene al tipo a cortile, un’evoluzione del tipo a corridoio rappresentato dalla porta di Casa Quaranta a Caulonia54, ma, così come la Porta di Parapezza, quella di Quote era probabilmente dotata di una sola torre poderosa, similmente alla porta cauloniate della Neapolis occidentale55. L’utilizzo di una grande torre come elemento difensivo principale di un varco, che a Caulonia è stato rilevato nella porta di Aulon56, sembra un uso locrese antico, se si considera la conformazione della prima fase della Porta di Afrodite, con la grande torre meridionale associata ad un’opera di dimensioni più ridotte, ma contemporaneamente il tipo della porta a varco semplice con percorso ortogonale alle mura e difeso da due torri ben armate, al quale corrisponde la Porta di Aulon, si ripropone nel rifacimento della Porta di Afrodite durante il III sec. a.C. In tale contesto trova inoltre un’adeguata collocazione la osservazione della Barra Bagnasco, quando rileva che la conservazione della tecnica del mattone crudo per gli elevati di età ellenistica non costituisce solo un dato di conservazione, bensì è una prova di evoluzione nell’utilizzo di un materiale che poteva efficacemente assorbire gli urti dei proiettili, scagliati dai grandi petroboli. È tuttavia opportuno tener presente che tale genere di muratura è comunque motivato dal caso di forza maggiore rappresentato dall’assenza in area locrese di un buon materiale lapideo da costruzione57. La funzione di assorbimento del crudo è comunque ancora segnalata da Apollodoro di Damasco, che, originario delle terre in cui furono inventate e usate da sempre tali tecniche costruttive, scriveva:
Dunque nel IV sec. a.C. i Locresi sono ben lungi dall’essere allieni ai precetti della «stratégie nouvelle», che allora Dionisio I andava diffondendo in Occidente, né tanto meno appaiono alleati succubi di Siracusa, così da guadagnarsi dopo il 389 a.C. il controllo dei territori di Caulonia, Hipponion e Skylletion. A questo punto entra in campo l’esperienza cauloniate. Infatti nell’ex colonia achea, come si è notato nel capitolo dedicato all’analisi delle sue fortificazioni, i Locresi applicarono tutti i principi della nuova teichopoiìa, realizzando grandi torri per le artiglierie, come la D e numerose altre53, che possono benissimo, non foss’altro che per le dimensioni, essere le naturali eredi della torre sud della Porta di Afrodite o di quella di Castellace. Ma sullo scorcio della prima metà del IV sec. a.C. a Locri venne meno l’appoggio di Siracusa e dopo la cacciata di Dionisio II iniziò a profilarsi minacciosa la presenza dei Brezii, cosicché, come provano le tabelle della teca, durante la seconda metà e alla fine del secolo, pur mantenendo la sua apertura verso il mare, la città prese i primi provvedimenti difensivi per l’aumento delle potenzialità dei fronti di terra, ora comunque più minacciati.
Dunque le mura in pietra crollano più rapidamente di quelle in mattoni. La tenerezza del mattone infatti indebolisce il colpo ed esso si incava piuttosto che crollare. La pietra invece oppone resistenza, riceve più violentemente il colpo e così crolla; molto di più inoltre vengono danneggiate le porte, gli angoli delle torri e quante difese si oppongano con non molto spessore […]58
Infine è verosimile attribuire la grande trasformazione del fronte di mare non tanto ai tempi della guerra di Pirro, quanto piuttosto, confidando sui dati derivanti dagli interventi archeologici, ad un periodo compreso fra la Prima e la Seconda Guerra Punica, quando, venuta meno definitivamente la potenza navale siracusana, Locri non poteva più pensare di fronteggiare da sola la minaccia dei Cartaginesi dal mare e in generale una situazione politica internazionale, in cui le forze di una sola pòlis non erano in
Le nuove opere furono realizzate secondo le tecniche difensive contemporanee, come può essere il caso delle torri circolari alla Mannella e Parapezza, ma è molto probabile che i Locresi abbiano tratto grande ispirazione dalle difese realizzate pochi decenni prima a Caulonia, in modo tale che la loro cultura fortificatoria, esportata ed evolutasi in un sito da ricostruire ex novo, poté tornare ad operare in patria, non solo seguendo principi teorici, ma anche forte di una insostituibile esperienza pratica. È emblematico il caso delle porte ellenistiche note. La porta di Quote 52 53
54
supra pp. 51, 55. supra p. 52; inoltre per i confronti con le porte a cortile supra p. 18. 56 supra p. 52. 57 BARRA BAGNASCO 2000, p. 12; TRÉZINY 2004, pp. 606-607. Nasce di nuovo spontaneamente un confronto con l’epoca moderna, quando durante il XVI secolo non tutte le scuole di ingegneri militari sostenevano la validità delle poderose murature a paramenti di mattoni e nuclei in ciottoli e calce, per resistere al-l’urto dei proiettili sparati dagli assedianti. In particolare esisteva il gruppo dei fratelli Savorgnan che proponeva la realizzazione di semplici paramenti immediatamente frantumabili dalle palle di cannone, ma che affidavano il completo assorbimento dell’urto al terrapieno del bastione senza opporre una superficie di rimbalzo (BONARDI, pp.74-75). 58 Arte dell’assedio (1999), 158,1, dove il termine pl¤nyow significa appunto «mattone crudo». 55
supra p. 57 nota n. 2 e in particolare NIUTTA 1977, p. 269. supra pp. 50-51.
64
grado di garantire il successo di una strategia bellica attiva.
§ L’acropoli di Locri Infine esiste un’ultima questione che è quella dell’assetto difensivo della città alta nel settore nord-occidentale dei primi declivi, antistanti la zona più impervia delle cime di Abbadessa e Mannella. Le ricerche archeologiche della prima metà del ‘900 hanno restituito alcuni dati importanti, quando l’Orsi e poi l’Arias indagarono questo settore alla ricerca di testimonianze che documentassero la presenza del primo insediamento dei coloni locresi. Narra infatti Strabone che, dopo l’arrivo al capo Zefirio, i coloni
§ Le mura e l’idrografia del sito Un problema rilevante ereditato dal sistema difensivo ellenistico, ma già risolto in maniera funzionale nei secoli precedenti, è quello della gestione dei corsi di numerosi torrenti interni al circuito murario. Sono noti tre principali bacini idrici, ovvero quello del vallone Stranghilò e quelli più grandi dei valloni Miligri e Saitta-Abbadessa. Il primo ha origine all’interno del circuito murario, gli altri due derivano dalle alture a monte del fronte occidentale e determinarono in antico la realizzazione dei due complessi di sbarramento e passaggio sul fondo dei canaloni.
¶th m¢n oÔn tr¤a µ t°ttara ’koun §p‹ t“ Zefur¤ƒ: e‰ta metÆnegkan tØn pÒlin, sumprajãntvn ka‹ Surakous¤vn [...] ÜIdrutai d'≤ pÒliw §p'ÙfrÊow, ¥n ÉEs«pin kaloËsi60.
L’Orsi rivolse la sua attenzione al pianoro di contrada Cusemi e, in seguito al rinvenimento del tempio di casa Marafioti, estese le indagini nelle vicinanze individuando lungo il bordo orientale del pendio un poderoso muro in opera isodoma, spesso 2,50 metri e assai simile a quelli arcaici della fortificazione a valle, ma del quale non fornì una datazione. Le fondazioni dell’opera, come nel caso dei muri d’argine del vallone della Mannella, erano gradinate per meglio assolvere alla funzione di contenimento, ma l’Orsi propose anche una interpretazione della medesima struttura come opera di fortificazione, alla luce del rinvenimento successivo, costituito da una platea in blocchi di calcarenite arenacea disposti di testa, solidale al muro di contenimento e piuttosto ampia (circa 6,00 × 5,00 metri), che egli ricondusse all’impianto di una torre61. A monte di contrada Marafioti e lungo il confine occidentale di contrada Cusemi era noto da tempo un lungo tratto di muro, realizzato in calcarenite arenacea, che fu più volte interpretato come opera di terrazzamento, ma che in realtà separa due aree di un dolce declivio che non necessita poderose strutture di contenimento, quale appare il muro in questione. Perciò, pur ammettendo una funzione simile, trattandosi di un’opera in pendio, è verosimile una più specifica funzione militare62. È dunque probabile che la dorsale discendente dal colle di Abbadessa fosse stata chiusa fin dalla seconda metà del VI sec. a.C., contestualmente alla definizione dell’impianto urbano e difensivo, da due strutture con andamento nord-sud, parallele fra di loro e alla linea di costa, che isolavano un’area ben delimitata a nord e a sud dai valloni Saitta e Milligri. Inoltre in questo settore non solo l’Orsi portò alla luce il tempio di Marafioti e riferiva dell’esistenza di un grande edificio in blocchi e grappe metalliche andato distrutto nel XIX secolo63, ma fu rinvenuto in seguito a ricerche più recenti un gruppo di frammenti ceramici di VII sec. a.C., associati ad impasti dell’età del ferro indigeni64.
I varchi a valle dovevano garantire la fuoriuscita delle acque, per evitare l’allagamento dell’abitato e l’effetto diga contro le mura del fronte di mare. Innanzitutto sono noti due varchi che alleggerivano l’impatto dei torrenti sulla città bassa e venivano riutilizzati a scopi difensivi, si tratta del varco di Quote San Francesco, dal quale fuoriusciva il torrente del vallone Stranghilò, per proteggere il fronte meridionale di pianura, e quello simmetrico di contrada Pirettina, attraversato dalle acque del vallone Saitta, che svolgevano la stessa funzione protettiva per il fronte nord. Lungo il fronte di mare erano aperti gli altri tre varchi a Centocamere Sud, a Marasà Sud presso la Porta di Afrodite e l’ultimo presso la Porta Portuense. La loro importanza era tale che neanche le ristrutturazioni del III sec. a.C. ne segnarono la fine; attraverso i primi due fuoriuscivano probabilmente due diramazioni del torrente di Milligri, mentre dal terzo, considerato il poderoso apprestamento, è necessario ipotizzare il passaggio di un torrente derivante forse dal vallone Saitta, arricchito da affluenti minori che nascevano anticamente dalle alture interne al circuito. Sta di fatto che la fortificazione locrese di fronte al problema dell’acqua dovette cedere il passo e sacrificare sempre le esigenze difensive a quelle dello smaltimento idrico, che fu previsto fin dai tempi della creazione dell’impianto urbano e del sistema difensivo, come dimostrano le cronologie dei varchi stessi, e già probabilmente razionalizzato e ripartito in canalizzaioni artificiali all’altezza del dromo59. Analogo è il rapporto fra il circuito murario e l’impianto urbano, ma in questo caso il primo conserva l’autonomia conferitale dall’adeguamento necessario e sempre rispettato, alla natura del suolo. L’impianto urbano assunse l’orientamento migliore fin dalla seconda metà del VI sec. a.C., imponendo alle difese l’apertura delle porte là dove risultava necessario, e tale assetto rimase costante fino all’età ellenistica, quando furono piuttosto modificate le opere difensive delle porte, ma non le loro localizzazioni.
60
Geografia (1967), VI, 1, 7. ORSI 1912a, pp. 18-19 62 ORSI 1911, p. 75; BARILLARO 1964a, pp. 12-13; FOTI 1977, p. 358; COSTAMAGNA-SABBIONE 1990, p. 52; BARRA BAGNASCO 1996a, p. 242 nota n. 24. Pertanto è decisamente condivisa l’ipotesi di una funzione militare, svolta da tale muro, proposta recentemente dal Tréziny (2004, pp. 598-600). 63 ORSI 1909a, p. 75. 64 FOTI 1977, p. 358; BARRA BAGNASCO 1983, p. 3. Nel 1978 furono inoltre condotte delle indagini da parte dell’Università di Torino in contrada San Cono, immediatamente a valle dell’area di Cusemi-Marafioti, 61
59 BARRA BAGNASCO 1996a, p. 248; SCONFIENZA 1996, pp. 58-59; BARRA BAGNASCO 2000, pp. 16, 30, 31.
65
Il complesso dei rinvenimenti lascia dunque presupporre che quest’area del pianoro di Cusemi corrisponda all’Esòpis straboniana, ovvero al sito in cui si stanziarono i Locresi con il contingente di rinforzo siracusano alla fine dell’VIII sec. a.C. Al momento in cui furono compiute le principali opere di organizzazione e difesa urbana, l’Esòpis fu munita di fortificazioni, trasformandosi in una vera e propria acropoli, depositaria delle tradizioni più antiche della colonia. Pertanto in epoca ellenistica le difese erano probabilmente le stesse dell’età arcaica, ma, in seguito all’edificazione del teatro65, l’intero complesso assunse l’aspetto monumentale e scenografico tipico di quel periodo, che poteva essere inoltre suggerito dalla frequentazione assidua con Siracusa. D’altro canto una conferma del valore centrale assunto dalla contrada Cusemi fin dall’età arcaica consiste nel fatto che ad essa conducevano sia la grande plateìa est-ovest, che si collegava attraverso la Porta di Afrodite al santuario omonimo fuori le mura del fronte di mare66, sia un’ipotetica via nascente dalla Porta Portuense, che, collegandosi a valle con il santuario del tempio ionico di Marasà, intercettava il dromo proprio davanti al tempio di Marafioti e proseguiva poi verso il vallone Saitta per raggiungere i santuari della Mannella e di Grotta Caruso67.
dava sul vallone Polisà e dominava dall’alto l’acropoli dell’Esòpis. § Le duae arces di Livio A questo punto vale la pena riportare i passi di Livio in cui si descrive l’attacco del 205 a.C. condotto dal contingente romano di Quinto Pleminio, luogotenente di Scipione, che riuscì ad impadronirsi di una delle duae arces locresi, ricordate dallo storico romano, e da lì mantenere un caposaldo fino all’abbandono della piazza da parte dei Cartaginesi, ripetutamente battuti nelle scaramucce urbane e minacciati dalla flotta di Scipione che giungeva da Reggio […] Partirono da Reggio, portando delle scale fabbricate per l’altezza della rocca, e circa a mezzanotte da quel luogo che si era convenuto diedero il segnale a coloro che avrebbero dovuto consegnare la rocca. Questi stavano pronti e attenti e, dopo aver essi stessi calato delle scale fatte allo scopo, accolsero gli assalitori che salivano contemporaneamente in più punti. Prima che cominciasse il clamore furono assalite le sentinelle cartaginesi, che dormivano come se non temessero nulla di simile. All’inizio si udì il gemito dei morenti, poi dalla sonnolenza furono improvvisi lo sbigottimento e la confusione, perché se ne ignorava la causa, infine la situazione fu più chiara quando l’uno si dava a svegliare gli altri. Ormai per proprio conto ognuno dava l’allarme: i nemici erano sulla rocca e le sentinelle erano state uccise. I Romani, assolutamente inferiori di numero, sarebbero stati sopraffatti, se le urla levate da quelli che stavano ancora fuori dalla rocca non avessero reso incerto il luogo da dove provenivano, mentre il tumulto notturno ingrandiva ogni vana supposizione. Pertanto i Cartaginesi atterriti, come se la rocca fosse stata ormai colma di nemici, abbandonarono lo scontro e ripiegarono sull’altra rocca, esse sono due infatti e non molto distanti fra di loro. Gli abitanti stavano in città, posta nel mezzo come un premio per i vincitori, mentre quotidianamente dalle due rocche si verificavano delle scaramucce. Quinto Pleminio era a capo del presidio romano, Amilcare di quello cartaginese. Essi, facendo arrivare rinforzi da luoghi vicini, aumentavano gli effettivi. Alla fine lo stesso Annibale si mise a marciare su Locri e i Romani non avrebbero potuto farvi fronte, se la popolazione di Locri, esacerbata dall’arroganza e dall’avidità dei Cartaginesi, non fosse passata dalla parte dei Romani69
Negli anni ’40 del secolo scorso l’Arias volse i suoi interessi a contrada Caruso, dove rinvenne il santuario rupestre delle Ninfe, ma le indagini furono estese a tutto l’altopiano, limitato a nord da un tratto di mura già note all’Orsi, nella convinzione che quello fosse il sito dell’antica Esòpis, poiché dominava dall’alto le altre contrade di pendio, Cusemi e Pirettina. In realtà i risultati dei sondaggi restituirono l’immagine di un insediamento rarefatto, di ambienti semplici e qualche fornace, databili non prima della metà del IV sec. a.C., ma emersero anche i resti di un grande muro di sostruzione in blocchi di calcare con tramezzi di tegoloni, spesso soltanto 1 metro, che era collocato lungo il limite orientale del pianoro, con direzione nord-sud, e che fu datato nel tardo V sec. a.C., poiché all’interno della tessitura dell’opera si rinvennero i frammenti di un pinax risalente alla seconda metà del secolo68. Sembra pertanto, in base alla documentazione archeologica, che l’altopiano di Caruso non corrisponda all’Esòpis, ma che sia un’area periferica che venne riplasmata con un muro di contenimento alla fine del V sec. a.C., probabilmente in relazione alla presenza della strada, che attraverso la porta delle mura del fronte settentrionale conduceva al santuario delle Ninfe, appunto frequentato a partire dallo stesso secolo. In età ellenistica l’altopiano si presentava foderato da un’opera meno poderosa rispetto alle mura urbane o a quelle di Cusemi, ma comunque delimitante un settore difensivo connesso all’accesso della porta che
I Romani attuarono dunque un vero e proprio attacco di sorpresa, scalando le mura di una delle due acropoli, secondo una ben nota pratica degli assalti alle rocche, frequente in epoca ellenistica e inaugurata da Alessandro al69 Ab urbe condita (1957), XXIX, 6, 10-16. Si riporta il testo latino per una verifica diretta del problema nella lingua originale:
[…] Profecti ab Regio, scalas ad editam altitudinem arcis fabricatas portantes; media ferme nocte ex eo loco unde conuenerat signum dedere proditoribus arcis; qui parati intentique et ipsi scalas ad id ipsum factas cum demisissent pluribusque simul locis scandentes accepissent, priusquam clamor oreretur in uigiles Poenorum, ut in nullo tali metu sopitos, impetus est cactus. Quorum gemitus primo morientium exauditus, deinde subita consternatio ex somno et tumultus cum causa ignoraretur, postremo certior res aliis excitantibus alios. Iamque ad arma pro se quisque uocabat: hostes in arce esse et caedi uigiles; oppressique forent Romani nequaquam numero pares ni clamor ab iis qui extra arcem erant sublatus incertum unde accidisset omnia uana augente nocturno tumultu fecisset. Itaque uelut plena iam hostium arce territi Poeni omisso certamine in alteram arcem - duae sunt haud inter se distantes - confugiunt. Oppidani urbem habebant, uictoribus praemium in medio positam; ex arcibus duabus proeliis cottidie leuibus certabatur. Q. Pleminius Romano, Hamilcar Punico praesidio praeerat. Arcessentes ex propinquis locis subsidia copias augebant: ipse postremo veniebat Hannibal, nec sustinuissent Romani nisi Locrensium multitudo, esacerbata superbia atque avarizia Poenorum, ad Romanos inclinasset.
in cui si rinvennero dei livelli risalenti al VII sec. a.C., prova definitiva della frequentazione altoarcaica della zona (BARRA BAGNASCO 1979, pp. 398-403; BARRA BAGNASCO 1985, pp. 183-185). 65 ARIAS 1946a, pp. 75-76; BARILLARO 1964b; TODISCO 1990, pp. 133137; COSTAMAGNA-SABBIONE 1990, pp. 251-260. 66 BARRA BAGNASCO 1996a, pp. 239 nota n. 9, 258; supra p. 58 nota n. 11. 67 BARRA BAGNASCO 1996a, pp. 247-248; BARRA BAGNASCO 2000, p. 24. 68 ARIAS 1946a, pp. 74-76; ARIAS 1947, pp. 165-171.
66
l’assedio di Sogdiana70. Gli assalitori riuscirono a rimanere padroni del campo, inducendo i Cartaginesi ad abbandonare la posizione, per attestarsi sulla seconda acropoli. Alla luce dei rinvenimenti archeologici e delle considerazioni precedenti si può ipotizzare che Livio, ben lungi dal riferirsi alle torri di Abbadessa e Mannella, com’è già stato proposto71, riconoscesse in un’arx l’acropoli vera e propria di contrada Cusemi, mentre nell’altra la postazione di Piani Caruso. Esse sono però nominate non in ordine d’importanza, ma in base alla dinamica degli eventi, perciò la prima arx, conquistata di sopresa dai Romani, è l’altopiano di Caruso, che, affacciandosi a nord sul vallone Polisà, rese necessario l’impiego delle scale, indicate chiaramente dallo storico, ed essendo in posizione accentrica lungo le mura, a differenza dell’altopiano di Cusemi, fu logicamente considerata da Pleminio l’obiettivo principale dell’azione, tale da poter garantire il mantenimento della posizione grazie alla sua orografia. Di conseguenza la seconda arx nominata da Livio è quella di Cusemi, in realtà la vera acropoli di Locri, ma dominata da quella occupata dai Romani e, in quel frangente, l’unica posizione difendibile dai Cartaginesi, per impedire ai Romani la conquista totale della città. In questa prospettiva si capisce bene perché Livio, dicendo che le acropoli sono due, specifica haud multum inter se distantes, se si considera che i due altopiani sono separati soltanto dal tratto finale del vallone Saitta. Pertanto è necessario pensare che in età ellenistica le due postazioni d’altura fossero un elemento ben integrato nel sistema difensivo, tanto quanto le tre torri del fronte occidentale, prova ne è che anche in ragione della presenza di una porta i Cartaginesi presidiavano Piani Caruso. Ma d’altro canto, ancora una volta, sembra calzante il confronto con Caulonia, dotata anch’essa di due postazioni d’altura, il Colle A e la Piazzetta, non molto distanti fra loro e separate dalla sella del vallone Campana, che corrispondevano la prima ad un punto strategico dominate a 360° la città e il terreno estreno, la seconda alla vera e propria acropoli urbana72.
70
GARLAN 1974, pp. 204-207. OLDFATHER 1927; Il Barillaro (1964a, pp. 6, 8) cita con relativi rimandi bibliografici le opinioni del Petersen, del Nissen, dello Jacopi e del Larizza, tutte a favore dell’associazione Abbadessa-Mannella, con le quali concorda riferendo ad esse il passo di Livio delle duas arces, sebbene dedichi l’intero lavoro alla dimostrazione dell’esistenza di un’acropoli locrese sull’altopiano di Caruso. 72 supra p. 53. 71
67
68
CAPITOLO
7
Velia
La città di Eléa, denominata poi Velia dai Romani, venne fondata fra il 540 e il 535 a.C. da un gruppo di coloni originari di Focea, che, esuli dalla madrepatria in seguito alla conquista persiana, avevano dovuto lasciare Alàlia sulla costa della Corsica, la prima località in cui si stanziarono dopo la fuga dalla Ionia, a causa della grave minaccia esercitata nei loro confronti dagli Etruschi di Tarquinia e dai Cartaginesi. La nuova colonia sorse lungo la costa tirrenica della Campania a sud del territorio acheo di Poseidonia in località Castellamare della Bruca, nel comune di Ascea, al centro di in una piana costiera delimitata dai fiumi Alento e Palistro a nord e dalla Fiumarella di Santa Barbara a sud. Il sito corrisponde ad un promontorio, su cui sorse l’acropoli della città, che anticamente si protendeva nel mare, essendo piuttosto arretrata la costa antica rispetto a quella moderna, mentre l’immediato entroterra è delimitato dall’allargamento delle dorsali dei colli che fanno sistema con il promontorio dell’acropoli, aprendo due pendii a nord e a sud di esso, su cui si svilupparono i settori dell’abitato1.
L’impianto difensivo velino Velia, dunque, come e forse più di tutte le altre pòleis della Magna Grecia, dovette far affidamento sul proprio sistema di fortificazioni per attraversare indenne le turbolente vicende storiche del IV e III sec. a.C. Tuttavia le ricerche condotte ormai da decenni dalla missione austriaca dell’Università di Innsbruk hanno chiarito che durante l’età ellenistica le mura della città furono al centro di una notevole attività di ristrutturazione e rifacimento, ma non vennero riedificate ex novo, ovvero è ormai invalso che Velia fu già racchiusa all’interno del circuito murato più esteso fin dal tardo arcaismo3. Pertanto, come nel caso di Locri, parlare delle mura ellenistiche di Velia significa illustrare il sistema difensivo che i Focei definirono già sommariamente sul terreno negli ultimi decenni del VI sec. a.C., individuando contemporaneamente gli elementi che furono potenziati a partire dalla fine del IV sec. a.C. in considerazione delle nuove tecniche poliorcetiche4. § Tecniche costruttive e cronologia
Fin dai primi anni di vita Eléa fu un’importante corrispondente di Massalia e delle città della Ionia, fiorendo nel V sec. a.C., quando svolse la stessa attività con Atene. I contrasti con la vicina Poseidonia furono complicati nel corso dello stesso secolo in seguito alla venuta dei Lucani, perciò la colonia focea entrò nella Lega Italiota e, riuscendo comunque ad evitare lo scontro diretto con Dionisio I, seppe difendere il proprio territorio dall’avanzata degli Italici, grazie ad un si-stema limitaneo di phroùria nell’entroterra e al suo efficiente circuito di fortificazioni urbane. Non si dimostrò o-stile a Roma e divenne una civitas foederata subito dopo la fine della guerra tarantina, partecipando con la sua flotta alla Prima Guerra Punica ed aiutando la potente alleata durante la guerra annibalica. Fu infine dichiarata municipium nell’89 a.C.2.
Prima di iniziare l’analisi dei diversi fronti in età tardoclassica ed ellenistica è bene considerare l’argomento delle tecniche costruttive, che hanno permesso, in associazione ai dati di scavo, di identificare le fasi cronologiche delle mura di Velia5. Le testimonianze risalenti al tardo VI sec. a.C. presentano strutture composte da zoccoli in muratura pseudopoligonale di blocchi d’arenaria, spessi circa 1,80/1,90 metri, 3
Gli archeologi austriaci hanno stabilito questa periodizzazione e modalità costruttiva dopo aver compiuto una serie di saggi in profondità lungo tutti i tratti noti delle mura veline, sia in quelli perimetrali esterni dei fronti nord ed est sia in quelli interni, che collegano il Castelluccio all’acropoli e l’acropoli al quartiere portuale sud (KRINZINGER 1979; KRINZINGER 1980; JOHANNOWSKY 1982, pp. 230-231; KRINZINGER 1986; KRINZINGER 1989; KRINZINGER 1994, pp. 28-29, 37-39; TOCCO SCIARELLI 1993, p. 733; TOCCO SCIARELLI 1994, p. 15; KRINZINGER 1997, p. 968; TRÉZINY 2004, p. 600). L’opinione generale precedente, che derivava dalle inda-gini archeologiche condotte negli anni ’60 e ’70, era quella sostenuta da Mario Napoli, secondo il quale la città si era ampliata progressivamente dal tardo arcaismo, estendendosi dal primo insediamento sull’acropoli verso le dorsali nord e sud prospicienti la costa, e le fortificazioni ne a-vevano seguito lo sviluppo a partire dalla fine del VI sec. a.C., soprat-tutto in due fasi, intorno al 490-480 a.C. e poi fra IV e III sec. a.C. (NA-POLI 1966b, pp. 208-210; NAPOLI 1970a, pp. 232-233; GRECO 1987, p. 190 e nota n. 2; TOCCO SCIARELLI 1994, p. 15). 4 In generale sulle fortificazioni di Velia VAN BUREN 1951, pp. 178-180; SESTIERI 1957, pp. 8, 10; NAPOLI 1964, p. 190; NAPOLI 1966b, pp. 209222; NAPOLI 1966c, pp. 1113-1114; JOHANNOWSKY 1978, p. 348; KRINZINGER 1979; KRINZINGER 1980; JOHANNOWSKY 1982, pp. 230231; KRINZINGER 1986; KRINZINGER 1994, pp. 28-30, 37-39, 46-48; KRINZINGER 1997, pp. 967-968. 5 KRINZINGER 1979, p. 63; KRINZINGER 1980, pp. 358-361; KRINZINGER 1994, pp. 28-30, 37, 38, 54 nota n. 53; KRINZINGER 1997, p. 968.
1
Sulla geomorfologia del sito NAPOLI 1964, pp. 191-192; NAPOLI 1966b, pp. 202-203; NAPOLI 1966c, pp. 1113-1114; SCHMIEDT 1970b; BAGGIONI LIPPMANN 1982; ORTOLANI 1999, in particolare pp. 132133. Sulla topografia della città e sull’impianto urbano, il suo sviluppo e le fasi NAPOLI 1964; NAPOLI 1965; NAPOLI 1966a; NAPOLI 1966b; NAPOLI 1966c, pp. 1114-1115; SCHMIEDT 1968-69, pp. 414-415; SCHMIEDT 1970a, pp. 62-63, tav. LXIV; NAPOLI 1970a; NAPOLI 1973, pp. 303-304; NAPOLI 1974; NAPOLI 1975; NEUTSCH 1980, pp. 1615-1616; GRECO 1981a, pp. 40-48; GUZZO 1982, pp. 221-224; JOHANNOWSKY 1982; GRECO-TORELLI 1983, pp. 216-219; JOHANNOWSKY 1983; GRECO 1987, pp. 189-192; GRECO 1993, pp. 221-224; KRINZINGER 1994; TOCCO SCIARELLI 1994; KRINZINGER 1997, pp. 967-971. 2 SESTIERI 1957, pp. 2-5; SESTIERI 1962, p. 90; LEPORE 1966; NAPOLI 1966c, p. 1114; MOREL 1970 passim; SCHMIEDT 1970b, pp. 66-70; GRECO 1981a, pp. 37-38; GUZZO 1982, pp. 100; 108-169 passim; JOHANNOWSKY 1982, passim; GRECO-TORELLI 1983, pp. 212, 215-216; PUGLIESE CARRATELLI 1983 passim; CORDANO 1985, pp. 329-335; GRECO 1985, pp. 364-367; GIANGIULIO 1987 passim; LOMBARDO 1987a passim; GRECO 1993, pp. 81-86; KRINZINGER 1994, pp. 19, 42; KRINZINGER 1997, p. 967.
69
sui quali si impostava un elevato in mattone crudo. L’utilizzo dell’opera poligonale a Velia è ben nota negli edifici arcaici del primo insediamento sull’acropoli6, ma il Martin aveva isolato a suo tempo quella delle fortificazioni come tipo autonomo, a causa dell’utilizzo di un’arenaria in grandi blocchi, più tenera e consunta rispetto alle strutture dell’acropoli, e di un assemblaggio grossolano e approssimativo, con ampi vuoti presso le giunture angolari, derivanti da una rapida preparazione dei blocchi dopo l’estrazione dalla cava7.
classico-ellenistico. Alla fine del IV sec. a.C., come già duecento anni prima, il perno di tale sistema a monte era il forte del Castelluccio13, di impianto rettangolare (circa 27 × 10,80 metri) in opera isodoma fin dall’età precedente, ma ora dotato di un fossato dalla parte del fronte d’attacco prima della sella che separa l’altura da un colle superiore a nord-est. Durante la fase ellenistica fu aggiunta una torre quadrata lungo il lato interno del rettangolo, con rampa scalare d’accesso alla gola per l’utilizzo delle artiglierie, e una cisterna collegata tramite un doppio canale alla città, per garantire evidentemente un approvvigionamento idrico alternativo, in caso di eventi ossidionali, secondo le buone prescrizioni di Aristotele14.
La seconda fase, collocata nella prima metà del V sec. a.C., corrisponde al periodo della monumentalizzazione definitiva di tutto il circuito difensivo, con la realizzazione delle torri, e presenta poderose fondazioni in opera isodoma di arenaria, che raggiungono uno spessore di circa 3 metri e sono composte da grandi blocchi parallelepipedi, uniti presso i giunti da grappe a doppio Γ e a Ζ negli angoli delle torri, analogamente all’Heraìon di Rhoìkos a Samo. L’elevato è ricostruito ancora in mattone crudo.
§ Il fronte settentrionale Al Castelluccio giungevano le estremità orientali del fronte est e del fronte nord. Quest’ultimo era composto dalla porzione superiore del tratto A, che proseguiva lungo la dorsale principale fino all’acropoli, ma poco oltre la torre A6 si raccordava al circuito D del quartiere settentrionale, completando così a valle il fronte nord. L’andamento della cortina seguiva la natura del pendio creando un profondo rientrante fra le torri A3 e A4 e uno ad angolo ottuso fra A5 e A6, in corrispondenza dell’ampia terrazza del santuario di Zeus. Questo primo tratto era difeso da una successione di torri A1, A2, A3 non a cadenza regolare, ma distanziate a seconda della conformazione orografica e dei punti specifici da difendere, come per esempio il saliente della torre A4 o la posizione di A5, prossima al témenos suddetto. Le torri, di pianta quadrata (in media circa 7,00 × 7,00 metri) e sporgenti con tutto il corpo di fabbrica al di fuori della linea delle mura, furono impiantate già nel V sec. a.C. e ristrutturate in epoca ellenistica per l’utilizzo delle artiglierie15. Poco dopo A6 iniziava la sezione più scoscesa del tratto D, con andamento sud/est-nord/ovest; essa raccordava la torre D1 al tratto A e rappresenta un esempio raro in Magna Grecia di tracciato a cremagliera16, che tuttavia non risponde al tipo più diffuso, con sezioni di cortina parallele collegate da fianchi ortogonali17, ma i segmenti successivi si giustapponevano semplicemente ad ogni passaggio di curve di livello, creando sempre un minimo rientrante lungo quanto lo spessore della muratura. Si contano infatti tre risalti e gli ultimi due, essendo simmetrici, isolavano una sorta di avancorpo rivolto verso il pendio di nord-est. La torre D1 fortificava un saliente, simile a quello superiore, difeso dalla torre A4, e da essa si diramava il braccio est-ovest
La terza fase, quella di nostro specifico interesse, poiché ha inizio intorno al 320 a.C., è caratterizzata da una trasformazione notevole della tecnica costruttiva. Innanzitutto le parti delle cortine e delle torri rifatte furono fondate sullo zoccolo isodomo di età classica, in seguito allo scavo dei crolli degli elevati precedenti, causati molto probabilmente dal cedimento strutturale del mattone crudo8; mentre, nei casi in cui furono rifatte anche le fondazioni, si utilizzò un materiale nuovo che era l’arenaria di Centola. Per gli elevati fu abbandonata la tecnica del mattone crudo e si introdusse quella della struttura a cassone con émplekton e paramenti, ma per la realizzazione di questi ultimi venivano utilizzati vari tipi di muratura, quali l’opera isodoma in blocchi di calcarenite, proveniente dalle cave di Marina di Camerota9, l’opera a scacchiera, costituita da filari in blocchi di arenaria disposti per lungo e alternati a spazi per i blocchi di testa, riempiti da scaglie o blocchetti di calcare10, e la muratura in mattoni cotti del tipo velino11. § Il Castelluccio Il circuito delle fortificazioni è stato distinto dal Krinzinger in tratti definiti con lettere maiuscole, che vengono adottate per comodità anche in questa sede12, ed essi risultano tutti presenti nell’ambito del sistema difensivo tardo 6
MARTIN 1970; MOREL 1970; NEUTSCH 1970a; NEUTSCH 1970b; NAPOLI 1971, pp. 459-461. 7 MARTIN 1970, pp. 99-100. 8 KRINZINGER 1994, p. 39. 9 KRINZINGER 1994, pp. 39, 54 nota n. 66; ORTOLANI 1999, p. 130. 10 NAPOLI 1966a, p. 202; NAPOLI 1966b, p. 221; KRINZINGER 1994, pp.
13
Sul Castelluccio MAIURI 1928; MAIURI 1954, pp. 97-109; SESTIERI 1957, p. 10; MAIURI 1962, p. 89; NAPOLI 1964, p. 190; NAPOLI 1966b, pp. 193, 214; SCHMIEDT 1970a, tav. LXV fig. 6; CIPRIANI 1986, pp. 518-519; KRINZINGER 1994, p. 38; TOCCO SCIARELLI 1994, p. 13; GASSNER-SOKOLICEK-TRAPICHLER 2002; TRÉZINY 2004 p. 611 14 supra p. 6. La città di Velia fu sempre assai sensibile ai problemi dell’approvvigianamento idrico e della gestione delle acque all’interno del circuito difensivo a causa della presenza di una sorgente, forse la mitica fonte Hyéle, che sgorgava a valle del Castelluccio dalla parte del quartiere meridionale (SCONFIENZA 1996, pp. 39-45). 15 Per il tratto A NAPOLI 1965, p. 116; KRINZINGER 1980, p. 356; KRINZINGER 1994, p. 37; KRINZINGER 1997, p. 967. 16 Un altro esempio di tracciato ellenistico è quello delle mura a cremagliera della collina di Santa Lucia a Crotone, datato al terzo quarto del IV sec. a.C., poco prima di questo velino (supra pp. 45-46). 17 supra p. 16.
38-39. MINGAZZINI 1954, pp. 39-47; GALLO 1966; JOHANNOWSKY 1982, pp. 235- 236. 12 KRINZINGER 1979. Si ricorda pertanto che il tratto A corrisponde alla linea fortificata che scende dal Castelluccio fino all’acropoli, con B si indicano le mura che dalla sella di Porta Rosa si dirigono fino al quartiere portuale, C coincide con la linea del fronte orientale fino all’incontro con l’estremità meridionale del fronte di mare, D è il circuito del quartiere settentrionale e infine E il fronte di mare sud. Le torri sono indicate con la lettera del tratto di appartenenza e il numero arabo progressivo. 11
70
del tratto D, al quale apparteneva la Porta Marina Nord. Prima di giungere al complesso della porta, la cortina disegnava sul terreno un angolo rientrante ottuso, al quale faceva seguito la torre D2, che difendeva anch’essa un risalto di cremagliera rivolto verso ovest, ponendosi con tutto il suo corpo di fabbrica nello scarto fra i due segmenti di cortina sfalsati. Il tratto di cortina fra D1 e D2 è l’unico monumento eleate che abbia restituito, in un frammento di elevato ancora conservato, un esempio di opera in mattoni velini poggiante sulle fondazioni in muratura isodoma di blocchi lapidei, già risalente all’inizio del V sec. a.C.18.
In epoca ellenistica l’assetto del tratto A venne dunque modificato con la realizzazione della monumentale opera di Porta Rosa che corrisponde ad un passaggio voltato lungo circa 7,70 metri e alto da terra alla chiave dell’intradosso 5,36 metri. Ortogonale alla fronte sud della porta esisteva un poderoso anàlemma in opera isodoma, costituito da tre gradoni successivi, realizzati in tempi diversi, per il contenimento ad ovest del terreno della gola. Verosimilmente l’opera doveva rientrare nell’ambito del complesso difensivo, così come un varco posto più a valle, denominato Porta Arcaica, ma contemporaneo di Porta Rosa e risultante da un’opera a cortile, le cui esigue tracce sembrano collegarsi direttamente alla torre A9. Non fu mai rinvenuta tuttavia una struttura parallela all’anàlemma ovest, che chiudesse a oriente il complesso e contenesse il terreno della gola. La Porta Rosa, tradizionalmente datata alla fine del IV sec. a.C., e quindi concepita contestualmente alle ristrutturazioni della fase ellenistica, doveva permettere il passaggio della strada che collegava le porte Marina Nord e Marina Sud, per agevolare la viabilità fra i quartieri separati dalla dorsale acropoli - Castelluccio22. Precedentemente bisognava percorrere a mezza costa i declivi a nord e a sud del tratto di mura fra la torre A9 e il santuario di Poseìdon Asphaleìos e valicare la dorsale poco lontano dal teatro e dall’accesso al santuario dell’acropoli23. Poco tempo fa è stata proposta una data per l’edificazione della porta ancor più recente, nel II sec. a.C., ritenendo il monumento incompiuto e mai entrato in funzione a causa di una frana che costrinse ad ostruire gli ingressi del fornice, mentre l’interpretazione tradizionale, pur riconoscendo l’avvenimento delle frane, proponeva un primo periodo di utilizzo effettivo entro il 250 a.C. e la chiusura definitiva alla fine del II sec. a.C.24.
La Porta Marina Nord era compresa fra un saliente ottuso ad est e un risalto di cremagliera a ovest. Intorno al 320 a.C. il suo impianto fu ristrutturato con l’elevazione ex novo della torre D3, dotata di ampio basamento quadrato e concepita per l’utilizzo delle artiglierie pesanti in interazione con la torre D4; venne inoltre realizzato un cortile interno, retrostante il varco fra le due torri, nella cui struttura era incorporato un canale di scarico19. La restante parte del circuito che difendeva il quartiere settentrionale è andata dispersa, a causa del passaggio della ferrovia Napoli - Reggio Calabria e dell’apertura di una cava moderna proprio lungo il percorso del tratto a valle della Porta Marina Nord. Pertanto non è noto l’assetto difensivo dell’intero fronte di mare nord, in cui è verosimile che si aprisse un’altra porta per il collegamento con il bacino portuale ipotizzato a settentrione20, né si conosce il raccordo di tale fronte con le difese dell’acropoli. § Il diateìchisma fra il Castelluccio e l’acropoli Il tratto A proseguiva a valle del raccordo con il tratto D lungo la dorsale che conduce all’acropoli, disegnando subito un angolo ottuso con rientrante a nord e raggiungendo la torre A7, appartenente allo stesso tipo delle precedenti e sporgente dalla linea della cortina verso il quartiere settentrionale. La successiva, A8, sporgeva a sud verso il vallone del Frittolo, dove sgorgava la fonte Hyéle. Dopo aver superato ancora un breve tratto, le mura giungevano alla sella di Porta Rosa, creando a monte di essa un breve fianco con andamento nord/ovest-sud/est per proteggere il terreno antistante la fronte settentrionale di Porta Rosa. Oltrepassata la sella la cortina disegnava un profondo rientrante che permetteva di dominare l’area immediatamente a sud di Porta Rosa ed era difeso dalla torre A9, un’opera poderosa che dominava l’intero settore a 360°, sporgendo dalla linea difensiva verso il quartiere settentrionale. Poco oltre la torre, le mura presentavano ancora un risalto, ma attualmente scompaiono in prossimità dell’area sacra a Poseìdon Asphaleìos, così da rendere ignoto il loro sviluppo presso l’acropoli e il raccordo con essa21.
§ Il diateìchisma fra Porta Rosa e il fronte di mare La sella di Porta Rosa e la dorsale della torre A9 costituivano uno dei punti più complessi del sistema difensivo velino, poiché presso la medesima torre, forse dal rientrante che essa difendeva, traeva origine il tratto B, un lungo braccio di mura che attraversava il declivio a valle del raccordo, fiancheggiando ad ovest la via di Porta Rosa e la costa del vallone del Frittolo, fino alla pianura litoranea dove si dirigeva a sud-ovest verso il mare. Questo tratto presenta come A e D una successione di torri quadrate, sporgenti interamente dalla linea della cortina verso est, che furono impiantate nella fase di età classica e mantenute in epoca ellenistica. La prima torre B1 difendeva una porta, detta «dell’agorà», che fu realizzata per il collegamento fra l’abitato delle pendici occidentali della dorsale dell’acropoli e la zona della cosiddetta agorà presso il raccordo della via di 22
supra p. 69 nota n. 1. DE MAGISTRIS 2000, p. 64. Sul complesso di Porta Rosa NAPOLI 1964, p. 194; NAPOLI 1965, pp. 117-119; LUGLI 1966; NAPOLI 1966a, pp. 206-211; NAPOLI 1966b, pp. 211, 217-220; NAPOLI 1966c, p. 1115; NAPOLI 1970b, pp. 189-190; KRINZINGER 1980, p. 363; GRECO 1981a, p. 48; JOHANNOWSKY 1982, p. 235; KRINZINGER 1994, pp. 38, 47-48; TOCCO SCIARELLI 1994, p. 13; KRINZINGER 1997, p. 968. Per la recente interpretazione dell’intero monumento e delle sue vicende costruttive DE MAGISTRIS 2000.
18
23
Per il tratto D NAPOLI 1975, pp. 242-243; KRINZINGER 1979, pp. 5358; KRINZINGER 1980, pp. 357-360; KRINZINGER 1994, pp. 37, 38, 4748; KRINZINGER 1997, p. 968; 19 Su Porta Marina Nord NAPOLI 1964, pp. 192-193; NAPOLI 1966b, p. 216; NAPOLI 1966c, p. 1115; NAPOLI 1975, p. 242; KRINZINGER 1980, pp. 360-361; KRINZINGER 1994, p. 38; TOCCO SCIARELLI 1994, p. 13. 20 DE MAGISTRIS 2000, p. 64. Per il porto infra p. 74 nota n. 43. 21 supra p. 70 nota n. 15
24
71
Porta Rosa, con la terrazza inferiore dello stesso complesso25. A valle di B1, poco dopo il superamento della curva di livello si ergeva una seconda torre, B2, assai simile alla precedente e con la medesima funzione difensiva rispetto ad un varco di collegamento fra l’abitato delle pendici orientali e quello delle pendici occidentali26. Infine le mura giungevano in pianura, atte-standosi presso la torre B3 che difendeva un terzo varco, detto «di via del Porto»27.
sive curve di livello intersecavano la linea delle mura. Dopo C3 la cortina disegnava sul terreno un ampio rientrante ottuso, per proseguire fino a valle con percorso rettilineo; di esso sono noti soltanto alcuni minimi segmenti, al secondo dei quali apparteneva la torre C4. La parte rimanente del fronte orientale non è stata indagata archeologicamente, ma la traccia sul terreno è piuttosto leggibile, tanto da permettere la ricostruzione del percorso. Non è invece possibile definire l’esistenza e la posizione di torri o porte, se non in via ipotetica. Il raccordo fra il tratto di dorsale e quello a valle era segnato da un profondo rientrante verso nord-est, la cui estremità orientale era probabilmente difesa da una torre appartenente al sistema difensivo di una porta. Dopo la torre gemella di quella ipotizzata presso il varco della porta, le mura puntavano direttamente verso la fiumarella di Santa Barbara. Questo tratto, essendo vulnerabile in pianura e aperto verso una delle vie di penetrazione interne, poteva essere difeso da una successione regolare di torri sporgenti, come per esempio il fronte nord di Caulonia29. Dall’ultima torre si dipartiva, con andamento ortogonale al precedente, il primo segmento del tratto di collegamento fra il fronte est e quello di mare, lungo il quale si ipotizza la presenza di un primo rientrante ad angolo retto, difeso a sud-est da una torre.
Dalla torre B3 aveva inizio il segmento finale del tratto B, che fu interpretato erronea-mente dal Napoli come la trasformazione difensiva nel IV sec. a.C. di un molo del porto meridionale, realizzato nella prima metà del V sec. a.C. In realtà il braccio di fortificazione, già dotato in età classica di tre torri quadrate B3, B4, e B5 fu ristrutturato in epoca ellenistica con un muro a doppio paramento, realizzato in opera a scacchiera, nel quale si apriva una posterla fra B3 e B4. Queste due torri, ristrutturate in epoca ellenistica, presentano l’ingresso alla gola per la camera inferiore ed occupano un’area molto estesa, misurando di lato rispettivamente 10 e 8,40 metri, che può far presupporre l’installazione di artiglierie. Proseguendo verso il mare, la ristrutturazione della fine del IV sec. a.C. colmava un’apertura piuttosto ampia fra le torri B4 e B5, forse corrispondente ad una porta. La torre B5 era un’altra poderosa struttura quadrata (8,20 × 8,20 metri) con i muri spessi 1,15 metri e 1,58 quello ri-volto verso mare; essa difendeva tutta l’area antistante le mura del fronte di mare ad est del raccordo con il tratto B, e quindi in età ellenistica poteva certamente essere armata con artiglierie. Il tratto B terminava in mare attestandosi su uno scoglio, individuato durante i sondaggi archeolo-gici, sul quale fu realizzata, alla fine del IV o all’inizio del III sec. a.C. una piccola torre rotonda (diametro 3 metri). Infine di recente si è proposta una datazione per l’origine del tratto B agli anni fra lo scorcio del V e l’inizio del IV sec. a.C. sulla scorta di indagini archeologiche cosa che confermebbe effettivamente la funzione strategico difensiva del diateìchisma, posto fra due quartieri urbani e ricalcante il percorso di un più antico braccio murario arcaico28.
È probabile che al medesimo tratto appartenga la Porta della Fiumarella, individuata dai sondaggi archeologici degli anni ’60-70 e difesa da una robusta torre quadrata30. In questa zona si sono rinvenuti due tratti di mura della fine del IV sec. a.C., orientati in direzione monte-mare, e si è ipotizzata la presenza di un porto fluviale difeso da una torre isolata, che può forse corrispondere a quella più meridionale della serie ricostruita lungo il tratto di pianura nord-sud31. Infine è assolutamente ignoto il raccordo con il fronte di mare32. § Il fronte di mare Il fronte di mare sud corrisponde al tratto E, anticamente realizzato sul cordone dunario, che separava l’area abitata dalla spiaggia del litorale a sud-ovest dell’acropoli33. Sono stati riconosciuti alcuni tratti appartenenti ad esso presso l’attuale Hotel Magna Grecia, dove si è inoltre ipotizzata la presenza del bacino portuale meridionale, tuttavia il settore più noto del fronte di mare resta quello di Porta Marina Sud e del raccordo con il tratto B. L’andamento generale del tratto E, rilevato dalle prospezioni della Fondazione Lerici34, sembra comunque che fosse li-
§ Il fronte orientale Tornando al Castelluccio, presso il suo spigolo meridionale il sistema difensivo ellenistico, ripercorrendo il tracciato di quello classico, si sviluppava lungo il tratto C in direzione sud-ovest, seguendo una dorsale orientata verso il corso della Fiumarella di Santa Barbara. Del fronte orientale, sono noti soltanto alcuni segmenti iniziali difesi da tre torri, C1, C2, e C3, strutturalmente simili a quelle del tratto A, ma qui cadenzate a distanze abbastanza regolari, poiché vennero impiantate nel punto in cui le succes-
29
supra pp. 50-51. Sulla Porta della Fiumarella NAPOLI 1970a, p. 227; KRINZINGER 1994, p. 37. 31 NAPOLI 1970a, p. 228; JOHANNOWSKY 1982, p. 234. 32 Per il tratto C KRINZINGER 1980, p. 357; JOHANNOWSKY 1982, p. 234; JOHANNOWSKY 1987, p. 606; KRINZINGER 1994, p. 37; KRINZINGER 1997, p. 968; 33 Sul tratto E SESTIERI 1960, p. 308; SESTIERI 1962, p. 89; NAPOLI 1965, p. 113; NAPOLI 1966a, p. 198; NAPOLI 1966b, p. 211; NAPOLI 1970b, p. 186; SCHMIEDT 1970b, pp. 70-85; KRINZINGER 1980, p. 358; TOCCO SCIARELLI 1994, p. 13; KRINZINGER 1994, pp. 37, 38, 41, 47; KRINZINGER 1997, p. 968. 34 KRINZINGER 1994, p. 38. 30
25
NAPOLI 1964, p. 194; NAPOLI 1966b, pp. 212-213, 222; NAPOLI 1966b, p. 212; 27 NAPOLI 1966b, pp. 213, 222; 28 GASSNER-SOKOLICEK 2000; GASSNER 2001; TRÉZINY 2004, p. 600. Sul tratto B inoltre NAPOLI 1964, p. 194; NAPOLI 1965, pp. 113-114; NAPOLI 1966a, pp. 200-203; NAPOLI 1966b, pp. 211-212, 215, 222; NAPOLI 1970a, pp. 229-230, 231-232; NAPOLI 1970b, pp. 185-186, 189; NAPOLI 1971, p. 460; NAPOLI 1975, pp. 241-242, 243; KRINZINGER 1980, pp. 356-357; GRECO 1987, pp. 191-192; KRINZINGER 1994, pp. 37, 40; TOCCO SCIARELLI 1994, p. 13; KRINZINGER 1997, pp. 967-968, 969-970; TOCCO SCIARELLI 1999, pp. 683-684. 26
72
con efficacia37. Il tratto noto del fronte di mare avanza ancora per pochi metri, poi la prosecuzione si interrompe, ma alle falde dell’acropoli doveva assumere una conformazione adeguata alla possibile presenza di un altro bacino portuale, ipotizzato in conseguenza ai risultati dei carotaggi eseguiti in zona dalla missione austriaca38.
neare e parallelo alla costa fino al congiungimento con il segmento nord/est-sud/ovest del tratto C. In epoca ellenistica il rifacimento delle mura di età classica produsse una cortina con struttura a cassone ed émplekton, i cui paramenti erano realizzati all’esterno in opera isodoma di blocchi di calcare e all’interno in opera a scacchiera. La fortificazione assunse l’aspetto di un fronte turrito costituito dalla successione regolare delle torri E1 ed E2, poderose strutture quadrate (circa 10,00 × 10,00 metri) in opera isodoma, con camera inferiore aperta alla gola che, sporgendo dalla linea difensiva principale, dal momento del rifacimento di fine IV sec. a.C., accoglievano verosimilmente le belostàseis per le artiglierie e incrociavano il tiro con quello della torre B5, per proteggere la linea di costa prospiciente il quartiere meridionale. Presso la torre E2 si apriva una postierla, che aveva funzione di smaltimento delle acque oltre le mura e anche logicamente un’utilità strategica.
§ L’acropoli di Velia Chiude il quadro delle fortificazioni di Velia la situazione dell’acropoli, che purtroppo è in gran parte ignota. Mancano come si è detto i raccordi con le mura dei fronti di mare nord e sud e con il tratto A. La carenza di dati risulta ancor più grave, se si tiene conto che l’acropoli costituiva il perno occidentale dell’intero sistema difensivo, in corrispondenza di quello orientale interno del Castelluccio, collocato sulla medesima dorsale. Quanto alle opere vere e proprie che costituivano le difese dell’acropoli si possono segnalare i due poderosi muri di terrazzamento emersi lungo le pendici meridionali dell’altura, che obliterarono il primo insediamento dei coloni focei a partire dall’inizio del V sec. a.C., in fase con il momento di prima monumentalizzazione dell’intero circuito difensivo. Tuttavia è soltanto ipotizzabile che tali strutture svolgessero funzioni difensive in conseguenza alla loro collocazione topografica, ma d’altro canto non sarebbe la prima volta che un’opera di terrazzamento costituisce il limite munito di un’acropoli urbana, come per esempio nel caso di contrada Cusemi-Marafioti a Locri o della Piazzetta a Caulonia39. Si tratta di un lungo muro in opera pseudopoligonale con andamento nord/est-sud/ovest che delimitava a sud la terrazza inferiore dell’acropoli e svoltava ad angolo retto all’altezza circa del tempio ionico, per andarsi ad at-testare evidentemente contro il secondo terrazzamento.
Salendo verso nord-ovest si incontra il complesso di Porta Marina Sud, al quale appartiene la torre E1. La porta fu realizzata al momento del rifacimento del fronte, alla fine del IV-inizio III sec. a.C., ma i livelli della soglia esterna denunciano la presenza di una fase più antica. Comunque l’opera in età ellenistica presentava un varco carraio con soglia e stipiti in calcare, che creavano una sorta di breve corridoio difeso sul lato sud dalla poderosa struttura della torre E1. Presso lo stipite nord invece si apriva una postierla con copertura voltata e percorso parallelo al varco carraio, la cui utilità era legata sia allo smaltimento delle acque sia al regolare passaggio pedonale35. Oltre la Porta Marina Sud le mura procedevano in linea retta fino al congiungimento con il tratto B fra le torri B4 e B5, ma poco prima, in epoca ellenistica, si poteva notare la tampognatura di una seconda porta che durante la fase di età classica si apriva attraverso la cortina in forma di varco semplice senza particolari difese36.
Gli archeologi della missione austriaca hanno rilevato che l’assetto della terrazza inferiore era tale fin dall’inizio del V sec. a.C. e così rimase in età ellenistica a partire dalla fine del IV sec. a.C. In questa data, al contrario, la strutturazione originaria del secondo muro di terrazzamento, già realizzato in opera isodoma contemporaneamente al primo, per sostenere il témenos del santuario di Athéna, fu integrata da una prosecuzione rettilinea verso sud-ovest, svoltante poi ad angolo retto verso nord-est, per contenere l’ampliamento occidentale del santuario stesso. Pertanto in età ellenistica l’acropoli risultava difesa su due livelli. Quello superiore si spingeva in avanti verso il mare con il nuovo avancorpo e si chiudeva ad est con il limite del santuario presso l’anàlemma meridionale del teatro; quello inferiore terminava a sud-ovest in posizione più arretrata, rispetto a quello superiore, e si spingeva fino al vallone che nasce dalla sella fra l’acropoli e il santuario di Poseìdon Asphaleìos, luogo in cui si potrebbe ipotizzare la presenza del raccordo con le mura ascendenti dal fronte
Il fronte di mare dopo il raccordo con il segmento terminale del tratto B creava dunque uno spigolo con rientrante rivolto a sud oltre il quale si collocavano le due torri già descritte B5 e B6. Superata quest’ultima le mura svoltavano di nuovo ad angolo retto, riprendendo la direzione del tratto di Porta Marina Sud, ma erano verosimilmente a contatto del mare e seguivano un percorso attualmente ignoto verso le difese meridionali dell’acropoli. A ridosso della torre B6 si apriva un varco bipartito per lo scarico delle acque interne alla cinta muraria, che presentava un profilo strombato dall’interno verso l’esterno e che fu realizzato in quel punto per ragioni connesse all’assetto del sistema di drenaggio interno alle mura, ma certamente anche per la presenza della torre B6 che poteva difenderlo 35
Per la Porta Marina Sud SESTIERI 1953; SESTIERI 1954, p. 234; VAN BUREN 1954, p. 326; VAN BUREN 1955, p. 307; SESTIERI 1957, p. 10; SESTIERI 1960, p. 308; SESTIERI 1962, p. 93; NAPOLI 1964, p. 189; NAPOLI 1966b, p. 200; NAPOLI 1966c, p. 1115; NAPOLI 1970b, pp. 186187; SCHMIEDT 1970b, pp. 81-82; KRINZINGER 1994, p. 38; TOCCO SCIARELLI 1994, p. 13. 36 Il Napoli interpretò la porta come l’accesso da mare ad una darsena interna, nell’ambito della sua lettura generale dell’area portuale in età tardoarcaica e classica (NAPOLI 1966a, p. 199; NAPOLI 1966b, p. 211).
37
SCHMIEDT 1970b, p. 82; NAPOLI 1972, p. 18. KRINZINGER 1994, p. 38. 39 supra pp. 53, 65-66. 38
73
di mare sud. Infine nulla si conosce riguardo alle difese del lato settentrionale dell’acropoli40.
so est, evidentemente per il fatto che l’intero quartiere sud-orientale di Velia era sentito come la parte più vulnerabile, essendo aperto in pianura verso est nei segmenti inferiori del tratto C e verso mare lungo tutto il tratto E. Sembra pertanto che almeno in epoca ellenistica il diateìchisma B svolga una funzione difensiva importante lungo tutto il suo sviluppo fino al fronte delle torri B3, B4, B5 e B6 e operi sistematicamente con la parte superiore del tratto A, chiudendo il vallone del Frittolo in un’area totalmente dominata dalle strutture difensive.
Questioni interpretative Il sistema difensivo della città di Velia può certamente essere collocato nella categoria dei circuiti a «Geländemauern», non solo, ma, come nel caso di Locri Epizefiri, ci si trova davanti ad uno degli esempi più antichi, accettando la ricostruzione cronologica delle fasi proposta dal Krinzinger41.
§ I porti e il fiancheggiamento L’ignoranza di dati riguardo ai fronti di mare è connessa a quella relativa ai porti, ipotizzati in vari punti: uno a nord dell’acropoli, uno a sud presso la Porta Marina Sud, e altri due scali navali lungo le foci del Palistro e della Fiumarella di Santa Barbara43. Tuttavia la situazione indagata lungo le mura di Porta Marina Sud permette di notare l’applicazione delle leggi del fiancheggiamento reciproco fra le strutture sporgenti e la copertura di tutto il terreno antistante questo tratto del fronte di mare grazie all’incrocio di tiri che potevano attuare le artiglierie delle torri E1, E2 e B5.
§ I diateichìsmata Una caratteristica specifica di Velia, che per motivi stratigraficamente dimostrati non può essere soltanto attribuita alla fase di ristrutturazione ellenistica, è la presenza dei bracci di fortificazione interni al circuito perimetrale. Essi sono tecnicamente dei veri e proprii diateichìsmata, le cui definizioni e prime realizzazioni monumentali, fra la fine del VI sec. a.C. e il ventennio iniziale del V sec. a.C. ne determinano la collocazione fra gli esempi più antichi di opere simili. La presenza dei diateichìsmata non sembra il risultato di una integrazione corollaria, per quanto precoce, ma, se il tratto B può effettivamente essere concepito come un lungo braccio di mura con torri rivolte verso est, per creare un secondo fronte di resistenza in previsione della caduta delle mura orientali e di tutta l’area urbana di contrada Vignale, il tratto A costituisce l’asse portante di tutto il sistema difensivo. Tant’è vero che il segmento di A, compreso fra il Castelluccio e la torre A6, rappresenta un fronte di prima linea rivolto a nord, mentre, soltanto dopo il raccordo con il tratto D la sua porzione centrale si trasforma in diateìchisma, con la torre A7 ancora rivolta verso nord e l’A8 invece verso sud, a riprova della sua funzione di protezione di entrambe le aree urbane.
Stessa applicazione del fiancheggiamento è deducibile dalla presenza delle cremagliere lungo il tratto D e dal posizionamento delle torri appartenenti al medesimo sistema, così come, d’altro canto, risulta operante l’attività difensiva delle torri del tratto C, individuate e ipotizzate, e quelle del tratto A, fra cui emerge la poderosa A9 che domina l’intero settore di Porta Rosa. § Le porte di Velia La Porta Marina Nord documenta la presenza a Velia in età ellenistica del tipo a cortile, che interviene come modello di ristrutturazione dei varchi ortogonali alle mura difesi in età precedente da una o due torri. L’aggiunta della struttura del cortile interno alla linea difensiva, che raddoppiava i varchi d’ingresso44, è completata dall’utilizzo di una delle due torri, la D3, in qualità di elemento strategico portante del complesso difensivo, come nei casi delle porte locresi di Afrodite e di Quote San Francesco o della cauloniate Porta di Aulon45.
Il Krinzinger42 non attribuisce solo un valore militare ai diateichìsmata specialmente nelle età precedenti l’Ellenismo, tuttavia lascia aperta la soluzione del problema interpretativo, ipotizzando una possibile divisione dell’area urbana riflettente l’assetto sociale. Dal punto di vista strategico difensivo si può rilevare che il tratto B risulta attraversato in parecchi punti da varchi, quali la Porta dell’agorà, la porta presso la torre B1 e la Porta di via del Porto, che sono giustificati dalla viabilità orizzontale fra l’abitato di contrada Vignale e il quartiere a terrazze lungo le pendici ovest della dorsale dell’acropoli e, a valle, fra le diverse zone del quartiere portuale. D’altro canto esso è armato da una successione di torri quadrate rivolte ver-
Interessante è anche la sistemazione di Porta Marina Sud per la presenza del varco carraio con accanto la postierla investita di varie funzioni, strategico-difensive in casi di necessità, per il passaggio pedonale e per lo scarico delle acque. Essa richiama una composizione che poteva essere quella della Porta Temenide di Taranto46, ma più in generale appartiene comunque al tipo con varco semplice dife-
40
Sulle opere difensive e di terrazzamento dell’acropoli supra p. 70 nota n. 6 e inoltre VAN BUREN 1951, pp. 178-179; VAN BUREN 1957, p. 378; VAN BUREN 1958, p. 420; SESTIERI 1962, p. 91; NAPOLI 1965, p. 115-116; NAPOLI 1966b, pp. 204-207; NAPOLI 1966c, p. 1114; MOREL 1970, pp. 135-136, 140-142, 144; NAPOLI 1973, pp. 304-305; NAPOLI 1974, p. 371; GRECO 1977, pp. 781-786; CICALA e A. 1993; TOCCO SCIARELLI 1993, p. 732; KRINZINGER 1994, p. 33; KRINZINGER 1997, p. 967; DAUM 1999; KRINZINGER 1999. 41 supra p. 69 nota n. 3. 42 KRINZINGER 1997, p. 37.
43 Per le diverse localizzazioni di ciascuno di questi apprestamenti portuali NAPOLI 1964, p. 193; NAPOLI 1966b, pp. 202-203; NAPOLI 1966c, pp. 1114-1115; SCHMIEDT 1966, pp. 315-321; NAPOLI 1970a, pp. 228, 229-230; SCHMIEDT 1970b, pp. 74-75; JOHANNOWSKY 1982, p. 234; JOHANNOWSKY 1987, p. 606; KRINZINGER 1994, p. 38; KRINZINGER 1997, p. 971; 44 Per i confronti del tipo a cortile supra p. 18. 45 supra pp. 52, 58, 60-61. 46 supra pp. 30-31.
74
so da una sola poderosa torre di fiancheggiamento, così come la Porta della Fiumarella sul fronte di sud-est.
cesso a monte di tutte le valli fluviali che collegano il territorio velino alla Lucania interna, infatti immediatamente a valle della vetta, cinta dalle mura greche del IV sec. a.C., ma frequentata fin dal VI sec. a.C., si trovano le sorgenti del Badolato, affluente del Palistro. Quest’ultimo nasce ad est di Moio e anticamente, a differenza di oggi, sfociava a nord di Velia, separato dall’Alento. Infine dal medio corso del Palistro si può accedere alla valle della Fiumarella di Santa Barbara e da lì alla strada che conduce a Velia attraverso la porta omonima.
Infine le recenti ricerche del De Magistris non solo aprono un nuovo capitolo sull’interpretazione di un monumento importante, qual è Porta Rosa, nell’ambito dell’architettura antica, ma anche determinano una rilettura generale del tratto A in prossimità del raccordo con l’acropoli. Infatti, se effettivamente l’opera non entrò mai in funzione, la strada fra i quartieri nord e sud continuò a seguire il percorso attraverso la sella a valle del santuario di Poseìdon Asphaleìos, dove è necessario ipotizzare la presenza di una porta di collegamento già a partire dall’inizio del V sec. a.C., quando fu realizzato il tratto A, e immaginare che essa abbia continuato a svolgere la sua attività difensiva durante tutto il periodo ellenistico. Ovviamente l’ipotesi dell’esistenza di tale porta va verificata prima ancora di pensare quale possa essere la sua conformazione.
Infine chiudeva a sud il sistema di phroùria la postazione di Castelluccio, omonimo del forte che difendeva il vertice orientale delle mura di Velia, ma posizionato al confine con il territorio di Pixunte-Palinuro, a monte del vallone Carusello, il cui sbocco al mare presso Marina di Pisciotta corrispondeva ad un approdo navale lungo la costa, precedente lo scalo di Velia51. § Difesa territoriale e precetti teorici Dopo aver dunque passato rapidamente in rassegna queste località, che corrispondono a veri e proprii phroùria, è opportuno ricordare che la difesa di Velia, integrante la componente urbana a quella territoriale, esemplifica perfettamente le prescrizioni di Aristotele sulla collocazione strategica della pòlis, aperta sul mare e ben munita di opere fortificate, nell’ambito di una chòra facile da difendere e difficile all’accesso52.
La difesa del territorio La fortuna di Velia, durante le bellicose vicende storiche dei due secoli precedenti la definitiva conquista romana della Magna Grecia, fondò una delle sue ragioni sull’efficienza delle fortificazioni urbane pensate assai prima che si profilassero minacce gravi, quali l’avanzata dei Lucani e le guerre dionigiane. Tuttavia contò anche moltissimo l’ottima difesa territoriale.
D’altro canto la logica che mette in rapporto la città fortificata, centro di coordinamento della difesa, con le postazioni limitanee è quella professata da Enea Tattico53. Infatti i quattro phroùria noti nel territorio di Velia non hanno solo funzione d’avvistamento, ma sono degli epitheichismoì, concepiti per fermare il nemico sui confini della chòra e per la resistenza ad oltranza, prima di ripiegare sulla linea delle mura urbane, la quale è ancora un fronte di difesa avanzata rispetto ai diateichìsmata, interni alla «Geländemauern», e alle difese finali dell’acropoli. Questo sistema rappresenta pertanto uno dei più chiari esempi di quel concetto di difesa avanzata e scalare elaborato nel IV sec. a.C. con la nascita della «stratégie nouvelle» e dominante per tutto l’Ellenismo.
§ Le fortezze limitanee Il sistema difensivo di Velia, dal V sec. a.C., si articolò in maniera più complessa, comprendendo alcune località strategiche della chòra, Punta della Carpinina, Torricelli, Moio della Civitella e Castelluccio, localizzate a guardia delle principali vie di accesso alla costa, che facevano capo alla città, avente a sua volta funzione di piazzaforte centrale e di linea difensiva ultima in caso di invasione47. Punta della Carpinina è un’altura a nord-ovest di Velia, fortificata per difendere la strada litoranea, che collegava Paestum a Velia attraverso il promontorio di Licosa48. Torricelli si trova in cima ad un’altura sulla destra dell’Alento, di fronte al paese moderno di Vallo Scalo, e governava a vista la via d’accesso a Velia, che seguendo il corso del fiume, giungeva in città attraverso la Porta Marina Nord49. La collina della Civitella, nel comune di Moio della Civitella, presso Vallo della Lucania50, rappresentava una posizione di alta rilevanza strategica per il controllo dell’ac47 Sull’interpretazione dei siti come phroùria greci concepiti per la difesa del territorio velino GRECO 1975, pp. 92-100; GUZZO 1982, p. 225. 48 GRECO 1975, pp. 83-85; TOCCO SCIARELLI 1994, p. 17. 49 GRECO 1975, pp. 85-86; GANGEMI-COLLINA 1987. 50 GRECO 1970, pp. 195-197; NAPOLI 1971, p. 459; NAPOLI 1973, pp. 297-298; GRECO 1975, pp. 86-88; SCHNAPP 1977; GUZZO 1978, p. 473; GRECO 1981a, pp. 49-51; GRECO-SCHNAPP 1983; TRÉZINY 1983, pp. 112-116; GRECO-SCHNAPP 1986; LAFAGE 1988; TOCCO SCIARELLI 1994, p. 17.
51
GRECO 1975, p. 88. supra pp. 5-6. 53 supra p. 8. 52
75
76
CAPITOLO
8
Paestum
L’antica Poseidonìa, colonia fondata da Sibari intorno al 600 a.C. sulla costa tirrenica della Campania, come ultimo avamposto dell’area di influenza achea verso occidente oltre la Lucania interna, sorgeva nel centro della piana del Sele al di sopra di un banco roccioso in travertino, sollevato rispetto alla pianura circostante e alla linea di costa, un tempo più arretrata e forse percorsa da un braccio del Sele, che creava una laguna presso la città utile per l’impianto di un porto marittimo e fluviale1.
la tarda repubblica e l’alto impero la città si contrasse sempre di più, nonostante la deduzione di una colonia di veterani in età tiberiana, e fu poi definitivamente abbandonata nell’VIII sec. d.C. per l’espansione delle zone acquitrinose e le minacce saracene2. Le fortificazioni di Paestum Gli avvenimenti storici del periodo compreso fra l’occupazione lucana e la fine della guerra annibalica sono densi di valide motivazioni per la realizzazione dell’imponente cinta muraria ancor oggi apprezzabile lungo l’antico perimetro urbano di Paestum, che seguiva i limiti del banco calcareo. Tuttavia non è possibile attribuire a fatti storici precisi la costruzione delle fortificazioni e le loro ristrutturazioni, che iniziarono ad essere studiate, fin dal 1907, dai soprintendenti campani3 e, negli anni ’60, dall’Istituto Germanico di Roma4. In seguito le ricerche sulle fortificazioni pestane sono state riprese nell’ambito del programma di ricerca portato avanti dall’università di Salerno e dall’Istituto Orientale di Napoli in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica di Salerno, l’École Française de Rome e il CNRS5.
L’importanza e il potere della città durante l’età arcaica e il V sec. a.C. sono chiaramente documentati dalla monumentalità, ancor oggi apprezzabile, dei santuari urbani con i tre grandi templi dorici e dalla fama dell’Heraion alla foce del Sele. Tuttavia la storia di Poseidonia alla fine del V sec. a.C. subì un forte cambiamento di rotta con l’occupazione lucana, in seguito all’espansione delle genti italiche verso la costa del mar Tirreno. Nel giro di poco tempo comunque la venuta dei Lucani determinò una fusione con la popolazione di origine greca e la città, nel IV sec. a.C., tornò ad essere un centro fiorente e visse marginalmente il grande conflitto fra Italici e Italioti che si andava sviluppando lungo la costa ionica della Magna Grecia. Tuttavia nel 335 a.C. Poseidonia, schierata sempre dalla parte italica, fu occupata dall’armata di Alessandro il Molosso, vincitore di una coalizione fra Lucani e Sanniti proprio nella piana del Sele. Sembra che tali avvenimenti possano giustificare la presenza di una cinta muraria realizzata a partire dagli anni successivi il 350 a.C., in previsione di possibili conflitti con il mondo italiota, che, come si è detto, portarono effettivamente ad un breve periodo di occupazione greca terminato comunque entro il 331 a.C., anno della morte del Molosso.
§ Datazione dell’impianto Riguardo alle mura dell’antica Poseidonia non si sa nulla e nessuna struttura difensiva, indagata in passato o attualmente visibile, può essere ricondotta con sicurezza alla colonia achea6. I resti monumentali che oggi si ergono nel cuore della piana del Sele risalgono all’epoca della conquista lucana e testimoniano l’esistenza di una grande
L’alto Ellenismo rappresenta il momento in cui la città lucana entrò in conflitto con Roma, ma si ignorano gli avvenimenti che portarono nel 273 a.C. alla deduzione della colonia latina di Paestum, dal nome lucano Paistom dell’antica Poseidonia. In questa data la città divenne il caposaldo dell’espansione romana verso sud, lungo la costa tirrenica, e ottenne il grado di civitas foederata, mantenendo sempre una certa autonomia e fornendo uomini e mezzi a Roma soprattutto durante la Seconda Guerra Punica. Allora Paestum non passò dalla parte dei Cartaginesi dopo la battaglia di Canne, come fecero invece numerose colonie italiote, ma costituì un centro di resistenza importante nel cuore della Campania occupata. Durante
2
Per gli eventi storici relativi a Poseidonia-Paestum dalla fondazione all’età romana SCHMIEDT-CASTAGNOLI 1955, p. 125; ZANCANI MONTUORO 1963, pp. 829-831; SESTIERI 1976, pp. 5-6;GRECO 1981a, pp. 17-20; GUZZO 1982, pp. 108-169 passim, 209-218; GRECO-TORELLI 1983, pp. 208-212; PUGLIESE CARRATELLI 1983 passim; CORDANO 1985, pp. 309-312; GRECO 1985, p. 361; GIANGIULIO 1987 passim; LOMBARDO 1987a passim; GRECO 1988a passim; GRECO 1988b, pp. 79-82; TORELLI 1988, pp. 33-41, 85-115; GRECO 1993, pp. 63-74, 249, 251-257; ROBERT 1993, pp. 136-139; MELLO-MANGIERI 1996, pp. 302-303; TORELLI 1999, pp. 7-13. 3 GRECO 1986b. 4 SCHLÄGER 1957; SCHLÄGER 1962; SCHLÄGER 1964; SCHLÄGER 1965; SCHLÄGER 1969. 5 D’AMBROSIO 1990, pp. 71-73. Inquadramenti generali e notizie specifiche sulle fortificazioni di Paestum si trovano in KRISCHEN 1941, pp. 19-24; KÄHLER 1942, pp. 14-16; LUGLI 1957, pp. 293-294; SCHLÄGER 1962; ZANCANI MONTUORO 1963, pp. 831-832; VOZA 1963, pp. 223226; VOZA 1964, p. 290; SCHLÄGER 1965, pp. 184-188; SCHMIEDT 1970a, p. 56; SESTIERI 1976, pp. 7-11; ADAM 1982, pp. 245-247; GUZZO 1982, p. 133; GRECO-TORELLI 1983, p. 210; BLUM 1988; GRECO 1988a, p. 475; MERTENS 1988, pp. 563-567; THEODORESCU 1988, pp. 524-526; D’AMBROSIO 1990; GRECO 1990 passim; GRECO 1993, p. 254; TORELLI 1999, pp. 18-20; D’AMBROSIO 2000. 6 infra pp. 79-80.
1
DELEZIR-GUY 1988, pp. 464-465. Inoltre sulla natura geografica del sito urbano SCHMIEDT-CASTAGNOLI 1955, p. 126; ZANCANI MONTUORO 1963, p. 829; VOZA 1963, pp. 224, 226; VOZA 1964, p. 290; SCHLÄGER 1965, pp. 182-184; SCHMIEDT 1966, pp. 311-314; WINTER 1971, pp. 25-26; SESTIERI 1976, p. 7; GRECO 1981a, p. 17; GUZZO 1982, pp. 109-110; BLUM 1988, p. 577; THEODORESCU 1988, p. 518; GRECO 1990, pp. 90-91.
77
cinta difensiva, che rimase in funzione fino all’età imperiale. Le indagini archeologiche e storico-architettoniche hanno permesso di fissare l’origine delle fortificazioni pestane dopo il 350 a.C. e di individuare due fasi costruttive principali. La prima è collocata nella seconda metà del IV sec. a.C., la seconda fra la fine del IV e l’inizio del III sec. a.C; esse sono accompagnate da una serie di interventi di ristrutturazione alle cortine e alle porte attribuibili già al periodo di vita della colonia latina, dopo il 273 a.C.7. In questa sede si rende conto dell’aspetto delle fortificazioni di Paestum nel III sec. a.C., considerando il pieno sviluppo assunto da esse nell’ultimo periodo lucano e gli interventi romani che le integrarono alla fine del secolo o all’inizio di quello successivo.
Lungo il fronte nord si elevano ben sette torri, cinque ad est di Porta Aurea (nn. 3-7) e due ad ovest (nn. 10-11)10, appartenenti alla prima fase costruttiva del settore e poste a cavallo della cortina. Tuttavia il raddoppiamento dei paramenti esterni vanificò completamente l’aggetto delle torri rispetto alla linea delle mura più antiche e di conseguenza il fiancheggiamento reciproco, tanto che nel III sec. a.C. esse dovevano apparire come semplici emergenze successive lungo il cammino di ronda. Queste torri hanno tutte pianta quadrangolare (in media 6/6,50 × 5,50/6,50 metri) e basamento pieno fino all’altezza del cammino di ronda, dal quale si accedeva ad una camera della torre con pareti spesse 0,60 metri, capaci forse di sorreggere il soppalco di un secondo piano per le artiglierie11. Altri elementi caratteristici del fronte nord sono le numerosissime postierle, appartenenti tutte alla fase del raddoppiamento dei paramenti, tranne la 9 e la 16, che sono ristrutturazioni di varchi già presenti nella cortina di IV sec. a.C. Escludendo una funzione connessa alla viabilità urbana12, la presenza così massiccia di tali apprestamenti, indipendenti dalle torri, induce a pensare che, almeno per la fase di III sec. a.C., fosse necessario garantire un collegamento molto fluido fra il corpo di piazza e l’area esterna, a ridosso del fossato, di cui si parlerà oltre. Probabilmente il terreno compreso fra le mura e il fossato nord era stato trasformato in un lungo proteìchisma per l’alloggiamento di artiglierie mobili in difesa avanzata a tiro radente13.
§ Il fronte settentrionale Il fronte settentrionale del circuito murario8 è caratterizzato dalla compresenza di due fasi costruttive di epoca ellenistica, infatti nel III sec. a.C. la cortina era composta da un muro interno chiuso fra due poderosi paramenti, aggiunti come rinforzo all’interno e all’esterno della linea difensiva. Il muro interno viene ricondotto alla prima fase, datata nella seconda metà del IV sec. a.C., ed è costituito da due paramenti in opera isodoma di blocchi parallelepipedi in calcare, assemblati per filari regolari e paralleli, collegati da diatoni, che creano una struttura a cassoni, colmati da un émplekton in materiale eterogeneo. La seconda fase presenta l’aggiunta dei due paramenti che chiudono il muro interno come una sorta di nucleo, ma senza alcun legame strutturale. Essi sono realizzati con blocchi di calcare, assemblati per lungo e in chiave, così da aumentare lo spessore del paramento, secondo una composizione pseudoisodoma per filari paralleli, ma con interfacce a superfici irregolari. La datazione di questo raddoppiamento, che riguarda non solo il fronte nord, ma anche quello orientale e quello meridionale nel tratto dall’angolo sud-est fin quasi a Porta Giustizia, è ricondotta al secondo quarto del III sec. a.C., dopo la deduzione della colonia latina, sebbene il fronte occidentale e parte di quello meridionale siano caratterizzati in facciavista da una tecnica costruttiva analoga, ma collocata poco prima, fra la fine del IV e l’inizio del III sec. a.C.9.
Chiude il quadro del fronte settentrionale la Porta Aurea, quella meno conosciuta delle quattro porte pestane, poiché fu quasi completamente distrutta dal passaggio della strada ex ss.18, che già nel XVIII secolo conduceva ai templi maggiori. Il varco era difeso da una torre circolare (n. 8) e da una quadrata (n. 9), pertanto la situazione archeologica del monumento non permette più di distinguerne le fasi, ma in analogia con le altre strutture d’ingresso si è proposto un primo impianto a cortile, difeso dalla torre circolare nota e forse da una simile, che fu individuata negli scavi precedenti il secondo conflitto mondiale14, risalenti entrambe alla fine del IV o all’inizio del III sec. a.C., cioè contestualmente al periodo del rafforzamento del fronte settentrionale. È stato inoltre ipotizzato un secondo momento in cui fu trasformato il corpo centrale a difesa del varco. Riguardo la torre 9 non si hanno dati sufficienti per dire se essa sostituì e quando la torre rotonda non più visibile, gemella della n. 815.
7
KRISCHEN 1941; SCHLÄGER 1962; VOZA 1963, p. 221; SCHLÄGER 1965, pp. 184-186; BLUM 1988, pp. 583-589; MERTENS 1988, pp. 564565; TORELLI 1988, pp. 41-43; GRECO 1990, p. 96; D’AMBROSIO 1990, pp. 86-96. La datazione della prima fase dopo la metà del IV sec. a.C. è stata fissata in seguito ad un sondaggio in una sezione del muro interno del fronte settentrionale svolto dagli archeologi dell’Istituto Germanico di Roma (BLUM 1988, p. 585; MERTENS 1988, p. 566), confutando la datazione dello Schläger (1964, pp. 22-24) agli anni immediatamente successivi la conquista lucana. Una sintesi sulle opere difensive pertinenti alle diverse fasi è in BLUM 1988, pp. 586-588. 8 BLUM 1988, p. 579; D’AMBROSIO 1990, pp. 73-76, 87-89; D’AMBROSIO 2000. 9 È comunque stato individuato per il raddoppiamento un terminus post quem non intorno alla metà del III sec. a.C., in base alla cronologia di alcune epigrafi, che testimoniano la realizzazione del paramento interno e per estensione anche di quello esterno, edificato con le stesse modalità (D’AMBROSIO 1990, pp. 90-91). Inoltre riguardo al raddoppiamento delle mura dei fronti nord, est e sud KRISCHEN 1941, p. 21 e tav. 27; SCHLÄGER 1962, pp. 23-24; SCHLÄGER 1965, pp. 184-186; WINTER 1971, pp. 134-135, nota 34; BLUM 1988, p. 575, 577-579, 584-585; ROBERT 1993, p. 120
10
D’AMBROSIO 1990, pp. 73-75, 87. La D’Ambrosio (1990, p. 74 e note n. 7, 8), ricordando le proposte ricostruttive del Krischen (1941, p. 24) e del Marsden (1969, p. 133), fa giustamente notare che, pur ammettendo un secondo piano con le thyrìdes per l’azione delle artiglierie, non è possibile pensare alla posa in batteria di grandi calibri a causa della esiguità del muro perimetrale della camera inferiore che non avrebbe potuto fornire un appoggio sufficientemente ampio al soppalco del piano superiore per sopportare il peso di macchine petrobole, ma soltanto quello per esempio delle gastraphétai. 12 Al contrario di quanto proponeva il Castagnoli (SCHMIEDT-CASTAGNOLI 1955, p. 125) e per cui già il Voza (1963, p. 229) esprimeva dei dubbi. 13 D’AMBROSIO 1990, pp. 75, 87. 14 GRECO 1986b, p. 45. 15 SESTIERI 1976, p. 10; BRANDS 1988, pp. 161-162; D’AMBROSIO 1990, p. 91. 11
78
§ Il fronte orientale
immetteva in un cortile, ricavato nello spessore della muratura delle cortine, dotate di rampe scalari. La cortina del pilone sud era attraversata da un acquedotto, fin dalla prima fase di vita della porta, che si collegava ad una cisterna immediatamente a ridosso del fronte interno della cinta, da dove partiva un secondo condotto idraulico. In epoca successiva il cortile fu chiuso da altre due strutture a pilone dalla parte interna della città, ma quel che più interessa è che nel pieno III sec. a.C. questa porta rappresentava un esempio del tipo a torre, una «Kammertor», costituita da un torrione unico, con ambienti soprastanti il passaggio voltato e forse anche il cortile, per l’alloggiamento di pesanti macchine petrobole19.
Il fronte orientale16, come quello settentrionale, presentava nel III sec. a.C. una struttura costituita dal muro interno, chiuso fra i due paramenti esterni più recenti, ma un numero assai minore di torri, che corrispondono soltanto alla 1, presso il termine sud del tratto obliquo prossimo all’angolo nord-est, alla 2, edificata proprio alla congiunzione dei fronti settentrionale e orientale, e alla 28, che simmetricamente alla precedente difendeva l’angolo sudest. La prima e la terza sono del secondo quarto del III sec. a.C., in fase con il raddoppiamento dei paramenti, essendo strutturalmente legate ad essi; sporgono notevolmente rispetto alla linea delle mura e hanno dimensioni maggiori rispetto alle torri del fronte nord, ma la torre 1 (7,60 × 9,10 metri) presenta una composizione meno articolata delle altre, avendo un basamento pieno. Essa inoltre difendeva una postierla (n. 2) immediatamente a contatto con il suo fianco meridionale. La torre 28 invece (9,35 × 9,75 metri) presenta il basamento vuoto, con una postierla (n. 46) aperta verso l’esterno e un collegamento dalla parte interna del circuito, in modo da creare una camera di passaggio per la preparazione delle sortite o per un accesso pedonale in città limitato, e controllato. Al livello del cammino di ronda vi era una seconda camera, che a sua volta sosteneva il pavimento di un terzo ambiente, forse dotato di ampie thyrìdes per le artiglierie, analogamente alla torre 27 del fronte sud, che appartiene allo stesso tipo di manufatto17.
A proposito della datazione di questi interventi radicali nella trasformazione delle strutture difensive dell’interturrio o del corpo centrale delle porte pestane la D’Ambrosio nota che sarebbe appagante individuarne i motivi nella deduzione della colonia latina del 273 a.C., tuttavia considerando che il primo impianto delle porte è contestuale alla seconda fase ellenistica delle fortificazioni, datata all’inizio del III sec. a.C., la cronologia di un ulteriore rifacimento si restringe troppo rispetto ai termini di partenza, considerando l’impegno architettonico e la portata strategica di una struttura qual era la «Kammertor». Perciò, anche alla luce dei resti della decorazione architettonica rinvenuta nelle indagini archeologiche, la studiosa propone un ampio orizzonte cronologico, che comprende il III e il II sec. a.C., e attribuisce di conseguenza i rifacimenti al consolidamento della presenza romana20.
La torre 2 fu edificata in un momento successivo al raddoppiamento dei paramenti murari, poiché essa si inserisce nella struttura della cortina, occupando l’area necessaria (10 × 8,95 metri) con l’interruzione dell’émplekton, e si ricollega ai paramenti tramite suture in blocchi disposti di taglio. Come la torre 28 era dotata di camera inferiore, armata di feritoie per il tiro radente il terreno e la difesa di una postierla immediatamente prossima (n. 4); l’elevato era infine completato da altri due piani sovrapposti per l’alloggiamento delle artiglierie. La concezione costruttiva che sta alla base dell’opera è analoga a quella delle altre due torri, pertanto anche la numero 2 appartiene alla fase del III sec. a.C., ma il suo inserimento successivo, dopo la metà del secolo, è motivato da un’azione di completamento del sistema difensivo orientale, che era privo, alla congiunzione con il fronte nord, di un’opera adeguata, qual era la torre 2, che effettivamente privalegiasse una strategia balistica per la copertura completa del terreno, più che quella di azione extramuranea18.
§ Il fronte meridionale Dopo la torre 28 in direzione est si sviluppa il fronte meridionale che risulta nettamente diviso in due parti per quanto concerne la tecnica costruttiva. Infatti la cortina del tratto compreso fra l’angolo sud-est del circuito e la torre 26 conserva la struttura a muro interno con paramenti raddoppiati, mentre a ovest della torre 26 i due paramenti esterni non contengono più il muro della seconda metà del IV sec. a.C. Tuttavia durante il III sec. a.C. l’aspetto esteriore della fortificazione appariva unitario, come sugli altri fronti già presi in esame, essendo uniformato dall’opera pseudoisodoma, che compare fra IV e III sec. a.C. e prosegue dopo il 273 a.C.21. Nel tratto occidentale del fronte sud si erge ancor oggi una quarta torre a struttura complessa, del tipo con postierla, come le tre precedenti del fronte est, che è segnalata con il numero 27
In posizione eccentrica rispetto alla linea del fronte est si apre la Porta Sirena che sembra contemporanea alla fase del raddoppiamento delle cortine, se non forse più antica, e appartiene anch’essa al tipo a cortile. Sulla fronte esterna era priva di torri di fiancheggiamento, ma due piloni restringevano il varco d’ingresso, coperto da un arco che
19 Probabilmente l’arco fra i piloni è motivato proprio dalla necessità di scaricare il peso del ballatoio superiore e di un grande litobolo posto al di sopra della chiave. Sulla Porta Sirena SCHLÄGER 1962, p. 25; SCHLÄGER 1964, pp. 105-107; WINTER 1971, pp. 184, 186-187; SESTIERI 1976, p. 10; BLUM 1988, p. 582; BRANDS 1988, pp. 158-160; D’AMBROSIO 1990, pp. 93-94; 20 D’AMBROSIO 1990, pp. 95-96. Esprime sostanzialmente la stessa idea la Blum (1988, pp. 581-583, 588), che prospetta un unico progetto per la ricostruzione delle quattro porte, ciascuna adeguata al sito di edificazione e pansata per l’utilizzo di artiglierie pesanti; in particolare propone di fissare l’epoca dei rifacimenti alla fine del III sec. a.C. in concomitanza alla guerra annibalica. Riguardo alla collocazione in epoca romana delle porte pestane a «Kammertor» si veda anche KRISCHEN 1941, pp. 23-24; KÄHLER 1942, pp. 14-16; MERTENS 1988, p. 566. 21 D’AMBROSIO 1990, pp. 77-78.
16
BLUM 1988, pp. 579-580; THEODORESCU 1988, p. 510; D’AMBROSIO 1990, pp. 84-86, 90-91. 17 WINTER 1971, p. 245; D’AMBROSIO 1990, pp. 84-85. 18 KRISCHEN 1941, pp. 20-21; GRECO 1988b, p. 85; GRECO 1990, p. 99; D’AMBROSIO 1990, pp. 96-97; PONTRANDOLFO 1996, p. 157.
79
(8,75 × 7,54 metri) e possiede il lato occidentale fortemente aggettante, per garantire un buon fiancheggiamento della cortina che la separa dalla torre 28. Il piano al livello del cammino di ronda è dotato delle più ampie thyrìdes individuate o ricostruite lungo le mura di Paestum; ciò lascia intendere che l’opera poteva essere dotata di un armamento piuttosto pesante sia al primo piano sia a quello superiore22.
stessa della seconda fase ellenistica e delle tre torri-postierla 1, 27 e 2827. Al centro dello sviluppo del fronte sud è collocato il complesso difensivo di Porta Giustizia, che sorge all’estremità occidentale della rientranza del banco di travertino seguente la torre 25. Questo tratto di mura termina poco prima di Porta Giustizia con un saliente, il cui fianco orientale domina tutto il terreno e il fossato antistanti il fronte sud, almeno fino alla torre 25 e oltre fino alla 26, completando così il rinnovamento della difesa di un settore ridefinito ex novo all’inizio del III sec. a.C. La porta, come le precedenti analizzate, risale all’epoca della ricostruzione delle mura ellenistiche fra fine IV inizio III sec. a.C. e successivamente vive una seconda fase edilizia, con la trasformazione della struttura difensiva dell’interturrio, in analogia alla situazione di Porta Marina. Nel III sec. a.C. la porta aveva dunque una composizione a cortile, con due torri di fiancheggiamento sulla fronte, le numero 24 e 23, realizzate contestualmente alla seconda fase ellenistica delle mura. La torre 24, al di sotto della quale sbucava nel fossato lo scarico della cloaca fiancheggiante la grande plateìa nord-sud, posta fra l’abitato e le aree sacre e pubbliche, aveva impianto quadrato ed era forse il prodotto del rifacimento di un’opera precedente, mentre la torre circolare 23 (diametro 10,20 metri) è assolutamente uguale alla 25 e riconducibile alla stessa epoca. La seconda fase della porta è caratterizzata dal rifacimento del cortile, ma la cronologia e l’aspetto definitivo sono ricostruiti in analogia a Porta Marina, per la quale, oltre alla ristrutturazione del cortile interno, si è proposta l’idea che il nuovo complesso corrispondesse ad una «Kammertor», il cui torrione si sovrapponeva completamente ai varchi d’ingresso. Nel caso di Porta Giustizia non si hanno dati sufficienti per una tale affermazione, tanto più che nessuna delle due torri di fiancheggiamento sembra posta in disarmo dall’estensione del corpo difensivo centrale, perciò la seconda fase può essere un rifacimento del cortile interno, come corpo autonomo, secondo criteri difensivi ancor più evoluti, ma può anche corrispondere ad una trasformazione in «Kammertor» la cui struttura basamentale era costituita dall’impianto del cortile stesso28.
Proseguendo oltre la strada ex ss. 18 si incontrano i resti della torre 26, che segna il limite di un settore piuttosto discusso non solo a causa del cambiamento di tecnica costruttiva oltre la torre, ma anche per la presenza di un breve tratto di muro ad ampio angolo ottuso, conservato solo in fondazione all’interno del circuito murario di III sec. a.C. e tagliato dalla cortina fra le torri 26 e 25. Originariamente lo Schläger23 interpretò questa struttura, venuta alla luce nel 1951 durante gli scavi del Sestieri24, come unico resto conservato dell’antico circuito difensivo di Poseidonia achea, proponendo una ricostruzione con elevato in mattone crudo e una datazione alla metà del VI sec. a.C. Più recentemente si è proposto di individuare in essa un resto del muro di IV sec. a.C. interno ai due paramenti, individuato sui fronti nord ed est e lungo il tratto precedente la torre 26. Si tratterebbe così di una prova della prosecuzione verso l’area occidentale del circuito delle strutture appartenenti alla prima fase delle mura tardo classiche-ellenistiche, ma anche un dimostrazione del fatto che la seconda fase nella zona occidentale ha completamente sostituito la prima con mini-me variazioni di percorso. Infine la torre 26 risulta inglobata nelle nuove strutture difensive del III sec. a.C., allineandosi ai paramenti in opera pseudoisodoma, ma viste le sue caratteristiche costruttive e dimensionali (6,35 × 6,40 metri), analoghe a quelle delle torri del fronte nord, doveva già essere stata realizzata con l’erezione della prima fase difensiva25. Dopo il superamento di questo tratto di congiunzione fra due momenti distinti della vita delle mura, la cortina a doppio paramento in opera pseudoisodoma, con diatoni ed émplekton, datata al passaggio fra IV e III sec. a.C., si dirige verso il complesso difensivo di Porta Giustizia, seguendo il limite della rientranza del banco di travertino. A metà di questo tratto si ergeva una poderosa torre circolare (n. 25, diametro 10,20 metri) verosimilmente a due piani, con basamento pieno fino al camminino di ronda, sporgente sia all’interno sia all’esterno del circuito e solidale alle cortine adiacenti, come tutte le altre opere dello stesso tipo, ossia le torri 12, 14, 15, 2326. La datazione della torre 25, e delle altre torri circolari, è pertanto la
Oltre Porta Giustizia il fronte meridionale era difeso circa a metà del percorso finale, prima dell’angolo sud-ovest, da una torre pentagonale (n. 19), che copriva tutto il tratto fra la torre 20 e la 18 d’angolo. Ma prima di giungere al settore dominato dalla torre 19 le mura seguivano un andamento curvo a linea spezzata fra Porta Giustizia e la torre 20, lungo il quale si ergevano altre due torri, la 21 e la 22, assai simili alla 20 con profilo quadrangolare (in media 6,30/6,50 × 6,30/6,50 metri), lievemente obliquo rispetto alla linea delle cortine e basamento pieno. Esse non presentano un legame strutturale con i paramenti in
22
27 Contrariamente a quanto proponevano il Krischen (1941, pp. 21-22) e il Marsden (1969, p. 147) che pensavano ad una realizzazione delle torri del settore occidentale rispettivamente prima e dopo l’edificazione delle cortine. 28 VOZA 1963, p. 226; SESTIERI 1976, p. 10; BRANDS 1988, pp. 160161; THEODORESCU 1988, p. 510; D’AMBROSIO 1990, pp. 79, 90, 9293; TOCCO SCIARELLI 1997, p. 448; STEFAN 2000, pp. 187-188; TRÉZINY 2004 p. 617.
KRISCHEN 1941, pp. 22-23; D’AMBROSIO 1990, pp. 84-85. SCHLÄGER 1962, p. 22; WINTER 1971, pp. 25-26. 24 SESTIERI 1951, p. 164. 25 BLUM 1988, p. 586; D’AMBROSIO 1990, pp. 77-78. Per indagini archeologiche recenti nel settore difensivo fra l’Heraion e Porta Giustizia STEFAN 2000; TRÉZINY 2004, p. 603. 26 VOZA 1963, p. 225; MARSDEN 1969, p. 147; D’AMBROSIO 1990, pp. 78-79. 23
80
opera pseudoisodoma e poco ad ovest della 20 e della 21 si aprono rispettivamente due postierle (n. 39 e 40)29.
All’estremità meridionale del tratto obliquo è collocata la cosiddetta Porta Marina, una poderosa struttura difensiva aperta verso il litorale, presso la quale usciva la plateìa est-ovest principale, che si dirigeva nel cuore della città intercettando la principale nord-sud all’altezza dell’agorà e poi del foro romano. Come le altre, la Porta Marina è caratterizzata da due fasi cronologicamente distinte, la prima delle quali, risalente alla fine del IV-inizio III sec. a.C., contemporanea della seconda fase ellenistica delle mura, corrispondeva ad uno schema a cortile con due torri rotonde (n. 14 e 15) sulla fronte, che difendevano il varco d’accesso. La torre 15 è stata completamente obliterata dall’impianto della seconda fase della porta, ma l’altra, la numero 14, è ancora ben visibile e, sondata archeologicamente in fondazione, ha confermato la sua appartenenza alla fase di ristrutturazione delle mura ellenistiche, risalente all’inizio del III sec. a.C. La torre 15 è costituita da un massiccio basamento (diametro 9,84 metri), sul quale si impostano le pareti della prima camera a livello del terreno, che aveva funzione di magazzino. L’elevato successivo, solo ipotizzabile, comprendeva certamente una camera al livello del cammino di ronda e forse una terza ad una quota ancora superiore. La fase più antica della porta presentava, ancora all’esterno del varco, una struttura in blocchi che conteneva una massicciata d’accesso e svolgeva probabilmente la funzione di proteìchisma, per la difesa avanzata esterna. La ristrutturazione della Porta Marina, in una fase successiva l’inizio del III sec. a.C. e coincidente con il pieno sviluppo della colonia latina34, segnò il destino della torre 15, ma salvò la 14, che evidentemente continuava ad avere valore strategico per la difesa del terreno antistante la porta, e soprattutto del tratto di cortina superiore, fino circa al rientrante fra le postierle 31 e 32 oltre la torre 13. L’intervento di rinnovamento interessò la struttura dell’antico interturrio con il rifacimento del cortile in un’opera ad ingressi ristretti, coppia di bastioni quadrangolari, delimitanti il primo varco, e corridoi paralleli a quello centrale di passaggio attualmente visibile, in modo da creare una pesante struttura che poteva evidentemente fare a meno della difesa attuata a sud dalla torre 15. Questa situazione ha fatto sì che, contrariamente all’opinione dello Schläger, il quale immaginava la conservazione di un cortile ipetrale e la presenza di due torri impostate sui bastioni frontali, il Winter e il Brands abbiano proposto la presenza di una «Kammertor», costituita da un poderoso corpo di fabbrica con un primo piano al livello del cammino di ronda, che, accessibile tramite una rampa scalare presso lo stipite interno nord, copriva i lati del cortile e permetteva di difenderne lo spazio interno. Vi era poi un secondo piano, sviluppato lungo la parte frontale, al di sopra dei due bastioni e del varco d’ingresso, e destinato all’alloggiamento delle artiglierie, al quale forse si accedeva tramite la prosecuzione della scala d’accesso al primo piano, che
La torre pentagonale 19 è una robusta opera difensiva (7,90 × 7,20 metri), con muri spessi 1,10 metri e terrapieno interno arginato dall’aggiunta di un muro di rinforzo alla gola, che conteneva anche la rampa scalare d’accesso al cammino di ronda. Lungo i fianchi della torre si aprivano inoltre due postierle (n. 36 e 37) e una ancora (n. 38) presso il raccordo orientale fra la torre e la cortina, tanto da indurre a datare l’opera ad un periodo successivo all’inizio del III sec. a.C. e alla seconda fase ellenistica, come nel caso della torre 2, in ragione di un più complesso sistema difensivo, sia dal punto di vista della strategia extra muros sia dell’efficienza balistica30. § Il fronte occidentale Il fronte occidentale è rivolto verso il mare ed è caratterizzato da un andamento obliquo lungo il settore che si sviluppa dall’angolo nord-ovest fino a Porta Marina, mentre l’ultimo tratto che unisce la porta all’angolo sudovest è più breve, rettilineo e avanzato rispetto alla parte precedente31. La tecnica costruttiva delle mura del fronte occidentale corrisponde a quella della seconda fase ellenistica, a doppio paramento in opera pseudoisodoma con diatoni ed émplekton. La congiunzione della struttura descritta con quella del fronte nord, costituita dal muro interno di prima fase e paramenti aggiunti, non è localizzata precisamente nell’angolo nord-ovest, ma presso il lato occidentale della torre 11 appartenente ancora al fronte settentrionale. Infatti il brevissimo tratto finale di quest’ultimo, con le postierle 20 e 21, appartiene già alla fase di ricostruzione delle mura fra fine IV e inizio III sec. a.C. Come nel caso del fronte sud nel tratto ad ovest della torre 26, l’unione delle cortine con tecnica costruttiva diversa non è percepibile esteriormente, né lo era nel III sec. a.C., quando il paramento esterno in opera pseudoisodoma uniformava le facciaviste per tutto lo sviluppo del sistema difensivo. Il fronte occidentale, lungo il tratto obliquo, presenta soltanto una torre circolare, la numero 12, che come tutte le altre sue simili è solidale alla struttura della cortina, ma raggiunge dimensioni più grandi (diametro 10,60 metri), essendo l’unica opera sporgente a difesa di un lungo tratto di mura32. Tuttavia il dato più interessante è fornito dall’elevato numero di postierle33 (n. 20-33), presenti in questo settore, che si aprono attraverso la cortina a cadenze quasi regolari, tanto da far pensare ad una situazione simile a quella del fronte nord e ipotizzare la presenza di un proteìchisma fra le mura e il fossato per la difesa avanzata con artiglierie di piccolo o medio calibro. Infine è necessario rilevare che presso la postierla 33 esiste una torre quadrata (n. 13) di piccole dimensioni, a poca distanza dalla 14 di Porta Marina, forse preesistente rispetto a questa fase delle mura e mantenuta a difesa della postierla. 29
D’AMBROSIO 1990, pp. 80-81. KRISCHEN 1941, pp. 20-21; WINTER 1971, pp. 246-247; GRECO 1990, p. 99; D’AMBROSIO 1990, pp. 85-86, 90. 31 BLUM 1988, p. 579; D’AMBROSIO 1990, pp- 76-84, pp. 89-90. 32 VOZA 1963, pp. 225-226; D’AMBROSIO 1990, p. 78. 33 D’AMBROSIO 1990, p. 83. 30
34 Un sondaggio condotto nel 1991 all’interno del corridoio settentrionale ha potuto fissare archeologicamente la datazione della nuova struttura della porta grazie al rinvenimento dei resti di un rito di fondazione di tradizione romana, databile agli anni intorno al 273 a.C. (ROBERT 1993).
81
svoltava ad ovest su un ispessimento del muro nord a contatto con la torre 1435.
presenza di un corso d’acqua, che correva lungo il limite del banco roccioso e che derivava dalle sorgenti di contrada Lupata, localizzate ad ovest di Porta Aurea37.
L’ultimo tratto delle mura del fronte ovest si sviluppa ai limiti dell’alto sperone creato dal banco di travertino di fronte al mare, che offriva una favorevole posizione di dominio rispetto alla fascia litoranea e che fu ovviamente sfruttato nel modo strategicamente migliore. Infatti la cortina rettilinea venne armata con tre poderose torri quadrangolari (n. 16, 17, 18), dotate almeno di un piano al cammino di ronda e di uno superiore, appartenenti al tipo delle torri-postierla 1, 2, 27, 28. Rispetto a queste però le tre torri occidentali, in ragione del loro posizionamento, privilegiavano assolutamente la funzione di sedi per macchine da lancio e non quella per l’attività difensiva extramuranea. Le torri 16 (6,50 × 7,30 metri) e 18 (7,90 × 8,20 metri) appartengono all’epoca di costruzione delle mura di questo fronte, perciò risalgono alla fine del IV-inizio III sec. a.C., mentre la 17, di dimensioni ancora maggiori (9,00 × 9,50 metri), è il prodotto di un intervento romano successivo, verosimilmente nel corso del III sec. a.C., come accade per la torre pentagonale 19 del fronte sud e la 2 dell’angolo nord-est. La torre 17, il cui inserimento successivo è dimostrato dalla presenza di blocchi che inzeppano le suture con il paramento delle mura, rappresenta il completamento del sistema difensivo dello sperone di sud-ovest, poiché non solo garantiva un fiancheggiamento efficace della cortina, operando in associazione con le torri 16 e 18, ma le sue artiglierie pesanti, ipotizzabili in conseguenza alle dimensioni della struttura, dominavano ampiamente e con efficacia il terreno antistante. Infine è significativo notare che il tratto di collegamento fra la Porta Marina e la torre 16, che governava dall’alto del banco di travertino l’intero spazio antistante la porta, fu realizzato con una tecnica lievemente diversa rispetto alla solita adottata. Infatti i paramenti in opera pseudoisodoma presentano ancor oggi tutti i blocchi disposti di taglio e nessuno in chiave, così da ridurre lo spessore della struttura, probabilmente per un miglior effetto estetico presso la porta occidentale e per il risparmio di materiale in un punto giudicato inattaccabile dalle macchine d’assalto, a causa della natura del terreno e della copertura attuata dalla torre 16 e dalle difese di Porta Marina36.
Il fossato del fronte nord è stato indagato e ricostruito dallo Schläger secondo una sezione ampia 20 metri e profonda 11, con profilo a scarpa e controscarpa, dotate di gradone mediano e con palizzata sul fondo presso la controscarpa. Esso era molto probabilmente allagato e viene collocato cronologicamente nella seconda metà del IV sec. a.C., contestualmente alla prima fase delle mura38. Verosimilmente il fossato proseguiva senza soluzione di continuità, e con la stessa sezione lungo il fronte orientale per raggiungere l’angolo sud-est. Lungo il fronte meridionale è stata accertata archeologicamente la presenza di un fossato artificiale davanti al tratto fra le torri 18 e 19, risalente all’epoca della seconda fase ellenistica delle mura e verosimilmente esteso fino al complesso di Porta Giustizia39. Davanti al sito della porta doveva giungere la prosecuzione meridionale del fossato risalente alla prima fase di vita delle mura pestane, proveniente dal fronte orientale, che in questa zona lo Schläger40 ha ricostruito con la stessa sezione descritta sopra. Il dato più interessante tuttavia è che probabilmente questo tratto del fossato sud era percorso dalle acque del fiume Salso, che nasce dalle sorgenti di Capodifiume a monte della città, e anticamente era incanalato fino a Porta Giustizia, come hanno dimostrato i sondaggi dello Schläger sotto le fondazioni della torre 2441, per poi venire deviato artificialmente in epoca moderna42. Verosimilmente nel III sec. a.C. il corso del fiume proseguiva oltre la porta, lungo la porzione occidentale del fossato. Pare quindi che il fossato della seconda metà del IV sec. a.C. seguisse i tratti di fortificazione che sono costituiti dal muro interno di prima fase compreso fra i due paramenti aggiunti durante il III sec. a.C. Invece il tratto fra Porta Giustizia e la torre 18, realizzato con la tecnica propria della seconda fase delle mura e datato all’inizio del III sec. a.C., presenta verosimilmente un fossato aperto al momento della sua costruzione. Non si hanno altre documentazioni di un fossato risalente alla seconda fase, poiché gli altri tratti di mura appartenenti a questo periodo si sviluppano tutti lungo il fronte di mare protetto diversamente dal salto di quota del banco di travertino e dal corso d’acqua proveniente da contrada Lupata.
§ Il fossato Chiude il quadro del sistema difensivo ellenistico di Paestum e del suo aspetto durante il III sec. a.C. la presenza accertata archeologicamente di un fossato antistante i fronti nord, est e sud. Il fronte ovest, trovandosi ai limiti del terrazzo urbano costituito dal banco di travertino non fu dotato di fossato, ma si sfruttò, come è già stato detto, il salto di quota rispetto al piano della fascia litoranea e la
37
VOZA 1963, p. 224; BLUM 1988, p. 577; D’AMBROSIO 1990, p. 85. SCHLÄGER 1962, p. 23; SCHLÄGER 1965, pp. 186-188; D’AMBROSIO 1990, pp. 87-88. La Blum (1988, pp. 586-587) riconduce invece il fossato alla fine del IV sec. a.C. cioè alla seconda fase delle mura. 39 SCHLÄGER 1965, pp. 186-188; SCHLÄGER 1969; D’AMBROSIO 1990, p. 83. 40 SCHLÄGER 1965, pp. 186-188. 41 SCHLÄGER 1965, pp. 353-354. 42 VAN BUREN 1955, p. 306; VOZA 1963, p. 224; D’AMBROSIO 1990, p. 99 nota n. 69.
35
38
VAN BUREN 1953, p. 213; SCHLÄGER 1957; SCHLÄGER 1964, p. 104; WINTER 1971, pp. 184-185; SESTIERI 1976, pp. 10-11; BRANDS 1988, pp. 151-157; BLUM 1988, p. 583; GRECO 1988a, p. 494; GRECO 1988b, p. 85; THEODORESCU 1988, pp. 510, 524-526; D’AMBROSIO 1990, pp. 79-80, 92-93, 94-95 passim; ROBERT 1993, pp. 121-123; PONTRANDOLFO 1996, p. 157; ROUVERET-THEODORESCU 2000; TRÉZINY 2004, p.
617. KRISCHEN 1941, p. 21; GRECO 1990, p. 99; D’AMBROSIO 1990, pp. 81-84.
36
82
A partire dalla fine del VI sec. a.C. fino al momento della conquista lucana, l’assetto urbanistico di Poseidonia corrisponde a quello ristrutturato secondo l’impianto attualmente visibile45, ma anche per questo periodo non vi sono documentazioni di un circuito difensivo, mentre le prime notizie si hanno riguardo al muro interno, presente sui fronti nord, est e sud, realizzato con le torri del fronte nord dopo il 350 a.C. Alcune indagini condotte fra il 1986 e il 1987 ad est degli altari dei templi maggiori e sotto la ex ss. 18 hanno dimostrato che l’area orientale fu abitata solo a partire dal III sec. a.C., dopo la deduzione della colonia latina46. Pertanto l’espansione delle mura ad est della città greca e lucana, durante la seconda metà del IV sec. a.C., non dovrebbe comprendere un abi-tato, ma corrisponderebbe ad una sorta di «Geländemau-ern», che non aveva particolari finalità strategiche, ma forse, come suggerisce la D’Ambrosio47, quella di recintare un’ampia porzione di terreno coltivabile. Tale provvedimento non sembra immotivato in relazione alla contingenza storica dei conflitti fra Lucani e Italioti, durante la seconda metà del IV sec. a.C., causa per altro della nascita stessa delle mura.
Questioni interpretative Lo sviluppo del sistema difensivo di Paestum in età ellenistica è il prodotto di una complessa successione di interventi. § Natura e fasi del circuito difensivo Osservando il tracciato finale emerge innanzitutto l’ampiezza di quasi 50 ettari dell’area recintata che induce a riflettere sulla presenza o meno di una «Geländemauern». L’adeguamento alla natura del sito è palese, infatti le fortificazioni si attestano lungo i limiti del banco di travertino, sollevato rispetto al piano della campagna circostante, ma il percorso del circuito, specialmente nel settore orientale, non procede in modo da inglobare particolari conformazioni del terreno strategicamente favorevoli alla difesa e per altro inesistenti. Sembra di individuare una logica di espansione delle fortificazioni simile a quella adottata a Metaponto, non tanto in ragione della comune origine achea delle due città, ma per la natura pianeggiante del sito occupato da entrambe. Il caso di Paestum tuttavia rivela una situazione più complessa, che permette forse di applicare il concetto di «Geländemauern» per un determinato periodo di vita della città. Innanzitutto, come si è già detto altrove, non si hanno notizie di una fortificazione arcaica o classica a difesa dell’abitato di Poseidonia achea, ma, in seguito alle ricerche compiute negli anni ’80 del secolo scorso, è stato possibile affermare che la città greca si estendeva nella porzione compresa fra l’attuale ex ss. 18 e il limite occidentale del banco di travertino.
È significativo a tal proposito rilevare che le indagini archeologiche hanno chiarito che il raccordo fra i fronti nord ed est, presso la torre 2, ristrutturato poi in epoca romana, insisteva su una strada extraurbana del secondo quarto del V sec. a.C.48, che seguiva lo stesso percorso delle mura, come se la collocazione del limite fortificato nord-orientale dell’area messa a coltura coincidesse con un’infrastruttura che, nell’assetto più antico dell’insediamento, aveva una funzione simile di separazione dalla chòra o di partizione agraria. Infine risale già forse a questo periodo l’esistenza di un muro, spesso circa 1,30 metri, del quale si è rinvenuta soltanto la traccia del cavo di spoliazione e che avendo andamento nord-sud, al di sotto della ex ss. 18, potrebbe essere il limite orientale fra la città e l’area messa a coltura49. Non è dato sapere se si tratta del témenos del santuario di Hera oppure di un muro di fortificazione, come ipotizza il Theodorescu accanto alla prima soluzione, ma se così fosse si potrebbe trattare di un diateìchisma, il cui spessore lascia aperte ragioni di discussione riguardo alla sua capacità difensiva, ma che assolverebbe benissimo alla funzione divisionale fra le due aree comprese dalla cinta urbana.
Il Theodorescu43 ha proposto l’esistenza di un impianto urbanistico databile fra la fine del VII sec. a.C. e l’ultimo decennio del VI sec. a.C., basato su una grande plateìa nord-sud, che collegava i siti delle future porte Aurea e Giustizia, e su una seconda plateìa est-ovest, proveniente dal sito di Porta Marina, che intercettava ad angolo retto la precedente presso l’agorà. Non è dato sapere attualmente se gli estremi di questi assi viari, collegati rispettivamente alle strade per l’Heraion al Sele, per Agropoli e per la zona portuale, fossero difesi o se attraversassero un teìchos come quello arcaico di Metaponto, che poteva definire la città lungo il banco di travertino e ad est lungo il limite delle aree sacre44, ma certamente essi segnano tre punti che nei secoli futuri verranno mantenuti come chiave di collegamento fra la viabilità urbana e quella territoriale.
La presenza delle fortificazioni nella parte orientale presuppone anche un circuito difensivo in quella occidentale, 45 Una trattazione sistematica delle possibili fasi dell’impianto urbano della città, dalla fondazione achea alla colonia latina, e che si raffronta alle altre indagini condotte in materia si trova in THEODORESCU 1988, pp. 507-526. Inoltre per l’urbanistica di Poseidonia-Paestum SCHMIEDT-CASTAGNOLI 1955, pp. 124128; VOZA 1963, pp. 228-232; ZANCANI MONTUORO 1963, pp. 831-832; VOZA 1964, pp. 291-292; SCHLÄGER 1965, pp. 188-197; SCHMIEDT 1968-69, pp. 400-401; SCHMIEDT 1970a, pp. 56-57; GRECO 1988a, pp. 475-497 passim; GRECO 1988b passim; D’AMBROSIO 1990, pp. 98-101; GRECO 1990, pp. 91-97; PONTRANDOLFO 1996, p. 156 46 GRECO 1988a, pp. 488-489; THEODORESCU 1988, pp. 518-519; GRECO 1990, p. 94; PONTRANDOLFO 1996, p. 156. 47 D’AMBROSIO 1990, pp. 88-89 nota n. 45. 48 GRECO 1988a, p. 489; D’AMBROSIO 1990, p. 98. 49 GRECO 1988a, p. 488; THEODORESCU 1988, pp. 518-519.
43
THEODORESCU 1988, pp. 509-511. 44 La menzione di Strabone (Geografia [1967], V, 4, 13), in cui si ricorda che Subar›tai m¢n oÔn §p‹ yãlatth+ te›xow ¶yento, ofl d'ofikisy°ntew énvt°rv met°sthsan [...], non si riferisce ad una fortificazione tracciata intorno alla città appena fondata, né probabilmente al santuario di Hera alla foce del Sele, ma, come ha proposto il Greco (1974-75; GRECO 1988a, pp. 477-479; GRECO 1990, pp. 89-90; GRECO 1993, pp. 65-69), ad un centro fortificato che deve essere localizzato sul promontorio di Agropoli e che fu insediato dai primi coloni achei per far fronte alle minacce delle genti etruschizzate della cultura di Pontecagnano.
83
che tuttavia risulta più recente, poiché è costituito dall’opera a paramenti pseudoisodomi che non inglobano più un muro precedente e sono datati alla fine del IV-inizio III sec. a.C. Ciò induce a credere che ancora durante l’epoca lucana le mura del fronte occidentale e della porzione ovest di quello meridionale siano state completamente rifatte. Così dimostrerebbero alcune opere testimonianti l’esistenza, nello stesso settore, di un circuito più antico, quali il tratto di cortina obliterato presso la torre 26 del fronte sud, la stessa torre 26 e i mancati legami strutturali fra i paramenti pseudoisodomi e le torri quadrate 20, 21, 22, 13, simili a quelle del fronte nord. A questo periodo risalgono inoltre i primi impianti delle porte e la conformazione delle difese della città è perfettamente adeguata alle tecniche belliche dell’alto Ellenismo, con la presenza anche dei fossati allagati, in un’epoca in cui l’aristocrazia lucana di Paistom dimostrava una forte connotazione filoromana50, contestualmente alla fine delle guerre sannitiche, all’avanzata di Roma verso sud e allo scontro con Taranto e Pirro.
§ Il sistema di fiancheggiamento e tiro radente L’avanzato sistema difensivo delle mura ellenistiche di Paestum è tecnicamente riscontrabile non solo nell’applicazione dei principi di fiancheggiamento, operanti grazie alla disposizione delle torri di tutte le fasi descritte a cavallo della cortina o nel rapporto di copertura reciproca fra i salienti delle mura presso Porta Marina e Porta Giustizia e le difese delle porte stesse, ma anche nell’utilizzo di strutture che consentivano il tiro radente, per dominare un’ampia porzione di terreno extramuraneo, secondo i principi filoniani della difesa attiva53. Queste applicazioni del tiro radente sembrano emergere dalla presenza di un altissimo numero di postierle sui fronti nord, ovest, prima di Porta Marina, e sud, prima di Porta Giustizia, che presuppongono, come già si è detto, un collegamento agevole e frequente con l’interno del circuito. Esso è motivato dall’utilizzo delle artiglierie ai piedi delle mura, sistemate su proteichìsmata davanti al fossato, che ovviamente possono attuare un’immediata reazione nei confronti di un assalitore prossimo alle difese e annullano la presenza di aree non coperte dal tiro di fiancheggiamento, immediatamente a ridosso della fortificazione principale.
§ Le fortificazioni della colonia latina Non a caso infatti la colonia latina venne dedotta un anno prima della fine della guerra tarantina e, da quel momento in avanti, l’area orientale venne occupata dai quartieri dei nuovi coloni, cosicché cessò la funzione di «Geländemauern» delle fortificazioni del settore. Si rese anzi necessario un adeguamento delle medesime alle nuove tecniche difensive, evolutesi nell’utilizzo delle torri e delle porte come sedi delle belostàseis per le artiglierie pesanti e nell’aumento della capacità di resistenza delle cortine alla maggior potenza delle macchine d’assalto.
Tale genere di opere sembra già attestato nella fase del IV sec. a.C. sul fronte nord, ma anche in quel settore le posterle risalgono al periodo del raddoppiamento romano, intorno alla metà del III sec. a.C., così come quelle del fronte sud, quando l’integrazione fra difesa radente e per fiancheggiamento inizia a toccare livelli di complessa elaborazione54. Sul fronte ovest invece la presenza di un eventuale proteìchisma corrisponderebbe ad un momento di poco precedente la metà del III sec. a.C., essendo le postierle in fase con le mura lucane di fine IV-inizio III sec. a.C.
Pertanto è corretto ricondurre a tali motivazioni il raddoppiamento delle cortine del settore orientale, con l’aggiunta delle grandi torri-postierla entro la metà del III sec. a.C., poiché l’assetto della fortificazione di IV sec. a.C. non avrebbe potuto far fronte alle nuove necessità, mentre il settore occidentale era già sufficientemente armato di cortine robuste e di strutture poderose, risalenti all’ultimo periodo lucano e adattabili all’utilizzo delle artiglierie pesanti, quali le torri rotonde 12, 14, 15, 23 e le quadrate 16 e 18.
Completa il quadro tecnico balistico l’alta capacità di dominio del terreno antistante le mura proprio delle grandi torri rotonde dell’inizio del III sec. a.C. (n. 8, 12, 14, 15, 23, 25), di quelle quadrate lucane (n. 16, 18) e romane (n. 1, 2, 17, 27, 28), della torre pentagonale 19 e delle belostàseis delle «Kammertor» romane, che potevano alloggiare grandi pezzi di artiglieria su piani alti, operanti quasi a 360°. Ultimo elemento caratteristico delle fortificazioni ellenistiche pestane è la torre pentagonale 19, che, essendo inserita lungo un tratto di cortina rettilineo, applica il principio filoniano dell’opposizione di un angolo saliente al fronte d’attacco, come se si trattasse di una torre quadrangolare con una punta al posto del lato piano sporgente, in modo che anche il tiro di fiancheggiamento, attuato dalle cortine limitrofe, potesse proteggere il vertice della torre55.
Gli ultimi perfezionamenti al sistema, ossia la traformazione in «Kammertor», sicura o ipotizzabile, delle quattro porte urbiche e le aggiunte di poderose opere aggettanti per l’utilizzo dei petroboli, in punti nevralgici del circuito, quali le torri 2, 19 e 17, devono essere ricondotti alla seconda metà del III sec. a.C. e, in accordo con la Blum51 e il Greco52, sembra verosimile individuare le ragioni della loro costruzione nell’approssimarsi della guerra annibalica.
53
supra pp. 12-14. È l’epoca della seconda generazione di proteichìsmata identificata dal Winter (supra p. 19). 55 supra pp. 13, 14, 17; per le torri pentagonali inoltre WINTER 1971, pp. 197-199. 54
50
GRECO 1988b, p. 79. supra p. 79 nota n. 20 52 GRECO 1988 b, p. 85; GRECO 1990, p. 99. 51
84
§ Le porte di Paestum Per quanto concerne ancora le porte di Paestum, molto si è detto sulla fase romana e sulla loro riconduzione al tipo della «Kammertor», per i cui confronti si rimanda a quelli segnalati nella parte dedicata alla trattazione generale delle porte fortificate ellenistiche56, mentre è importante ricordare che le fasi più antiche, documentate e ricondotte alla fine del IV-inizio III sec. a.C., rappresentano esempi importanti del tipo a cortile che, in conseguenza alla presenza di torri circolari, trovano confronto, come segnala la D’Ambrosio57, con la porta nord-orientale di Castiglione di Paludi, datata alla seconda metà del IV sec. a.C., e con tutte le altre porte simili a cui si rimanda nelle sedi di trattazione58. È chiaro nel caso di Paestum, su vasta scala, quanto già emergeva per Castiglione di Paludi, ovvero che le genti italiche accolsero immediatamente le tecniche difensive e costruttive dell’architettura militare greca, realizzando opere inserite pienamente, sul piano formale e strategico, nella koiné militare ellenica, nata durante il IV sec. a.C. § Il fronte portuale Infine è importante segnalare che il sistema difensivo dello sperone sud-occidentale, perfezionatosi nel corso del tempo con l’aggiunta della torre 17, nella seconda metà del III sec. a.C., ma già operante con efficacia fin dall’inizio del secolo grazie alle torri 16 e 18, privilegiava una difesa balistica, come la torre 2 presso l’angolo nord-est del circuito, poiché il settore extramuraneo ad ovest dello sperone era probabilmente occupato dalle strutture portuali. Il porto di Poseidonia e poi di Paestum è stato appunto ricostruito davanti a Porta Marina nella depressione lagunare alimentata dal Salso, che lambiva il fronte occidentale, e forse da un braccio del Sele. Il bacino era probabilmente collegato al mare da un canale che attraversava il cordone dunario occidentale limitante la spiaggia, fermo restando che anticamente la linea di costa era più arretrata rispetto a quella attuale59. La presenza del porto rappresenta così non solo il motivo principale della poderosa struttura difensiva, attuata in entrambe le fasi costruttive di Porta Marina, e del suo sistema di fiancheggiamento con le mura meridionali, ma anche la giustificazione del sistema di torri dello sperone occidentale, che in caso di attacco dal mare, avrebbe sottoposto il bacino portuale e il canale ad un fitto e distruttivo tiro da una posizione assolutamente dominante.
56
supra p. 18. D’AMBROSIO 1990, p. 80, in cui nella nota 25 si rimanda ad altri confronti di porte a cortile e a tenaglia nel resto del mondo greco. 58 supra pp. 41-42. 59 Sul porto di Poseidonia-Paestum presso Porta Marina DELEZIR-GUY 1988, p.464; con particolare attenzione alla problematica difensiva e bibliografia inerente le ricerche passate in materia D’AMBROSIO 1990, pp. 83-84 nota n. 34. 57
85
86
PARTE TERZA La cultura fortificatoria della Magna Grecia fra il IV sec. a.C. e l’Ellenismo
La rassegna delle otto città studiate permette di tentare un sommario punto della situazione sull’argomento trattato, certamente suscettibile di revisione, ma comprendente alcune conclusioni che paiono verosimili in base ai dati provenienti dall’esame condotto1.
V sec. a.C. A Crotone durante lo stesso secolo vennero collegate le fortificazioni sulle alture più importanti a coronamento della città, già munite di postazioni isolate nel VI sec. a.C.; a Taranto il circuito difensivo della città nuova fu realizzato intorno fra la seconda metà del VI sec. a.C. e la metà del V, datazione quest’ultima più tradizionalmente conforme ai limiti cronologici della «Geländemauern». Fra le due città achee con circuito di pianura, solo a Metaponto è stata provata l’esistenza di un primo teìchos limitaneo, risalente al VI sec. a.C., mentre per Poseidonia non se ne ha notizia, tan-t’è che le mura di Paestum risultano le uniche veramente elevate ex novo dopo il 350 a.C. Da tali risultati si può concludere che le fortificazioni di queste città in epoca ellenistica furono certamente al centro di una grande attività di ristrutturazione e adeguamento alle nuove tecniche poliorcetiche, ma, in termini di progettazione e concezione generale del sistema difensivo, esse non modificarono la strutturazione originaria. Sembra che addirittura i diateichìsmata fossero il prodotto di un impianto in cui essi furono previsti fin dall’inizio, come a Velia, oppure risultavano da tratti di mura più antiche, passate in posizione di secondo fronte per l’ampliamento di alcuni settori della cinta, come nel caso di Caulonia. Ciò determina una deduzione, ossia che le città prese in esame dal IV sec. a.C. in poi non sentirono la necessità di modificare i circuiti difensivi alla luce delle nuove conoscenze architettoniche e militari, non perché mancò la volontà di adeguamento, ma perché quei circuiti, forse in maniera sommaria, rispondevano già alle norme della difesa integrata fra pòlis e chòra.
La Geländemauern La prima caratteristica dei circuiti fortificati urbani nella Magna Grecia d’età tardo classica ed ellenistica è la frequente applicazione della «Geländemauern», come soluzione ottimale per il controllo strategico di tutte quelle posizioni favorevoli alla difesa della città che, non potevano essere escluse dal circuito senza offrire ad un eventuale assalitore una vantaggiosa posizione dominante. È questo il caso dei sistemi difensivi di Crotone, Caulonia, Locri, Velia e in scala ridotta anche di Castiglione di Paludi. Accanto a queste città si sono poi rilevati i casi di Metaponto e Paestum, per i quali la scelta della «Geländemauern» non pare pienamente condivisa, probabilmente in ragione del fatto che il sito da difendere non presentava posizioni d’altura lontane dall’abitato che dovevano essere assolutamente comprese nel perimetro murario. A Taranto si realizzò un ampio circuito, che inglobava anche le necropoli e creava a tutti gli effetti una «Geländemauern», ma non per il controllo di una posizione strategica esiziale, bensì per lo sfruttamento a vantaggio difensivo della particolare conformazione acquitrinosa del terreno di fronte al quale si attestavano le mura. In buona sostanza nei casi di Taranto, Metaponto e Paestum l’imperativo dominante dell’adeguamento alla natura di un terreno pianeggiante indusse a sfruttare le depressioni circostanti l’area su cui sorgeva la città che corrispondeva ad un’eminenza del terreno, geologicamente distinta dalle zone circostanti e, per Metaponto e Paestum, definita da corsi d’acqua. Negli altri casi la «Geländemauern» era sempre e comunque giustificata dall’adeguamento alla natura del sito, che però impose la necessità di integrare una buona difesa di pianura con il controllo delle alture immediatamente a ridosso dell’area urbanizzata.
Le motivazioni per cui in occidente le cinte fortificate urbane nascano precocemente sono ancor oggi argomento di discussione2 ed esulano in parte dalla tematica affrontata in questa sede, per quanto sia un problema originario che deve essere affrontato con ulteriori approfondimenti, ma sta di fatto che in Magna Grecia la «Geländemauern» offre alcuni fra gli esempi più antichi di applicazione, coevi della sua più famosa sperimentazione a Samo, in occasione della costruzione delle mura di Policrate3, ed è chiaro che in epoca ellenistica la conservazione degli impianti precedenti definisce il contesto di applicazione delle novità architettonico-difensive. Questo genere di conservazione induce subito a notare il caso analogo relativo alle tecniche costruttive, dove si nota, accanto all’introduzione generale della moderna muratura a cassoni con due paramenti esterni, diatoni ed émplekton, l’uso più antico degli elevati in mattone crudo a
Origine degli impianti difensivi Il fatto però più rilevante di questi circuiti difensivi consiste nell’antichità dell’impianto orginario. Si è visto infatti che nei casi di Caulonia, Locri e Velia è archeologicamente dimostrata la nascita del circuito a «Geländemauern» fin dal tardo arcaismo e la sua piena funzionalità nel
2
Si vedano a tal proposito DUCREY 1995 e MOGGI 1999, pp. 524-525, 532-533;. Sulla continuità delle fortificazioni arcaiche in Magna Grecia durante la prima età ellenistica anche TRÉZINY 2004, pp. 595-596. 3 TÖLLE KASTENBEIN 1969, pp. 12-14; MARTIN 1974, pp. 84-85; KIENAST 1978.
1 Un’integrazione delle considerazioni presenti, anche alla luce dei dati relativi alle pòleis magnogreche non analizzate in questa sede, si trova in SCONFIENZA 2003.
87
Fra le porte riconducibili al secondo caso si trovano esempi provenienti dalle stesse città a cui appartengono quelle del primo, poiché la natura del terreno, anche nel caso di Paestum, poteva invece favorire, in altri settori, la necessaria apertura dei varchi. La Porta Marina di Paestum, fondamentale per il collegamento con il porto, era difesa naturalmente dallo scoscendimento verso mare del banco di travertino e dall’avancorpo dello stesso poco più a sud. A Caulonia la Porta di Aulon era ben difesa dalle sue opere e dai tratti di cortina discendenti dal Colle A e dalla Piazzetta sulla sella del vallone Campana, che metteva in comunicazione la città con la sua chòra meridionale interna. La porta locrese di Quote San Francesco, una delle principali per la viabilità urbana e territoriale, era parzialmente favorita dalla natura del sito, che poco più a monte del varco imponeva alle mura un percorso d’altura favorevole al fiancheggiamento della porta stessa. La Porta Marina Nord di Velia si apriva sulla valle del Palistro, per collegare la città ad una delle principali vie extraurbane verso la Lucania interna e il territorio di Paestum, ma era protetta dal pendio lungo il quale furono realizzati i tratti di cortina a cremagliera.
Locri e forse anche a Crotone, ma ancora una volta non per inadeguatezza al nuovo clima culturale, bensì sfruttando la capacità di assorbimento della muratura in crudo, contestualmente all’assenza di buona pietra da costruzione, per far fronte alle azioni dell’artiglieria assediante. L’urbanistica e le mura Ulteriori caratteristiche delle fortificazioni magnogreche d’età tardo classica-ellenistica sono il rapporto che intercorreva fra l’impianto urbano e il circuito difensivo, la strutturazione dei fronti di mare, le difese delle acropoli e il problema dello smaltimento delle acque. § Impianto urbano e impianto difensivo Il primo argomento tocca una problematica che esce dai limiti specifici dell’architettura militare per estendersi alla materia urbanistica. Dai casi presi in esame sembra di poter dedurre che la definizione dell’impianto difensivo non rispettava rigidamente gli orientamenti di quello urbanistico, poiché rispondeva innanzitutto alla norma di adeguamento al sito. Le vie cittadine per canto loro erano tracciate ignorando l’andamento più adatto scelto per le mura. Tuttavia i due sistemi erano strettamente collegati presso le porte urbiche, ovvero i punti in cui quello viario doveva attraversare quello difensivo per entrare in collegamento con la chòra e le strade extraurbane. Quindi le porte venivano realizzate là dov’era imposto dagli orientamenti delle plateìai urbane, determinando la necessità di fortificare dei varchi, che rappresentavano un indebolimento del sistema difensivo, non nel sito strategicamente migliore, ma in quello più funzionale per il rapporto fra viabilità urbana e territoriale. Generalmente in tali situazioni era l’opera difensiva di tutto il complesso della porta che tentava di superare artificialmente l’elevata esposizione a cui la costringeva il sito, ma in altre occasioni la situazione del terreno non appare così strategicamente sfavorevole.
§ La funzionalità difensiva degli impianti urbani Sempre riguardo al rapporto fra il circuito difensivo e l’impianto urbano si nota la buona efficienza dei collegamenti rettilinei e regolari fra il centro politico e religioso delle pòleis e le zone periferiche destinate alla difesa. Basti citare il collegamento fra l’agorà di Metaponto e la Porta Settembrini, oppure a Taranto fra la Porta Temenide e la zona centrale dell’agorà e dei porti, la plateìa locrese che dalla Porta di Afrodite conduceva ai piedi dell’acropoli di Cusemi-Marafioti, e infine la via di Porta Rosa a Velia, un asse di collegamento centrale, che fra la Porta Marina Nord e la Sud univa tutte le zone religiose, civili e insediative della città. Questa situazione generale sembra riflettere l’immagine di efficienza fra le varie componenti della città professata da Enea Tattico4, ovviamente derivante dall’assetto degli impianti urbani coloniali per strigas, definiti ben prima della nascita del trattato di Enea, ma comunque testimoni di una concezione unitaria della città, che dal punto di vista difensivo anticipa la trattatistica dell’età ellenistica e ne esemplifica sul terreno alcuni precetti.
Al primo caso appartengono la Porta Settembrini di Metaponto, aperta verso la chòra necessariamente sul prolungamento della grande plateìa est-ovest e armata quindi di poderosi torrioni, per supplire la protezione insufficiente fornita dal solo risalto del terrazzo urbano. Segue la porta presso Casa Quaranta a Caulonia, così esposta in pianura che, oltre ad essere rifatta completamente dopo il 350 a.C., venne irrobustita con l’avanzamento della cinta della Neapolis occidentale. A questo gruppo fanno ancora capo la nuova porta ipotizzabile presso la torre III di Caulonia, la Porta di Afrodite a Locri, con la sua poderosa torre sud, la Portuense fiancheggiata dal proteìchisma settentrionale del porto e tutte le aperture del fronte di mare della stessa città, sguarnite fino alla prima metà del III sec. a.C., la Porta della Fiumarella a Velia, l’unica della colonia focea aperta in piena campagna per collegare la plateìa principale del quartiere meridionale con lo scalo fluviale, le porte di Paestum, esclusa la Porta Marina, che furono realizzate necessariamente lungo i fronti della città, aperti sulla piana del Sele, e dunque passarono dal già munito schema a cortile al tipo della «Kammertor».
D’altro canto questo genere di rapporto fra l’impianto urbano e quello difensivo sembra ignorare le considerazioni di Aristotele sulla pericolosità di un collegamento diretto fra le periferie fortificate e i centri direzionali e sulla validità della conservazione dell’archaìon tròpon urbanistico nelle zone limitanee dell’impianto. Evidentemente è la stessa genesi delle colonie che determina questo distacco, in quanto esse nacquero non già conformi alle norme dell’urbanistica milesia, ma su impianti a schema ortogonale, razionalizzati e funzionali allo sviluppo economico e sociale di cui godettero in età arcaica, ben lungi dal considerare primario il problema difensivo come nei secoli successivi. L’argomento torna a coinvolgere la problema4
88
supra pp. 8-9.
tica della nascita delle cinte fortificate in occidente fin dall’età arcaica, motivate probabilmente dalla necessità di difesa in terre occupate da altre popolazioni, contro le quali i coloni greci, in caso di conflitto, forse pensavano di far conto anche sulle fortificazioni e non solo sull’ordinamento militare oplitico, ma d’altro canto non sembra generalizzabile la diffusione delle cinte coloniali nello stesso periodo e la loro presenza deve anche essere considerata alla luce dei rapporti non sempre pacifici fra una colonia e l’altra5. Rimane pertanto un dato di fatto che la componente difensiva anche se precoce in età arcaica non è dominante, come dimostrano chiaramente i casi di Metaponto e di Locri.
mare la città, come d’altro canto fece Alessandro il Molosso, e poi le ristrutturazioni successive risalgono ai tempi in cui la colonia latina fu schierata al fianco di Roma durante il confronto con Cartagine, un’altra potente città marinara. § Le acropoli Un ulteriore elemento da considerare, in relazione al rapporto fra le fortificazioni e il loro contesto urbano, è la presenza in alcune città esaminate dell’acropoli, munita di fortificazioni in epoche più antiche, ma conservata e rinforzata in età tardo classica ed ellenistica per garantire un centro ultimo di resistenza, nell’ambito di una concezione scalare della difesa secondo la strategia di IV e III sec. a.C.
§ I porti e le fortificazioni La concezione urbana aristotelica sembra invece ben presente nell’evidente apertura verso il mare delle città prese in esame6, fatto che in età ellenistica determina conseguenze notevoli sulla difesa dei fronti portuali. Se infatti la presenza di una porta causava l’indebolimento del diaframma difensivo, la sua apertura lungo un fronte rivolto verso il mare poteva raddoppiare i pericoli, esponendo la città ad attacchi navali concentrati sui porti.
Sembra che queste fortezze interne al circuito urbano esistessero nelle pòleis la cui natura orografica permetteva l’isolamento di un’altura, che corrispondeva in alcuni casi, come quello di Locri, al sito del primo impianto dell’apoikìa e quindi alla sede delle tradizioni patrie. Così avveniva a Taranto, dove l’acropoli, pur essendo minimamente rilevata rispetto alla città nuova, corrispondeva al luogo in cui si insediarono i primi coloni spartani e fornì ancora ai Romani nel 213 a.C. un ottimo centro di resistenza.
Pur rammaricando la mancanza di notizie sulla situazione difensiva del fronte orientale di Crotone e del portocanale di Metaponto, l’esempio più significativo in materia è quello di Locri, il cui fronte di mare risultava aperto e permeabile fino all’età ellenistica inoltrata, ma comunque difeso dai proteichìsmata del bacino portuale e dalle strutture poderose della Porta di Afrodite, per poi trasformarsi in un lungo tratto di mura chiuso e impenetrabile dalla metà del III sec. a.C. Accanto all’esempio locrese sembra interessante quello del fronte di mare sud a Velia, che, a differenza del precedente, non visse due momenti opposti di massima apertura e massima chiusura, ma, mantenendo il collegamento fra la città e il presunto porto fin dal V sec. a.C., tramite la Porta Marina Sud, presentava un efficiente sistema di fiancheggiamenti e coperture dell’area litoranea, attuato dalle difese delle torri della porta e del tratto terminale del diateìchisma proveniente dal vallone del Frittolo.
In ordine ad un vantaggio strategico le posizioni d’altura, in parecchi casi si moltiplicarono, determinando in età ellenistica situazioni come quella di Crotone, la cui acropoli, collocata, non con certezza, sulla collina del castello spagnolo all’interno al circuito difensivo, fu supportata dalle postazioni di Santa Lucia, Vigna Nuova e Batteria. Altri casi evidenti sono quello di Caulonia, dove l’acropoli sulla Piazzetta era coperta a monte dalle difese del Colle A, oppure il sistema locrese, la cui acropoli sul pianoro di Cusemi era circondata dalle postazioni d’altura di Castellace, Abbadessa, Mannella e Piani Caruso, e infine la composizione assiale delle fortificazioni di Velia che si articolavano tutte intorno alla linea di collegamento fra il Castelluccio ad est e la vera acropoli urbana ad ovest. § Sistema di drenaggio e sistema difensivo
Due fronti di mare difesi invece in maniera tale da far prevalere assolutamente le esigenze strategiche erano quelli di Taranto e Paestum. A Taranto tutto il lato della città nuova e dell’acropoli, esposto verso il Mar Grande, era difeso da una linea continua di mura, mentre il fronte nord, quello veramente aperto sul porto interno del Mar Piccolo, presentava in epoca ellenistica le aperture monumentali, immagine della potenza della pòlis, che erano protette dalla natura stessa del sito e non si trovavano esposte in prima linea come quelle locresi. Il fronte di mare pestano, invece, rispetto agli altri, sembra addirittura quello meglio munito, ma è necessario cercare nelle vicende storiche la ragione di tale sistemazione; infatti la prima fase della difesa risale all’epoca dell’occupazione lucana, quando le pòleis italiote potevano minacciare dal 5 6
Chiude la serie delle tematiche urbanistiche il rapporto esistente fra il sistema difensivo e quello di drenaggio urbano, che si esplicava, come nel caso del rapporto con l’impianto viario, nei punti in cui le fortificazioni dovevano essere modificate per la fuoriuscita dei canali di scarico o delle fognature. In generale però la problematica si estende alla questione della gestione dell’acque dell’intero territorio di una città, poiché, come si è rilevato nei casi di Paestum, Metaponto, Locri, Caulonia, la presenza di corsi d’acqua prossimi alle fortificazioni permetteva il loro utilizzo per l’allagamento dei fossati, esaltandone il valore strategico di opere avanzate, capaci di ostacolare l’approccio delle macchine d’assalto.
supra p. 87 nota n. 2. supra pp. 5-6.
89
Per quanto concerne invece la gestione e lo smaltimento delle acque all’interno del circuito murario i casi più rilevanti sono forniti da Metaponto, Locri e Velia, che risolsero il problema aprendo dei varchi di dimensioni diverse attraverso la muratura delle cortine7. In termini difensivi l’apertura di questi apprestamenti fu attuata trovando degli accorgimenti che impedissero l’accesso di nuclei d’assalto mandati da un eventuale assediante. A tal fine fu realizzato l’avanzamento della struttura delle cloache metapontine fino al limite del fossato, oppure fu creato un passaggio bipartito, non praticabile e difeso da una torre, a Velia o nella stessa città, come a Metaponto, si realizzò la fuorisuscita dei canali attraverso le strutture delle porte. Furono anche previste delle paratie o delle griglie per occludere grandi varchi come quelli locresi, realizzati in associazione a poderose opere difensive.
sante notare che tuttavia è rara, se non inesistente, la disposizione della torre quadrangolare con uno spigolo rivolto verso il fronte d’attacco, secondo le norme filoniane8, non solo nei casi di ristrutturazione o mantenimento di opere più antiche, come per esempio a Velia, ma anche quando le torri sono aggiunte durante il III sec. a.C., come le opere della seconda fase della Porta di Afrodite a Locri o a Paestum le torri quadrate, realizzate dopo la deduzione delle colonia latina. Tuttavia è proprio la presenza di una torre pentagonale a Paestum, risalente probabilmente alla seconda metà del III sec. a.C., che può far luce sul problema, in quanto la diffusione delle sofisticate norme per la realizzazione di opere a fiancheggiamento perfetto e reciproco fra torri e cortine, di cui il trattato filoniano è la massima espressione teorica da noi finora conosciuta, si attuò in occidente, e in tutto il mondo ellenizzato dopo che le pòleis magnogreche realizzarono le principali ristrutturazioni dei sistemi difensivi, pressate dalle guerre dionigiane e dall’avanzata delle genti italiche. Perciò in Magna Grecia l’architettura militare ellenistica offre soprattutto esempi della sua prima fase di vita e documenta quelle ricerche e sperimentazioni che furono poi sintetizzate e normalizzate dai teorici del III sec. a.C. È necessario ricordare comunque a tal proposito che il tipo della torre quadrangolare è attestato in Magna Grecia fin dal tardo Arcaismo, come dimostrano per esempio le torri di Castellace e della Porta di Afrodite a Locri, i primi impianti d’età severa delle torri di Velia, i resti della fase precedente quella di IV sec. a.C. della porta di Casa Quaranta a Caulonia..
Pertanto è necessario sottolineare, come appare chiaramente in ciascuna di queste tre città, che la necessità della gestione razionale delle acque e il loro deflusso controllato risultava di importanza fondamentale per la sicurezza interna, tanto da far prevalere la presenza dei varchi di scarico sulle ragioni strategiche del circuito difensivo, che, nei punti deputati all’installazione di questi apprestamenti, doveva essere modificato opportunamente per assolvere ad entrambe le funzioni. Le opere della nuova teichopoiìa Le più importanti tracce della presenza della nuova teichopoiìa in Magna Grecia, come si è accennato sopra, sono costituite dalle opere aggiunte ex novo lungo i circuiti o dalle ristrutturazioni di quelle più antiche, a partire dal IV sec. a.C.
§ Le porte La documentazione che comprova quanto si è appena detto è quella relativa alle porte urbiche, infatti si sono soprattutto individuati i generi di porta risalenti al IV sec. a.C. e alla prima metà del III sec. a.C., quali il varco semplice ortogonale alle mura difeso da una o due poderose torri e i tipi a corridoio e a cortile, specifiche evoluzioni dei varchi semplici.
§ Le torri Le torri rappresentavano, nelle città prese in esame, un elemento fondamentale per la fortificazione urbana; erano punti organizzativi della difesa di una porzione del fronte di appartenenza e in esse era possibile moltiplicare le postazioni di tiro e le belostàseis.
Al primo tipo appartengono la Porta Settembrini di Metaponto, la Porta di Aulon e quella della torre III a Caulonia, la Porta di Afrodite e quella di Parapezza a Locri, le porte veline della Fiumarella e Marina Sud. Il tipo a corridoio è ben esemplificato dalla trasformazione di IV sec. a.C. della porta di Casa Quaranta a Caulonia. Corrispondono invece al tipo a cortile la porta principale di Castiglione di Paludi, quella di Quote San Francesco a Locri, la Porta Marina Nord di Velia e tutte le fasi lucane delle porte di Paestum.
Pur essendo presenti a Metaponto, Castiglione di Paludi, Locri, Velia e Paestum alcune torri che provano la diffusione del tipo circolare, risulta dominante la torre quadrangolare con poderose fondazioni a camera inferiore, vuota o colmata da émplekton, e generalmente due piani a partire dal livello del cammino di ronda. Le dimensioni sembrano variare fra i 6 e i 10 metri di lato e lo spessore delle pareti fra 1,50 e 4 metri con una prevalenza verso la fine del IV e per tutto il III sec. a.C. delle grandi torri quadrangolari a più piani per l’alloggiamento di artiglierie pesanti. Tale situazione è dimostrata dalle difese della Porta Settembrini di Metaponto, dai casi del fronte nord a Caulonia, da alcune torri delle porte locresi, da gran parte delle torri di Velia e di Paestum, dove si rileva anche la presenza di un esemplare a forma pentagonale. È interes-
Ancora una volta è a Paestum che si individuano le caratteristiche di un’evoluzione successiva delle difese, che, come nel caso della torre pentagonale, ha fatto riferimento alle ricerche architettonico-militari del medio Ellenismo, dopo la nascita della colonia latina e in vista delle lotte con Cartagine, introducendo la «Kammertor», il poderoso torrione armato di artiglierie pesanti, che viene so-
7
Specificamente sull’argomento della gestione delle acque SCONFIENZA 1996, pp. 45-48; supra pp. 65 nota n. 59, 70 nota n. 14.
8
90
supra pp. 12 nota n. 78, 14.
sul terreno9. Nelle altre città invece ci sembra di cogliere un momento precedente a questa fase, quando contava soprattutto creare strutture che alloggiassero più pezzi d’artiglieria operanti in direzione frontale o lungo i tratti di cortina; così infatti si può spiegare l’ispessimento delle mura locresi dalla seconda metà-fine del IV sec. a.C. o la concezione del sistema difensivo di Caulonia o ancora l’interazione delle torri di Velia, sia nei tratti d’altura, semplici e a cremagliera, sia in quelli di fronte al porto meridionale.
vrapposto ai cortili delle fasi precedenti, determinando una difesa del varco non più mediata dal fiancheggiamento delle due torri presso gli stipiti, ma diretta dall’alto su tutto il terreno antistante. Il livello di «modernità» della nuova teichopoiìa L’argomento affrontato porta a considerare la questione centrale della cultura fortificatoria d’età ellenistica, che è la presenza in Magna Grecia delle norme di fiancheggiamento e di tiro radente e del loro livello di applicazione.
Conclusione In generale, a conferma di quanto accennato sopra, sembra che l’interazione fra le torri, come per esempio a Caulonia, a Velia, lungo il fronte nord di Paestum, rispondesse ad un principio elementare di fiancheggiamento reciproco fra le opere in successione lungo la cortina, per la difesa di sé medesime e della cortina stessa. Tale principio non sembra applicato a Locri dove dominavano piuttosto le opere isolate, come le torri angolari del fronte di mare, la torre Marzano, quella di Castellace e le opere delle porte, a differenza delle torri di Abbadessa e Mannella che potevano difendersi reciprocamente a vista, ma avevano il compito principale di governare l’ingresso del vallone Saitta. Anche a Paestum, escluso il fronte settentrionale, era invalso l’utilizzo della torre poderosa autonoma specialmente lungo i fronti est, sud e ovest prima di Porta Marina, oltre la quale operava invece un sistema di fiancheggiamenti che comprendeva tutto l’avancorpo di sud-ovest.
Il quadro che viene dunque a delinearsi pone in risalto soprattutto l’attività fortificatoria sviluppata nelle città della Magna Grecia fra il IV sec. a.C. e la prima metà del successivo. Certamente la ragione, per cui solo in una città come Paestum si individua un’applicazione delle tecniche architettoniche adeguata alla poliorcetica medio ellenistica, mentre nelle altre città come Velia, Locri, Metaponto, Caulonia, Crotone rimasero in funzione gli apparati difensivi dell’inizio del III sec. a.C., deve essere ricercata nelle vicende storiche di ogni singola pòlis e complessivamente in quelle della conquista romana e della guerra annibalica, che, senza dubbio, stanno alla base di un indebolimento sempre più grave delle antiche colonie, tanto da impedire un ulteriore ed oneroso rifacimento del sistema difensivo. La ricerca in tal senso richiederebbe l’apertura di un’indagine parallela sulla situazione della difesa territoriale delle pòleis magnogreche, tuttavia è possibile, alla luce degli attuali risultati, sostenere che nelle antiche colonie della Magna Grecia, fra il tardo Classicismo e l’età ellenistica, era presente nelle antiche colonie una tradizione architettonico-militare ben fondata su esperienze precedenti e aggiornata nelle nuove tecniche della difesa attiva, ma particolarmente sviluppata nel periodo iniziale dell’Ellenismo, in ragione del coinvolgimento del mondo italiota nelle lotte per l’egemonia di Siracusa e nel grande scontro fra i Greci d’occidente e le genti italiche.
Nel caso di Locri tuttavia è possibile ipotizzare che le torri e le difese delle porte, aggiunte dalla fine del IV sec. a.C., fossero l’integrazione di un sistema difensivo che soprattutto nella zona pianeggiante, era ancora molto legato alla concezione della difesa passiva, per quanto la tradizione fortificatoria locrese avesse ascendenze antiche e, dopo il 350 a.C., avesse saputo produrre un sistema difensivo come quello di Caulonia. D’altro canto è necessario considerare l’alto costo della trasformazione «moderna» di un circuito ampio come quello locrese, tanto da indurre probabilmente alla scelta di costruire opere singole in punti deboli, dove l’azione delle artiglierie permetteva la sicura copertura della cortina e del terreno antistante. Nel caso di Paestum invece, soprattutto dopo la deduzione della colonia latina, sembra che il fiancheggiamento, attuato dalle grandi torri isolate e dalle porte, sia il prodotto di un’evoluzione dalla copertura reciproca semplice alla riproduzione, lungo tutto il circuito, della difesa totale dell’area controllata da ogni opera, tramite l’utilizzo di postierle per l’azione extramuranea, l’aumento dei calibri delle artiglierie, la presenza di camere inferiori, per l’alloggiamento di pezzi a tiro radente, e di proteichìsmata fra le mura e il fossato, per la difesa ravvicinata durante gli assalti. È proprio in questa integrazione pestana, fra il fiancheggiamento dall’alto delle torri e delle cortine e la difesa avanzata a tiro radente, associata al fossato, che si ritrova il complesso delle teorie di Filone di Bisanzio applicate
9
91
supra pp. 12-14.
92
BIBLIOGRAFIA
Le fonti antiche sono state abbreviate indicando il titolo in italiano o in lingua con l’anno di edizione fra parentesi.
In questa parte finale sono raccolti i titoli di tutte le opere consultate per la redazione della parte prima, dedicata alla storia della poliorcetica ellenica e alle vicende politicomilitari della Magna Grecia, e per la ricostruzione dei sistemi fortificati di ogni città, presa in esame nella parte seconda .
Le opere consultate, divise in una sezione dedicata alla poliorcetica e all’architettura militare e in un’altra alle ricerche archeologiche e storiche in Magna Grecia, inerenti l’argomento trattato, sono elencate in ordine alfabetico con l’abbreviazione, precedente la dicitura per esteso e costituita dal cognome dell’autore e dall’anno di edizione. I cognomi doppi sono privi del trattino di separazione, usa-to invece per distinguere i cognomi di due o più autori che hanno contribuito alla produzione della stessa opera.
Vengono elencate dapprima le abbreviazioni dei periodici, generalmente secondo l’uso dell’Archäologische Bibliographie, tranne in alcuni casi in cui si è scelto un tipo di abbreviazione personale e più rapido. Seguono le abbreviazioni delle opere di autori vari, con un termine o una sigla caratteristici e l’anno di edizione.
Universo L’Universo. Rivista dell’Istituto Geografico Militare. Firenze
Abbreviazioni di periodici AION Annali dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli. Sezione di Archeologia e Storia Antica AJA American Journal of Archaeology ArcCal Archivio Storico per la Calabria e la Lucania ASAA Annuario della Scuola Archeologica Italiana di Atene ASMG Atti e Memorie della Società Magna Grecia ASNP Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa DdA Dialoghi di Archeologia DossArch Les Dossiers d’Archéologie FA Fasti Archeologici. Annual Bulletin of Classical Archaeology Hist Historica. Rivista trimestrale di cultura Klearchos Klearchos. Bollettino dell’Associazione Amici del Museo di Reggio Calabria MEFRA Mélanges de l’École Française de Rome. Antiquité MG Magna Graecia. Rassegna di Archeologia Storia Arte Attualità diretta da Tanino De Santis MonAnt Monumenti Antichi pubblicati per cura dell’Accademia Nazionale dei Lincei NSA Notizie degli Scavi di Antichità Orizzonti Orizzonti. Rassegna di Archeologia PdP La Parola del Passato QRS Quaderni de La Ricerca Scientifica RA Revue Archéologique RendLinc Atti dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Rendiconti - Classe di Scienze morali, storiche e filologiche RM Mitteilungen des Deutschen Archaeologischen Instituts. Roemische Abteilung Taras Taras. Rivista di Archeologia
Abbreviazioni di opere miscellanee e di autori vari ACT Atti del Convegno di Studi sulla Magna Grecia. Taranto ACIAC Atti del Congresso Internazionale di Archeologia Classica ArchUrb 1987 R. MARTIN, Architecture et Urbanisme, Préface de J. POUILLOUX et G. VALLET, Collection De l’Ecole Française de Rome 99, Roma 1987 Basilicata 1999 D. ADAMESTEANU (a cura di), Storia della Basilicata. 1. L’Antichità, Roma-Bari 1999 BTCG 1984-1999 G. NENCI, D. VALLET (a cura di), Bibliografia topografica della colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche, Pisa-Roma-Napoli 1984-1999 Crotone 1993 Crotone e la sua storia fra IV e III sec. a.C., Napoli 1993 EAA 1958-1997 Enciclopedia dell’Arte Antica Classica e Orientale, Roma 1958-1997 Fortificationes Antiquae 1992 S. VAN DE MAELE, J. M. FOSSEY (a cura di), Fortificationes Antiquae, Amsterdam 1992 Greci 1998 S. SETTIS (a cura di), I Greci. Storia Cultura Arte Società. 2 Una storia greca. III. Trasformazioni, Torino 1998 GreciOcc 1996 G. PUGLIESE CARRATELLI (a cura di), I Greci in Occidente. Catalogo della mostra, Milano 1996 GuerreGr 1985 J. P. VERNANT (a cura di), Problèmes de la guerre en Grèce ancienne, Paris 1985 Kaulonia I 1989 H. TREZINY (a cura di), Kaulonia I. Sondages sur la fortification nord (1982-1985), Cahiers di Centre Jean Bérard, XIII, Naples 1989 LG I-III 1992-1996 G. CAMBIANO, L. CANFORA, D. LANZA (a cura di), Lo spazio letterario della Grecia antica, 3 Volumi, Roma 1992-1996 Locri I 1977 Locri Epizefiri I. Ricerche nella zona di Centocamere, Firenze 1977 Megale Hellas 1983 Megale Hellas. Storia e civiltà della Magna Grecia, Milano 1983 Metaponto I 1975 D. ADAMESTEANU, D. MERTENS, F. D’ANDRIA, Metaponto I, in NSA, Suppl. 1975 MG I-IV 1985-1990 G. PUGLIESE CARRATELLI (a cura di), Magna Grecia, 4 Volumi, Milano 1985-1990
93
Paestum 2000 E. GRECO, F. LONGO, Paestum. Scavi,studi e ricerche. Bilancio di un decennio (1988-1998), Paestum 2000 Sikanie 1989 Sikanie. Storia e civiltà della Sicilia greca, Milano 1989 SiriMeta 1998 Siritide e Metapontino. Storie di due territori coloniali, Atti dell’incontro di studio Policoro, 31 Ottobre - 2 Novembre 1991, Naples-Paestum 1998 TerreGr 1983 M. I. FINLEY (a cura di), Problèmes de la terre en Grèce ancienne, Paris- La Haye 1983 Valbonne 1986 P. LERICHE, H. TREZINY (a cura di), La fortification dans l’histoire du monde grec. Actes du Colloque International, La fortification et sa place dans l’histoire politique, culturelle et sociale du monde grec, Valbonne, Décembre 1982, Paris 1986 Velia 1994 G. GRECO, F. KRINZINGER (a cura di), Velia. Studi e ricerche, Modena 1994 Velia 1999 F. KRINZINGER, G. TOCCO (a cura di), Neue Forschungen in Velia. Akten des Kongresses, La Ricerca archeologica a Velia (Rom, 1-2 Juli 1993), Archäologische Forschungen Band 2, Velia-Studien I, Wien 1999
Sintassi Meccanica (1974) Le livre «V» de la Syntaxe Mécanique de Philon de Byzance, texte, traduction et commentaire, in GARLAN 1974, pp. 281-404. Storie (1982) Polybe. Histoires, Livre VII-VIII-IX, texte établi et traduit par R. WEIL, Paris, Les Belles Lettres, 1982 Uccelli (1987) Aristofane. Gli Uccelli, a cura di G. ZANETTO, introduzione e traduzione di D. DEL CORNO, Milano, Fondazione Lorenzo Valla, Mondadori, 1987
Storia, urbanistica, ingegneria, architettura militare ADAM 1982 J. P. ADAM, L’architecture militaire grecque, Paris 1982 ADAM 1992 J. P. ADAM, Approche et défense des portes dans le monde hellénisé, in Fortificationes Antiquae 1992, pp. 5-43 ADCOCK 1957 F. E. ADCOCK, The Greek and Macedonian Art of Warfare, London 1957 ANGLIM E A. 2002 S. ANGLIM, P. G. JESTICE, R. S. RICE, S. M: RUSCH, J. SERRATI, Fighting Techniques of the Ancient World. 3000 bC - aD 500, London 2002 ANDRONIKOS 1970 M. ANDRONIKOS, Sarissa, in «Bulletin de Correspondence Hellénique», 94, 1970, pp. 91-107 ASHLEY 1998 J. R. ASHLEY, The Macedonian Empire. The art of warfare under Philip II and Alexander the Great. 359-323 b.C., Jefferson 1998 BAKHUIZEN 1986 S. C. BACHUIZEN, La grande batterie de Gorìtsa et l’artillerie défensive, in Valbonne 1986, pp. 315-321 BAKHUIZEN E A. 1992 S. C. BAKHUIZEN (a cura di), A Greek City of the Fourth Century B. C., Roma 1992 BAR KOCHVA 1976 B. BAR KOCHVA, The Seleucid Army, Cambridge 1976 BENTLEY KERN 1999 P. BENTLEY KERN, Ancient Siege Warfare, Bloomington 1999 BENEVOLO 1993 L. BENEVOLO, Storia della città 1. La città antica, Roma-Bari 1993 BENGSTON 1988 H. BENGSTON, Storia greca I. La Grecia arcaica e classica, tr. it., Bologna 1988 BENGSTON 1989 H. BENGSTON, Storia greca II. La Grecia ellenistica e romana, tr. it., Bologna 1989 BETTALLI 1998 M. BETTALLI, L’esercito e l’arte della guerra, in Greci 1998, pp. 729742 BETTALLI 2004 M. BETTALLI, I “Condottieri” di Taranto e la Guerra nel mondo greco, in Alessandro il Molosso e i “Condottieri”in Magna Grecia, ACT XLIII, Taranto-Cosenza 2003, Napoli 2004, pp. 111-134 BLANCHARD 1996 A. BLANCHARD, Vauban, Paris 1996 BON 1967 A. M. BON, Introduction, in Poliorcetica (1967), pp. VII-LVII BONARDI 1990 C. BONARDI, La cittadella dei Gonzaga, in A. MAROTTA (a cura di), La cittadella di Casale da fortezza del Monferrato a baluardo d’Italia. 1590-1859, Alessandria 1990 BONARDI 1995 C. BONARDI, Cinte murarie e città, in M. VIGLINO DAVICO (a cura di), Cultura castellana. Atti del Corso 1994, Istituto Italiano dei Castelli, Torino 1995 BOULOUMIE-FINKER 1986 B. BOULOUMIE, M. FINKER, Le rempart hellénistique de Saint-Blaise : III. Description préliminaire et position des problèmes, in Valbonne 1986, pp. 401-406 BRACONI 2001 P. BRACONI, Emplecton, in AION, n. s. 8, 2001, pp. 71-101 BRANDS 1988 G. BRANDS, Republikanische Stadttore in Italien, BAR international Series 458, Oxford 1988
Fonti antiche Ab urbe condita (1957) Titi Livi ab urbe condita, recognoverunt et adnotatione critica instruxerunt R. SEYMOUR CONWAY et S. KEYMER JOHNSON, Tomus IV, Libri XXVI-XXX, Oxonii, tipographo Claredoniano 1957 Ab urbe condita (1958) Titi Livi ab urbe condita, recognoverunt et adnotatione critica instruxerunt C. FLAMSTEAD WALTERS et R. SEYMOUR CONWAY, Tomus III, Libri XXI-XXV, Oxonii, tipographo Claredoniano 1958 Arte dell’assedio (1999) L’arte dell’assedio di Apollodoro di Damasco, a cura di A. LA REGINA, Milano, Electa, 1999 Crizia (1985) Platon. Œuvres complètes, Tome X, Timée - Critias, texte établi et traduit par A. RIVAUD, Paris, Les Belles Lettres, 1985 De Architectura (1990) Vitruve. De l’architecture, Livre I, texte établi, traduit et commenté par P. FLEURY, Paris, Les Belles Lettres, 1990 Entrate (1956) Xenophon. Scripta Minora. Ways and Means, with an English translation by E. C. MARCHANT, London, William Heinemann LTD, 1956 Geografia (1967) Strabon. Géographie, Tome III (Livres V et VI), texte établi et traduit par F. LASSERRE, Paris, Les Belles Lettres, 1967 Ipparchico (1973) Xénophon. Le commandant de la cavalerie, texte établi et traduit par E. DELEBECQUE, Paris, Les Belles Lettres, 1973 Leggi (1951) Platon. Oeuvres complètes, Tome XI (2e partie), Les Lois, texte établi et traduit par E. DES PLACES, Paris, Les Belles Lettres, 1951 Leggi (1956) Platon. Oeuvres complètes, Tome XII (1re partie), Les Lois, texte établi et traduit par A. DIES, Paris, Les Belles Lettres, 1956 Memorabili (1959) Xenophon. Memorabilia and Oeconomicus, with an English translation by E. C. MARCHANT, London, William Heinemann LTD, 1959 Periégesis (1999) Pausania. Guida della Grecia. Libro VI. L’Elide e Olimpia, testo e traduzione a cura di G. MADDOLI e M. NAFISSI, commento a cura di G. MADDOLI, M. NAFISSI e V. SALADINO, Milano, Fondazione Lorenzo Valla, Mondadori, 1999 Poliorcetica (1967) Éneée le Tacticien. Poliorcétique, texte établi par A. DAIN, traduit et annoté par A. M. BON, Paris, Les Belles Lettres, 1967 Politica (1986) Aristote. Politique, Tome III (1re partie), Livre VII, texte établi et traduit par J. AUBONNET, Paris, Les Belles Lettres, 1986
94
BRIZZI 2002 G. BRIZZI, Il guerriero, l’oplita, il legionario. Gli eserciti del mondo classico, Bologna 2002. BURNS 1974 A. BURNS, Ancient Greek Water Supply and City Planning. A study of Syracuse and Akragas, in «Technology and Culture», XV, 1974, pp. 389-406 CAMBIANO 1996 G. CAMBIANO, Alle origini della meccanica: Archimede e Archita, in Eredità della Magna Grecia, ACT XXXV, Taranto 1995, Taranto 1996, pp. 459-495 CAMERA-FABIETTI 1969 A. CAMERA, R. FABIETTI, Elementi di storia antica. Roma, Vol. II, Bologna 1969 CANFORA 1989 L. CANFORA, Una società premoderna. Lavoro morale scrittura in Grecia, Bari 1989 CASSI RAMELLI 1996 A. CASSI RAMELLI, Dalle caverne ai rifugi blindati, Milano 1964 (ristampa Bari 1996) CASSOLA-CRACCO RUGGINI 1982 F. CASSOLA, L. CRACCO RUGGINI, Storia antica delle grandi civiltà, Vol. II, Firenze 1982 CASTAGNOLI-FRACCARO 1963 F. CASTAGNOLI, P. FRACCARO, Mura e Fortificazione, in EAA, V, 1963, pp. 254-266 CAVALIERI 1998 M. CAVALIERI, Le fortificazioni di età ellenistica della Sicilia : il caso di Tyndaris, in «Sicilia Archeologica», XXXI, 1998, pp. 185-199 COURBIN 1985 P. COURBIN, La guerre en Gréce à l’haute époque d’après les documents archéologiques, in GuerreGr 1985, pp. 69-91 DE SETA-LE GOFF 1989 C. DE SETA, J. LE GOFF (a cura di), La città e le mura, Roma-Bari 1989 DETIENNE 1985 M. DETIENNE, La phalange. Problèmes et controverses, in GuerreGr 1985, pp. 119-142 DUCAT 2000 J. DUCAT, La societé spartiate et la guerre, in PROST 2000b, pp. 35-50. DUCREY 1986 P. DUCREY, Les fortifications grecques: rôle, fonction, efficacité, in Valbonne 1986, pp. 133-142 DUCREY 1995 P. DUCREY, La muraille est-elle un élément constitutif d’une cité, in M. H. HANSEN (a cura di) Sources for the Ancient Greek City-State, Copenhagen 1995, PP. 245-256 DUFFY 1996 C. DUFFY, Fire and stone. The Science of Fortress Warfare, 1660-1860, London 1996 FARA 1989 A. FARA, Il sistema e la città. Architettura fortificata dell’Europa moderna dai trattati alle realizzazioni: 1464-1794, Genova 1989 FARA 1993 A. FARA, La città da guerra, Torino 1993 FAUCHERRE 1991 N. FAUCHERRE, Places fortes bastion du pouvoir, Paris 1991 FAURE 1993 P. FAURE, La vita quotidiana degli eserciti di Alessandro Magno, tr. it., Milano 1993 FERRARI 1985 G. A. FERRARI, Meccanica allargata, in G. GIANNANTONI, M. VEGETTI (a cura di), La scienza ellenistica, Atti delle tre giornate di studio tenutesi a Pavia dal 14 al 16 aprile 1982, Napoli 1985, pp. 225-296 FINLEY 1985 M. J. FINLEY, Sparta, in GuerreGr 1985, pp. 143-160 FLEURY 1990 P. FLEURY, Introduction, in De Architectura (1990), pp. IX-CXV GARLAN 1974 Y. GARLAN, Recherches de poliorcétique grecque, Paris 1974 GARLAN 1983 Y. GARLAN, La dèfense du territoire à l’époque classique, in TerreGr 1983, pp. 149-160 GARLAN 1985a Y. GARLAN, Guerra e società nel mondo antico, tr. it., Bologna 1985 GARLAN 1985b Y. GARLAN, Fortifications et histoire grecque, GuerreGr 1985, pp. 245-260 GARLAN 1992 a Y. GARLAN, La poliorcétique, in DossArch, 172, 1992, pp. 28-35
GARLAN 1992b Y. GARLAN, Textes et fortifications, in DossArch, 172, 1992, pp. 52-57 GARLAN 1992c Y GARLAN, L’assedio di Rodi, in C. MOSSÉ (a cura di), La Grecia antica, tr. it., Bari 1992, pp. 323-337 GENTILI 1959 G. V. GENTILI, Castello Eurialo e mura dionigiane sottostanti, in FA, XIV, 1959, p. 173 VON GERKAN 1924 A. VON GERKAN, Griechische Städteanlagen. Untersuchungen zur Städtebaues im Altertum, Berlin und Leipzig 1924 GRECO-TORELLI 1983 E. GRECO, M. TORELLI, Storia dell’urbanistica. Il mondo greco, RomaBari 1983 GROS 1998 P. GROS, L’architecture romaine du début du IIIe siècle av. J.C. à la fin du Haut-Empire. 1 Les monuments publics, Paris 1998 HALLIER 1986 G. HALLIER, Pierre de taille et mesures normalisées: les enceintes hellénistiques d’Apollonia de Cyrenaïque et de Massalia, in Valbonne 1986, pp. 251-271 HANSON 1990 V. D. HANSON, L’arte occidentale della guerra. Descrizione di una battaglia nella Grecia Classica, tr. it., Milano 1990 HANSON 1999 V. D. HANSON, The Wars of the Ancient Greeks and Their Invention of Western Military Culture, London 1999 HERMANN 1992 M. Z. HERMANN, Ramparts. Fortification from the Renaissance to West Point, New York 1992 HOGG 1982 I. HOGG, Storia delle fortificazioni, tr. it., Novara 1982 KÄHLER 1942 H. KÄHLER, Die Römischen Torbungen der Frühen Kaiserzeit, in «Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts», 57, 1942, pp. 1-104 KARLSSON 1992 L. KARLSSON, Fortification Towers and Masonry Techniques in the Hegemony of Syracuse, 405-211 B. C., Stockholm 1992. KEYSER 1994 P. T. KEYSER, The use of artillery by Philipp II and Alexander the Great, in «Ancient World», 25, 1994, pp. 27-59 KIENAST 2004 H. KIENAST, Die Stadtmauer von Samos, (Samos XV), Bonn 1978 KLINGENBERG 1980 E. KLINGENBERG, Sull’interdipendenza tra l’agglomerato urbano e il diritto greco, in La città antica come fatto di cultura, Atti del Convegno di Como e Bellagio 16-19 giugno 1979, Milano 1980, pp. 195-213 KRAUSE 1972 C. KRAUSE, Das Westtor. Ergebnisse der Ausgrabungen 1964-1968, in Eretria IV, Bonn 1972, pp. 50-87. KRISCHEN 1941 F. KRISCHEN, Die Stadtmauern von Pompeij und Festungsbaukunst in Unteritalien und Sicilien, Berlin 1941 LAMBERINI 1988 D. LAMBERINI, La politica del guasto. L’impatto del fronte bastionato sulle preesistenze urbane, in C. CRESTI, A. FARA, D. LAMBERINI (a cura di), Atti del Convegno di Studi di Architettura Militare nell’Europa del XVI secolo, Firenze 25-28 novembre 1986, Siena 1988 LANDELS 1978 J. G. LANDELS, Engineering in the Ancient World, London 1978 LAUNEY 1987 M. LAUNEY, Recherches sur les armées hellenistiques, Paris 1949, ristampa con addenda 1987 LAWRENCE 1967 A. W. LAWRENCE, Greek Architecture, London 1967 LAWRENCE 1979 A. W. LAWRENCE, Greek Aims in fortification, London 1979 LE BOHEC BOUHET 2000 S. LE BOHEC-BOUHET, Les techniques de la guerre au IVe siècle, in PROST 2000b, pp. 257-275 LEVEQUE 1985 P. LEVEQUE, La guerre à l’époque hellenistique, in GuerreGr 1985, pp. 261-287 LORETO 1995 L. LORETO, Il generale e la biblioteca. La trattatistica militare greca da Democrito di Abdera ad Alessio I Comneno, in La ricezione e l’attualizzazione del testo, LG II 1995, pp. 563-589 LUGLI 1957 G. LUGLI, Tecnica edilizia romana, Roma 1957
95
SCHEFOLD 1968 K. SCHEFOLD, The Architecture of Eretria, in «Archaeology», 21, 1968, pp. 274-297 SCONFIENZA 1999 R. SCONFIENZA, Fortificazioni campali nel secolo XVIII. Contesti culturali e confronti per i trinceramenti dell’Assietta, in «Armi Antiche. Bollettino dell’Accademia di San Marciano», 1996 (1999), pp. 91-123 SCONFIENZA-ZANNONI 1998 R. SCONFIENZA, F. ZANNONI, Introduzione alla guerra d’assedio in età ellenistica, in «Armi Antiche. Bollettino dell’Accademia di San Marciano», 1995 (1998), pp. 41-74 SEKUNDA 1987 N. SEKUNDA, The Army of Alexander the Great, London 1987 SEKUNDA 1994 N. SEKUNDA, Seleucid and Ptolemaic Reformed Armies 168-145 BC, Volume 1: The Seleucid Army under Antiochus IV Epiphanes, Stockport 1994 SEKUNDA 1995 N. SEKUNDA, Seleucid and Ptolemaic Reformed Armies 168-145 BC, Volume 2: The Ptolemaic Army under Ptolemy VI Philometor, Stockport 1995 SEKUNDA 2000 N. SEKUNDA, Greek Hoplite, 480-323 BC, Oxford 2000 SNODGRASS 1986 A. M. SNODGRASS, The historical significance of fortification in Archaic Greece, in Valbonne 1986, pp. 125-131 SNODGRASS 1991 A. M. SNODGRASS, Armi e armature dei Greci, tr. it., Roma 1991 SOKOLICEK 2003 A. SOKOLICEK, Zum Phänomen des Diateichisma im Griechischen Städtebau, in «Forum Archeologiae. Zeitschrift für Archäologie», 27-62003, pubblicazione su sito INTERNET http://mailbox.univie.ac.at/elisabeth.trinkl/forum/forum0603/27mauern.htm SOMMELLA 1988 P. SOMMELLA, Italia antica. L’urbanistica romana, Roma 1988 SOLIS SANTOS 1998 C. SOLIS SANTOS, Macchine, tecniche e meccanica, in Greci 1998, pp. 704-728 TAM 1930 W. W. TAM, Hellenistic military and naval development, London 1930 TÖLLE KASTENBEIN 1969 R. TÖLLE KASTENBEIN, Die antike Stadt Samos, Mainz 1969 TÖLLE KASTENBEIN 1993 R. TÖLLE KASTENBEIN, Archeologia dell’acqua. La cultura idraulica nel mondo classico, tr. it., Milano 1993 TOLSTIKOV 1986 V. P. TOLSTIKOV, L’apport de la fortification à l’histoire du Bosphore antique, in Valbonne 1986, pp. 167-177 TOMLINSON 1961 R. A. TOMLINSON, Emplekton masonry and Greek structure, in «Journal of Hellenic Studies», 81, 1961, pp. 133-140 TRÉZINY 1986 H. TRÉZINY, Les techniques grecques de fortification et leur diffusion à la périphérie du monde grec d’Occident, in Valbonne 1986, pp. 185-200 TZONIS-LEFAIVRE 1989 A. TZONIS, L. LEFAIVRE, Il bastione come mentalità, in DE SETA-LE GOFF 1989, pp. 321-346 VIDAL NAQUET 1985 P. VIDAL NAQUET, La tradition de l’hoplite athénien, in GuerreGr 1985, pp. 161-181 WALBANK 1983 F. W. WALBANK, Il mondo ellenistico, tr. it., Bologna 1983 WARRY 1980 J. WARRY, Warfare in the Classical World. An illustrated encyclopedia of weapons, warriors and warfare in the ancient civilisations of Greece and Rome, London 1980 WARRY 1998 J. WARRY, Warfare in the Classical World. War and the ancient civilisations of Greece and Rome, London 1998 WINTER 1963 F. E. WINTER, The chronology of the Eurialos fortress at Syracuse, in AJA, 67, 1963, pp. 363-387 WINTER 1971 F. E. WINTER, Greek Fortifications, London 1971 WINTER 1997 F. E. WINTER, The use of artillery in fourth-century and hellenistic towers, in «Echos du Monde Classique/Classical News», 41, 1997, pp. 247-292
LUGLI 1970 G. LUGLI, Torre, in EAA, Suppl. 1970, pp. 854-861 MANSEL 1963 A. M. MANSEL, Die Ruinen von Side, Berlin 1963 MARSDEN 1969 E. W. MARSDEN, Greek and Roman Artillery. Historical development, Oxford 1969 MARTIN 1974 R. MARTIN, L’urbanisme dans la Grèce antique, Paris 1974 MARTIN 1984 R. MARTIN 1984, La Grecia e il mondo greco dalle origini all’età classica, Torino 1984 MARTIN 1987a R. MARTIN, Rôle des principes fonctionnels dans l’urbanisme de la Grèce antique, in ArchUrb 1987, pp. 89-117 MARTIN 1987b R. MARTIN, Agora et forum, in ArchUrb 1987, pp. 155-185 MARTIN 1987c R. MARTIN, L’espace civique, religieux et profane dans les cités grecques de l’archaïsme à l’époque hellénistique, in ArchUrb 1987, pp. 549-579 MARTIN 1987d R. MARTIN, Rapports entre les structures urbaines et les modes de division et d’exploitation du territoire, in ArchUrb 1987, pp. 581-597 MERTENS 1990 D. MERTENS, Die Befestigungen von Selinunt und Syrakus, in Akten des 13 Internationalen Kongresses für Klassische Archaeologie, Berlin West 1988, Mainz 1990, pp. 475-478 MERTENS 2002 D. MERTENS, Le lunghe mura di Dionigi I a Siracusa, in N.BONACASA, L. BRACCESI, L. DE MIRO (a cura di), La Sicilia dei due Dionisii, Atti della settimana di studio, Agrigento 24-28 febbraio 1999, Roma 2002, pp. 243-252 MC NICOLL 1978 A. MC NICOLL, Some developments in hellenistic siege warfare with special reference to Asia Minor, in The Proceedings of 10th International Congress of Classical Archaeology, Ankara-Izmir 1973, Ankara 1978, pp. 406-419 MC NICOLL 1986 A. MC NICOLL, Developments in techniques of siegekraft and fortifications in the Greek World ca. 400-100 B.C., in Valbonne 1986, pp. 305313 MOMIGLIANO 1935 A. MOMIGLIANO, Re e popolo in Macedonia prima di Alessandro Magno, in «Athenaeum», 13, 1935, pp. 3-21 MONTAGU 2000 J. D. MONTAGU, Battles of the Greek and Roman Worlds. A Chronological Compendium of 667 Battles to 31 BC, from the Historians of the Ancient World, London 2000 MÜLLER 2000 C. MÜLLER, La défense du territoire civique: stratégies et organisation spatiale, in PROST 2000b, pp. 16-33. OBER 1987 J. OBER, Early Artillery Towers: Messenia, Boiotia, Attic, Megarid, in AJA, 91, 1987, pp. 569-583 OBER 1992 J. OBER, Towards a tipology of Greek artillery-towers. The first and second generation, c. 375-275 B.C., in Fortificationes Antiquae 1992, pp. 147-169 PLEKET 1973 H. W. PLEKET, Technology in the Greco-Roman World: a general report, in «TALANTA», V, 1973, pp. 6-47 PROST 2000a F. PROST, Les combattants de Marathon :idéologie et societé hoplitiques à Athenes au Ve s., in PROST 2000b, pp. 69-88 PROST 2000b F. PROST (a cura di), Armées et sociétés de la Grèce Classique. Aspects sociaux et politiques de la guerre aux Ve et IV e s. av. J.-C., Paris 2000. REPELLINI 1993 F. F. REPELLINI, Matematica, astronomia e meccanica, in La produzione e la circolazione del testo, LG I 1993, pp. 305-343 RIZZA 2000 S. RIZZA, Studi sulle fortificazioni greche di Leontini, Catania 2000 RUSSO 1989 F. RUSSO, La difesa costiera del Regno di Napoli dal XVI al XIX secolo, Roma 1989 RUSSO 2002 F. RUSSO, Tormenta.Venti secoli di artiglieria meccanica, Roma 2002
96
ARIAS 1946a P. E. ARIAS, Note di archeologia locrese, in ArcCal, XV, 1946, pp. 7178 ARIAS 1946b P. E. ARIAS, Scavi archeologici in contrada Caruso-Polisà (aprile-maggio 1940), in NSA, 1946, pp. 138-161 ARIAS 1947 P. E. ARIAS, Locri. (Piani Caruso). Scavi di case antiche, in NSA, 1947, pp. 165-171 ARIAS 1959 P.E. ARIAS, Caulonia, in EAA, II, 1959, pp. 443-444 ARIAS-PARRA 1991 P. E. ARIAS, M. C. PARRA, Locri, in BTCG, IX, 1991, pp. 191-249 AUMÜLLER 1994 T. AUMÜLLER, Die Stadtmauernvon Hipponium. Ergebnisse der Bauforschung am Nordstflügel der griechischen Stadtmauern von Vibo Valentia, in RM, 101, 1994, pp. 241-278. BAGGIONI LIPPMANN 1982 M. BAGGIONI LIPPMANN, Étude gèomorphologique du site de Vélia, in PdP, XXXVII, 1982, pp. 210-223 BARBERIS 1999 V. BARBERIS, I siti tra Sinni e Bradano dall’età arcaica all’età ellenistica: schede, in M. BARRA BAGNASCO, E. DE MIRO, A. PINZONE (a cura di), Magna Grecia e Sicilia. Stato degli studi e prospettive di ricerca, Atti dell’Incontro di Studi, Messina 2-4 dicembre 1996, Messina 1999, pp. 59-105 BARILLARO 1964a E. BARILLARO, L’Akropolis di Lokroi Epizephyrioi, Corigliano Calabro 1964 BARILLARO 1964b E. BARILLARO, Il teatro greco-romano di Locri Epizefiri, Corigliano Calabro 1964 BARRA BAGNASCO 1971 M. BARRA BAGNASCO, Locri (intervento), in Taranto nella civiltà della Magna Grecia, ACT X, Taranto 1970, Napoli 1971, pp. 517-520 BARRA BAGNASCO 1973 M. BARRA BAGNASCO, Lo scavo di Locri (1972), in Economia e società nella Magna Grecia, ACT XII, Taranto 1972, Napoli 1973, pp. 353-360 BARRA BAGNASCO 1977a M. BARRA BAGNASCO, Lo scavo, in Locri I 1977, pp. 3-49 BARRA BAGNASCO 1977b M. BARRA BAGNASCO, Problemi di urbanistica locrese, in Locri Epizefirii, ACT XVI, Taranto 1976, Napoli 1977, pp. 375-408 BARRA BAGNASCO 1978 M. BARRA BAGNASCO, Indagine archeologica su Locri Epizefiri: i suoi monumenti e la sua produzione artistica nel quadro della cultura della Magna Grecia, in QRS, 100, 1978, pp. 555-590 BARRA BAGNASCO 1979 M. BARRA BAGNASCO, Locri Epizefiri - Campagna di scavo 1978, in Gli Eubei in Occidente, ACT XVIII, Taranto 1978, Napoli 1979, pp. 398-409 BARRA BAGNASCO 1983 M. BARRA BAGNASCO, L’impianto urbanistico, in Locri Epizefiri. Ricerche archeologiche su un abitato della Magna Grecia, Milano 1983, pp. 1-10 BARRA BAGNASCO 1984 M. BARRA BAGNASCO, Locri Epizefiri. Organizzazione dello spazio urbano e del territorio nel quadro della cultura greca d’occidente, Chiaravalle 1984 BARRA BAGNASCO 1985 M. BARRA BAGNASCO, Indagine archeologica su Locri Epizefiri, 19761979, in QRS, 112, 1985, pp. 181-216 BARRA BAGNASCO 1986 M. BARRA BAGNASCO, Locri Epizefiri - Campagna di scavo 1985, in Neapolis, ACT XXV, Taranto 1985, Taranto 1986, pp. 431-441 BARRA BAGNASCO 1987 M. BARRA BAGNASCO, Locri Epizefiri. Campagna di scavo 1986 a Marasà Sud, in Lo stretto crocevia di culture, ACT XXVI, Taranto 1986, Taranto 1987, pp. 711-717 BARRA BAGNASCO 1988 M. BARRA BAGNASCO, Locri Epizefiri - Marasà Sud, in PoseidoniaPaestum, ACT XXVII, Taranto 1987, Taranto 1988, pp. 657-664 BARRA BAGNASCO 1991 M. BARRA BAGNASCO, Locri Epizefiri. Campagna di scavo 1990, in I Messapi, ACT XXX, Taranto 1990, Taranto 1991, pp. 605-613 BARRA BAGNASCO 1992a M. BARRA BAGNASCO, Le strutture e la vita dell’area, in M. BARRA BAGNASCO (a cura di) Locri Epizefiri IV. Lo scavo di Marasà Sud. Il sacello tardo arcaico e la «casa dei leoni», Firenze 1992, pp. 5-53
ZACCARIA RUGGIU 1995 A. ZACCARIA RUGGIU, Spazio privato e spazio pubblico nella città romana, Collection De l’Ecole Française de Rome 210, Roma 1995
Ricerche storiche e archeologiche in Magna Grecia ADAMESTEANU 1965 D. ADAMESTEANU, Metaponto (Matera). Appunti fotointerpretativi, in NSA, 1965, pp. 179-184 ADAMESTEANU 1967 D. ADAMESTEANU, Problèlemes de la zone archéologique de Métaponte, in RA, 1967, pp. 3-38 ADAMESTEANU 1970 D. ADAMESTEANU, Metaponto, in EAA, Suppl. 1970, pp. 481-486 ADAMESTEANU 1973a D. ADAMESTEANU, Metaponto, Napoli 1973 ADAMESTEANU 1973b D. ADAMESTEANU, L’attività archeologica in Basilicata, in Economia e società nella Magna Grecia, ACT XII, Taranto 1972, Napoli 1973, pp. 313-327 ADAMESTEANU 1974 a D. ADAMESTEANU, Problemi topografici ed urbanistici metapontini, in Metaponto, ACT XIII, Taranto 1973, Napoli 1974, pp. 153-186 ADAMESTEANU 1974b D. ADAMESTEANU, Metaponto. Topografia e urbanistica, in MG, IX, 1974, pp. 7-9 ADAMESTEANU 1974c D. ADAMESTEANU, L’attività archeologica in Basilicata, in Metaponto, ACT XIII, Taranto 1973, Napoli 1974, pp. 441-456 ADAMESTEANU 1974d D. ADAMESTEANU, La Basilicata antica, Cava de’ Tirreni 1974 ADAMESTEANU 1975 D. ADAMESTEANU, L’attività archeologica in Basilicata, in Orfismo in Magna Grecia, ACT XIV, Taranto 1974, Napoli 1975, pp. 247-259 ADAMESTEANU 1978 D. ADAMESTEANU, L’attività archeologica in Basilicata nel 1977, ACT XVII, Taranto 1977, Napoli 1978, pp. 365-390 ADAMESTEANU 1980 D. ADAMESTEANU, Siris. Il problema topografico, ACT XX, Taranto 1980, pp. 61-93 ADAMESTEANU 1982 D. ADAMESTEANU, Siris e Metaponto alla luce delle nuove scoperte archeologiche, in «Annuario della Scuola Archeologica Italiana di Atene», XLIV, 1982, pp. 300-313 ADAMESTEANU 1987 D. ADAMESTEANU, Una porta metapontina, in Saggi in onore di G. de Angelis d’Ossat, Roma 1987, pp. 15-18 ADAMESTEANU-DILTHEY 1978 D. ADAMESTEANU, H. DILTHEY, Siris. Nuovi contributi archeologici, in MEFRA, 90, 1978, pp. 515-565 ADAMESTEANU-SICILIANO-SUELI MILANEZZI 1992 D. ADAMESTEANU, A. SICILIANO, S. SUELI MILANEZZI, Metaponto, in BTCG 1992, pp. 65-112 ANDREASSI 1994 G. ANDREASSI, L’attività archeologica in Puglia, in Magna Grecia Etruschi e Fenici, ACT XXXIII, Taranto 1993, Taranto 1994, pp. 755776 ANDREASSI 1995 G. ANDREASSI, L’attività archeologica in Puglia nel 1994, in Corinto e l’Occidente, ACT XXXIV, Taranto 1994, Taranto 1995, pp. 785-808 ANDREASSI 1996 G. ANDREASSI, L’attività archeologica in Puglia nel 1995, in Eredità della Magna Grecia, ACT XXXV, Taranto 1995, Taranto 1996, pp. 725-754 ANDREASSI 1997 G. ANDREASSI, L’attività archeologica in Puglia nel 1996, in Mito e storia in Magna Grecia, ACT XXXVI, Taranto 1996, Taranto 1997, pp. 531-535 ANDREASSI 2000 G. ANDREASSI, L’attività archeologica in Puglia nel 1999, in Magna Grecia e Oriente mediterraneo prima dell’età ellenistica, ACT XXXIX, Taranto 1999, Taranto 2000, pp. 761-796 ARDOVINO 1979 A. M. ARDOVINO, Crotone, in Gli Eubei in Occidente, ACT XVIII, Taranto 1978, Napoli 1979, pp. 375-382
97
BARRA BAGNASCO 1992b M. BARRA BAGNASCO, Locri Epizefiri. Campagna di scavi 1991 a Marasà Sud, in La Magna Grecia e i grandi santuari della madrepatria, ACT XXXI, Taranto 1991, Taranto 1992, pp. 437-441 BARRA BAGNASCO 1993 M. BARRA BAGNASCO, Locri Epizefiri, Centocamere e Marasà Sud. Scavo 1992, in Sibari e la Sibaritide, ACT XXXII, Taranto-Sibari 1992, Taranto 1993, pp. 813-818 BARRA BAGNASCO 1994a M. BARRA BAGNASCO, Locri Centocamere e Marasà Sud. Scavo 1993, in Magna Grecia Etruschi e Fenici, ACT XXXIII, Taranto 1993, Taranto 1994, pp. 745-751 BARRA BAGNASCO 1994b M. BARRA BAGNASCO, Il culto di Adone a Locri, in «Ostraka», 2, 1994, pp. 231-247 BARRA BAGNASCO 1995 M. BARRA BAGNASCO, Locri Epizefiri: la Porta di Afrodite (Campagna di scavo 1994), in Corinto e l’Occidente, ACT XXXIV, Taranto 1994, Taranto 1995, pp. 753-756 BARRA BAGNASCO 1996a M. BARRA BAGNASCO, Fortificazioni e città a Locri Epizefiri, alla luce delle più recenti scoperte, in RM, 103, 1996, pp. 237-274 BARRA BAGNASCO 1996b M. BARRA BAGNASCO, Locri Epizefiri. Campagna di scavo 1995 a Marasà, in Eredità della Magna Grecia, ACT XXXV, Taranto 1995, Taranto 1996, pp. 691-697 BARRA BAGNASCO 1997 M. BARRA BAGNASCO, Locri Epizefiri. Campagna di scavo 1996 in località Marasà, in Mito e storia in Magna Grecia, ACT XXXVI, Taranto 1996, Taranto 1997, pp. 519-524 BARRA BAGNASCO 1999a M. BARRA BAGNASCO, Strutture esterne alle mura di Locri Epizefiri e il problema del porto, in M. BARRA BAGNASCO, M. C. CONTI (a cura di ), Studi di A-cheologia Classica dedicati a Giorgio Gullini, Torino 1999, pp. 1- 18 BARRA BAGNASCO 1999b M. BARRA BAGNASCO, Sistemi insediativi nella Basilicata dal Sinni al Bradano, tra il IV e il III sec. a.C., in M. BARRA BAGNASCO, E. DE MIRO, A. PINZONE, Magna Grecia e Sicilia. Stato degli studi e prospettive di ricerca, Atti dell’Incontro di Studi, Messina 2-4 dicembre 1996, Messina 1999, pp. 39-57 BARRA BAGNASCO 2000 M. BARRA BAGNASCO, Spazi interni ed esterni alle mura di Locri Epizefiri: un esempio di pianificazione integrata, in Orizzonti, I, 2000, pp. 11-33 BARRA BAGNASCO 2002 M. BARRA BAGNASCO, Ancora sull’impianto urbano di Locri Epizefiri: una nota alla luce delle recenti scoperte, in Orizzonti, III, 2002, pp. 8997 BLUM 1988 I. BLUM, Le mura, in Poseidonia-Paestum, ACT XXVII, Taranto 1987, Taranto 1988, pp. 575-589 BORELLI 1995 L. V. BORELLI, Locri Epizefirii, in EAA, Suppl. III, 1995, pp. 400-406 BORELLO 1993 L. BORELLO, Lo scavo in località «Vigna Nuova», in Crotone 1993, pp. 45-50 BOTTINI 1983a A. BOTTINI, L’attività archeologica in Basilicata, in Magna Grecia e mondo miceneo, ACT XXII, Taranto 1982, Napoli 1983, pp. 451-473 BOTTINI 1983b A. BOTTINI, Metaponto 1982, in MG, XVIII, 1983, pp. 20-21 BOTTINI 1985 A. BOTTINI, L’attività archeologica in Basilicata nel 1984, in Magna Grecia, Epiro e Macedonia, ACT XXIV, Taranto 1984, Taranto 1985, pp. 497-511 BOTTINI 1986 A. BOTTINI, L’attività archeologica in Basilicata - 1985, in Neapolis, ACT XXV, Taranto 1985, Taranto 1986, pp. 457-471 BOTTINI 1991 A. BOTTINI, L’attività archeologica in Basilicata nel 1991, in I Messapi, ACT XXX, Taranto 1990, Taranto 1991, pp. 553-566 BOTTINI 1992 A. BOTTINI, L’attività archeologica in Basilicata nel 1991, in La Magna Grecia e i grandi santuari della madrepatria, ACT XXXI, Taranto 1991, Taranto 1992, pp. 383-398 VAN BUREN 1951 A. W. VAN BUREN, Archaeological News. Italy, in AJA, 55, 1951, pp. 171-189
VAN BUREN 1953 A. W. VAN BUREN, News Letter from Rome, in AJA, 57, 1953, pp. 211218 VAN BUREN 1954 A. W. VAN BUREN, News Letter from Rome, in AJA, 58, 1954, pp. 323331 VAN BUREN 1955 A. W. VAN BUREN, News Letter from Rome, in AJA, 59, 1955, pp. 303314 VAN BUREN 1957 A. W. VAN BUREN, News Letter from Rome, in AJA, 61, 1957, pp. 375386 VAN BUREN 1958 A. W. VAN BUREN, News Letter from Rome, in AJA, 62, 1958, pp. 415427 VAN BUREN 1961 A. W. VAN BUREN, News Letter from Rome, in AJA, 65, 1961, pp. 377388 BYVANK 1914 A. W. BIVANK, Aus Bruttium. I. Kroton, in RM, XXIX, 1914, pp. 145155 CARANDO 1999 E. CARANDO, Sibari-Thuri: note per una revisione dei dati, in AION, n.s. 6, 1999, pp. 174-175 CASTAGNOLI 1959 F. CASTAGNOLI, La pianta di Metaponto. Ancora sull’urbanistica ippodamea, in RendLinc, XIV, 1959, pp. 49-55 CAVAGNARO-LININGTON 1977 L. CAVAGNARO VANONI, R. E. LININGTON, Nuove indagini con i metodi di prospezione archeologica a Crotone, in RendLinc, XXXIII, 1977, pp. 667-683 CAVAGNARO VANONI 1985 L. CAVAGNARO VANONI, Prospezioni archeologiche a Nocera Terinese e a Castiglione di Paludi, in Magna Grecia, Epiro e Macedonia, ACT XXIV, Taranto 1984, Taranto 1985, pp. 551-554 CHEVALLIER-ROUILLARD 1971 R. CHEVALLIER, P. ROUILLARD, Mission archéologique de la Faculté des Lettres de Tours à Métaponte (Septembre 1970), in RA, 1971, pp. 309-326 CICALA E A. 1993 L. CICALA, C. A. FIAMMENGHI, R. MAFFETTONE, L. VECCHIO, Velia: saggi di scavo sull’acropoli, in Sibari e la Sibaritide, ACT XXXII, Taranto-Sibari 1992, Taranto 1993, pp. 741-752 CIPRIANI 1986 M. CIPRIANI, L’attività dell’ufficio scavi di Velia, in Neapolis, ACT XXV, Taranto 1985, Taranto 1986, pp. 518-519 COCCHIARO 1981 A. COCCHIARO, Contributo per la carta archeologica del territorio a sud-est di Taranto, in Taras, I, 1981, pp. 49-67 COLLIN BOUFFIER-IANNELLI-TRÈZINY 1987 S. COLLIN BOUFFIER, M. T. IANNELLI, H. TRÈZINY, Caulonia (Monasterace Marina, prov. de Reggio Calabria), in MEFRA, 99, 1987, pp. 524-525 COLLIN BOUFFIER-IANNELLI-TRÈZINY 1989 S. COLLIN BOUFFIER, M. T. IANNELLI, H. TRÈZINY, Caulonia (Monasterace Marina, prov. de Reggio Calabria), in MEFRA, 101, 1989, pp. 538-539 COPPOLA 2004 A. COPPOLA, Cleonimo, Corcira e lo spazio ionico, in Alessandro il Molosso e i “Condottieri”in Magna Grecia, ACT XLIII, Taranto-Cosenza 2003, Napoli 2004, pp. 197-215 CORDANO 1974-76 F. CORDANO, Phònos ellenikòs méghistos, in ASMG, 1974-76, pp. 203206 CORDANO 1985 F. CORDANO, La fondazione delle colonie greche, in Il Mediterraneo, le metropoleis, e la fondazione delle colonie, MG I 1985, pp. 265-336 COSTABILE 1991 F. COSTABILE (a cura di), I ninfei di Locri Epizefiri. Architettura, culti erotici, sacralità delle acque, Catanzaro 1991 COSTABILE 1992 F. COSTABILE (a cura di), Polis e Olympieion. Costituzione Economia e Finanze di una città della Magna Grecia. Editio Altera e traduzione delle tabelle locresi, Catanzaro 1992 COSTAMAGNA-SABBIONE 1990 L. COSTAMAGNA, C. SABBIONE, Una città in Magna Grecia. Locri Epizefiri. Guida archeologica, Reggio Calabria 1990 CRISTOFANI 1970 M. CRISTOFANI, Crotone, in EAA, Suppl. 1970, pp. 269-270
98
SPOT), in Poseidonia-Paestum, ACT XXVII, Taranto 1987, Taranto 1988, pp. 463-470 DELL’AGLIO 1988 A. DELL’AGLIO, Via Venezia, Via C. Battisti, S.A.R.A.M., in Taras, VIII, 1988, pp. 133-135 DELL’AGLIO 1996a A. DELL’AGLIO, Pendio La Riccia, in Taras, XVI, 1996, p. 80 DELL’AGLIO 1996b A. DELL’AGLIO, Salita San Martino, in Taras, XVI, 1996, pp. 84-86 DELL’AGLIO-MARUGGI 1987 A. DELL’AGLIO, G. A. MARUGGI, Collepasso, in Taras, VII, 1987, pp. 129-130 DE MAGISTRIS 2000 E. DE MAGISTRIS, Su Porta Rosa a Velia, in Orizzonti, I, 2000, pp. 4764 DE SIENA 1990 A DE SIENA, Il Castro romano di Metaponto, in M. SALVATORE (a cura di), Basilicata. L’espansionismo romano nel Sud-est d’Italia. Il quadro archeologico, Atti del Convegno, Venosa 1987, Venosa 1990, pp. 301314 DE SIENA 1998 A DE SIENA, Metaponto: problemi urbanistici e scoperte recenti, in SiriMeta 1998, pp. 141-170 DE SIENA 1999 A. DE SIENA, La colonizzazione achea del Metapontino, in Basilicata 1999, pp. 211-245 DE SIENA 2001 A. DE SIENA, Profilo storico archeologico, in A. DE SIENA (a cura di), Metaponto. Archeologia di una colonia greca, Taranto 2001, pp. 7-44 FAVIA 1988 P. FAVIA, Largo S. Martino, in Taras, VIII, 1988, pp. 119-120 FOTI 1974a G. FOTI, L’attività archeologica in Calabria, in Metaponto, ACT XIII, Taranto 1973, Napoli 1974, pp. 375-386 FOTI 1974b G. FOTI, Scavi e scoperte, in «Studi Etruschi», XLII, 1974, n. 15, p. 513 FOTI 1975 G. FOTI, L’attività archeologica in Calabria, in Orfismo in Magna Grecia, ACT XIV, Taranto 1974, Napoli 1975, pp. 280-323 FOTI 1977 G. FOTI, La topografia di Locri Epizefirii, in Locri Epizefirii, ACT XVI, Taranto 1976, Napoli 1977, pp. 343-362 FOTI 1978 G. FOTI, L’attività archeologica nelle province di Reggio e di Catanzaro, in Magna Grecia Bizantina e tradizione classica, ACT XVII, Taranto 1977, Napoli 1978, pp. 445-466 FOTI 1981 G. FOTI, L’attività archeologica in Calabria, in Siris e l’influenza ionica in Occidente, ACT XX, Taranto 1980, Taranto 1981, pp. 299-317 FRISONE 2004 F. FRISONE, Alessandro il Molossoe i popoli dell’Apulia, in Alessandro il Molosso e i “Condottieri”in Magna Grecia, ACT XLIII, Taranto-Cosenza 2003, Napoli 2004, pp. 473-517 GABRICI 1951 E. GABRICI, Contributo archeologico alla topografia di Napoli della Campania, in MonAnt, XLI, 1951, coll. 553-674. GALLO 1966 G. GALLO, I bolli sui mattoni di Velia, in PdP, XXI, 1966, pp. 366-377 GANGEMI-COLLINA 1987 G. GANGEMI, R. COLLINA, Casalvelino, località Torricelli, in Lo stretto crocevia di culture, ACT XXVI, Taranto 1986, Taranto 1987, pp. 607608 GASSNER 2001 V. GASSNER , Neue Forschungen zu den frühen Stadtmauern von Velia, in F. Blakolmer, H. Szmethy (a cura di), Akten des 8. Österreichischen Archäologentages am Institut für Klassische Archäologie der Universität Wien vom 23 bis 25 April 1999, Wien 2001, pp. 81-90 GASSNER-SOKOLICEK 2000 V. GASSNER, A. SOKOLICEK, Die Befestigungsanlagen von Velia. Vorbericht zu den Grabungen in der Unterstadt 1977-1999, in «Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes», 69, 2000, pp. 95128 GASSNER-SOKOLICEK-TRAPICHLER 2002 V. GASSNER, A. SOKOLICEK, M. TRAPICHLER, Velia 2002. Forschungen im Bereich des «Castelluccio», in «Forum Archeologiae. Zeitschrift für Klassische Archäologie», 21-12-2001, pubblicazione su sito INTERNET http://mailbox.univie.ac.at/elisabeth.trinkl/forum/forum1202/25velia. htm
D’AMBROSIO 1990 I. D’AMBROSIO, Le fortificazioni di Poseidonia-Paestum. Problemi e prospettive di ricerca, in AION, XII, 1990, pp. 71-101 D’AMBROSIO 2000 I. D’AMBROSIO, La cinta muraria. L’angolo nord-orientale, in Paestum 2000, pp. 181-184. D’ANDRIA 1976 F. D’ANDRIA, Metaponto romana, in La Magna Grecia nell’età romana, ACT XV, Taranto 1975, Napoli 1976, pp. 539-544 D’ANDRIA 1977 F, D’ANDRIA, Scavi a Metaponto (1976), in Locri Epizefirii, ACT XVI, Taranto 1976, Napoli 1977, pp. 855-859 D’ANDRIA 1978 F. D’ANDRIA, Metaponto - fornaci (1977), in Magna Grecia bizantina e tradizione classica, ACT XVII, Taranto 1978, Napoli 1978, pp. 409-412 D’ANGELA-LIPPOLIS 1989 C. D’ANGELA, E. LIPPOLIS, 1882-1889. Gli scavi dell’Arsenale e l’archeologia tarantina, Taranto 1989 DAUM 1999 J. DAUM, Die Terrassenmauer II auf der Akropolis von Elea, in Velia 1999, pp. 35-37 DE CARO 1999 S. DE CARO, L’attività della Soprintendenza archeologica di Napoli e Caserta nel 1997, in Confini e frontiera nella grecità d’Occidente, ACT XXXVII, Taranto 1997, Taranto 1999, pp. 793-843. DE FRANCISCIS 1955 A. DE FRANCISCIS, Locri Epizephyrii, LÒkroi EpizefÊrioi, in FA, X, 1955, n. 1926, pp. 153-154 DE FRANCISCIS 1956 A. DE FRANCISCIS, Locri Epizephyrii, LÒkroi EpizefÊrioi, in FA, XI, 1956, n. 2048, pp. 128-129 DE FRANCISCIS 1959a A. DE FRANCISCIS, Le ultime scoperte archeologiche, in «Almanacco Calabrese», 1959, pp. 31-41 DE FRANCISCIS 1959b A. DE FRANCISCIS, Restauri alle mura di Locri, in FA, XIV, 1959, n. 249, pp. 18-19 DE FRANCISCIS 1962 A DE FRANCISCIS, La documentazione archeologica in Calabria, in Greci e Italici in Magana Grecia, ACT I, Taranto 1961, Napoli 1962, pp. 212-222 DE FRANCISCIS 1971 A. DE FRANCISCIS, Ricerche sulla topografia e i monumenti di Locri Epizefiri, Napoli 1971 DE FRANCISCIS 1972 A. DE FRANCISCIS, Stato e società in Locri Epizefiri, Napoli 1972 DE GENNARO 2004 R. DE GENNARO, I circuiti murari in Lucania, in Alessandro il Molosso e i “Condottieri”in Magna Grecia, ACT XLIII, Taranto-Cosenza 2003, Napoli 2004, pp. 647-660 DE GRASSI 1966 N. DE GRASSI, Taranto, in EAA, VII, 1966, pp. 603-617 DE JULIIS 1981 E. M. DE JULIIS, L’attività archeologica in Puglia, in Siris e l’influenza ionica in Occidente, ACT XX, Taranto 1980, Taranto 1981, pp. 353379 DE JULIIS 1982 E. M. DE JULIIS, L’attività archeologica in Puglia, in Megale Hellas nome e immagine, Taranto 1981, Taranto 1982, pp. 293-321 DE JULIIS 1983 E. M. DE JULIIS, L’attività archeologica in Puglia, in Magna Grecia e mondo miceneo, ACT XXII, Taranto 1982, Napoli 1983, pp. 503-531 DE JULIIS 1984 E. M. DE JULIIS, L’attività archeologica in Puglia nel 1983, in Crotone, ACT XXIII, Taranto 1983, Taranto 1984, pp. 421-446 DE JULIIS 2000 E. M. DE JULIIS, Taranto, Bari 2000 DE JULIIS 2001 E. M. DE JULIIS, Metaponto, Bari 2001 DE SENSI SESTITO 2004 G DE SENSI SESTITO, Alessandro il Molosso e le popolazioni della Lucania e del Bruzio, in Alessandro il Molosso e i “Condottieri”in Magna Grecia, ACT XLIII, Taranto-Cosenza 2003, Napoli 2004, pp. 519560 DELEZIR-GUY 1988 J. DELEZIR, M. GUY, Les conditions géografiques du site et du terrori de Paestum etudiées d’après des images de satellites (Landsat TM et
99
GIANGIULIO 1987 M. GIANGIULIO, Aspetti di storia della Magna Grecia arcaica e classica fino alla guerra del Peloponneso, in Lo sviluppo politico sociale ed economico, MG II 1987, pp. 9-54 GIANGIULIO 2004 M. GIANGIULIO, L’eredità di Archita, in Alessandro il Molosso e i “Condottieri”in Magna Grecia, ACT XLIII, Taranto-Cosenza 2003, Napoli 2004, pp. 55-78 GIANGIULIO-SABBIONE 1987 M. GIANGIULIO, C. SABBIONE, Crotone, in BTCG, V, 1987, pp. 472521 GIANNOTTA 1980 M. T. GIANNOTTA, Metaponto ellenistico-romana. Problemi topografici, Galatina 1980 GIARDINO 1978 L. GIARDINO, Metaponto 1977 - La campagna di scavo nell’area del castrum, in Magna Grecia bizantina e tradizione classica, ACT XVII, Taranto 1977, Napoli 1978, pp. 413-429 GIARDINO 1998 L. GIARDINO, Aspetti e problemi dell’urbanistica di Herakleia, in SiriMeta 1998, pp. 171-220 GIARDINO 1999 L. GIARDINO, Herakleia: città e territorio, in Basilicata 1999, pp. 295337 GRECO 1970 E. GRECO, Moio della Civitella (intervento), in La Magna Grecia nel mondo ellenistico, ACT IX, Taranto 1969, Napoli 1970, pp. 195-197 GRECO 1974-75 E. GRECO, Il «teichos» dei Sibariti e le origini di Poseidonia, in DdA, 1974-75, pp. 98-110. GRECO 1975 E. GRECO, Velia e Palinuro. Problemi di topografia antica, in MEFRA, 87, 1975, pp. 81-142 GRECO 1977 E. GRECO, Velia, in Locri Epizefirii, ACT XVI, Taranto 1976, Napoli 1977, pp. 779-786 GRECO 1981a E. GRECO, Magna Grecia, Guide Archeologiche Laterza, Roma-Bari 1981 GRECO 1981b E. GRECO, Dal territorio alla città: lo sviluppo urbano di Taranto, in AION, III, 1981, pp. 139-157 GRECO 1985 E. GRECO, Topografia archeologica della Magna Grecia, in Il Mediterraneo, le metròpoleis, e la fondazione delle colonie, MG I 1985, pp. 337-367 GRECO 1986a E. GRECO, L’impianto urbano di Neapolis greca: aspetti e problemi, in Neapolis, ACT XXV, Taranto 1985, Taranto 1986, pp. 187-219 GRECO 1986b E. GRECO (a cura di), I primi scavi di Paestum (1907-1939), Testi di S. AURIGEMMA - V. SPINAZZOLA - A. MAIURI, Salerno 1986 GRECO 1987 E. GRECO, Su di un problema urbanistico velino: l’area del criptoportico, in AION, IX, 1987, pp. 189-195 GRECO 1988a E. GRECO, La città e il territorio: problemi di storia topografica, in Poseidonia-Paestum, ACT XXVII, Taranto 1987, Taranto 1988, pp. 471499 GRECO 1988b E. GRECO, Archeologia della colonia latina di Paestum, in DdA, 1988, pp. 79-86 GRECO 1990 E. GRECO, Topografia e urbanistica, in Paestum. La città e il territorio. Quaderno di documentazione, Istituto dell’Enciclopedia Italiana fondato da G. Treccani, Roma 1990, pp. 89-100 GRECO 1993 E. GRECO, Archeologia della Magna Grecia, Roma-Bari 1993 GRECO-MERTENS 1996 E. GRECO, D. MERTENS, Urbanistica della Magna Grecia, in GreciOcc 1996, pp. 243-262 GRECO-SCHNAPP 1983 E. GRECO, A. SCHNAPP, Moio della Civitella et le territoire de Velia, in MEFRA, 95, 1983, pp. 381-415 GRECO-SCHNAPP 1986 E. GRECO, A. SCHNAPP, Fortifications et emprise de la polis: le cas de Velia (province de Salerne), in Valbonne 1986, pp. 209-212
GROSSO 1951 F. GROSSO, Gli assedi di Locri, in «Giornale Italiano di Filologia», IV, 1951, pp. 112-134 GUARDUCCI 1978 M. GUARDUCCI, Siris, in RendLinc, 1978, pp. 273-288. GULLINI 1980 G. GULLINI, La cultura architettonica di Locri Epizefirii. Documenti e interpretazioni, Taranto 1980 GULLINI 1983 G. GULLINI, Urbanistica e architettura, in Megale Hellas 1983, pp. 205-321 GUZZO 1975 P. G. GUZZO, Paludi (Cosenza): località Castiglione. Necropoli dell’età del ferro, in Klearchos, XVII, 1975, , pp. 99-177 GUZZO 1978 P. G. GUZZO, Ricerche archeologiche nella Sibaritide, in Magna Grecia bizantina e tradizione classica, ACT XVII, Taranto 1977, Napoli 1978, pp. 467-478 GUZZO 1979 P. G. GUZZO, L’attività archeologica in Calabria. L’area di Sibari, in Gli Eubei in Occidente, ACT XVIII, Taranto 1978, Napoli 1979, pp. 369-375 GUZZO 1982 P. G. GUZZO, Le città scomparse della Magna Grecia, Roma 1982 GUZZO 1984 P. G. GUZZO, Archeologia e territorio nella Sibaritide. Una storia della ricerca ed una linea di lavoro, in Studi di antichità in onore di Guglielmo Maetzke, Roma 1984, pp. 309-315 GUZZO 1986 P. G. GUZZO, Fortificazioni della Calabria settentrionale, in Valbonne 1986, pp. 201-207 GUZZO 1987 P. G. GUZZO, Castiglione di Paludi, in BTCG, V, 1987, pp. 136-140 GUZZO 1989 P. G. GUZZO, L’attività archeologica in Puglia nel 1988, in Un secolo di ricerche in Magna Grecia, ACT XXVIII, Taranto 1988, Taranto 1989, pp. 567-581 HAENSEL 1973 B. HAENSEL, Policoro (Matera). Scavi eseguiti nell’area dell’acropoli di Eraclea negli anni 1965-1967, in NSA, 1973, pp. 400-492 IACOPI 1949 G. IACOPI, Identificazione della “quarta Sibari”, in FA IV, 1949, n. 1841, p. 189 IACOPI 1950 G. IACOPI, Esplorazione archeologica, in FA V, 1950, n. 1624, p. 142 IACOPI 1952 G. IACOPI, Il problema di Sibari, in «Almanacco Calabrese», 1952, pp. 40-51 IACOPI 1953 G. IACOPI, Castiglione di Paludi, near Rossano, in FA VIII, 1953, n. 1611, p. 114 IANNELLI 1985 M. T. IANNELLI, Kaulonia e l’organizzazione urbana ellenica, in P. SPADA (a cura di), Roccella - Storia degli insediamenti ed evoluzione urbanistica, Roccella Ionica 1985, pp. 28-51. IANNELLI 1989 M. T. IANNELLI, Caulonia: un piano programmatico di ricerca, in Kaulonia I 1989, pp. IX-XV IANNELLI 1992 M. T. IANNELLI, Monasterace Marina, in BTCG, X, 1992, pp. 190-217 IANNELLI-RIZZI 1985 M. T. IANNELLI, S. RIZZI, Kaulonia: indagini ed ipotesi sull’impianto urbano di età ellenistica alla luce delle più recenti campagne di scavo, in «Rivista Storica Calabrese», 6, 1985, pp. 281-316 IANNELLI- TRÉZINY 1985 M. T. IANNELLI, H. TRÉZINY, Caulonia (Monasterace Marina, prov. de Reggio Calabria), in MEFRA, 97, 1985, p. 572 IANNELLI-TRÉZINY 1986 M. T. IANNELLI, H. TRÉZINY, Caulonia (Monasterace Marina, prov. de Reggio Calabria), in MEFRA, 98, 1986, p. 419 JOHANNOWSKY 1960 W. JOHANNOWSKY, Problemi archeologici napoletani con particolare riferimento alle zone interessate dal Risanamento, in G. RUSSO (a cura di) La città di Napoli dalle origini al 1860, Napoli 1960, pp. 494-496. JOHANNOWSKY 1978 W. JOHANNOWSKY, L’attività archeologica nelle province di Avellino, Benevento e Caserta, in Magna Grecia bizantina e tradizione classica, ACT XVII, Taranto 1977, Napoli 1978, pp. 345-351
100
JOHANNOWSKY 1982 W. JOHANNOWSKY, Considerazioni sullo sviluppo urbano e la cultura materiale di Velia, in PdP, XXXVII, 1982, pp. 225-246 JOHANNOWSKY 1983 W. JOHANNOWSKY, L’attività archeologica nelle province di Salerno, Avellino e Benevento. Velia, in Magna Grecia e mondo miceneo, ACT XXI, Taranto 1982, Taranto 1983, pp. 424-427 JOHANNOWSKY 1987 W. JOHANNOWSKY, Velia, in Lo stretto crocevia di culture, ACT XXVI, Taranto 1986, Taranto 1987, p. 606 KRINZINGER 1979 F. KRINZINGER, Die Stadtmauern von Elea. Eine archäologischtopographische Untersuchungen, Innsbruck 1979 KRINZINGER 1980 F. KRINZINGER, Le mura urbane di Velia, in L’epos greco in Occidente, ACT XIX, Taranto 1979, Taranto 1980, pp. 355-364 KRINZINGER 1986 F. KRINZINGER, Die Stadtmauern von Velia, in Valbonne 1986, pp. 121124 KRINZINGER 1989 F. KRINZINGER, Anmerkungen zur Griechischen Stadtplanung, in Akten des 3. Österreichischen Archäologentages, Wien 3-5 April 1987, Wien 1989, pp. 113-119 KRINZINGER 1994 F. KRINZINGER, Intorno alla pianta di Velia, in Velia 1994, pp. 19-54 KRINZINGER 1997 F. KRINZINGER, Velia, in EAA, Suppl. V, 1997, pp. 967-972 KRINZINGER 1999 F. KRINZINGER, Die Monumentalisierung der Akropolis und die urbanistische Entwicklung von Velia, in Velia 1999, pp. 23-33 LACAVA 1891 M. LACAVA, Topografia e storia di Metaponto, Napoli 1891 LAFAGE 1988 F. LAFAGE, Moio della Civitella, in Poseidonia-Paestum, ACT XXVII, Taranto 1987, Taranto 1988, pp. 787-788 DE LA GENIERE 1970 J. DE LA GENIERE, Contribution à l’étude des relations entre Grecs et Indigènes sur la Mer Ionienne, in «Mélanges d’Archéologie et d’Histoire. École Française de Rome», LXXXII, 1970, pp. 621-636 DE LA GENIERE 1978a J. DE LA GENIERE, C’è un ‘modello’ Amendolara?, in ASNP, VIII, 1978, pp. 335-354 DE LA GENIERE 1978b J. DE LA GENIERE, La colonisation grecque en Italie Méridionale et en Sicile et l’acculturation des non-grecs, in RA, 1978, pp. 257-276 LATTANZI 1980 E. LATTANZI, L’attività archeologica in Basilicata nel 1979, in L’epos greco in Occidente, ACT XIX, Taranto 1979, Taranto 1980, pp. 399406 LATTANZI 1982a E. LATTANZI, L’attività archeologica in Basilicata, in Megale Hellas nome e immagine, Taranto 1981, Taranto 1982, pp. 259-283 LATTANZI 1982b E. LATTANZI, L’attività archeologica della Soprintendenza Archeologica della Calabria, in Megale Hellas nome e immagine, Taranto 1981, Taranto 1982, pp. 217-236 LATTANZI 1983 E. LATTANZI, L’attività archeologica in Calabria, in Magna Grecia e mondo miceneo, ACT XXII, Taranto 1982, Napoli 1983, pp. 539-575 LATTANZI 1984a E. LATTANZI, Problemi archeologici – Dalla ricerca alla tutela, in Crotone, ACT XXIII, Taranto 1983, Taranto 1984, pp. 95-117 LATTANZI 1984b E. LATTANZI, L’attività archeologica in Calabria, in Crotone, ACT XXIII, Taranto 1983, Taranto 1984, pp. 562-583 LATTANZI 1985a E. LATTANZI, L’attività archeologica in Calabria nel 1984, in Magna Grecia, Epiro e Macedonia, ACT XXIV, Taranto 1984, Taranto 1985, pp. 521-531 LATTANZI 1985b E. LATTANZI, Attività della Soprintendenza archeologica della Calabria, in Klearchos, XXVII, 1985, pp. 107-158 LATTANZI 1986 E. LATTANZI, L’attività archeologica in Calabria nel 1985, in Neapolis, ACT XXV, Taranto 1985, Taranto 1986, pp. 417-431 LATTANZI 1988 E. LATTANZI, L’attività archeologica in Calabria nel 1987, in Poseidonia-Paestum, ACT XXVII, Taranto 1987, Taranto 1988, pp. 647-657
LATTANZI 1989 E. LATTANZI, L’attività archeologica in Calabria, in Un secolo di ricerche in Magna Grecia, ACT XXVIII, Taranto 1988, Taranto 1989, pp. 545-563 LATTANZI 1990 E. LATTANZI, L’attività archeologica in Calabria – 1989, in La Magna Grecia e il lontano Occidente, ACT XXIX, Taranto 1989, Taranto 1990, pp. 581-593 LATTANZI 1991 E. LATTANZI, L’attività archeologica in Calabria – 1990, in I Messapi, ACT XXX, Taranto 1990, Taranto 1991, pp. 581-603 LATTANZI 1992 E. LATTANZI, L’attività archeologica in Calabria nel 1991, in La Magna Grecia e i grandi santuari della madrepatria, ACT XXXI, Taranto 1991, Taranto 1992, pp. 415-429 LATTANZI 1994 E. LATTANZI, L’attività della Soprintendenza archeologica della Calabria, in Magna Grecia Etruschi e Fenici, ACT XXXIII, Taranto 1993, Taranto 1994, pp. 727-750 LATTANZI 1996 E. LATTANZI, L’attività archeologica in Calabria nel 1995, in Eredità della Magna Grecia, ACT XXXV, Taranto 1995, Taranto 1996, pp. 673-690 LATTANZI 1997 E. LATTANZI, L’attività archeologica In Calabria nel 1996, in Mito e storia in Magna Grecia, ACT XXXVI, Taranto 1996, Taranto 1997, pp. 501-517 LATTANZI 1999a E. LATTANZI, L’attività archeologica in Calabria nel 1997, in Confini e frontiera nella grecità d’Occidente, ACT XXXVII, Taranto 1997, Taranto 1999, pp. 909-928 LATTANZI 1999b E. LATTANZI, Attività della Soprintendenza archeologica della Calabria nel 1998, in L’Italia meridionale in età tardo antica, ACT XXXVIII, Taranto 1998, Taranto 1999, pp. 735-751 LEPORE 1966 E. LEPORE, Elea e l’eredità di Sibari, in PdP, XXI, 1966, pp. 255-278 LININGTON 1974 R. E. LININGTON, La prospezione magnetica a Metaponto, in MG, IX, 1974, pp. 1-5 LININGTON 1982 R. E. LININGTON, La seconda campagna di prospezione archeologica a Crotone, in Megale Hellas nome e immagine, Taranto 1981, Taranto 1982, pp. 253-256 LIPPOLIS 1981 E. LIPPOLIS, Alcune considerazioni topografiche su Taranto romana, in Taras, I, 1981, pp. 77-114 LIPPOLIS 1987 E. LIPPOLIS, Organizzazione delle necropoli e struttura sociale nell’Apulia ellenistica. Due esempi: Taranto e Canosa, in Römische Gräberstrassen. Selbstdarstellung-Status-Standard, München 1985, München 1987, pp. 139-154 LIPPOLIS 1994 E. LIPPOLIS, Catalogo del Museo Nazionale di di Taranto, III, 1, Taranto la necropoli: aspetti e problemi della documentazione archeologica dal VII al I sec. a.C., Taranto 1994 LIPPOLIS 1997a E. LIPPOLIS, Fra Taranto e Roma. Società e cultura urbana in Puglia tra Annibale e l’età imperiale, Taranto 1997 LIPPOLIS 1997b E. LIPPOLIS, Taranto, in EAA, Suppl. V, 1997, pp. 531-539 LIPPOLIS 2002 E. LIPPOLIS, Taranto: forma e sviluppo della topografia urbana, in Taranto e il Mediterraneo, ACT XLI, Taranto 2001, Napoli 2002, pp. 119169 LIPPOLIS D’ANGELA 1996 E. LIPPOLIS, C. D’ANGELA, Taranto: dall’acropoli al Kastron, in «Archivio Storico Pugliese», XLIX, 1996, pp. 7-45 LIPPOLIS-GARRAFFO-NAFISSI 1995 E. LIPPOLIS, S. GARRAFFO, M. NAFISSI, Culti greci in Occidente. Fonti scritte e documentazione archeologica, I, Taranto, Taranto 1995 LISSI 1962 E. LISSI, Gli scavi della Scuola Nazionale di Archeologia a Locri Epizefiri, in ACIAC VII, Roma 158, Roma 1962, pp. 109-115 LOMBARDO 1987a M. LOMBARDO, La Magna Grecia dalla fine del V sec. a.C. alla conquista romana, in Lo sviluppo politico sociale ed economico, MG II 1987, pp. 55-88
101
LOMBARDO 1987b M. LOMBARDO, L’organizzazione militare degli Italioti, in Lo sviluppo politico sociale ed economico, MG II 1987, pp. 225-258 LOMBARDO 1989 M. LOMBARDO, I Brettii, in Italia omnium terrarum parens, Milano 1989, pp. 247-297 LO PORTO 1961 F. G. LO PORTO, Ricerche archeologiche in Heraclea di Lucania, in «Bollettino d’Arte», 1961, pp. 133-150 LO PORTO 1966 F. G. LO PORTO, Metaponto. Scavi e ricerche archeologiche, in NSA, 1966, pp. 136-231 LO PORTO 1969 F. G. LO PORTO, L’attività archeologica in Puglia, in ACT VIII, Taranto 1968, Napoli 1969, pp. 179-201 LO PORTO 1971a F. G. LO PORTO, Topografia antica di Taranto, in Taranto nella civiltà della Magna Grecia, ACT X, Taranto 1970, Napoli 1971, pp. 343-383 LO PORTO 1971b F. G. LO PORTO, L’attività archeologica in Puglia, in Taranto nella civiltà della Magna Grecia, ACT X, Taranto 1970, Napoli 1971, pp. 524535 LO PORTO 1974 F. G. LO PORTO, L’attività archeologica in Puglia, in Metaponto, ACT XIII, Taranto 1973, Napoli 1974, pp. 413-422 LO PORTO 1978 F. G. LO PORTO, La documentazione archeologica in Puglia, in Magna Grecia bizantina e tradizione classica, ACT XVII, Taranto 1977, Napoli 1978, pp. 495-504 LO PORTO 1992 F. G. LO PORTO, Ricerche sulle antiche mura di Taranto, in Taras, XII, 1992, pp. 7-27 LUGLI 1966 G. LUGLI, Velia (intervento), in Filosofia e scienze in Magna Grecia, ACT V, Taranto 1965, Napoli 1966, pp. 265-270 MAIURI 1928 A. MAIURI, Velia: prima ricognizione ed esplorazione, in Campagne della Società Magna Grecia, ASMG, 1928, pp. 14-29 MAIURI 1954 A. MAIURI, Saggi di varia antichità, Venezia 1954 MAIURI 1962 A. MAIURI, Scavi e scoperte in Magna Grecia, in ACIAC VII, Roma 1958, Roma 1962, pp. 81-98 MARTIN 1970 R. MARTIN, Le problème de l’appareil polygonal à Vélia, in PdP, XXV, 1970, pp. 94-107 MARTIN 1971 R. MARTIN, L’architecture de Tarente, in Taranto nella civiltà della Magna Grecia, ACT X, Taranto 1970, Napoli 1971, pp. 297-305 MATTIOLI 1998 B. MATTIOLI, Piazza Castello angolo Discesa Vasto, in Taras, XVIII, 1998, pp. 88-89 MELE 2002 A. MELE, Taranto dal IV sec. a.C. alla conquista romana, in Taranto e il Mediterraneo, ACT XLI, Taranto 2001, Napoli 2002, pp. 79-99 MELE 2004 A. MELE, Alessandro il Molosso e le città greche d’Italia, in Alessandro il Molosso e i “Condottieri”in Magna Grecia, ACT XLIII, Taranto-Cosenza 2003, Napoli 2004, pp. 283-318 MELLO-MANGIERI 1996 M. MELLO, G. L. MANGIERI, Poseidonia, in BTCG, XIV, 1996, pp. 301-395 MERTENS 1988 D. MERTENS, Note sull’architettura di Poseidonia-Paestum. Problemi e stato della ricerca, in Poseidonia-Paestum, ACT XXVII, Taranto 1987, Taranto 1988, pp. 541-574 MERTENS 1995 D. MERTENS, Metaponto, in EAA, Suppl. III, 1995, pp. 641-648 MERTENS 1998 D. MERTENS, L’architettura e l’urbanistica di Metaponto nel quadro dell’economia locale e dell’evoluzione generale nella Magna Grecia, in SiriMeta 1998, pp. 121-140 MERTENS 1999 D. MERTENS, Metaponto: l’evoluzione del centro urbano, in Basilicata 1999, pp. 247-294 MINGAZZINI 1954 P. MINGAZZINI, Velia. Scavi 1927: fornace di mattoni ed altre antichità, in ASMG, 1954, pp. 21-60
MOGGI 1999 M. MOGGI, Guerra e diplomazia, in Confini e frontiera nella grecità d’Occidente, ACT XXXVII, Taranto 1997, Taranto 1999, pp. 523-545 MOGGI 2002 M. MOGGI, Taranto fino al V sec. a.C., in Taranto e il Mediterraneo, ACT XLI, Taranto 2001, Napoli 2002, pp. 45-78 MOREL 1970 J. P. MOREL, Sondages sur l’acropole de Vélia, in PdP, XXV, 1970, pp. 131-145 NAFISSI 2004 M. NAFISSI, Sparta, Taranto e la spedizione di Archidamo, in Alessandro il Molosso e i “Condottieri”in Magna Grecia, ACT XLIII, TarantoCosenza 2003, Napoli 2004, pp. 181-195 NAPOLI 1964 M. NAPOLI, La documentazione archeologica in Lucania, in Metropoli e colonie di Magna Grecia, ACT III, Taranto 1963, Napoli 1964, pp. 183-195 NAPOLI 1965 M. NAPOLI, La documentazione archeologica in Campania, in Santuari di Magna Grecia, ACT IV, Taranto - Reggio Calabria 1964, Napoli 1965, pp. 106-120 NAPOLI 1966a M. NAPOLI, L’attività archeologica nelle province di Avellino, Benevento e Salerno, in Filosofia e scienze in Magna Grecia, ACT V, Taranto 1965, Napoli 1966, pp. 193-211 NAPOLI 1966b M. NAPOLI, La ricerca archeologica di Velia, in PdP, XXI, 1966, pp. 191-226 NAPOLI 1966c M. NAPOLI, Velia, in EAA, VII, 1966, pp. 1112-1116 NAPOLI 1970a M. NAPOLI, Intorno alla pianta di Velia, in PdP, XXV, 1970, pp. 226235 NAPOLI 1970b M. NAPOLI, L’attività archeologica nelle province di Avellino, Benevento e Salerno, in La Magna Grecia nel mondo ellenistico, ACT IX, Taranto 1969, Napoli 1970, pp. 179-190 NAPOLI 1971 M. NAPOLI, L’attività archeologica nelle province di Avellino, Benevento e Salerno, in Taranto, ACT X, Taranto 1970, Napoli 1971, pp. 453461 NAPOLI 1972 M. NAPOLI, Guida agli scavi di Velia, Cava dei Tirreni 1972 NAPOLI 1973 M. NAPOLI, Il territorio a sud del Sele, in Economia e società nella Magna Grecia, ACT XII, Taranto 1972, Napoli 1973, pp. 297-305 NAPOLI 1974 M. NAPOLI, L’attività archeologica nelle province di Salerno, Avellino e Benevento, in Metaponto, ACT XIII, Taranto 1973, Napoli 1974, pp. 357-371 NAPOLI 1975 M. NAPOLI, L’attività archeologica nelle province di Salerno, Avellino e Benevento, in Orfismo in Magna Grecia, ACT XIV, Taranto 1974, Napoli 1975, pp. 239-244 NAVA 1997 M. L. NAVA, L’attività archeologica in Basilicata nel 1996, in Mito e storia in Magna Grecia, ACT XXXVI, Taranto 1996, Taranto 1997, pp. 455-494 NENCI 1976 G. NENCI, Il barbaros polemos fra Taranto e gli Iapigi e gli anathemata tarantini a Delfi, in ASNP, VI, 1976, pp. 719-731 NEUTSCH 1968a B. NEUTSCH, Heraklia am Golf von Tarant, in «Antike Kunst», XI, 1968, pp. 146-152 NEUTSCH 1968b B. NEUTSCH, Neue archäologische Entdeckungen, in «Archäologischer Anzeiger », IV, 1968, pp. 187-234 NEUTSCH 1970a B. NEUTSCH, Neue archäologische Untersuchungen am Südhang der Akropolis von Elea, in PdP, XXV, 1970, pp. 146-152 NEUTSCH 1970b B. NEUTSCH, Velia (intervento), in La Magna Grecia nel mondo ellenistico, ACT IX, Taranto 1969, Napoli 1970, pp. 191-195 NEUTSCH 1980 B. NEUTSCH, ZumEros-Brunnen von Elea, in Philias Charin. Miscellanea di studi classici in onore di Eugenio Manni, Roma 1980, pp. 16121620
102
NIUTTA 1977 F. NIUTTA, Le fonti letterarie ed epigrafiche, in Locri I 1977, pp. 253355 OLDFATHER 1927 W. A. OLDFATHER, Lokroi, in Pauly-Wissowa, Real Encyclopädie der Classischen Altertumwissenschaft, Vol. XIII, Parte II, Stuttgart 1927, coll. 1289-1363 ORSI 1902 P. ORSI, Lokroi Epizephyrioi (Comune di Gerace) - Scoperte varie nella città antica, in NSA, 1902, pp. 39-43 ORSI 1909a P. ORSI, Lokroi Epizephyrioi - Quarta campagna di scavi (1909), pp. 319-326 ORSI 1909b P. ORSI, Locri Epizefiri. Resoconto sulla terza campagna di scavi locresi (aprile-giugno 1908), in «Bollettino d’Arte», III, 1909, pp. 406-428 ORSI 1910 P. ORSI, Appunti di protostoria e storia locrese, in Saggi di storia antica e di archeologia offerti a G. Beloch, Roma 1910, pp. 155-168 ORSI 1911 P. ORSI, Rapporto preliminare sulla quinta campagna di scavi nelle Calabrie durante l’anno 1910. I - Locri Epizephyrii, in NSA, 1911, Suppl., pp. 3-76 ORSI 1912a P. ORSI, Scavi in Calabria nel 1911 (relazione provvisoria). I - Locri Epizephyrii, in NSA, 1911, pp. 3-56 ORSI 1912b P. ORSI, Crotone materiale inedito del Museo civico, in NSA, 1912, Suppl., pp. 60-66 ORSI 1916 P. ORSI, Caulonia. Campagne archeologiche del 1912, 1913 e 1915, in MonAnt, XXIII, 1916, coll. 685-948 ORSI 1921 P. ORSI, Monteleone Calabro. Nuove scoperte, in NSA, 1921, pp. 473483 ORTOLANI 1999 F. ORTOLANI, Evoluzione geologica dell’area archeologica di Velia (Cilento, Italia meridionale) in relazione alle variazioni climatiche avvenute nel periodo storico nel bacino del mediterraneo, in Velia 1999, pp. 125-138 PAGANO 1986 M. PAGANO, Una proposta di identificazione del centro fortificato di Castiglione di Paludi, in MEFRA, 98, 1986, pp. 91-99 PESCE 1936 G. PESCE, Metaponto, in NSA, 1936, pp. 439-449 PONTRANDOLFO 1996 A. PONTRANDOLFO, Paestum, in EAA, Suppl. IV, 1996, pp. 154-161 PORSIA-SCIONTI 1989 F. PORSIA, M. SCIONTI, Taranto, Roma-Bari 1989 PROCOPIO 1954 G. PROCOPIO, Castiglione di Paludi, Sybaris?, in FA, IX, 1954, n. 2016, pp. 139-140 PROCOPIO 1956 G. PROCOPIO, Castiglione di Paludi, in FA, XI, 1956, n. 2688, pp. 173174 PUCCI 1993 G. PUCCI, Lungomare Vittorio Emanuele, in Taras, XIII, 1993, pp. 143144 PUGLIESE CARRATELLI 1983 G. PUGLIESE CARRATELLI, Storia civile, in Megale Hellas 1983, pp. 3102 QUILICI 1967 L. QUILICI, Siris-Heraclea, in Forma Italiane. Regio III - Volumen primum, Roma 1967 ROGLIANO 1962 G. ROGLIANO, Castiglio di Paludi è la vetusta Petelea ?, Cosenza 1962 ROBERT 1993 R. ROBERT, Rites de protection et de defense. A propos des ossements d’un chien decouverts au pied du rempart de Paestum, in AION, XV, 1993, pp. 119-140 ROUVERET-THEODORESCU 2000 A. ROUVERET, D. THEODORESCU, Recherches a Porta Marina: rapport préliminaire, in Paestum 2000, pp. 191-196. RUSSI 1999 A. RUSSI, La romanizzazione: il quadro storico. Età repubblicana ed età imperiale, in Basilicata 1999, pp. 487-558
SABBIONE 1976 C. SABBIONE, L’attività archeologica nelle province di Reggio Calabria e di Catanzaro, in La Magna Grecia nell’età romana, ACT XV, Taranto 1975, Napoli 1976, pp. 569-598 SABBIONE 1977 C. SABBIONE, Attività della Soprintendenza archeologica della Calabria nelle province di Reggio e Catanzaro, ACT XVI, Taranto 1976, Napoli 1977, pp. 893-939 SABBIONE 1979 C. SABBIONE, L’attività archeologica in Calabria, in Gli Eubei in Occidente, ACT XVIII, Taranto 1978, Napoli 1979, pp. 369-398 SABBIONE 1987 C. SABBIONE, Caulonia (2), in BTCG, V, 1987, pp. 183-187 SÄFLUND 1935 G. SÄFLUND, Dating of ancient Fortifications in Southern Italy and Greece with a spacial reference to Hipponium, in «Acta Instituiti Romani Regni Sueciae», IV, 1935, pp. 87-119 SCHLÄGER 1957 H. SCHLÄGER, Das Westtor von Paestum, München 1957 SCHLÄGER 1962 H. SCHLÄGER, Zu den Bauperioden der Stadtmauer von Paestum, in RM, 69, 1962, pp. 21-26 SCHLÄGER 1964 H. SCHLÄGER, Zur frage der Torverschlüsse von Paestum, in RM, 71, 1964, pp. 104-111 SCHLÄGER 1965 H. SCHLÄGER, Zu paestaner problemen, in RM, 72, 1965, pp. 182-197 SCHLÄGER 1969 H. SCHLÄGER, Weiteres zum Wallgraben von Paestum, in RM, 76, 1969, pp. 348-354 SCHMIEDT 1964 G. SCHMIEDT, Contributo delle fotointerpretazioni alla ricostruzione della situazione geografica dei porti antichi in Italia, Firenze 1964 SCHMIEDT 1966 G. SCHMIEDT, Antichi porti d’Italia. Parte prima, in Universo, XLVI, 1966, pp. 297-353 SCHMIEDT 1967 G. SCHMIEDT, Antichi porti d’Italia. Parte seconda (seguito), in Universo, XLVII, 1967, pp. 2-44 SCHMIEDT 1968-69 G. SCHMIEDT, Le ricerche sull’urbanistica delle città italiote e siceliote, in «KVKALOS. Studi pubblicati dall’Istituto di Storia Antica dell’Università di Palermo», XIV-XV, 1968-1969, pp. 397-420 SCHMIEDT 1970a G. SCHMIEDT (a cura di), Atlante aerofotografico delle sedi umane in Italia, Parte Seconda, Note introduttive, Firenze 1970 SCHMIEDT 1970b G. SCHMIEDT, Contributo alla ricostruzione della situazione geotopografica di Velia nell’antichità, in PdP, XXV, 1970, pp. 65-92 SCHMIEDT-CASTAGNOLI 1955 G. SCHMIEDT, F. CASTAGNOLI, Fotografia aerea e ricerche archeologiche. Il complesso urbanistico di Paestum, in Universo, XXXV, 1955, pp. 117-128 SCHMIEDT-CHEVALLIER 1959 G. SCHMIEDT, R. CHEVALLIER, Caulonia e Metaponto. Applicazioni della fotografia aerea in ricerche di topografia antica nella Magna Grecia, in Universo, XXXIX, 1959, pp. 349-370 SCHMIEDT-CHEVALLIER 1960 G. SCHMIEDT, R. CHEVALLIER, Photographie aérienne et urbanisme antique en Grande-Gréce. Caulonia, Métaponte, in RA, 1960, pp. 1-31 SCHNAPP 1977 A. SCHNAPP, Moio della Civitella, in Locri Epizefirii, ACT XVI, Taranto 1976, Napoli 1977, pp. 787-791 SCONFIENZA 1996 R. SCONFIENZA, Sistemi idraulici in Magna Grecia: classificazione preliminare e proposte interpretative, in «Bollettino Storico della Basilicata», 12, 1996, pp. 25-66 SCONFIENZA 2003 R. SCONFIENZA, Architettura militare in Magna Grecia fra il IV sec. a.C. e l’età ellenistica, in Orizzonti, IV, 2003, in corso di stampa SESTIERI 1951 P. C. SESTIERI, Paestum, Poseid≈nia, in FA, VI, 1951, n. 1974, pp. 163-164 SESTIERI 1953 P. C. SESTIERI, Velia, in FA, VIII, 1953, n. 2270, p. 178 SESTIERI 1954 P. C. SESTIERI, Velia, in FA, IX, 1954, n. 3047, pp. 234-235
103
SESTIERI 1957 P. C. SESTIERI, Greek Elea - Roman Velia, in «Archaeology», 10, 1957, pp. 2-10 SESTIERI 1960 P. C. SESTIERI, Velia, in FA, XV, 1960, n. 4542, pp. 308-309 SESTIERI 1961 P. C. SESTIERI, Metaponto, in EAA, IV, 1961, pp. 1095-1097 SESTIERI 1962 P. C. SESTIERI, De steden von het Lucanië. Magna Graecia, De Griekse Steden von Zud Italië, in «Antiquity and Survival», III, 2-4, 1962, pp. 85-98 SESTIERI 1976 P. C. SESTIERI, Paestum. La città, la necropoli preistorica in contrada Gaudo, lo Heraion alla foce del Sele, Roma 1976 SEVERINO 1988 C. G. SEVERINO, Crotone, Roma-Bari 1988 SMALL 1999 A. M. SMALL, L’occupazione del territorio in età romana, in Basilicata 1999, pp. 559-600 SPADEA 1984 R. SPADEA, La topografia, in Crotone, ACT XXIII, Taranto 1983, Taranto 1984, pp. 119-166 SPADEA 1994 R. SPADEA, Crotone, in EAA, Suppl. II, 1994, pp. 331-336 STAZIO 1965 A. STAZIO, La documentazione archeologica in Puglia, in Santuari di Magna Grecia, ACT IV, Taranto - Reggio Calabria 1964, Napoli 1965, pp. 153-179 THEODORESCU 1988 D. THEODORESCU, Elements d’urbanisme et de topographie. Etat actuel et perspectives, in Poseidonia-Paestum, ACT XXVII, Taranto 1987, Taranto 1988, pp. 501-540 TOCCO SCIARELLI 1993 G. TOCCO SCIARELLI, L’attività archeologica della Soprintendenza archeologica di Salerno, Avellino e Benevento, 1992, in Sibari e la Sibaritide, ACT XXXII, Taranto-Sibari 1992, Taranto 1993, pp. 723740 TOCCO SCIARELLI 1994 G. TOCCO SCIARELLI, Storia degli scavi e nuove prospettive di ricerca, in Velia 1994, pp. 13-18 TOCCO SCIARELLI 1997 G. TOCCO SCIARELLI, L’attività della Soprintendenza archeologica di Salerno, Avellino e Benevento nel 1996, in Mito e storia in Magna Grecia, ACT XXXVI, Taranto 1996, Taranto 1997, pp. 447-448 TOCCO SCIARELLI 1999 G. TOCCO SCIARELLI, Attività della Soprintendenza archeologica nelle province di Salerno, Avellino e Benevento nel 1998, in L’Italia meridionale in età tardo antica, ACT XXXVIII, Taranto 1998, Taranto 1999, pp. 675-686 TODISCO 1990 L. TODISCO, Teatro e theatra nelle immagini e nell’edilizia monumentale della Magna Grecia, in Arte e artigianato, MG IV 1990, pp. 103-158 TOMASELLO 1972 E. TOMASELLO, Monasterace Marina (Reggio Calabria). Scavi presso il tempio dorico di Punta Stilo, in NSA, 1972, pp. 561-643 TORELLI 1988 M. TORELLI, Paestum romana, in Poseidonia-Paestum, ACT XXVII, Taranto 1987, Taranto 1988, pp. 33-115 TORELLI 1999 M. TORELLI, Paestum romana, Roma 1999 TRÉZINY 1983 H. TRÉZINY, Main-d’œuvre indigène et hellénisation: le problème des fortifications lucaniennes, in Architecture et Société de l’Archaïsme grec à la fin de la Republique Romaine. Actes du Colloque international organisé par le Centre National de la Recherche Scientifique et l’Ecole française de Rome (Rome 2-4 décembre 1980), Roma 1983, pp. 105118 TRÉZINY 1984a H. TRÉZINY, Crotone - Saggi sulla collina di Santa Lucia, in Crotone, ACT XXIII, Taranto 1983, Taranto 1984, pp. 593-598 TRÉZINY 1984b H. TRÉZINY, Caulonia (intervento), in Crotone, ACT XXIII, Taranto 1983, Taranto 1984, pp. 177-182 TRÉZINY 1984c H. TRÉZINY, Caulonia (Reggio Calabria), in MEFRA, 96, 1984, pp. 550-551 TRÉZINY 1988 H. TRÉZINY, Kaulonia (Calabre): urbanisme et fortifications à la lumière des fouilles récentes, in RA, 1988, pp. 205-212
TRÉZINY 1989a H. TRÉZINY, Introduction, in Kaulonia I 1989, pp. 5-12 TRÉZINY 1989b H. TRÉZINY, Les structures, in Kaulonia I 1989, pp. 13-25 TRÉZINY 1989c H. TRÉZINY, Les fortifications, in Kaulonia I 1989, pp. 129-152 TRÉZINY 1989d H. TRÉZINY, Fortifications et urbanisme, in Kaulonia I 1989, pp. 154157 TRÉZINY 2004 H. TRÉZINY, Aspects des fortifications urbaines de la Grande-Grèce dans la deuxieme moitié du IV e s. av. J.C., in Alessandro il Molosso e i “Condottieri”in Magna Grecia, ACT XLIII, Taranto-Cosenza 2003, Napoli 2004, pp. 595-631. TURANO 1970 C. TURANO, Alla ricerca di Locri antica, in Hist, XXIII, 1970, pp. 143156 TURANO 1973 C. TURANO, I Cartaginesi a Locri nel 215 a.C. Appunti sul porto locrese, in Hist, XXVI, 1973, pp. 166-174 VIOLA 1881 L. VIOLA, Taranto, in NSA, 1881, pp. 376-437 VOZA 1963 G. VOZA, La topografia di Paestum alla luce di alcune recenti indagini, in «Archeologia Classica», XV, 1963, pp. 223-232 VOZA 1964 G. VOZA, Paestum (intervento), in Metropoli e colonie di Magna Grecia, ACT III, Taranto 1963, Napoli 1964, pp. 290-292 WUILLEUMIER 1939 P. WUILLEUMIER, Tarente des origines à la conquête romaine, Paris 1939 ZANCANI MONTUORO 1959 P. ZANCANI MONTUORO, Il tempio di Persefone a Locri, in RendLinc, XIV, 1959, pp. 225-232 ZANCANI MONTUORO 1961 P. ZANCANI MONTUORO, Locri Epizefiri, in EAA, IV, 1961, pp. 668677 ZANCANI MONTUORO 1963 P. ZANCANI MONTUORO, Paestum, in EAA, V, 1963, pp. 829-840 ZANOTTI BIANCO 1955 U. ZANOTTI BIANCO, Le ricerche archeologiche in Calabria durante l’ultimo cinquantennio, in ArcCal, XXIV, 1955, pp. 257-272 ZANOTTI BIANCO 1957 U. ZANOTTI BIANCO, Le ricerche archeologiche in Calabria durante l’ultimo cinquantennio, in Aatti del primo congresso storico calabrese, Cosenza 1954, Roma 1957, pp. 1-18
104
ILLUSTRAZIONI Didascalie
Tavola I Esempi di «Geländemauern»: Siracusa (Valbonne 1986) Tavola II Esempi di «Geländemauern»: Agrigento, Stratos d’Acarnania, Messene (Valbonne 1986) Tavola III Esempi di «Geländemauern»: Samo, Efeso (Valbonne 1986) Tavola IV Esempi di «Geländemauern»: Mileto, Eritre (Valbonne 1986)
Tavola XVII Esempi di porte a varco semplice difeso da due torri presso gli stipiti, dall’alto in basso: Porte di Etioneia al Pireo, Porta dei Leoni a Mileto (ADAM 1982), Porta Sacra a Mileto (fase classica, LAWRENCE 1967) Tavola XVIII Esempi di porte a cortile, dall’alto in basso: porta ovest di Assos, porta sud di Pergamo, Porta di Isthmia a Corinto (WINTER 1971), Porta di Arcadia a Messene (ADAM 1982) Tavola XIX in alto: modello assonometrico di «Kammertor» (BRANDS 1988); in basso, esempi di «Kammertor»: porta principale di Sidé (WINTER 1971), porta della fortezza di Patraios (Valbonne 1986)
Tavola V Esempi di «Geländemauern»: Pergamo, Priene (Valbonne 1986) Tavola VI I tipi di cortina teorizzati da Filone di Bisanzio, dall’alto in basso: a semicerchi, doppio, a meandro; il fossato filoniano triplicato (GARLAN 1974) Tavola VII dall’alto in basso: tracciati a cremagliera da Samiko di Trifilia, a cremagliera bastionata da Mileto, a denti di sega da Mileto (ADAM 1982)
Tavola XX Taranto: la penisola della città, il Mar Piccolo e il Mar Grande (DE GRASSI 1966) Tavola XXI Taranto: pianta del Viola, 1881 (LIPPOLIS 1981) Tavola XXII Taranto: estensione della città antica e circuito murario (PORSIA-SCIONTI 1960)
Tavola VIII Esempi di tenaglie: Gorìtsa (BAKHUIZEN E A. 1992), Gortina d’Arcadia (ADAM 1982)
Tavola XXIII Taranto: tratto di mura a Masseria del Carmine (LO PORTO 1992)
Tavola IX Esempi di tenaglie: Ramnunte, Gyphtokastro (ADAM 1982)
Tavola XXIV Fortificazioni di Saint-Blaise e porta sud con postierla (Valbonne 1986)
Tavola X in alto, esempio di tenaglia: Agrigento (Sikanie 1989); in basso, esempio di muratura a cassoni con émplekton (GARLAN 1974)
Tavola XXV Metaponto: collocazione territoriale (SCHMIEDT-CHEVALLIER 1959)
Tavola XI Esempi di torri, dall’alto in basso: torre semicircolare, quadrata, pentagonale (GARLAN 1974), a ferro di cavallo (ADAM 1982) Tavola XII in alto: torre quadrangolare posizionata con uno spigolo rivolto verso il fronte di attacco; in basso: ricostruzione di una belostàsis all’interno della camera di una torre quadrata (ADAM 1982) Tavola XIII a sinistra: sezione di una torre quadrata con piano terreno, primo e secondo e corrispondenti rastremazioni delle pareti (GARLAN 1974); a destra: ricostruzione di torre quadrangolare con ampie thyrìdes all’ultimo piano (ADAM 1982) Tavola XIV in alto: porte a copertura D e G di Mantinea; in basso: porta a corridoio/tenaglia A di Mantinea (ADAM 1982) Tavola XV dall’alto in basso, esempi di porte a corridoio/tenaglia: Porta della Pnice ad Atene (WINTER 1971), Porta del Dipylon ad Atene (ADAM 1982), Porta Sacra di Mileto (fase ellenistica, LAWRENCE 1967), porta est di Massalia (Valbonne 1986) Tavola XVI Esempi di porte a tenaglia aperta, in alto: Tripylon di Siracusa; in basso: porta di Leontini (ADAM 1982)
Tavola XXVI Metaponto: pianta del Lacava-1879 (ADAMESTEANU 1974a) Tavola XXVII Metaponto: estensione delle città e tracciato delle fortificazioni (MERTENS 1995) Tavola XXVIII Metaponto: in alto, fronte nord, tratto di mura presso il ceramico; in basso, fronte nord, Porta Tarantina (Metaponto I 1975) Tavola XXIX Metaponto: in alto a sinistra, ricostruzione della Porta Settembrini (DE SIENA 2001); in alto, fronte ovest tratto di mura in proprietà Favale-Mantice (Metaponto I 1975); in basso, fronte ovest, planimetria della Porta Settembrini (ADAMESTEANU 1987) Tavola XXX Castiglione di Paludi: la Sibaritide e localizzazione del sito (PAGANO 1986) Tavola XXXI Castiglione di Paludi: planimetria del circuito fortificato (PAGANO 1986) Tavola XXXII Castiglione di Paludi: a destra, particolari del fronte nord e ovest, la grande tenaglia settentrionale, la porta principale a cortile, il grande avancorpo triangolare, la seconda porta a tenaglia (PROCOPIO 1954); a sinistra: schema planimetrico della porta a cortile (TRÉZINY 2004)
105
Tavola XXXIII in alto: la Porta del Lago a Stinfalo in Arcadia (WINTER 1971); in basso: porta a cortile dell’acropoli di Kastraki (ADAM 1982)
Tavola L Locri Epizefiri: fronte di mare, il varco con postierla, in alto, planimetria generale; in basso, le fasi tardo arcaica (a sinistra) e alto ellenistica (a destra, BARRA BAGNASCO 2000)
Tavola XXXIV Crotone: planimetria generale del sito (ARDOVINO 1979) Tavola XXXV Crotone: percorso della cinta muraria ipotizzato dal Byvank-1914 (SEVERINO 1988) Tavola XXXVI Crotone: in alto, percorso ipotizzato della cinta muraria con le tre postazioni d’altura di Santa Llucia, Vigna Nuova e Batteria (Valbonne 1986); in basso, tratti delle mura rinvenuti a Santa Lucia (TRÉZINY 1984a) Tavola XXXVII Caulonia: planimetria generale del circuito fortificato (Kaulonia I 1989) Tavola XXXVIII Caulonia: planimetria generale del circuito fortificato e dell’impianto urbano indagato (Kaulonia I 1989) Tavola XXXIX Caulonia: fronte nord-ovest, tratto presso Casa Quaranta (ORSI 1916)
Tavola LI Locri Epizefiri: in alto, fronte sud, parte in vista della porta di Quote San Francesco e varco per l’uscita delle acque; in basso, torre di Castellace, fasi tardo arcaica e alto ellenistica (COSTAMAGNA-SABBIONE 1990) Tavola LII Locri Epizefiri: in alto, fronte ovest, le difese del vallonne AbbadessaMannella con muro d’argine e varco, il tratto delle mura lungo la costa della collina di Mannella, la torre rotonda della Mannella (ORSI 1909b); in basso, fronte nord, torre Marzano (COSTAMAGNA-SABBIONE 1990) Tavola LIII Locri Epizefiri: in alto, fronte nord, mura e porta di contrada Parapezza con la torre ellittica (COSTAMAGNA-SABBIONE 1990); in basso, schema di muratura in mattoni crudi su zoccolo in blocchi lapidei (ADAM 1982)
Tavola XL Caulonia: fronte ovest, tratto presso il cimitero dal Colle A alla ipotetica porta della torre III (ORSI 1916)
Tavola LIV Locri Epizefiri: contrada Cusemi-Marafioti, in alto, planimetria generale del santuario di Marafioti; in basso, tratto di sostruzione e fortificazione presso il tempio (ORSI 1912)
Tavola XLI Caulonia: fronte ovest e sud-est, il Colle A, la porta di Aulon, la Piazzetta (ORSI 1916)
Tavola LV Locri Epizefiri: contrade Cusemi-Marafioti e Caruso-Polisà, ipotetica posizione delle duae arces (BARRA BAGNASCO 1996a)
Tavola XLII Caulonia: in alto, la porta di Casa Quaranta su modello di porta a cortile/tenaglia (Kaulonia I 1989); in basso, torri IV e V del Colle A (ORSI 1916)
Tavola LVI Velia: il territorio di Velia con le posizioni dei phroùria di Punta della Carpinina, Torricelli, Moio della Civitella, Castelluccio (GRECO 1975)
Tavola XLIII Caulonia: dall’alto in basso, la torre D del fronte nord (Kaulonia I 1989), il bastione A dell’angolo tra i fronti nord e nord-ovest (ORSI 1916), ipotesi ricostruttiva del bastione A con torre (Kaulonia I 1989), torre VI del fronte sud-est (ORSI 1916) Tavola XLIV Caulonia: in alto, ipotesi ricostruttiva della torre IX bis; in basso, torri di Caulonia a confronto per forma e dimensioni (Kaulonia I 1989) Tavola XLV Locri Epizefiri: planimetria generale della città e del circuito difensivo (BARRA BAGNASCO 1996a) Tavola XLVI Locri Epizefiri: contrade Centocamere e Marasà, planimetria generale del fronte di mare (BARRA BAGNASCO 2000) Tavola XLVII Locri Epizefiri: fronte di mare, dall’alto in basso: protheìchisma settentrionale del porto, la Porta Portuense e il grande varco di scarico per le acque (BARRA BAGNASCO 2000), le fasi tardo arcaica (a sinistra) e alto ellenistica (a destra) del complesso della Porta Portuense (BARRA BAGNASCO 1999) Tavola XLVIII Locri Epizefiri: fronte di mare, la Porta di Afrodite, in alto, planimetria generale (BARRA BAGNASCO 1996a); in basso, fasi tardo arcaica (a sinistra) e alto ellenistica (a destra, BARRA BAGNASCO 1999) Tavola XLIX Locri Epizefiri: fronte di mare, il Propileo monumentale, in alto, planimetria generale; in basso, ipotesi ricostruttiva (BARRA BAGNASCO 1996a)
Tavola LVII Velia: planimetria generale e percorso delle fortificazioni (KRINZINGER 1997) Tavola LVIII Velia: fronte est, il Castelluccio (ORTOLANI 1999) Tavola LIX Velia: la dorsale principale dal Castelluccio all’acropoli e il tratto A, che funge da fronte nord fino alla torre A6 (ORTOLANI 1999) Tavola LX Velia: fronte nord, il tratto D, a cremagliera fino alla torre D1 e segmento della Porta Marina Nord (ORTOLANI 1999) Tavola LXI Velia: fronte nord, la Porta Marina Nord (KRINZINGER 1994) Tavola LXII Velia: fronte est, il tratto C noto fino alla torre C4 (ORTOLANI 1999) Tavola LXIII Velia: fronte di mare sud, il tratto E presso la Porta Marina Sud e il segmento ipotizzato per il collegamento con l’acropoli (ORTOLANI 1999) Tavola LXIV Velia: fronte di mare sud, Porta Marina Sud (SCHMIEDT 1970b) Tavola LXV Velia: in alto, tratto B, planimetria generale dal raccordo con il tratto A fino alla zona portuale (ORTOLANI 1999); in basso, segmento finale a valle del tratto B, con le torri B3, B4, B5, B6 e il varco bipartito per lo scarico delle acque presso B6 (TOCCO SCIARELLI 1999) Tavola LXVI Velia: acropoli in alto, planimetria generale con la sella fra il santuario dell’acropoli e quello di Poseìdon Asphaleìos (ORTOLANI 1999);
106
in basso, sistema zione dell’acropoli con i terrazzamenti superiore e inferiore del lato sud (KRINZINGER 1999) Tavola LXVII Paestum: planimetria generale con il circuito delle mura (D’AMBROSIO 1990) Tavola LXVIII Paestum: il fronte nord (D’AMBROSIO 1990) e planimetria della Porta Aurea (BLUM 1988) Tavola LXIX Paestum: fronte nord, ipotesi ricostruttiva (SCHÄLGER 1965) Tavola LXX Paestum: il fronte est (D’AMBROSIO 1990) e planimetria della Porta Sirena (SCHÄLGER 1964) Tavola LXXI Paestum: il fronte sud (D’AMBROSIO 1990) e planimetria della Porta Giustizia (BLUM 1988) Tavola LXXII Paestum: fronte est, ipotesi ricostruttiva (ADAM 1982) Tavola LXXIII Paestum: il fronte ovest (D’AMBROSIO 1990) e planimetria della Porta Marina (SCHÄLGER 1964) Tavola LXXIV Paestum: planimetria generale della città con ipotesi sui due orientamenti, precedente e seguente il tardo arcaismo, e rapporto con le porte (THEODORESCU 1988)
107
108






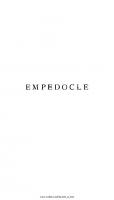

![Morgantina Studies, Volume III: Fornaci e Officine da Vasaio Tardo-ellenistiche. (In Italian) (Late Hellenistic Potters' Kilns and Workshops) [Course Book ed.]
9781400862108](https://ebin.pub/img/200x200/morgantina-studies-volume-iii-fornaci-e-officine-da-vasaio-tardo-ellenistiche-in-italian-late-hellenistic-potters-kilns-and-workshops-course-booknbsped-9781400862108.jpg)
