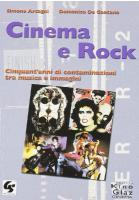Giulio De Angelis. Scritti di musica e di cinema 8887621195, 9788887621198
258 44 738KB
Italian Pages 152 Year 2001
Recommend Papers

- Author / Uploaded
- Marcello De Angelis (editor)
- Aldo Serafini (editor)
File loading please wait...
Citation preview
ETRURIÆ; 2
1 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
2 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
ETRURIÆ Musica e Letteratura Collana diretta da Marcello de Angelis
GIULIO DE ANGELIS SCRITTI DI MUSICA E DI CINEMA Nell’anniversario della scomparsa del traduttore di Ulysses A cura di Marcello de Angelis e Aldo Serafini Contributi di Claudia Corti, Cesare Orselli, Sandro Bernardi
LoGisma editore Firenze
3 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
Giulio de Angelis, Scritti di musica e di cinema Copyright © 2001 LoGisma editore 50030 Bivigliano, Firenze
www.logisma.it [email protected] ISBN 88-87621-19-5
4 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
Indice
Ricordo biografico
7
Claudia Corti, Giulio de Angelis contra James Joyce: un traduttore non traditore
11
Le traduzioni più note di Giulio de Angelis Cesare Orselli, La passione musicale di Giulio
22 23
Recensioni su «Disclub»
28
Camille Saint-Saëns: Sansone e Dalila
29
Il Requiem Tedesco di Johannes Brahms Hector Berlioz, Aroldo in Italia Toscanini e Wagner Felix Mendelssohn, Elijah Ancora a proposito di Mahler Mahler direttore Georg Friederich Haendel, Samson Le fonti dell’Anello del Nibelungo Pushkin e la musica russa Noterella in margine al Ring 1976. Profondità e chiarezza Il Settecento di Prokofiev Letteratura e musica. Pound e il Rinascimento vivaldiano
33 39 43 49 54 58 60 65 74 83 87 95
5 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
Sandro Bernardi, Un critico più sottile del suo tempo Il Tesoro di Arne L’Ultima Risata Femmine Folli M A proposito di Merry Go Round Que viva Mexico! Sofocle, Greene e compagni Le Vampyr ou l’étrange aventure de David Grey Visioni e revisioni Tabula in memoriam
105 109 113 117 123 127 132 136 141 144 149
6 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
RICORDO BIOGRAFICO
Facendo parte del gruppo più giovane dei cugini de Angelis, non ho conosciuto Giulio se non durante gli anni ‘50. I ricordi precedenti si mescolano a quelli vissuti nell’inconscio della guerra che sentivo passare sopra di me come fosse un tragico gioco fra uomini che costringevano altri simili a morire o a nascondersi. Il “rifugio” – con una grande R stampata sulla parete esterna – era quello di Via Brunetto Latini, n. 36. Nello scantinato, adibito a dimora di fortuna durante l’allarme aereo, la fisionomia di Giulio mi appare velata insieme con il ricordo dei miei genitori, della nonna Rosina, degli zii Elena e Cesare. L’unico loro figlio, diciottenne, si apprestava a conseguire la licenza liceale al “Galileo” dopo una permanenza a Genova, città della quale ha sempre conservato un ricordo dolcissimo, e del Liceo “Doria” in particolare. Con alcuni vecchi compagni di classe aveva mantenuto l’amicizia. Chiusa la parentesi genovese, lo avrebbe accolto nuovamente Firenze dove la famiglia, marchigiana di origine (Fano), si era insediata alla fine dell’Ottocento. Qui era nato il 4 ottobre 1925 dimostrando, fin da subito, una naturale attitudine agli studi con una sbalorditiva capacità di apprendimento aperta a poliedrici interessi culturali. La musica innanzitutto, quindi il cinema, la letteratura, o meglio, le letterature perché i suoi orientamenti erano andati subito verso le principali lingue europee (francese in primo luogo, poi inglese e tedesco) da lui frequentate per interesse filologico e critico, prima ancora che per necessità di comunicazione durante gli spostamenti all’estero. Perché i viaggi furono un’altra passione di Giulio, mirati tuttavia verso obbiettivi musicali o luoghi “fìsici” dove riassaporare i fantasmi del passato. Si trattava di pellegrinaggi veri e propri. Una casa, un albero, un’insegna, ed ecco dalla memoria ferrea riaffiorare ogni dettaglio, ogni sensazione “forte” alimentata dai miti di volta in volta coltivati. James Joyce su tutti. Lo scrittore irlandese lo aveva conquistato fin dalle aule dell’Università dove si era laureato in lettere moderne discutendo col prof. Orsini una tesi su “De Quincey e la lingua inglese”.
7 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
Nel perimetro di piazza S. Marco – sede allora delle lezioni – la coscienza dell’uomo e dello studioso venne scossa dalla prima emozione intellettuale. Nessuno aveva mai osato tradurre in lingua italiana Ulysses di James Joyce, caposaldo della letteratura europea, che ben pochi erano riusciti a leggere nell’originale, complicatissimo, farcito di espressioni e vocaboli addirittura inventati se non cabalistici. Tutto doveva essere attentamente verificato, vagliato, per essere sicuri che la corrispondente parola italiana esprimesse il significato vero, voluto dall’autore. Giulio si butta a capofitto nell’impresa, ritenuta impossibile. Le carte – ora donate dalla moglie Liliana all’Archivio contemporaneo G.P. Vieusseux di Firenze – si accumulavano, insieme con la bibliografia utilizzata, finché non arrivò a mettere la parola fine alla “montagna” di fogli dattiloscritti. Tutto ciò accadeva mentre cominciavo a frequentare assiduamente la casa, ignaro di tanta fatica che la naturale riservatezza di Giulio e dei familiari non esaltavano più di tanto. Venivo piuttosto attratto dai dischi di musica classica (ma anche di jazz di cui era attento cultore) posseduti in abbondanza e fatti girare a volume altissimo in un mastodontico apparecchio che mamma Elena invano pretendeva venisse abbassato. Lo aveva ribattezzato “macchina infernale”, croce e delizia di alcuni vicini. Per gli inquilini, essendo tutti dello stesso ceppo, non c’erano problemi. Che fare di quella fatica – atto d’amore e di studio per Joyce – compiuta nel silenzio (quando tacevano i 78 giri) delle pareti domestiche, prima ancora di pensare a un referente editoriale? Memorabili le tappe di avvicinamento all’edizione. Mondadori prima non credeva alla notizia che potesse essere stato compiuto correttamente un simile lavoro. Poco per volta l’editore designato si convinse della bontà di questa impresa sottoponendo le varie sezioni all’attenzione degli specialisti: Cambon, Izzo e Melchiori. Il gioco era fatto. L’opera andò sotto i torchi. Di pari passo con l’attività professionale continuavano gli ascolti, le letture, le “scoperte”. La sua “fede” per Schönberg, la Scuola di Vienna, per esempio. Mio fratello Ugalberto – il compositore scomparso prematuramente a cinquanta anni nel 1982 – e Giulio furono per me quindicenne (poco più, poco meno) indispensabili guide spirituali. Nel 1964, quando al Maggio Musicale arrivò il sottoscritto, universitario di primo pelo, avevo le chiavi giuste per aprire una porta ritenuta inaccessibile, se non
8 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
scandalosa. Su un fronte assolutamente diverso, era appena iniziata la rivendicazione di Anton Bruckner con l’apertura di una omonima associazione alla quale Giulio e Aldo Serafini, per citare chi ancora può darcene testimonianza, immediatamente aderirono. Alla fine degli anni ‘50 l’edizione mondadoriana dell’Ulisse era uscita provocando giusto scalpore. Fu l’evento culturale del dopoguerra ed eravamo orgogliosi che Giulio – di cui conoscevamo la modestia – ne fosse stato l’artefice. E veniva regolarmente invitato a partecipare a seminari, celebrazioni, convegni, tavole rotonde in Italia e all’estero. Netto però il rifiuto. Nessun motivo di orgoglio, per carità!, semplicemente naturale ritrosia o mostrarsi, a dibattere in ambienti paludati e, Dio ci liberi, accademici. L’Università lo avrebbe voluto, lui non volle mai l’Università. Sceglieva sempre la strada da percorrere e aveva ragione. Nel primo concorso a cattedra dopo la guerra ottiene il posto al Liceo scientifico di Salerno come insegnante di francese, ma opta per l’altra cattedra, di inglese, vinta contemporaneamente presso l’Istituto Professionale per il commercio a Empoli. Fu docente anche a Firenze, sempre ricevendo soddisfazione e affetto dai ragazzi e dai colleghi. Ciò gli sarebbe per appagare il naturale bisogno di gratificazione pubblica. Il lavoro del traduttore continuava, prezioso, al di là di Joyce: von Masoch, Venere in pelliccia, manifesto del masochismo, sarà un’altra scoperta rilevante, Faulkner, testi filosofici e scientifici (De Santillana, Le origini del pensiero scientifico), scritti di musica, che qui in parte si ripubblicano, senza contare l’interesse, mai abbandonato, per il cinema. Le note critiche, stese in età giovanile su periodici importanti come «Cinema» e l’«Eco del Cinema», furono osservazioni tutt’altro che irrilevanti per quei tempi di fervori neorealisti e di ammirazione per i bei divi di Hollywood. Sandro Bernardi li ha riletti e commentati con acume e precisione, ritenendo non gratuita la decisione di includerli nella raccolta in memoriam. Partecipazione culturale, semplici curiosità, lucidità di giudizio, vitalità sono state mantenute fino agli ultimi istanti di vita, si può dire, allontanando in noi l’idea che potesse andarsene da un momento all’altro, aggredito da una malattia che non perdona. Lo avevo visto il giorno prima della scomparsa. Era il 3 dicembre 2000. “Guarda come sono ridotto”, mi disse. Eppure ebbe la forza di ricordarmi se fossi riuscito a rintracciare in libreria una monografia su Bruno Walter (con disco alle-
9 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
gato) di cui aveva avuto notizia in un periodico appena comparso in edicola. Gli risposi che avevo ordinato il volume contando di fargli una sorpresa a Natale. Che purtroppo non arrivò per lui, andatosene in punta di piedi, ma circondato dall’affetto di tanti amici che gli vollero bene e che ora hanno voluto rendergli omaggio. Questo era Giulio, un insieme di umiltà, intelligenza e “graffiante” umanità di cui sentiremo, acuta, la nostalgia. Marcello de Angelis
10 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
GIULIO DE ANGELIS CONTRA JAMES JOYCE: UN TRADUTTORE NON TRADITORE
Claudia Corti
– Buonasera, Professore. – – Signorina, la prego, mi risparmi quel ‘professore’; quella parola proprio non la sopporto. – Eravamo agli inizi del 1968; l’incontro, nella piccola stanza di Rolando Anzilotti, docente di Letteratura Americana all’Università di Pisa, che, nell’àmbito di un suo corso sulla traduzione letteraria, aveva invitato Giulio de Angelis a tenere una conferenza sulla traduzione di Ulysses di Joyce, uno dei fenomeni più forti della vivacissima temperie culturale degli anni Sessanta in Italia. E io, che stavo concludendo la mia tesi di laurea in Letteratura Inglese proprio su Ulysses, caparbiamente ottenuta malgrado le ironiche condiscendenze o i paterni sarcasmi dei miei, per l’appunto, “professori”, restai ammutolita di fronte all’osservazione di de Angelis, per me già allora un mito letterario ‘secondo’ – per così dire -, affascinata com’ero dalla sua recente traduzione del mio allora mito letterario ‘primo’, cioè Joyce. Sensibile, delicato, ed innocente – nel senso più nobile del termine – quale era, de Angelis intuì subito che mi aspettavo una spiegazione, subito soddisfatta: “Vede, signorina, ‘professore’ è una parola troppo brutta; troppo lunga, anzitutto; e poi, troppe vocali, tutte quelle orribili /o/ ed /e/; come si fa a chiamare una persona civile proofeessoree?” Ebbi una sorta di illuminazione, e non seppi dargli torto. Allora sul piano strettamente fonologico. Poi, col tempo, faticosamente iniziata al mondo accademico, compresi anche il senso profondo di quella idiosincrasia, che chiama in causa categorie non solo estetiche ma anche esistenziali ed etiche; tant’è che, a distanza di molti anni, e forse inconsciamente ancora influenzata da quella memorabile lezione estemporanea, anch’io non sopporto di sentirmi chiamare “professoressa”: ché, se è brutto “professore”, figurarsi il suo prolungamento cacofonico al femminile! Dunque, niente “professore”, era chiaro. Ma allora, come indirizzarmi a lui? Decisi immediatamente di non chiamarlo in nessun modo, e lo pregai invece di parlarmi, a ruota libera, della sua traduzione di Ulysses,
11 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
descrivendomi i principali problemi linguistici e semantici che aveva incontrato. Ma non appena il discorso cadde – inevitabilmente – sul terribile monologo di Molly nell’ultimo capitolo, altrettanto inevitabilmente la nostra conversazione si arenò sul “lei”, il pronome femminile italiano. Attenti a non offenderci reciprocamente, evitando lui, a quel punto, per specularità di galateo cortese, l’appellativo “signorina” che mi spettava, l’ingorgo lessicale sul “lei” riferito a me, ed il “lei” riferito a Molly divenne insostenibile; per cui arrivammo istintivamente all’uso di “lei” solo per indicare il personaggio femminile joyciano, relegando me stessa in un limbo neutro e fluido di discorso privo di soggetto o oggetto grammaticale. E tale in fondo mi sentivo, davanti alla sapienza intensa ed insieme leggera di una mente e di uno spirito che non esito a definire, a distanza di tanto tempo, eccezionali. In seguito, quando scrissi il mio primo articolo, desunto, come di norma, dalle riflessioni più originali della tesi di laurea, venni di nuovo indirizzata alla competenza di Giulio de Angelis. Non solo come traduttore, ma come esperto filologo e fine chiosatore: la sua Guida alla lettura dell’Ulisse è tuttora una via d’accesso imprescindibile per inoltrarsi nel sentiero testuale più impervio che la letteratura del Novecento ci abbia invitato a percorrere. Questa volta un po’ più sicura di me, parzialmente cresciuta, gli esposi con calma i miei obiettivi. L’idea del saggio non era male: la simonia nella paralisi di Dublino; ne ero abbastanza fiera; al punto che quando de Angelis mi chiese se conoscevo tutti i sensi dell’idea di “simonia”, osai rispondere orgogliosamente (eravamo al tempo della autoreferenzialità del testo) che a me non interessava la simonia come categoria epistemologica, ma la simonia come paradigma testuale, quale era stata messa in gioco, in un gesto arbitrario e fittizio, dall’autore implicito. Mi guardò incuriosito, inclinando la testa da un lato; il sorriso interno gli fece brillare gli occhi: mi sentii presuntuosa ed ignorante. E tuttavia il saggio passò decorosamente il suo vaglio, e con tale garanzia mi apprestai a farlo pubblicare. Da allora non ho più incontrato de Angelis in sedi ufficiali, ma ci siamo visti spesso al Comunale, dove abbiamo per anni condiviso, insieme con la passione comune per la musica, anche la medesima preferenza, visiva ed uditiva, per la prima galleria. L’ultimo contatto pubblico risale a non più di due anni fa, quando ebbi il piacere e l’onore di vederlo in sala ad una conferenza che tenni al Gabinetto Vieusseux. Citai molti brani della sua inossidabile traduzione, ringraziandolo con lo
12 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
sguardo. Pochi giorni dopo ricevetti una sua lettera, di ringraziamenti e complimenti; la calligrafia era alquanto distorta, e se ne scusava, ma manteneva una grande forza e nobiltà. L’Ulisse, nella famosa “unica traduzione integrale autorizzata di Giulio de Angelis ecc.”, con la mitica copertina verde della “Medusa” Mondadori, ha accompagnato l’intera mia carriera universitaria, prima di scolara, e poi di docente e studiosa di Letteratura Inglese. Malgrado l’uso continuato, attestato da qualche pezzettino di nastro adesivo sulla costola, conserva ancora un suo decoro formale, affacciandosi nella zona più frequentata della mia libreria. Quel libro tante volte sfogliato non ha solo un valore affettivo personale; ne possiede uno oggettivo, culturale, di straordinaria pregnanza, rappresentando indubbiamente una delle manifestazioni più interessanti della disciplina della traduzione in Italia nel nostro secolo. E non soltanto per l’ovvio, indiscutibile merito di aver divulgato, qui da noi, il testo fondante del romanzo – o anti-romanzo – del Novecento, ma anche per il suo porsi quale campione privilegiato di qualsivoglia riflessione teorica nell’àmbito della traduttologia (pare ormai essersi affermato questo termine per indicare la disciplina che si occupa dei problemi del tradurre; ma immagino come de Angelis si sarebbe tappato le orecchie, sentendo tutte quelle vocali in cacofonico arrangiamento!). Sembrerà paradossale, ma il traduttore di Ulysses (e del resto di tanti altri autori difficili, non ultimo il difficilissimo Faulkner) non considerava la traduzione una scienza, né tantomeno poteva considerare una disciplina scientifica qualsiasi forma di teoresi su quella che per lui era sostanzialmente una materia empirica, una prassi operativa. Del resto, sappiamo tutti che alla base dell’impresa joyciana ci fu per lui un primario, irrinunciabile, divertimento; ed anche, forse, volendo impiegare un’iperbole che egli avrebbe di certo disdegnato, una sfida verso se stesso. Il fatto è che de Angelis (e ci insistette molto nelle nostre conversazioni) credeva nella traduzione come fenomeno incentrato sull’esperienza stessa del tradurre; ragion per cui non dobbiamo attenderci da lui, traduttore del testo più impervio che si possa immaginare, nessuna sistematizzazione teorica con pretese di obiettività assoluta, sentendosi lui troppo immerso nel proprio oggetto di lavoro, per poterlo afferrare complessivamente dal di fuori e a distanza. Tant’è che, se volessimo applicare ad ogni costo alla sua traduzione di Ulysses le categorie teorico-metodologiche messe a punto dalla traduttologia, ci troveremmo abbastanza spiazzati. È certamente vero
13 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
che potremmo escludere a priori due tipi di traduzione, uno per così dire “basso” e l’altro per così dire “debole”, ovvero: il primo sarebbe la traduzione/informazione, più comunemente conosciuta come traduzione di consumo, che ha come unico scopo quello – eminentemente pragmatico – di rendere accessibile ad un certo pubblico geograficamente determinato un testo letterario redatto in un’altra lingua; il secondo sarebbe la traduzione/approssimazione, cioè la traduzione non letterale e non lineare, che mira però a trasferire il contenuto semantico del testo, istituendo corrispondenze di significato anche a costo di forzature o distorsioni linguistiche. Credo che chiunque abbia in mente brani del romanzo joyciano ed i loro corrispondenti tradotti in italiano, non possa non concordare sia sulla intenzionalità estetica, e non puramente strumentale, della traduzione di de Angelis, sia sulla fondamentale aderenza linguistica del testo tradotto a quello di origine. E per quanto concerne le altre categorie traduttologiche “forti”, l’ Ulisse italiano non aderisce perfettamente a nessuna in special modo, ma piuttosto le assorbe tutte quante in una dimensione nuova ed originale, sintesi unitaria e soggettiva delle varie parzialità. Infatti, la traduzione italiana del testo joyciano assimila sì, e tuttavia trascende, la traduzione/imitazione, laddove il testo d’arrivo cerca di riprodurre da un lato le strategie linguistiche, e dall’altro lato le implicazioni semantiche del testo di partenza, al di là della traduzione letterale. E si avvicina molto, senza peraltro esaurirlo del tutto nelle sue predeterminazioni teoriche, al fenomeno della traduzione/interpretazione. Che gode attualmente di un grande favore critico: è la traduzione intesa come lavoro ermeneutico, come instancabile attività interpretativa dei segni linguistici, a loro volta compresi quali canali trasmettitori dell’energia creativa emessa dalla mente dello scrittore. L’Ulisse di de Angelis è senza dubbio uno straordinario lavoro di interpretazione, dove le istanze strettamente linguistiche (prosodiche, metriche, ritmiche, grammaticali e sintattiche), pur correttamente soddisfatte, vengono trasferite in un livello superiore di orizzonte di senso, che le smista, le seleziona, le coordina, per poi ricondurcele in basso, al puro livello lessicale, investite di una capacità più intensa di rappresentazione. Ma, soprattutto, la dimensione cui de Angelis sembra volere approssimarsi, e che secondo certi parametri teoretici attuali con pretese di “scientificità” potrebbe anche configurarsi come regressione, operazione filologico-critica di retroguardia, è a mio avviso la traduzione/ricreazione: quella – per intenderci – quale la intendeva Paul Valéry, peraltro
14 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
uno dei poeti più amati e frequentati da Giulio de Angelis, e comunque grande amante della traduzione letteraria. Sosteneva dunque Valéry, astioso contro il pregiudizio post ed antiromantico della possibilità del tradurre, che “se è possibile la traduzione originale” (ovvero il collegamento, in qualsiasi lingua usata, tra il segno linguistico ed il suo referente reale, la cosa per cui esso sta), allora è possibile anche la “traduzione seconda”, ovvero la traslazione di quel rapporto primario in una nuova relazione biunivoca, in cui i termini del confronto si assestano su di un parallelo di intercomunicazione. In altri termini: se è possibile la “creazione” linguistica, ovvero l’invenzione di un segno grafico per significare qualcosa, allora sarà possibile anche la ri-creazione di quel qualcosa in un altro segno grafico, appartenente ad un altro sistema linguistico. L’affinità tra creazione linguistica e ricreazione traduttiva discende dal fatto che si tratta di trovare, in entrambi i casi, “une autre enveloppe”, un altro involucro: dalle cose alle parole nella traduzione originale, o viceversa, dalle cose alle parole nella traduzione seconda (cfr. Variations sur les Bucoliques). Il maggiore lascito della teoria di Valéry che possiamo rintracciare nella traduzione italiana di Ulysses (e che rispecchia profondamente – si badi bene – la concezione estetica e poetica di Joyce) consiste nel presupposto dell’esistere stesso dell’opera d’arte come agire. Da cui discende un corollario importante: se l’opera non esiste che in quanto atto, allora l’opera esiste solo nel suo farsi, nel suo modellarsi progressivo, nel suo adattarsi o ritrarsi rispetto alle esigenze di chi la interpreta o semplicemente ne fruisce. L’opera d’arte si impone dunque non come oggetto finito, bensì come un joyciano “lavoro in corso” (work in progress), componimento mai definito né definitivo. Ed è così, allora, che anche la traduzione viene a far parte del “lavoro in corso”: prima ricerca, e poi tentativo di stabilizzazione secondaria di un oggetto primario, che è il testo da tradurre. L’impressione predominante che si trae dalla lettura dell’Ulisse in italiano, è senza dubbio quella che il traduttore abbia avuto alle spalle, se non una teoria precisa, sicuramente un’idea forte della traduzione. De Angelis traduceva, e non solo il grande romanzo joyciano, perché sapeva che tradurre è importante, tradurre è necessario per se stessi e per la cultura cui si appartiene. In tal senso, credo di poter affermare che il suo bagaglio culturale traduttologico è stato quello della grande esperienza traduttiva del Romanticismo, che è poi l’àmbito in cui la traduzione nasce come fenomeno e valore autonomo. Pensiamo ad un traduttore entu-
15 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
siasta che de Angelis naturalmente conosceva, ossia Ugo Foscolo, nelle parole di un’appassionata difesa dell’arte del tradurre, dove si dichiara convinto che “le visioni poetiche de’ grandi esemplari, sieno pur buone cattive o mediocri, e fin anche le scarse interpretazioni letterali, arricchiscono di nuove frasi e nervi e spiriti le lingue, e recano alla letteratura di una nazione la più nobile parte del capitale d’altre età e d’altre genti”. La traduzione, dunque, come esperienza alta e profonda. La traduzione non è un commercio di idee, né uno scambio di favori; la traduzione è il legame per eccellenza tra le culture diverse. Se è vero che le diverse lingue esistono perché, in una accezione idealistica, manifestano la poliedrica frammentazione dell’Essere, allora sarà compito della traduzione ricomporre i frammenti fra di loro, ricostruire l’Unità culturale del mondo. L’esigenza del tradurre nasce dalla tensione interna tra le lingue, che vogliono incontrarsi per porre in contatto le culture che esse rispettivamente esprimono. Si decide di tradurre un testo nella nostra lingua perché avvertiamo che la lingua straniera di quel testo vuole uscire da sé, trascendersi, e innestarsi nella nostra. È chiaro che ciò comporta una valutazione molto rigorosa ed impegnativa della techne del tradurre. Per chi sente – come capii nei nostri colloqui, ma come si evince anche indirettamente dalla lettura dell’Ulisse – per chi sente come de Angelis che tradurre è anche un dovere, un dovere addirittura morale, oltre che un piacere estetico, tradurre non può essere una semplice transizione strumentale da un sistema di segni linguistici ad un altro sistema linguistico equivalente. Dato che la frammentazione linguistica non è mero accidente storico, bensì la forma stessa in cui si rivelano le differenti culture, è compito – difficilissimo, arduo – della traduzione superare sì il divario culturale, senza tuttavia cancellare le specificità della cultura trasmessa dalla lingua di origine. E così, leggendo la traduzione di Ulysses, ci par di capire come l’innesto dell’italiano di de Angelis nell’inglese di Joyce istituisca pian piano una vera e propria dimensione superiore di pensiero, che non è la piatta somma di verità culturali contenute nelle due lingue a confronto, bensì la loro integrazione reciproca in un livello sovrano e per così dire “altro”, distaccato e diverso dalle due lingue coinvolte. A tale livello supremo, l’inglese e l’italiano entrano in un rapporto singolare e specifico, che è fatto insieme di affinità ed estraneità, o – per usare categorie idealistiche che sono certa de Angelis non avrebbe misconosciuto – di immanenza e trascendenza. La traduzione di Ulysses non è né la riproduzione né l’imitazione
16 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
della lingua di Joyce; è qualcosa di molto più importante, una ricreazione, un evento che conduce a qualcosa di nuovo. Questo qualcosa di nuovo è frutto di un’opera di mediazione tra la traduzione intesa come continuità di comunicazione fra una lingua e l’altra, o come trasferibilità di strutture linguistiche, e la traduzione intesa come ricerca di fusione fra i due orizzonti di senso attivati dalle due lingue contrapposte. L’Ulisse italiano si propone perciò come momento di una grande sintesi: interlinguistica, interculturale ed interepistemica. Ho appena cercato di attribuire alla traduzione di de Angelis una prospettiva di riferimenti teorici; ma, sul piano operativo, credo che il più autentico orizzonte di senso vada ricercato in quell’arte che è traduzione per eccellenza, traduzione di pensiero ed animo, la musica. Quella dimensione musicale che è marca stilistica della scrittura di Joyce, è anche l’impronta più specifica della scrittura di de Angelis, che si può dire interpreta in chiave musicale la maniera espressiva del testo da tradurre, accentuandone le basi sonore. Rispettosissimo in genere del ritmo, la cadenza, ed anche la metrica dei brani più poetici del testo in prosa, de Angelis diviene vero maestro nella resa delle onomatopee. Proprio di questo aspetto particolare della traduzione di Ulysses intendo fornire alcuni esempi, prelevandoli dal capitolo Proteo, dove la già intensa musicalità del testo di partenza viene iperesaltata nel livello acustico implicito nella superficie formale del testo di arrivo. Primo esempio. Stephen Dedalus – uno dei due protagonisti, l’altro è Leopold Bloom – sta camminando sulla spiaggia, in riva al mare, calpestando conchiglie. Joyce riproduce fonicamente il rumore scricchiolante: Stephen closed his eyes to hear his boots crush crackling wrack and shells. che de Angelis rende perfettamente, recependo la consonanza fra il suono “duro” del gruppo /cr/ e quello più “dolce” delle /s/: Stephen chiuse gli occhi per sentire le sue scarpe schiacciar scricchiolanti marami e conchiglie. Anzi, si può notare che tutto il gioco onomatopeico non solo è restituito nella sua integralità, ma addirittura migliorato dalla scelta lessicale di “scarpe” per “boots” (che sarebbe letteralmente “stivali”), che sinte-
17 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
tizza in un unico termine tutto il movimento delle consonanti joyciane. Ottima è anche la resa di un’altra difficile onomatopea: His tuneful whistle sounds again, finely shaded, with rushes of the air, his fists bigdrumming on his padded knees. Il fischio melodioso risuona di nuovo, finemente sfumato, con zampilli dell’aria, pugni stambureggianti sulle ginocchia imbottite. Che fa de Angelis? Recepisce le chiavi musicali della /f/ di “tuneful” e della /s/ di “whistle”, e le rielabora entrambe condensandole in “ fischio… sfumato”, rendendo poi perfettamente tutto il gioco delle sibilanti e spiranti. Ancora; Stephen osserva la figura di una zingara che avanza ansimante, trasportando un grosso involucro, sulla battigia resa morbida e di difficile percorrenza dalla marea che l’ha digià inondata. Così la rappresenta il narratore: She trudges, schlepps, trains, drags, trascines her load. E così il traduttore: Lei strascica, sleppa, traina, tira, rimorchia il suo fardello. La complessa assonanza di liquide, dentali, palatali, molto attiva nella frase di Joyce, riceve un supplemento di sonorità musicale nella traduzione, che accentua indubbiamente, anche nella lentezza del ritmo, la riproduzione fonica del fenomeno di flusso e riflusso dell’acqua del mare. Talvolta, aiutato dal suo ben addestrato orecchio di melomane, de Angelis ha degli spunti furbeschi. Per esempio, quando si trova a tradurre la complicata allitterazione della consonante /b/, in una frase a dir poco provocatoria, ideata da Joyce a proposito della primordiale Heva, la magna mater, ebraica madre di tutti i viventi: “Belly withous blemish, bulging big, a buckler of taut vellum”. Pensa e ripensa, sfogliando un ipotetico dizionario bilingue perfetto, il traduttore non trova comunque una resa allitterativa omologa, in italiano; e allora ha un colpo di genio: decide comunque di preservare il movimento allitterativo, ma non trovando assonanze simili nella traduzione letterale, vi rinuncia solo par-
18 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
zialmente, poiché enuclea dal gioco delle consonanti, al posto della /b/, la posizione centrale, e dunque semanticamente caricata, della /g/ di “bulging big”, una /g/ che diviene l’elemento fonico motore della resa allitterativa italiana: “Ventre senza macchia, gonfio e grosso, un brocchiere di pergamena tesa”. In altra occasione, pare che il melomane venga incontro al linguista filologo, per interpretare e trasmettere al pubblico italiano un concetto teologico molto difficile; un concetto che condensa quasi ideogrammaticamente, nella superficie linguistica di Ulysses, il nucleo semantico della dottrina sovversiva di un eresiarca molto rispettato da Joyce: Ario, che lottò sempre contro – nelle parole di Joyce - la “contransmagnificandjewbangtantiality”. La traduzione italiana è “contransmagnificagiudotambanzialità”, dove si può notare come il traduttore riesca brillantemente a mantenere il ritmo dato dai quattro accenti su di un numero corrispondente di sillabe; e soprattutto, come si mantenga intatta la sonorità nasale di “bang” in “tamb”, che inoltre ispessisce il senso del neologismo, condensando l’idea sia dell’impatto psicologico sia della forte risonanza dell’eresia ariana sulla comunità civile e religiosa: “tam-tam” più “tamburo”. Ma non vorrei indulgere in messe a confronto di tipo tecnico, le quali possono sì dare una qualche misura della competente, efficace metodologia del traduttore, ma rischiando – temo – di rendere troppo specialistico ed asettico il discorso su di una operazione traduttiva, che è sostanzialmente pensiero irriflesso e gesto sublime di amore: amore verso la lingua straniera ed il patrimonio culturale in essa depositato, ma ancor più amore verso il linguaggio privato di un singolo genio. La traduzione di de Angelis è grande e possente non tanto, o non solo, perché ci consegna quasi sempre un’equivalenza totale di senso, ma soprattutto perché sembra ricercare e trasferire a noi lettori una sorta di “spirito assoluto” del linguaggio umano, al di là delle frammentazioni e diversificazioni linguistiche. Quando de Angelis, alla stregua del traduttore ideale di Novalis, diviene “poeta del poeta”, allora diviene capace di ricostruire, tramite la traduzione, l’armonia di una matrice unitaria ancestrale, condivisa da entrambe le lingue, la lingua originale e quella finale. Ci sono tanti momenti del testo, in cui avvertiamo che la traduzione è efficace perché attinge ad un comune deposito culturale; non solo suoni, non solo segni, ma sensi, ritrovabili in una dimensione comune aprioristica e precategoriale, simultaneamente extra- ed infra-umana. Uno di questi preziosi momenti ci è dato in un brano del Proteo, che
19 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
scelgo per concludere questa succinta presentazione dell’arte traduttiva di Giulio de Angelis: A bloated carcass of a dog lay lolled on bladderwrack. Before him the gunwale of a boat, sunk in sand. Un coche ensablé, Louis Veuillot called Gautier’s prose. These heavy sands are language tide and wind have silted here. And there, the stoneheaps of dead builders, a warren of weasel rats. Hide gold there. Try it. You have some. Sand and stones. Heavy of the past. Sir Lout’s toys. Mind you don’t get one bang on the ear. I’m the bloody well gigant rolls all them bloody well boulders, bones for my steppingstones. Feefawfum. I zmellz de bloodz odz an Iridzman. La carcassa enfiata di un cane giaceva abbandonata sui sargassi. Davanti a lui lo scalmiere d’una barca, affondata nella sabbia. Un coche ensablé, Louis Veuillot chiamava così la prosa di Gautier. Queste grevi sabbie sono linguaggio che la marea e il vento hanno stacciato qui. E là i tumuli di morti costruttori, una garenna di topidonnola. Nasconderci dell’oro. Provaci. Ne hai. Sabbie e sassi. Gravi di passato. Gingilli per Sir Lout. Bada che non te ne arrivi uno dritto sulla testa. Io sono il gigante fottuto che rotola giù tutti ‘sti macigni fottuti, ossa per sassi da guado. Ucci, ucci. Sssento odor d’irlandesucci. Ecco, questo brano mi sembra la prova di come, nella buona traduzione, il senso comune della lingua di partenza acquisisca uno spessore concettuale più ampio e profondo, perché la traduzione pare scoprire i significati reconditi delle parole della lingua d’origine. Sembra che qui la traduzione precostituisca l’attuabilità di un paradosso: quello di rendere sì possibile in una lingua ciò che è possibile in un’altra, ma anche, contestualmente, di rendere possibile ciò che non sembrerebbe possibile né nella lingua di partenza, né nella lingua d’arrivo. È come se – davvero paradossalmente! – attraverso la traduzione, la lingua di partenza si autoconoscesse di più e meglio nelle proprie potenzialità di espressione e di descrizione, fino al punto di tradurre se stessa (in quanto manifestazione lessicale, grammaticale e sintattica) in se stessa in quanto contenuto semantico. Riflettiamo un attimo su “bloated carcass” e “carcassa enfiata”. I due sintagmi si equivalgono lessicalmente, eppure la tradu-
20 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
zione italiana, “enfiata” ci fa capire meglio il senso autentico dell’inglese, dove “bloated” contiene anche “blown”, ovvero “scoppiata”. E allora l’immagine del povero cane morto annegato è quella di un qualcosa di gonfiato fino allo scoppio, come il “fiato” di un bizzarro e insolente dio dei venti, o quello di un bambino nel parco dublinese, che gonfia a bocca un palloncino, ignaro del “vuoto” morale in cui è inserito. Il brano citato contiene anche una importante riflessione teorica, metalinguistica, applicabile alla traduzione come techne: “queste grevi sabbie sono linguaggio che la marea e il vento hanno stacciato qui”. La traduzione mette al vaglio, setaccia per l’appunto, la lingua d’origine, portando a galla, in superficie, nel flusso e riflusso delle parole, facoltà recondite di rappresentazione. La traduzione si configura allora non come riproduzione di un testo, ma come riproduzione di un processo. Si dovrà dunque ritornare a Novalis, all’idea che la traduzione è “poesia della poesia”, forma irrinunciabile del linguaggio letterario, costitutivamente presente in esso. Non possiamo rinunciare alla traduzione che de Angelis ci ha dato di Joyce, non solo perché l’Ulisse italiano è un testo letterario di altissima qualità, ma anche e soprattutto perché si riverbera sulla lingua originaria con l’efficacia euristica dell’interpretazione creativa. Per riprendere un contenuto della teoria romantica del tradurre, tanto sottesa io credo al modo di tradurre di de Angelis, si potrebbe invocare l’immagine della “camera oscura” inventata da Leopardi laddove, nello Zibaldone 963, ci consegnava una riflessione decisiva per una concezione moderna della traduzione: L’effetto di una scrittura in lingua straniera sull’animo nostro, è come l’effetto delle prospettive ripetute e vedute nella camera oscura, le quali tanto possono essere distinte e corrispondere veramente agli oggetti e prospettive reali, quanto la camera oscura è adattata a renderle con esattezza; sicché tutto l’effetto dipende dalla camera oscura piuttosto che dall’oggetto reale. Ecco; è per questo “effetto di camera oscura”, è per questa disposizione interpretativa e ricreativa capace di tenere in equilibrio il linguaggio straniero e quello familiare, è per questa capacità di fare apparire la prima lingua secondo i modi di un’immagine riflessa, che la traduzione italiana di Ulysses sfida e sfata il pregiudizio freudiano del “traduttoretraditore”; non solo de Angelis non tradisce Joyce, ma si mette al suo fianco come un fedele compagno di avventura.
21 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
GIULIO DE ANGELIS TRADUZIONI (in ordine alfabetico di autore)
GEORGE DE SANTILLANA, Le origini del pensiero scientifico. Sansoni, 1966 JAMES FARRELL, Tutto, ma non un cuore. Mondadori, 1957 WILLIAM FAULKNER, Mentre morivo. SE, 1958 WILLIAM FAULKNER, Zanzare.Mondadori, 1990 GRAHAM GREEN, Missione confidenziale. Mondadori, 1978 NATHANIEL HAWTHORNE, La lettera scarlatta. Libr. Editr. Fiorentina, 1951 IRVING HOWE, Politica e Romanzo. Lerici, 1962 ALDOUS HUXLEY, La filosofia perenne. Adelphi, 1959 JAMES JOYCE, Ulisse. Mondadori, 1960 JAMES, JOYCE, Ulisse, Telemachia. Mondadori, 1983 THOMAS MANN, Risposta alla «Protesta di Monaco città wagneriana»; In difesa di Wagner; Wagner - senza fine; «Maestri cantori», Lettere a Richard Wagner, in Dolore e grandezza di Riccardo Wagner, prefazione di Mazzino Montinari, Discanto, 1979. GILBERT MURRAY, Le origini dell’epica greca. Sansoni,1964 LEOPOLD VON SACHER-MASOCH, Venere in pelliccia. Vallecchi, 1964 LILLIAN SMITH, Gli assassini del sogno. Mondadori, 1957 STEPHEN SPENDER, Moderni o contemporanei? Vallecchi, 1963 JOHN STEINBECK, Il breve regno di Pipino IV. Rizzoli, 1958 JOHN STEINBECK, Quel fantastico giovedì. Mondadori, 1955 JOHN STEINBECK, La valle dell’Eden. Mondadori, 1974 VIRGINIA WOOLF, Gli anni. Mondadori, 1955 VIRGINIA WOOLF, Le onde. Rizzoli, 1979 INTRODUZIONI THOMAS HARDY, Jude l’oscuro. Casini, 1964 JAMES JOYCE, Penelope, Biblioteca Universale Rizzoli, 1978 PUBBLICAZIONI Guida alla lettura dell’«Ulisse» di J. Joyce. Lerici, 1961
22 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
LA PASSIONE MUSICALE DI GIULIO Cesare Orselli
La vita intellettuale di Firenze fra gli anni Trenta-Quaranta è un capitolo luminoso della storia della letteratura e delle arti, reso illustre dalla presenza di personalità come Montale, Gadda, Vittorini (tutti non fiorentini) e di Luigi Dallapiccola e Valentino Bucchi fra i musicisti, che sull’Arno trascorrono momenti fondamentali della loro formazione, continuando la grande tradizione delle riviste di inizio secolo e frequentando luoghi deputati come il Gabinetto Vieusseux o le Giubbe Rosse. Ma negli anni un po’ sonnolenti del dopoguerra, in cui Firenze si avvia a perdere in parte il ruolo di protagonista della cultura nazionale, rimanendo attaccata al suo Maggio Musicale, alle sue case editrici e alle sue mostre di moda, si ha la sensazione di passare sì dalla storia alla cronaca, eppure si percepisce anche che al posto dei centri intellettuali di un tempo, sempre meno frequentati, cominciano ad emergere altri punti di incontro, meno vistosi e solenni, eppure discretamente vivi e animati. È una cornice quasi inedita e molto differenziata, quella degli anni Sessanta, in cui si viene affermando il ruolo di nuovi strumenti di comunicazione mediale: le nuove associazioni, le istituzioni pubbliche, ristoranti come l’Antico Fattore e – accanto e quasi in concorrenza con le cattedrali della formazione musicale – i negozi di dischi classici. Ambienti amabili di ritrovo e discussione, dove ci si vede al tardo pomeriggio o il sabato, uscendo dai concerti degli Amici della Musica; e mentre si sfogliano o ascoltano le novità LP, si parla animatamente delle produzioni del Comunale, dei giovani direttori fiorentini emergenti Bellugi e Bartoletti (del suo Prokofjev, del suo Wozzeck), dell’arrivo di Muti che provoca immediati schieramenti, delle miracolose rivelazioni della Caballé, dell’indimenticabile Fidelio di Strehler, dell’unica apparizione di Domingo in Turandot. Ed è in questo contesto che si matura l’iniziativa coraggiosa di un mensile discografico che prende nome proprio da quel negozio, il Disclub di Giorgio Venturi in Piazza S. Marco: una sorta di unicum a livello nazionale che si estese ben presto alla dimensione di vera e propria rivista di discussione musicale, riuscendo ad accaparrarsi la partecipazione di penne illustri come Gavazzeni,
23 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
Dallapiccola e Mila, e che costituí il trampolino di lancio per molti futuri professionisti, che cominciarono a scrivere proprio su quel periodico fiorentino. Per un laureato come me, appena approdato a Firenze nell’anno dell’alluvione, incontrare al Disclub, chiuso nel suo cappotto scuro, con il suo volto pensoso, Giulio de Angelis, conosciuto nel mondo letterario come il grande traduttore dell’Ulysses di Joyce, cominciare poi a farci amicizia e impiantare con lui conversazioni in tono affabile, quasi modesto, di cose ed eventi musicali, è stata un’impressione difficile da cancellare. Ogni incontro con lui era un mettere a fuoco, magari sulla base di qualche “rarità” resa disponibile da una incisione preziosa, un problema di ordine generale, non un semplice scambio di opinioni su questo o quell’interprete, perché era difficile che de Angelis, parlando di musica, non rimandasse inevitabilmente alla sua variegata cultura di respiro europeo. Non è che le nostre chiacchierate fossero frequentissime: la sua attività primaria di docente e di traduttore dall’inglese lo teneva talvolta lontano dal Disclub; eppure egli continuava a coltivare senza interruzioni la sua passione musicale: così, su ogni numero della rivista, per molto tempo, si potevano leggere le sue recensioni e i più impegnativi contributi nella rubrica “Microsolco al microscopio” (quelli riprodotti nel presente volume), e il dialogo riprendeva, rinsaldando e mettendo a fuoco le discussioni tenute davanti alle colorite copertine dei LP che invadevano il negozio. De Angelis non era un puro amatore, né tanto meno un melomane, ma un frequentatore assiduo di teatri e di sale da concerto e tenace ascoltatore radiofonico sì, e professava saggiamente “l’idea dell’incisione discografica come fotografia, come qualcosa di aleatorio e transeunte che, a causa di fattori imponderabili, può non riuscire a cogliere la effettiva realtà musicale, e non meramente sonora di un testo”; ma era ugualmente molto grato al disco per la capacità di metterlo in contatto con opere non altrimenti avvicinabili, rarità, pagine scarsamente eseguite o interpretazioni storiche (e non conosceva ancora il delirio di produzione CD dei nostri giorni !). Per lui, “l’ascolto disinteressato della musica da parte di chi non sia legato ad essa da obblighi professionali (insegnamento, critica etc.)” si configurava “nella sua forma meno frivola e distratta, come un’appassionante e serissima avventura”; un’avventura che un intellettuale di razza come lui compiva con lo strumento privilegiato di conoscenza del disco, e lo dichiarava senza remore, avendo “il coraggio di sfida-
24 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
re le ire dei soloni della critica per i quali dischi ed analfabetismo musicale sono sinonimi”. A rileggerle oggi, le sue affermazioni coraggiose e un po’ provocatorie, le sue frecciatine, ad esempio, sull’“autore della Matthäus-Passion, fatto oggetto di una fanatica e ottusa ammirazione esclusiva”, o il dibattito sulla clarté francese di Boulez che s’impadronisce del Ring, impegnandosi “ad alleggerire il suono wagneriano, a smorzare una presunta enfasi, a far scendere dai loro coturni i cantanti-attori, a deromanticizzare…” mi hanno ripiombato nella temperie culturale di quegli anni, creando autentiche emozioni e rinfocolando gli echi di discussioni di cui avevo quasi perduto la memoria. Affiorano così, da queste recensioni discografiche, le opinioni correnti del gusto musicale degli anni Sessanta-Settanta, con le preclusioni nei confronti del Kitsch tardoromantico (si legga lo spiritoso articolo su Samson et Dalilas, con il suo baccanale “che ai nostri orecchi si offre disarmato nella sua ingenuità da pezzo di colore quasi alla Ketelbey”), e una certa cautela nell’accogliere le solennità un po’ accademiche dell’Elijah di Mendelssohn (“un musicista che ammiriamo e ascoltiamo volentieri, ma che non riusciamo ad amare, in quanto non ci propone mai interrogativi inquietanti”). Ma si fa apprezzare per il coraggio intellettuale la sua ammirazione per Berlioz “le cui azioni”, in quel tempo, erano “un investimento assai poco sicuro nella borsa dei valori musicali”. “Fu solo un grande intellettuale lucidissimo e velleitario e non un musicista autentico? – era il dubbio critico cui de Angelis sapeva bene come rispondere – O un genio anticipatore, un esploratore impavido di nuovi mondi sonori?” (e lo storico saggio su Berlioz di d’Amico doveva ancora vedere la luce); così come certe sue personali – ma tutt’altro che peregrine, anzi ancor oggi accettabili – opinioni sul Wagner di Toscanini e sul suono dell’orchestra NBC, che “dà nel suonare Wagner l’impressione di un individuo che parli a perfezione una lingua che non è la sua, padroneggiata magari in tutte le sue sfumature di intonazione ma pur sempre con un lontanissimo, ineliminabile accento straniero”. Mentre de Angelis saltella fra un’opera recensita e l’altra, trova sempre il modo di esibire discretamente la sua solida informazione di una pubblicistica musicale italiana e soprattutto inglese non così diffusa nell’Italia monolinguistica di allora, ed ovviamente la sua conoscenza professionale della sua letteratura d’elezione, come quando la recensione del Samson di Haendel diviene un saggetto sulle fonti del libretto, con un’analisi puntuale dei tagli e delle
25 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
interpolazioni del librettista Hamilton nei confronti del dramma originale di Milton. Ma, pur nell’alternanza un po’ eterogenea di titoli recensiti, de Angelis rivela, nell’approccio con l’evento musicale, una forte componente morale e politica, espressione della “mitica” stagione dell’impegno culturale vissuto dagli intellettuali negli anni Sessanta ed oggi irrimediabilmente perduta. Non occorre sottolineare la sua passione civile, il suo sdegno contro “l’Imbianchino” o la “matta bestialità nazista” che anche le recensioni en passant contengono; è inevitabile che Giulio ricordi più volte ammirato – fra i suoi titoli prediletti – il Moses und Aron di Schoenberg e “la sovrumana e spoglia grandezza delle due postreme cantate di Webern”, e che pertanto si offenda per i vuoti paurosi del Maggio Espressionista, “accolto dalla grande maggioranza del pubblico e, cosa ancor più grave, da quasi tutti i più qualificati rappresentanti della fauna musicale locale come un vero e proprio crimine di lesa patria”. In quest’ottica, scaturisce la sua pagina forse criticamente più pregevole, quando si avvicina a Mahler attraverso il saggio di Umberto Eco Apocalittici ed integrati (erano quelli gli anni delle premonizioni novecentesche mahleriane). Quando, dagli agili interventi su Disclub, de Angelis passa alla collaborazione con il Teatro Comunale, che gli commissiona dei contributi per i Numeri Unici del Maggio Fiorentino, la vena polemica stimolata dalla dimensione pubblicistica si attenua in favore di un’acculturazione più densa e riflessa. Sono tre autentici saggi, di cui uno, Le fonti dell’Anello del Nibelungo, è dedicato a uno dei grandi amori di Giulio, Wagner, ma senza affrontare il fatto musicale, intendendo ricostruire puntualmente come Wagner attinga e trasformi nella Tetralogia personaggi e situazioni dell’Edda, della Saga dei Velsunghi, della Saga di Thidrek e soprattutto del Nibelungenlied: un quadro discretamente ampio ed esaustivo, con l’esibizione di una dottrina letteraria di livello europeo. Ancora sul rapporto fra musica e letteratura si colloca lo studio su Pushkin e la sua fortuna teatrale, che si conclude con alcune belle pagine sull’Eugenio Onieghin di ¢iajkovskij e il suo rapporto con il testo pushkiniano, da Giulio analizzato con grande acume: “ogni grande scrittore, dice Borges, talvolta riscrive o trascrive opere altrui, cambiandone la natura e mostrandocele sotto altra luce…”. Un altro capitolo “russo”, ulteriore conferma della cultura letteraria inglese di Giulio è costituito dal saggio Il Settecento di Prokofjev, scritto in occasione della prima a Firenze dell’incantevole Matrimonio in con-
26 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
vento, occasione per un’ampia ricognizione del testo originale di Sheridan in rapporto alla riduzione librettistica. Ultimo atto della passione musicale di Giulio è il saggio pubblicato nel 1991 su «Chigiana», Letteratura e musica. Pound e il rinascimento vivaldiano, sotto il cui titolo emblematico tornano a rivivere, addensate in brevi ricordi o citazioni, le antiche passioni letterarie di Giulio de Angelis: da Mann a Shaw, da Joyce a – naturalmente – Pound e al suo contributo alla renaissance vivaldiana che ebbe nell’Accademia Chigiana di Siena, grazie a Olga Rudge, Alfredo Casella e al conte Chigi, un epicentro. Ma in queste pagine sembra quasi di aver di fronte un de Angelis inedito: non solo per l’abbandono totale di toni polemici, per l’assenza della “passione” musicale, per il rifiuto di esibizione culturalistica; ma per uno stile di scrittura inedito, tutto scandito per brevi periodi, con un qualcosa di poetico, rapsodico e quasi di allucinato. L’ultimo incontro di Giulio con i fatti della musica ridiviene così un ritorno alle proprie origini letterarie, ma con i toni di un amoroso, prosciugato addio.
27 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
RECENSIONI DISCOGRAFICHE SU «DISCLUB» (non inserite nella presente raccolta)
Britten, War Requiem H. Prey, Lieder di Schubert, Schumann, Brahms, Strauss J. Sutherland, Command Performance Bruckner, Messa in fa min. Franck, Sinfonia in re min. Puccini, Messa di gloria Brahms, Un requiem tedesco E. Haefliger, Lieder di Beeth e Schumann Puccini, Tosca Berlioz, Aroldo in Italia Mozart, Eine kleine Nachtmusik, Ein musikalisches spass Strauss, Arianna a Nasso Strauss, Vita d’eroe Haendel, Tre cantate italiane Schoenberg, Il libro dei giardini pensili Wagner, La Walkiria (estratti) Saint-Saëns, Danza macabra Mussorgsky, Quadri di un’esposizione Berlioz, Carnevale romano Gluck, Alceste (estratti) Strauss, La donna senz’ombra Stravinsky, Le sacre du printemps Verdi, Rigoletto Wagner, Tannhäuser The Age of Bel Canto Bellini, Beatrice di Tenda
(n. 1, ottobre 1963) (n. 1, ottobre 1963) (n. 1, ottobre 1963) (n. 2, novembre 1963) (n. 2, novembre 1963) (n. 2, novembre 1963) (n. 3, dicembre 1963) (n. 3, dicembre 1963) (n. 3, dicembre 1963) (n. 4, gennaio 1964) (n. 4, gennaio 1964) (n. 4, gennaio 1964) (n. 4, gennaio 1964) (n. 5, feb.-marzo 1964) (n. 6, aprile 1964) (n. 6, aprile 1964) (n.7, maggio 1964) (n.7, maggio 1964) (n.7, maggio 1964) (n. 8, giugno 1964) (n. 13, feb.-marzo 1965) (n. 13, feb.-marzo 1965) (n. 13, febb.-marzo 1965) (n. 15, giu.-luglio 1965) (n. 18, gen.-feb. 1966) (n. 25, gen.-feb. 1968)
28 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
CAMILLE SAINT-SAËNS: SANSONE E DALILA 1
L’eroe solare della Bibbia è legato, nella storia della musica, principalmente ai nomi di Haendel e di Saint-Saëns. E se non si può davvero dire che l’oratorio haendeliano che lo ha come protagonista sia un pezzo di repertorio in Italia, non si potrebbe neppure affermare che l’operaoratorio Sansone e Dalila sia familiare al pubblico. Tanto più gradita giunge quindi l’edizione integrale offertaci dalla Voce del Padrone-Angel, la quale ci permette di renderci compiutamente conto della consistenza effettiva e dei valori di un testo che si presenta fin dall’inizio tarato da difetti di origine quasi schiaccianti e irrimediabilmente datato (18771890). Si può definire sbrigativamente “musicista parnassiano” il SaintSaëns e lo si può anche sommariamente inquadrare nel clima e nell’ambiente floreale. Il dignitoso libretto prestatogli dal cugino Ferdinand Lemaire è un puntuale campionario di tutti i luoghi comuni di un certo gusto a definire il quale valgono i nomi di Hérédia e di Leconte de Lisle e, se si vuole, anche quello del Flaubert di Salammbô. Esotismo, ricostruzione archeologica, fasto barbarico e un certo sottofondo di sadomasochismo che esplode nella tipica situazione finale dell’eroe soggiogato dalla belle dame sans merci e esposto, con voluttà blasfematoria, allo scherno dei filistei che lo costringono ad adorare il loro dio, rinnegando Jahvè per cui il guerriero ha valorosamente combattuto. La musica di Saint-Saëns non si può dire sia stata all’altezza di una situazione del genere e ci possiamo facilmente immaginare quale partito avrebbero ricavato un espressionista o magari lo Strauss di Salomè e di Elektra, dall’orgia finale, culminante in una generale carneficina con il crollo del tempio. Il libretto del Lemaire avrebbe dovuto attendere il suo musicista una trentina di anni. La parte più debole dell’opera di Saint-Saëns è invece proprio il finale ed esso viene quindi a costituire un vero anti-climax cui mal serve da contrappeso il baccanale, una pagina che ai nostri orecchi si offre disarmata nella sua ingenuità da pezzo di 1
CAMILLE SAINT-SAËNS, Sansone e Dalila. Rita Gorr (ms), Jon Vickers (t) – Choeurs René Cuclos - Orchestra del Teatro nazionale dell’Opera diretto da George Prêtre. ANGEL AN 117-8-9 SAN 117-8-9.
29 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
colore quasi alla Ketelbey. Se non parrà irriverente il citare in questa sede a questo proposito tanto nome, si pensi solo un istante all’esplosiva barbarie dello Schoenberg nella Danza intorno al Vitello d’oro e a tutto il solenne impianto di Moses und Aron, che genialmente ripropone alla sensibilità moderna la formula dell’oratorio in una versione così ardita da farne un nuovo genere di dramma musicale. Ma è ovvio che sarebbe da ingenui chiedere allo scaltrito Saint-Saens più di quanto potesse darci. Siamo lontani con lui dalla profondità di pensiero e dal fervore e rigore morale con cui lo Schoenberg meditò e rivisse le pagine della Scrittura.Il musicista francese, alieno da ogni problematica e tendenzialmente assai prossimo (anche se non lo formulò mai programmaticamente) ad una posizione che oggi si potrebbe definire senz’altro neoclassica o di art pour l’art, sentì evidentemente l’episodio biblico come uno dei tanti pretesti per la sua felice e spensierata disponibilità. Scorriamo i titoli dei suoi lavori di teatro: La Principessa Jaune (1872) Henry VIII (l882) Proserpine (1887), Ascanio (1890), Les Barbares (1901), Hélène (1904), Déjanire (1911), Phryné (1893). Sono solo alcuni dei drammi e delle opéras comiques del fecondissimo compositore, ma rivelano già chiaramente quel che fu il suo gusto e il gusto della sua epoca. Figure mitologiche o eroi storici, ma sempre e sostanzialmente, almeno a giudicare da Sansone e Dalila, che soli sopravvivono oggi, tenori e soprani regolarmente forniti di grandi e ben tornite arie, di duetti perfettamente calibrati con contorno di cori opportunamente suggestivi, dentro e fuori scena. In più il grande balletto sempre al momento giusto e la grande scena d’effetto, Sansone accecato che fa girare la macina è un colpo di teatro, un forte contrasto con la situazione dell’eroe vittorioso al primo atto. La musica di Saint-Saëns è sempre perfettamente calibrata, sempre ben scritta e tutta prevedibile. Rivela un mestiere smaliziato e sembra di vederla trascritta in una calligrafia agghindata. Essa ottunde ogni spigolo delle situazioni anche le più ardite (la grande scena di seduzione del secondo atto) e nelle sue morbidissime volute liberty avvolge e uccide con la dolcezza il dramma. Sansone, Dalila, il grande sacerdote sono solo un tenore, un mezzo-soprano e un baritono che non pervengono ad una vera individuazione drammatica. Non si coagulano mai in un personaggio. Il coro stesso è come una piacevole tappezzeria o un sontuoso arazzo di sfondo. L’abilità e la discrezione del musicista sono ammirevoli ma il brivido del dramma è raramente avvertibile. L’unica situazione più autenticamente sentita è la seduzione dell’eroe al secondo atto, là dove
30 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
il floreale ha una sua funzione (significative le didascalie) e si rimpiange a questo punto che un regista come Zeffirelli, invece di soffocare, come ha fatto, l’Aida nei miasmi di Gustave Moreau non abbia piuttosto pensato a mettere in scena l’opera di Saint-Saëns che sembra scritta per lui, idealmente a lui dedicata. A questo proposito viene fatto anche di pensare come l’incisione finisca paradossalmente per rendere un servizio prezioso a Sansone e Dalila, costringendoci a valutare il testo, pur con i suoi limiti, in termini di puro suono, mancando quella bardatura scenica la quale, vi è motivo di temere, finirebbe per far naufragare la fragile navicella che per arrivare in porto ha bisogno tra l’altro di un pilota dalla mano fermissima. Va quindi data lode anzitutto a Georges Prêtre per aver tenuto saldamente in pugno la varia compagnia dei suoi esecutori che in questa edizione sono veramente quanto di meglio si potesse trovare. Jon Vickers e Rita Gorr non hanno bisogno di presentazioni e già in teatro si sono più volte segnalati con onore nei rispettivi ruoli. Qui ci consegnano una versione definitiva delle loro interpretazioni. Ambedue sono in ottima voce e cantano con abbandono e discrezione, completandosi ammirevolmente a vicenda nel grande duetto centrale. Il timbro stesso delle due voci sembra essersi amalgamato in un impasto felice. Ernest Blanc non è da meno nella parte molto convenzionale del gran sacerdote. I cori e l’orchestra trovano sempre il colore giusto e l’intonazione perfetta senza mai cadere nel dolciastro, che è un pericolo continuo. Sarà dunque Sansone e Dalida salvato, in virtù di un’esecuzione perfetta come questa, da quell’oblio che ha inghiottito il Sansone di Giovanni Paolo Colonna (1677), il Sansone Accecato di Francesco Antonio Uri (1700), il Sanson di J. N. Lefroid Mereaux (1774), il Sansone di Francesco Basili, (1824)? Le crepe che già oggi ampiamente rivela l’opera di Saint-Saëns non sono suscettibili di restauro? Rimarrà quest’oratorio da caffè concerto, come lo battezzò una dama parigina, una mera curiosità? Se ne salveranno solo alcune romanze, una delle quali, Aprile foriero (Printemps qui commence), si dice scherzosamente sia stata cantata alla fine del secolo scorso in 422.0l8 salotti? È un dubbio che ci assale e non saremmo davvero in grado di risolverlo. L’interesse di un eventuale recupero di un testo di questo genere è, come si è accennato, prevalentemente archeologico. È notevolissimo in questa svolta nella storia del Grand Opéra, alla quale Sansone e Dalila in parte è legato, l’influsso fortissimo di Wagner in certi clangori di ottoni e in un costante mareggiare di archi che deriva per direttissima dal-
31 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
l’Ouverture del Tannhäuser. Ma ancor più singolare e imponente ci sembra l’influenza verdiana. Tutto il secondo atto lascia vedere in trasparenza il terzo atto dell’Aida che arrivò all’Opera di Parigi solo nel 1880 ma che il Saint-Saëns doveva già conoscere nello spartito. Il gran sacerdote si rivolge a Dalila quasi con gli accenti di Amonasro anche se l’ombra augusta di Wotan fa qui più di una volta capolino e le frasi larghe e appassionate di Dalila ricordano molto da vicino quelle di Brunilde. Segnaliamo, infine, la tempesta sempre all’inizio di questo secondo atto, il più compatto e intenso che curiosamente ricorda il celeberrimo passo del Rigoletto. Dei pregi dell’esecuzione si è già detto. Prêtre imprime all’opera un tono drammatico e concitato, molto diverso dal lento ritmo oratoriale che in genere si ritiene più confacente al taglio originario del testo che fu concepito, in origine, appunto come un oratorio e quindi non destinato alle scene. L’incisione per la quale la Angel ha sfruttato ancora una volta l’ottima acustica della Salle Wagram, a Parigi, è assai ben riuscita. I piani sonori sono sapientemente dosati e i cori in particolare hanno uno straordinario rilievo. Perfetto lo stampaggio. L’opera in conclusione si presterebbe bene anche ad un ascolto antologico ed è quindi auspicabile che la Angel metta in circolazione un disco di Highlights che mai come in questo caso sarebbe bene accetto. (da «Disclub», n. 7, maggio 1963, a. II, pp. 15-17)
32 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
IL REQUIEM TEDESCO DI JOHANNES BRAHMS 1
L’ascolto disinteressato della musica da parte di chi non sia legato ad essa da obblighi professionali (insegnamento, critica etc.) si può configurare nella sua forma meno frivola e distratta come una appassionante e serissima avventura. O, per meglio dire, come richiesta sempre insoddisfatta e solo parzialmente appagata di una esecuzione definitiva, se pur l’aggettivo ha un senso in questo campo. Da questa ricerca continua nascerà l’esigenza di rinnovati contatti col brano e con l’autore oggetto dell’interesse. Nel caso di testi che implichino un particolare impegno di realizzazione, alle ripetute esperienze dal vivo si sostituisce poi efficacemente il disco e ci sembra sia proprio questo uno dei suoi più decisi connotati in quanto strumento di diffusione della cultura, anziché mero trastullo edonistico. Il disco è, infatti, da considerare anche, e soprattutto come un’istantanea, una foto più o meno riuscita di una certa esecuzione che altrimenti sarebbe per l’ascoltatore o fruitore di musica difficilmente raggiungibile. Caso esemplare e tipico quello di esecutori ormai non più attivi, la cui voce ci giunge ancora attraverso il disco. È proprio questa provvisorietà, questa continua diversità di proposte a costituire non solo il fascino dell’ascoltare musica incisa ma a darne una giustificazione (l’unica?) validissima. Di fronte a testi di alto valore, prendere conoscenza di diverse letture, di differenti accostamenti interpretativi diviene per l’ascoltatore una necessità ai fini di quell’avventura o ricerca di cui parlavamo che apparirà sempre più chiaramente come la ricerca di un’ideale pietra di paragone o di un paradigma ideale che di volta in volta potrà cambiare. 1
JOHANNES BRAHMS, Requiem Tedesco. D. Fischer-Dieskau – E. Grümmer – Coro della Cattedrale di S. Edvige – Berliner Philarmoniker. Direttore R. Kempe. Voce del Padrone QALPS 1046 – QALP 10147. D. Fischer-Dieskau – E. Schwarzkopf – Coro e Orchestra Philarmonia diretta da O. Klemperer. Columbia QCXS 10455 – QCX 10456 – SAXQS 7355 – SAXQ 7356. O. Wiener – M. Stader – Coro della Cattedrale di S. Edvige – Berliner Motettenchor – Berliner Philarmoniker – Direttore F. Lehmann. Deutsche Grammophon Gesellschaft LPM 18258/9.
33 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
In questo esercizio del gusto che non esclude, nella sua serietà, un aspetto di “lusus” o superiore giuoco, si procederà ogni volta ad una scelta tra le varie proposte finché il campo non sia sgombro, il più possibile, in attesa dell’unica, definitiva “offerta”. Queste considerazioni sommarie ci suggerisce il recente ascolto di tre versioni ugualmente autorevoli del Requiem tedesco. Brahms, come è largamente noto, con la più vasta delle sue composizioni per coro e orchestra volle onorare la memoria di coloro che più gli furono vicini: Schumann e sua madre. I primi tre dei sette movimenti di cui consta la partitura furono eseguiti il primo dicembre 1867 a Vienna sotto la direzione di Johann von Herbeck, ma la prima ufficiale si ebbe nel Duomo di Brema e fu un avvenimento nella vita musicale tedesca in quanto tutti i musicisti più noti e autorevoli erano presenti. Dirigeva Karl Rheinthaler. Il 18 febbraio 1869 la gloriosa orchestra del Gewandhaus di Lipsia, guidata da Carl Reinecke eseguiva il Requiem nella sua forma definitiva e cioè con l’aggiunta del quinto movimento per soprano solista e coro (Ihr habt nun Traurigkeit) più specificamente dedicato alla memoria della madre del compositore. Se si pensa che la I Sinfonia fu eseguita nel 1876 (anche se i primi appunti risalgono al 1862) e che dei grandi lavori orchestrali solo il I Concerto per piano(1861) precede il Requiem, quest’ultimo ci appare veramente come una specie di grande spartiacque della produzione brahmsiana (è l’opera 45), una sorta di riepilogo di tutti i motivi tratti da una lettura assidua delle sacre scritture, quella che ispirò lavori giovanili come l’Ave Maria (op. 12), il Canto dei Morti (op. 13), Marienlieder (op. 22), i Mottetti (op. 29) e i Cori Religiosi (op. 37). È un riepilogo, ma anche una prefazione ai grandi lavori sinfonici della maturità cui ci sembra fornisca una linfa segreta. Non è forse l’ultimo tempo della IV sinfonia una grande danza macabra, ancora una volta una meditazione sulla morte? Ed è significativo che tra le ultime pagine di Brahms, tra le sue più alte ed accorate, vi siano i Quattro Canti Gravi, scritti alle soglie delle morte, nel 1896, i quali riecheggiano il Requiem come tono e “Stimmung” della musica e del testo, costituendone una specie di folgorante epilogo ideale. Nei quattro canti tutte le ragioni del Requiem sono ribadite con perentorietà e nettezza di accenti. Il Requiem si situa quindi in un punto chiave dell’itinerario brahmsiano e ci è sempre sembrato (non si vuol qui fare una questione di valore assoluto, a dirimere il quale non ci sentiamo autorizzati né competenti) una grande meditazione individuale sulla morte, settanta
34 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
pagine del giornale intimo di Brahms, per noi più significative e moderne che non le amplificazioni a volte puramente retoriche delle sue sinfonie. È come se alla lettura ripetuta di quei testi dell’Antico e Nuovo Testamento, trascelti personalmente da Brahms, quindi una sua antologia ideale, le parole solenni e scabre del tedesco di Lutero si siano lentamente alonate di musica e risuonando, come in una cassa armonica, nello spirito del lettore musicista abbiano sprigionato quella musica che in esse era latente. Il fraseggiare sommesso del coro iniziale Selig sind, die da Lied tragen, la virile e stoica implorazione del baritono Herr, lehre doch mich, sono due esempi di questo lievitare impercettibile in canto del dettato luterano. Miracolo che si rinnova sugli esempi altissimi delle Passioni di Schutz e di Bach. E sono sempre parole gravissime che richiamano all’uomo il problema ultimo ed unico, quello della Morte, il solo che conti veramente. E tutto il tono del Requiem brahmsiano, che non ha niente, come si sa, di chiesastico e rifiuta per sua natura ogni sovrastruttura liturgica e rituale, è un tono sommesso e mormorato, almeno nelle sue parti più alte che sono poi preponderanti: una meditazione lirica ed intima. È l’io ripiegato in silenzio su se stesso che liberamente sceglie i suoi testi di meditazione. Per questo soprattutto il Requiem è giustamente stato definito da Brahms ‘tedesco’, cioè protestante nel senso più autentico del termine. Non un sospetto di pompa chiesastica o concertistica, mai un’ombra di enfasi. Questo Requiem si vorrebbe veramente ascoltarlo da soli, nel proprio studio, tendendo al massimo l’arco dell’attenzione, senza distrazioni esterne. Pur aborrendo i ridicoli estetismi in cui esigenze del genere di solito naufragano, vorremmo veramente sentir sempre questo Requiem in un ambiente adatto (che non sarà poi necessariamente una chiesa) e quindi anche ascoltando una edizione discografica sarà questo aspetto dell’ambiente, con tutti i valori atmosferici connessi, che si imporrà come preminente. Se scegliamo dunque tre edizioni del Requiem tra le varie disponibili sul mercato e le proponiamo ad un ascolto comparativo, sarà il caso di premettere che, proprio in base al criterio sopra esposto, due di esse ci sembrano letture o proposte magari diverse come accentuazione del tono fondamentale, ma comunque centrate (Fritz Lehmann con l’Orchestra Filarmonica di Berlino e Coro di S. Edvige, Berlino, per la D. G. G. e Rudolf Kempe, a capo degli stessi complessi per la Voce del Padrone); la terza, viceversa, costituisce un esempio tipico di esecuzione formal-
35 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
mente impeccabile ed esteriormente smagliante ma in sostanza mancata e fuori centro (Otto Klemperer, con l’Orchestra e Coro Philharmonia di Londra, per la Columbia). Sia Lehmann che Kempe sono due direttori “modesti”, vogliamo dire non “divi”; non provocano, a quanto si sa, risse ai botteghini, né “tutti esauriti” con tre mesi di anticipo sul concerto. Sono due onesti e solidi professionisti della direzione di orchestra che hanno i loro autori preferiti o approfonditi ed ovviamente non potrebbero dirigere “tutto”. Ebbene, sia l’uno che l’altro, e soprattutto Kempe, che purtroppo è servito da una incisione non eccelsa, ci danno una loro lettura del Requiem cosi pudica e schiva da ogni effetto e colore esterno da non far rimpiangere altre clamorose esecuzioni alle quali lo scrivente ha avuto la ventura di assistere (von Karajan, Perugia, Settembre 1952, e Schippers, Spoleto, Luglio 1961). La sensibilità di Kempe aderisce più immediatamente al tono elegiaco della partitura; centra con pronta immedesimazione il suono dell’orchestra e sfuma e dosa le sonorità con mano delicatissima. Al suo comando i cori di Berlino, stupendi per la perfezione dell’intonazione e per la precisione ritmica, assumono uno smalto particolare, un colorito tipico, il magico “Brahms-Klang”. L’orchestra accompagna con discrezione ma è continuamente presente e si decanta in pochi preziosi timbri ogni volta che deve incastonare la voce del solista. Riuscita suprema di questa versione del Requiem è il quinto movimento nel quale Elisabeth Grummer canta con un fervore ed un’intensità che neppure la Schwarzkopf, nell’edizione Klemperer, riesce ad eguagliare. Kempe, volendo riassumere con un solo aggettivo le nostre impressioni, ci dà un Requiem viennese più che “amburghese” o nord-tedesco. Una meditazione dolorosa e disadorna sul tema delle Cose Ultime, una elegia mesta e dolcissima. Lo immaginiamo interprete felice più della Seconda sinfonia brahmsiana che non della Prima. Lehmann è un solido Kapellmeister e sotto la sua bacchetta la stessa orchestra e lo stesso coro suonano disciplinatamente ma con risultati diversi. Non si tratta tanto di una questione interpretativa (si potrà dire che il Requiem di Lehmann è un po’ più mosso e drammatico, meno chiaroscurato, con colori più netti e contrasti dinamici più risentiti), quanto di una diversità impercettibile di accento; al tedesco fluente e cantabile del viennese-monacense Kempe (parliamo per metafora, s’intende, perché Kempe è nato notoriamente a Dresda), Lehmann oppone un tedesco settentrionale tutto esplosive e spigoli, più duro e gotico: un Brahms
36 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
amburghese. Ma la meraviglia dell’edizione D. G. G. è costituita dall’ambientazione. Non sappiamo se le riprese abbiano avuto luogo in una chiesa ed in fondo è un particolare trascurabile.2 Non esiste comunque a quanto ci risulta, una edizione più perfetta dal punto di vista del suono: orchestra e coro sono calati in un ambiente adeguato che ne amplifica le sonorità ma come ovattandole in una penombra dalla quale volta a volta vediamo e sentiamo affiorare e snodarsi le membrature polifoniche e in cui si spengono lentamente le ultime eco dei gemiti elegiaci (finale del quinto e settimo movimento). Eccezionale ed intonata all’interpretazione complessiva è la prestazione di Maria Stader: un po’ troppo melodrammatico è Otto Wiener, dal timbro di voce poco brahmsiano. Le due edizioni che abbiamo molto rapidamente esaminato sembrano, dicevamo, le più ragguardevoli sotto il profilo della autenticità e della immedesimazione interpretative, e la preferenza assegnate alla prima delle due sarà solo questione di inclinazione e gusto individuali. La più recente edizione di Otto Klemperer ci pare, invece, un caso di singolare insensibilità interpretativa, e ciò sia detto con tutto il rispetto per il grande direttore tedesco, animatore della gloriosa Kroll-Oper e bersaglio insieme a tanti altri musicisti della matta bestialità nazista. In una intervista, Klemperer dichiarò di non aver più avuto occasione dal 1931 di dirigere la Messa in si minore di Bach perché né in America, né in nessun altro dei paesi dove è vissuto esule, aveva trovato un complesso che gli permettesse di realizzarne una versione per lui soddisfacente. Fortunatamente da alcuni anni Klemperer ha trovato questo complesso a Londra nella Orchestra e nel Coro Philharmonia di cui è direttore stabile dal ’59 e con cui ha già realizzato incisioni memorabili del Fidelio e della Passione Secondo S. Matteo per iniziativa della His Master’s Voice. Ma questo Requiem Tedesco, per il quale il grande direttore si avvale di due solisti valorosissimi (Schwarzkopf e Fischer Dieskau) e degli stessi complessi, pur essendo tecnicamente perfetto e splendidamente inciso ci delude quasi completamente per quanto riguarda quella autenticità che in un testo del genere ha una particolarissima e quasi primaria importanza. L’orchestra e il coro sono sempre troppo brillanti e tirati al lucido, sono sempre troppo in primo piano. Mancano le mezze tinte e lo stesso Klemperer ci sembra quasi svogliato, disinteressato. Elisabeth 2
La registrazione del Requiem diretta da Kempe ebbe luogo in una chiesa di Berlino, nel luglio 1955.
37 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
Schwarzkopf si adegua a questo tono troppo mondano e “da sala di concerto” con una prestazione ineccepibile e gelida. In questi ultimi anni, la grande cantante dà l’impressione di essere sempre più spesso “la Schwarzkopf” qualsiasi cosa canti, e di porsi sempre meno spesso il problema dell’interpretazione. Resta difficile distinguere la sua interpretazione in questo Requiem da altre sue famose come ad esempio la Marescialla o la Contessa. La stesse preziosità nel fraseggio, la stessa perfezione puramente vocalistica, senza che si giunga ad una individuazione. Significativa di questa impostazione data da Klemperer alla sua versione del Requiem è la diversa intensità con cui reagisce il grande Fischer-Dieskau, che aveva già partecipato alla realizzazione di Kempe con un calore ed una intensità rattenutissimi nei suoi due interventi (terzo e sesto movimento). Con Kempe, Fischer-Dieskau riesce a mantenersi sulla linea del suo Brahms (quello dei vari dischi di Lieder da lui dedicati al Maestro) tutto chiaroscuri, sempre commosso e teso, mai retorico, tutto intimo e pudico. Sotto la guida di Klemperer, pur al livello di una prestazione altissima, perfino un interprete della sua sensibilità suona più melodrammatico e sostanzialmente assente, tutto esteriore. Siamo spiacenti di aver dovuto fare rilievi negativi nei confronti di un grandissimo artista che ammiriamo come il più grande interprete beethoveniano vivente e da cui attendiamo l’incisione di almeno un’opera di Mozart che sia degna della tradizione di Walter (il Flauto Magico?), ma la non riuscita di questa incisione del Requiem ci conferma nella nostra idea dell’incisione discografica come fotografia, qualcosa di aleatorio e transeunte che, a causa di fattori imponderabili, può non riuscire a cogliere la effettiva realtà musicale e non meramente sonora di un testo. (da «Disclub», n. 3, dic. 1963, A II, pp. 19-21)
38 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
HECTOR BERLIOZ, AROLDO IN ITALIA 1
“Il genio non si misura con la canna da merciaio”, disse Schumann recensendo la Sinfonia Fantastica e quasi profetando il destino critico di H. Berlioz, forse uno dei musicisti più problematici e discussi di quel grande secolo che fu l’Ottocento. Le sue azioni sono infatti tutte un investimento assai poco sicuro nella borsa dei valori musicali, essendoci ancora oggi, accanto ai detrattori più pervicaci, chi lo fa oggetto di un culto troppo fervido ed un tantino esclusivo. Nella tradizione della musica francese, in quella année di musicisti misurati, “classici”, che da Lully a Rameau attraverso i petit - maîtres del primo Ottocento arriva ai sommessi, discretissimi Fauré e Debussy e infine all’introverso e supremamente elegante Ravel, solo Berlioz e in modo e in misura assai diversi Bizet, figurano come due macchie di colore sgargiante, due personalità scomode. È stato in un certo modo facile catalogare e archiviare Bizet (fraintendendolo in parte) come un antesignano della scuola realista o verista e proprio il rilancio spoletino della Carmen sembrò avere un sottinteso del genere. Il successo popolare dell’opera ha certo contribuito alla sistemazione del fenomeno in un preciso capitolo della storia della musica ed è curioso che oggi il rivoluzionario Bizet agli occhi di certi raffinati appaia come una specie di Puccini magari anche più volgare. Le grida di Carmen suonano ad orecchie distratte molto simili alle appassionate apostrofi di Tosca. Per Berlioz le sistemazione è assai più difficile. Fu il musicista uno sfrenato romantico tutto intento, come un secondo Hugo, ad esibire il suo io in una confusione perenne fra vita ed arte? O fu invece un genio anticipatore, un esploratore impavido di nuovi mondi sonori? Fu solo un grosso talento un maestro dell’orchestrazione? Fu solo un grande intellettuale lucidissimo e velleitario e non un musicista autentico? Se diamo una rapida occhiata alle principali fra le sue opere o almeno a quelle per cui più spesso lo si ricorda e lo si onora nelle sale da 1
HECTOR BERLIOZ, Aroldo in Italia, o.p. 16. Menhuin (viola). Orchestra Philharmonia di Londra diretta da Colin Davis. Voce del Padrone QALP 10370.
39 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
concerto e nei teatri d’opera, ci colpiscono singolari ambiguità, per così dire, d’ordine tutto esteriore. L’ambiguità fondamentale resta sempre quella della mancanza di limiti ben definiti tra vita e musica. La Dannazione di Faust è opera o oratorio, o un oratorio travestito? Invero, la si esegue ancora oggi con la scena o senza. I Troiani sono due opere tradizionali unite dalla continuità dell’argomento e dalle presenza degli stessi personaggi o una specie di Tetralogia francese, un ampio affresco genialmente articolato che volle essere risposta del genio francese alla massiccia offensiva wagneriana che andava conquistando la Francia prima di ogni altra nazione d’Europa? Ancora oggi, nelle rare riprese, I Troiani vengono presentati in una edizione sempre ridotta con tagli abbondanti. Non è ancora ben chiaro come si debba affrontarli e in sostanza si finisce per ricavare dalla imponente partitura un’opera di taglio tradizionale. Quanto alle così dette sinfonie, Roméo et Juliette, La Fantastica e Aroldo in Italia, (di cui la Voce del Padrone presenta ora una validissima edizione che si avvale dell’apporto prestigioso di un Menuhin in veste di solista concertante e protagonista indiscusso), come si può arrivare ad intenderne il senso se non dimenticando completamente il significato consacrato della parola “sinfonia” in terra germanica? Se si parte dall’idea di forma sonata (pianta che per altro in Francia non sembra aver mai trovato un terreno troppo favorevole a rigogliosi sviluppi) non è possibile render giustizia alle tre composizioni che a Berlioz piacque definire Sinfonie. Roméo et Juliette col coro così mosso e i solisti un po’ melodrammatici è un altro oratorio travestito (Sinfonia drammatica specificherà lo stesso Berlioz); la Fantastica è una sapiente scelta di pagine dal diario di un artista febbrilmente vergate dalla penna di un romantico contemporaneo del primo Hugo. L’Aroldo in Italia è infine un vero Vorbild di poema sinfonico alla Strauss. Come il Maestro bavarese, Berlioz esibisce sfacciatamente il suo programma, non cela le sue fonti di ispirazione, gioca a carte scoperte a corre tutte le alee. Il descrittivismo è da lui accettato con tutti i suoi rischi, e si mescola impudicamente all’autobiografismo. Aroldo è Berlioz in persona alla scoperta, come del resto farà Mendelssohn in quegli anni, di una sua vagheggiata Italia un po’ letteraria e approssimativa, coi suoi briganti e i suoi pellegrini. E come nei poemi straussiani certi personaggi sono riconoscibili non solo attraverso il gesto orchestrale ma al timbro della voce (Don Chisciotte e Sancio, violoncello e viola) anche nell’Aroldo in Italia il protagonista si impone come strumento solista: la viola. Il filo del di-
40 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
scorso, il nesso che lega i quattro movimenti è extra-musicale, letterario. Siamo agli antipodi delle musica così detta “pura”. Una commistione di generi, (sinfonismo-oratorio-melodramma) che può trarre la sua giustificazione dalle fatale prefazione al Cromwell (1827). Siamo in certo qual modo fuori dalla clarté, dal genio francese, dall’estetica del depurato Grand Siècle. E Berlioz sembra farsi anche beffa allegramente e con forte anticipo di tutte le asettiche e schifiltosissime pseudo-estetiche novecentesche che dovranno vedere in lui, nell’artista irrimediabilmente “volgare”, solo il coté bête della generosa creazione priva di scrupoli inibitori. Berlioz poco conobbe e certo usò di rado il fren dell’ arte ma è da dire che se non sappiamo quanto resisteranno al tempo le sinfonie, poniamo, di un Honegger, è invece ben certo che le tre sinfonie del vulcanico ammiratore di Harriet Simpson si ascoltano ancora con vivo interesse e c’è chi legge in esse parole anticipatrici. È anche indiscutibile che nella storia della civiltà francese le prime di Hernani (1830) come le prima esecuzione della Sinfonia Fantastica (1832) segnano due date il cui significato non può davvero essere sminuito da brillanti paradossi alla Cocteau. Per tornare all’Aroldo in Italia (1834), il lavoro fu commissionato a Berlioz da Paganini. Il grande virtuoso voleva un pezzo da concerto con viola solista che gli permettesse di mettere in luce la sua bravura. I primi schizzi dell’opera che prevedeva anche l’impiego di un coro, non piacquero al violinista che si disinteressò al progetto. Berlioz proseguì per suo conto. Sembra che la prima idea dei lavoro fosse quella di rendere un omaggio a Maria Stuarda, Ma in seguito Berlioz collegò all’eroe di Byron questa specie di poema sinfonico concertante in quattro tempi. Quattro pannelli: Aroldo sui monti, Marcia dei Pellegrini, Serenata, Orgia dei Briganti. Nel suo calderone Berlioz versò un po’ di tutto e tra l’altro musica scritta in precedenza per un Rob-Roy, di cui ci resta l’Ouverture; non manca neppure un indiretto omaggio a Beethoven nella marcia dei pellegrini che ricorda lontanamente l’allegretto della Settima e d’altronde, nel finale, le citazioni retrospettive di temi dai tre movimenti precedenti risalgono all’ultimo tempo della Nona come modello. Lo stesso tema di Aroldo è un eco del soggetto principale del primo tempo della Settima. Una partitura così variegata richiede ovviamente un interprete che trovi il giusto equilibrio tra l’abbandono spericolato e il riserbo espressivo. Il magma incandescente dell’ispirazione del Berlioz trovò paradossalmente una sua forma proprio in virtù dell’ammirazione che il musici-
41 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
sta nutrì sempre per l’ideale classico e in particolare per Gluck. L’ideale interprete di Berlioz sarebbe, stranamente, per un recensore americano di questa incisione, chi sapesse contenere il fuoco berlioziano all’altezza del quale si mantenne sempre Sir Thomas Beecham che del maestro francese fu lettore assiduo e interprete entusiasta quanto sorvegliato, tanto da volerlo riproporre anche al pubblico scaligero in uno dei suoi ultimi concerti in Italia nel 1952. Non sapremmo mai con sicurezza se Colin Davis possa esser oggi considerato un degno successore del bizzarro e geniale Thomas. È certo un direttore con le carte in regola, un interprete immediato e convinto della partitura. Si noti l’ultimo tempo (Orgia dei briganti) che è il più rischioso, per chi voglia evitare cedute nel “volgare”. In questo caso il vero grande e solo interprete dell’Aroldo in Italia ci sembra Yehudi Menuhin che veramente dà l’impressione di avere imposto una linea ed una misura all’arco del lavoro berlioziano oltre ad aver intonato la voce calda e appassionata, schiettamente romantica, della sua viola. Menuhin appartiene a quella esigua schiera di solisti puri virtuosi, i quali come Serkin e Casals oggi, Busch negli anni passati, hanno allargato la sfere dei loro interessi e il campo dell’attività pratica, divenendo prima animatori di quartetti o piccoli complessi orchestrali e trasformandosi infine in geniali organizzatori di loro eletti festival musicali. Infatti, nella pletora dei festival rumorosi e mondani spiccano oggi quelli di Marlboro e di Prades, dei quali ci giunge l’eco anche attraverso le incisioni. In anni recenti si è aggiunto ad essi il festival di Bath, che ha fatto della neoclassica città termale una rivale temibile di Glyndebourne e di Edimburgo. Animatore di esso è Menuhin, musicista completo al quale vorremmo ascrivere gran parte del merito di questa riuscita esemplare nel campo della folta discografia berlioziana. Per convincersi della statura dell’interprete si ascoltino nel punto centrale Marcia dei pellegrini, gli arpeggi della viola che inghirlandano il corale intonato dai fiati. E si senta anche la viola dialogare con l’orchestra nell’introduzione all’ultimo movimento, controllato con polso fermissimo dal giovane Davis, che attendiamo ad altre prove. A chiusura di questa recensione, non si può non ricordare come il disco regge vittoriosamente il confronto con la versione Beecham-Primrose del 1952. Del direttore si è già detto, di Menuhin aggiungeremo che brillantemente esce dall’arduo paragone col più grande violista vivente. L’incisione e lo stampaggio sono perfetti e l’ambientazione è felicissima. (da «Disclub», n. 4, genn. 1964, a. II, pp. 22-24)
42 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
TOSCANINI E WAGNER 1
Sull’arte direzionale e sulle eccelse facoltà d’interprete di Arturo Toscanini è stato detto di tutto. Un umile cronista è quindi fortemente tentato di rifugiarsi nella retorica celebrativa, deplorevole sempre, ma particolarmente condannabile e offensiva se esercitata ai danni di un uomo che fu personificazione stessa dell’anti-retorica. E non si allude con questo solo alla modestia ammirevole dell’uomo privato, della quale ricordiamo un significativo esempio. “Io non sono che un onesto musicista” egli disse, interrompendo un discorso laudativo di Adrian Boult che lo presentava all’Orchestra della BBC, con la quale Toscanini iniziava le prove di un concerto a Londra nel 1935. Nel dire che Toscanini fu antiretorico o come lui stesso si definì “onesto” si vuol proprio sottolineare quella che fu la caratteristica principe del suo operare. Il senso della sua lezione altissima si riassume in poche parole: onestà e umiltà di fronte al testo da interpretare, chiarezza di lettura e ossequio scrupoloso alle intenzioni espresse dall’autore. “Tutto” il testo e “niente altro”che il testo. Una intuizione sempre sicura della pagina nella sua totalità e una calibratura puntigliosa dei minimi particolari. Questo il miracolo operato da Toscanini. Sulle caratteristiche di questo modo di far musica esiste ormai una vasta letteratura nella quale è facile orientarsi trascurando le interessate celebrazioni nazionalistiche del mito toscaniniano e puntando su testi più equilibrati e critici come il pregevole Toscanini and the Art of Orchestra Performance di Robert C. Marsh (Londra 1956) da integrare con l’agile volumetto del critico musicale ameri1
Toscanini e Wagner. Sigfrido: Mormorio della foresta LA WALKIRIA: Cavalcata delle Walkirie, Atto I, scena III. Il Crepuscolo degli dei: Marcia funebre di Sigfrido - Olocausto di Brunilde - L’alba, Brunilde e Sigfrido, Viaggio di Sigfrido sul Reno - I maestri cantori: Preludio Atto I - Preludio Atto III - Lohengrin: Preludio Atto I - Preludio Atto IV - PARSIFAL: Preludio - Incantesimo del Venerdì Santo – Tristano e Isotta: Preludio e Morte di Isotta - Faust: Ouverture – Idillio di Sigfrido. NBC Symphony Orchestra diretta da Arturo Toscanini. Helen Traubel (soprano), Lauritz Melchior (tenore). RCA VICTOR LM 64001 (4).
43 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
cano B. H. Haggin, Conversation with Toscanini (New York1959), assai denso di osservazioni acute sull’arte e la tecnica direttoriale del Maestro e frutto di una assiduità costante alle prove di molti suoi concerti in America e in Europa a partire dal 1942. Non mancano nella pubblicistica inglese e americana i rilievi limitativi se non negativi e la coscienza ben chiara di certi confini della sensibilità dell’interprete che parve singolarmente sordo a certe correnti tutto sommato secondarie del gusto musicale a lui contemporaneo. Ma questo processo demistificatorio ci sembra proprio l’omaggio più alto e più serio all’uomo cui dovette sommamente dispiacere il tentativo di trasformarlo in un mito. “Io non sono un grand’uomo” ebbe a dichiarare allo Haggin in una conversazione un po’ maligna nei confronti dell’estroso Kussevitzky, il quale si prendeva libertà eccessive nel dirigere Mozart, autore sul quale Toscanini ebbe sempre idee fermissime e più volte ribadite anche in polemica con celebrati maestri tedeschi ed austriaci. “Non le piaceranno i miei tempi nel Flauto Magico” disse a Bruno Walter nel 1937 a Salisburgo. La posizione di Toscanini nei confronti di una certa maniera di sentire e dirigere le musiche di Mozart, di Beethoven, di Schubert, di Wagner sarà eternamente oggetto di discussione, dato che il suo approach ai quattro grandi musicisti, pietre di paragone delle capacità di ogni grande direttore e parte preziosissima del patrimonio spirituale di ogni persona civile, fu certo personale e puntiglioso anche se trovò il suo più valido titolo di legittimità nell’osservanza sempre scrupolosa del testo. E la preferenza che ognuno accorderà alle letture dei classici tedeschi di un Toscanini rispetto a quella di un Furtwängler resterà sempre ed in ultima analisi una questione di gusto, di inclinazione individuale dell’ascoltatore. Nel caso di Wagner il problema si fa anche più complesso, intervenendo il fattore del suono dell’orchestra wagneriana. Le grandi orchestre tedesche e austriache, se dirette da interpreti dotati di una affinità elettiva, rendono questo Wagner-Klang con la naturalezza di chi parli la propria lingua madre. L’orchestra della N.B.C., strumento impeccabile e compagine mirabilmente forgiata da Toscanini in anni e anni di attività e consuetudine esecutive, dà invece nel suonare Wagner l’impressione di un individuo che parli a perfezione una lingua che non è la sua, padroneggiata magari in tutte le sue sfumature di intonazione ma pur sempre con un lontanissimo ineliminabile accento straniero.
44 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
Con questa osservazione non si vuole affatto sminuire il valore delle interpretazioni che Toscanini ha dato di tutte le opere di Wagner (escluso il Rienzi che non risulta egli abbia mai diretto). Per Wagner, Toscanini ha combattutto strenuamente in Italia all’inizio del secolo una serie di splendide battaglie, imponendo ad un pubblico ancora in parte restio e ciecamente nazionalista i valori eterni di quella musica. Toscanini, validamente affiancato da Guarnieri e da Serafin, ha fatto capire alle platee che fischiavano Wagner e perfino Beethoven in quanto erano tedeschi, negli anni precedenti e successivi al 1914, le ragioni vere ed eterne dell’arte del Maestro di Bayreuth. A chi allora opponeva stoltamente Wagner a Verdi o viceversa, Toscanini rispose sempre: Wagner e Verdi. Fatte le debite proporzioni e intendendo il confronto cum grano salis, una cosi ampia apertura mentale e una così oggettiva immedesimazione in mondi spirituali e sonori antitetici le ritroveremo alla distanza di un cinquantennio solo nel grande Mitropoulos della maturità, che sostenne validamente non solo le ragioni di Berg e di Schoenberg ma anche quelle di Puccini e del Verdi minore dell’Ernani, in esecuzioni ugualmente appassionate. La fervida testimonianza a favore di Wagner resa da Toscanini in quel determinato momento storico e in quel clima spirituale gli valse infine l’onore dell’invito a dirigere a Bayreuth. Quindi, nessun wagneriano, ortodosso o liberale, potrà mai essere abbastanza grato al maestro di Parma per l’intelligenza e la passione che in tutta la sua vita mise al servizio di Wagner, dando, oltre a tutto, ai propri connazionali una lezione memorabile di moralità, di gusto e di buona educazione. L’ouverture dei Maestri Cantori (uno dei brani che con maggior frequenza ricorreva nei suoi programmi) fu l’ultimo pezzo diretto dal Maestro in quella fatale tristissima domenica dell’aprile del 1954 alla Carnegie Hall in cui risultò evidente a lui stesso prima che al pubblico la necessità di abbandonare l’attività direttoriale per sempre. Quest’ultimo concerto era tutto dedicato a Wagner: Preludio del Lohengrin, Mormorio della Foresta, Alba e Viaggio di Sigfrido sul Reno, Ouverture e Baccanale dal Tannhäuser. Congedo significativo e suggello altissimo. Veniamo ora all’album in cui la R.C.A. ci offre riuniti per la prima volta tutti i brani wagneriani diretti da Toscanini dei quali resta una documentazione attraverso incisioni originali (tutte già pubblicate in dischi a 78 giri) e registrazioni di esecuzioni pubbliche negli auditori della N.B.C., autorizzate dal Maestro stesso per la divulgazione.
45 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
Un’occhiata all’opuscolo illustrativo basta per rendersi conto di come solo l’Ouverture del Tannhäuser sia assente ai fini di un panorama completo, e l’inclusione della giovanile Ouverture del Faust è forse un magro risarcimento. Ai più noti brani orchestrali si aggiungono alcune grandi scene dalla Tetralogia: Walchiria, Atto I scena III, Crepuscolo degli Dei, Prologo, Scena II e Finale Atto terzo. il Preludio e Morte di Isotta è presente senza l’intervento della voce. Graditissima è l’incisione dell’Idillio di Sigfrido, unico esempio, come è noto, di un Wagner autore di musica da camera, se cosi può dirsi. La qualità del suono è purtroppo disuguale e a volte tantalizzante, ma considerazioni di questo genere ci sembrano quasi irrilevanti e superflue di fronte al valore altissimo dell’interpretazione, la quale si impone con una luminosa evidenza e una perentorietà tali che non osiamo neppure sottolineare casi singoli di illuminazione geniale del testo per timore di arrecare offesa all’ascoltatore. Ci troviamo veramente di fronte a un tipo di lettura piana e aliena da ogni enfasi, con ogni accento al posto giusto, con ogni ritmo scandito come si richiede, con ogni periodo sicuramente articolato e snodato. Mai una intenzione extra-musicale o pseudo-letteraria; mai uno scadimento nel falso misticismo (Lohengrin e Parsifal) o nella morbosità (Tristano). Tutta musica. Una misura classica, una lezione di sobrietà. Un Wagner senza amplificazioni oratorie che ci appare in tutta la semplicità della sua grandezza, la quale certo non ha bisogno di sottolineature o di aggiunte. Diciamo pure, se si vuole, un Wagner non specificamente tedesco, ma in compenso universale, eternamente umano. E rimandiamo a questo proposito alla presentazione che Franco Soprano ha scritto per l’album illustrativo, della quale si accettano le conclusioni ma non alcune premesse e in particolare l’allusione al “culturalismo pan-europeistico” tedesco al cui carro sarebbero stati legati per molti anni una grossa categoria del pubblico e molti interpreti wagneriani. A conclusione di queste rapide osservazioni e come utile premessa all’ascolto diretto, ci sembra opportuno richiamare infine il limpido e fermo giudizio del critico americano W.J. Turner. Parlando nel 1935 delle esecuzioni toscaniane, egli disse che ascoltare un brano di musica diretto da Toscanini era come leggere una poesia di Keats nitidamente stampata su buona carta ovvero ammirare una fotografia fatta da un provetto fotografo con una macchina perfetta e usando una pellicola eccezionalmente sensibile.
46 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
Vorremmo aggiungere che la perfezione della resa toscaniana è proprio una perfezione “visiva”, se non sembrerà paradossale l’uso di questo aggettivo parlando di musica. Ascoltando sopratutto il Preludio dal I Atto del Lohengrin o il Preludio del Parsifal non si sfugge appunto ad una sensazione di tipo visivo. Visitando ripetutamente un museo è capitato a molte persone di guardare infinite volte un quadro e di credere di conoscerlo in tutti i particolari. Ma ecco che un giorno, in condizioni particolari ideali di luce, si torna a guardarlo riuscendo a prendere la distanza giusta e cioè la sola e definitiva prospettiva che ci permette di leggerlo veramente. Solo allora e per la prima volta lo si vede. Una esperienza di questo genere proviamo ascoltando le due pagine wagneriane cui accennavamo: il senso della unica prospettiva giusta che ci fa per la prima volta vedere i particolari, tutti i particolari bloccati in una luce ferma e definitiva. Il fatto che un simile miracolo fosse preceduto ogni volta da una lotta ostinata contro la materia sonora, contro le deficienze dell’orchestra e contro le infinite limitazioni imposte da necessità pratiche ineliminabili, il fatto che una simile perfezione nascesse dal lavoro artigianale dell’umilissimo e “onesto” Maestro è il segno più autentico della sua schietta grandezza. Nella felice scioltezza della riuscita non avvertiamo mai la minima eco della travagliata preparazione. Il brano musicale sorge davanti a noi come un blocco intatto che ammiriamo e si impone a noi solo con la sua oggettiva presenza. Una volta chiarito questo aspetto per altro evidentissimo delle versioni toscaniane dei brani wagneriani, potremmo cautamente attardarci a stabilire una scala di valori con la coscienza della precarietà di una sistemazione del genere e tenendo conto delle mutevoli e varie disposizioni d’animo di noi ascoltatori. Ad un primo ascolto complessivo, ci è dunque parso lievemente meno partecipe (ma sempre ad un altissimo livello di intensità espressiva) il Toscanini interprete della Tetralogia. Ma a proposito dei brani tratti dal Ring non vogliamo chiudere queste brevi note senza segnalare l’apporto di due cantanti come Lauritz Melchior e Helen Traubel, che qui si trasformano in docili esecutori al servizio di Wagner. La bellezza delle due voci è indiscutibile, anche se non ci sentiremmo per quanto riguarda la Traubel di accostarla, come è stato fatto, a Kirsten Flagstad. Il paragone ci sembra poco meno che blasfemo. Il recupero di questi pochi brani di un Wagner autentico, e cioè non tagliato e rimaneggiato per l’esecuzione in sala da concerto, rende anco-
47 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
ra più amaro il rimpianto per la mancanza di un’incisione di un’opera completa, e sopratutto dei Maestri Cantori o del Parsifal che anche in Germania conquistarono la critica senza riserve. L’ascolto dei quattro dischi, offertici dalla R.C.A., pure esaltandoci e commuovendoci, ci porta a ribadire la nostra convinzione dell’impossibilità di fare un discorso serio su Toscanini e Wagner, non potendo renderci direttamente conto dell’impostazione che il Maestro dava ai tre atti di un dramma e della dialettica che certo doveva istituire fra essi. È un ulteriore aspetto tantalizzante del magnifico album. Come i cospicui frammenti di una tragedia di Euripide, riscoperta in anni recenti, non ci hanno purtroppo restituito il testo, e come i frammenti disseminati fra Londra, Parigi e Atene non ci permettono di godere il Partenone nella sua integrità, questa antologia acuisce in noi il rimpianto nonostante gli splendori che essa ci permette di intravedere. (da «Disclub», n. 5, febbr. - mar. 1964, a. II, pp. 20-23)
48 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
FELIX MENDELSSOHN, ELIJAH 1
L’Italia, come è largamente noto ed autorevolmente si deplora, è il paese più antimusicale del mondo. Nonostante i grandi tenori, i loggionisti di Parma, i mandolini, San Remo e Napoli, o forse proprio a causa di essi in Italia la musica è la Cenerentola nelle scuole. Non può quindi meravigliare il fatto che un festival dedicato all’Espressionismo come il XXVII Maggio Musicale Fiorentino, generoso tentativo di far capire alla gente che qualcosa si è pur mosso ai primi di questo secolo al di fuori della cinta daziaria di Firenze sia stato accolto dalla grande maggioranza del pubblico e, cosa ben più grave da quasi tutti i più qualificati rappresentanti della fauna musicale locale, come un vero e proprio crimine di lesa patria. Questo recente episodio di malcostume civile oltre che di ignoranza non solo è tipico di tutta una situazione, ma fornirebbe utilmente lo spunto a una parabola o ad un apologo critico sulla grama condizione delle cose musicali nel bel paese là dove il sì suona, ridotto oggi ad una morta gora provinciale afflitto dal gracidio di burbanzosi e vacui retori, i quali si ammantano dei cenci di un umanesimo che non ha più senso alcuno. Non ci si stupirà, stando così le cose, se l’oratorio che è un genere musicale nato in Italia come dice il nome, e fu illustrato da un Caldara e da un Alessandro Scarlatti, musicisti ai quali tesero attento orecchio Bach e Haendel, abbia poi vigoreggiato in Germania e in Inghilterra assumendo col passare dei secoli fisionomia specificamente protestante e sia oggigiorno al di qua delle Alpi un rarissimo genere di importazione e come tale avvicinabile e fruibile solo attraverso rare esecuzioni soprattutto radiofoniche o per mezzo del disco. Chi voglia coltivare questo fertilissimo settore della storia della musica e non si accontenti di aspettare ogni anno il settembre e prendere il treno per Perugia (almeno finché i valorosi organizzatori della Sagra 1
FELIX MENDELSSOHN, Elijah o.p. 70. Jacqueline Delman (s), Norma Procker (c), Gorge Maran (br), Michael Cunningham (ragazzo – soprano) - London Philharmonic Choir diretto da F. Jacksn - London Philharmonic Orchestra diretta da Josef Krips. DECCA ACL 220/222 (SERIE ACE OF CLUBS).
49 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
Umbra resisteranno nella loro disperatissima lotta contro gli scarsi finanziamenti e l’indifferenza locale e romana) dovrà consultare attentamente i cataloghi delle case discografiche e potrà allora colmare molte gravi lacune, sempre che abbia anche il coraggio di sfidare le ire dei soloni della critica per i quali dischi ed analfabetismo musicale sono sinonimi. Noi non dubitiamo, anzi siamo sicurissimi, che tutti i nostri illustri critici possiedano perfettamente a memoria la partitura dell’Elia di Mendelssohn, anzi abbiamo la certezza morale che se lo vanno fischiettando per la strada tutti i giorni, ma da poveri dilettanti e ignoranti quali siamo non possiamo non plaudire all’iniziativa della Decca, che nella collana Ace of Clubs, ad un prezzo accessibilissimo, ci mette a disposizione proprio quel raro oratorio che Mendelssohn scrisse per la città di Birmingham e nella quale fu eseguito il 25 agosto 1846. Resta per noi un piccolo e affascinante mistero para-musicologico il fascino che il grande profeta solare evidentemente dovette esercitare su quella squallida cittadina industriale (una specie di Campobasso su grande scala) se i suoi musicalissimi abitanti sentirono il bisogno di commissionare nove anni dopo un altro Elia al celebre direttore e compositore Michele Costa. È un inquietante quesito che giriamo al primo solerte critico di tendenza logica post-adorniana, non riuscendo con i nostri deboli lumi a cogliere il rapporto dialettico tra la produzione di forbici e coltellerie e il fiero nemico di Jezebel di Achab. Ci limiteremo pertanto a registrare obbiettivamente il fatto che in una modesta cittadina inglese (e non a Londra o a Dublino) fu allestita la prima esecuzione di questo Elia, con cui l’apollineo Mendelssohn, musicista viziato dalla fortuna, colmato di doni aurei dalle Grazie più di quanto non fosse squassato dal soffio terribile delle Furie, gran signore e supremo dilettante della musica, si accostò per la seconda volta alle Sacre Scritture, dopo aver composto nel 1836 un Paulus, che è arrivato in Italia solo nel 1953 . E non si può a questo punto non lodare Gianandrea Gavazzeni per la sua recente ripresa (Aprile, 1964) di questo oratorio in un concerto romano che ha avuto accoglienze lietissime di pubblico e di critica. Ma per tornare a Elia o meglio a Elijah (che suona incredibilmente Ilaigia), ad un primo ascolto ci pare che esso si inserisca in uno dei due filoni nei quali il genere dell’oratorio si biforca. Su un versante del Sacro monte troviamo Schütz, Bach e Brahms, tutti chiusi nella loro severa corazza polifonica e austeramente ripiegati nella meditazione fervida in un intimo lirismo che fiorisce, specie nella arie di Bach, in esempi definitivi e riuscite altissime. Questo filone scor-
50 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
re sotterraneo e ci sembra riconoscerlo solo due secoli dopo nella sovrumana e spoglia grandezza delle due postreme cantate di Webern o nell’affresco di Moses und Aron. La seconda e più produttiva tendenza prende le mosse dalle gioiose ed estroverse creazioni del musico di Halle ed ha come carattere più evidente il giubilo alleluiatico e la piacevolezza illustrativa. Siamo qui alla Bibbia per i poveri (non c’erano ancora i Fratelli Fabbri), alla divulgazione del verbo sacro in grandi affreschi coloriti e mossi, nei quali tace ormai la voce severa dello storico e scompaiono le pause di fervore religioso dei corali nei quali la Gemeinde si univa agli esecutori, entrando attivamente nel gioco. Il diavolo del teatro fa capolino ad ogni istante a sommo dispetto del Lord Ciambellano che in Inghilterra vegliava geloso affinché non si trascinassero sulle tavole polverose i sacri argomenti. Da Haendel prendono le mosse Haydn con i suoi due oratori così moralistici e biedermeier ante litteram, il Berlioz dell’Infanzia di Cristo e tutta la fioritura dell’oratorio inglese fino ai Sullivan di The Prodigal Song e all’Elgar di The apostles. È un genere narrativo e piacevole in cui al momento giusto si inserisce Mendelssohn con il suo Elijah che può a buon diritto considerarsi cittadino inglese, come The Seasons o il Messia. Si accennava sopra al dilettantismo di Mendelssohn e sarà bene chiarire che il termine è da intendere in una particolare accezione. È infatti noto come il ricco amburghese fosse un musicista fin troppo esperto ed astuto, grande direttore d’orchestra e fine musicologo. A lui si deve il recupero della Matthäus Passion nel 1829 e basterebbe questo a garantirgli la gratitudine dei posteri. Se si può parlare di un dilettantismo di Mendelssohn, noi lo vediamo piuttosto in quella sua eterna e un po’ sospetta felicità inventiva cosi priva di sottofondi inquietanti, in quell’essere sempre disposto a tutte le occasioni. Schumann lo esaltò novello Mozart, me si tratta purtroppo di un Mozart senza il demonismo del Don Giovanni e senza l’orrido della Sinfonia in Sol Minore. È un musicista che ammiriamo e ascoltiamo volentieri, ma che non riusciamo ad amare, in quanto non ci propone mai interrogativi inquietanti. La sua imperturbabile olimpicità di agiato petit-maître può a volte irritarci. Orbene questi caratteri non sono certo contraddetti da Elia; solo che in questo lavoro, nonostante le consueta lucentezza dell’involucro e la eleganza della confezione, ci pare avvertire un maggiore e più profondo e più sostanziale impegno umano del compositore. Le prima delle due parti in cui l’oratorio si divide è la più conven-
51 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
zionale e specie nella grande ed abilmente impostata Scena della sfida di Elia ai sacerdoti di Baal, preceduta dal drammatico scontro con Achab, il modello haendeliano (e sopratutto del Belshazzar) traspare continuamente. Le suggestioni gestuali e teatrali sono continue sopratutto nelle condotte delle voci. Non stupisce che Elia fu rappresentato nel 1923 a Worchester, come dramma musicale, a cura di Charles Manner. Un grande pezzo di teatro è la scena dell’invocazione del popolo per la pioggia, con la voce dei fanciulli solisti, che si staglia sullo sfondo del coro. All’inizio della seconda parte la figura della Regina Jezebel ci mantiene in un clima che con tutte le cautele definiremmo sempre un po’ melodrammatico. Il motivo della Regina proterva adoratrice di Baal e persecutrice di Israele doveva affascinare Mendelsshon che qualche anno dopo scriverà delle musiche di scena per Athalie. Ma al momento in cui il profeta solo si rifugia sulla vetta del monte Horeb per sfuggire alla furia di Jezebel, l’ispirazione del musicista prende veramente aria e tutta l’ultima parte dell’oratorio è una grande meditazione sulla solitudine dell’uomo di fronte ai problemi massimi. Elia subito non è solo. Lo circondano e lo confortano gli angeli (si ascoltino il trio e il coro stupendi all’inizio della quinta facciata) e la Stimmung di questo finale che è unicum nella storia dell’oratorio è quella di una serena accettazione del destino, premiata dal Dio di Israele con la vittoria definitiva sugli infedeli. Abbiamo brevemente sottolineato le tre grandi scene in cui si articola il testo (Elia e i sacerdoti di Baal, Elia e la Regina, Elia sul monte Horeb) ma non si può dimenticare il breve episodio iniziale della vedova a cui il profeta fa resuscitare il figlio, piccola scena intima o quartetto di genere in cui splende il timbro lucente del soprano Jacqueline Delman, interprete appassionata e rigorosa. Quanto agli altri interpreti non si saprebbe immaginarne di più immedesimati e fervidi. È questa una edizione autentica e di puro stile che molto deve alla bacchetta sensibile di Joseph Krips e all’apporto dei due cori, dei quali si segnala in modo particolare lo stupefacente coro dei ragazzi della chiesa parrocchiale di Hampstead che sotto la guida di Martingale Sidwell non fanno rimpiangere i piccoli cantori viennesi, per lo smalto delle voci e la limpidezza della emissione. Una lode particolarissima va al tenore George Maran che nella sua prima aria If with all your hearts you seek me, centra un tono di dolce intimità che ritroviamo con uguale eleganza e rigorosa calibratura nella deliziosa romanza dei tenori di Sullivan. E non sembri irriverente l’accostamento. La contralto Norma Procker piega una voce caldissima alle sfumature di un’interpretazione che per la tenu-
52 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
ta e il livello ricorda la grande Ferrier. Quanto al protagonista, il baritono Bruce Boyce, dotato di voce gradevole e di bello squillo, si cala perfettamente in un personaggio ricchissimo di sfumature psicologiche che vanno dall’ironia e dallo scherno nel dibattito coi sacerdoti di Baal al fervore dell’aria con viola obbligata It is enough, o Lord, nel classico schema tripartito (ABA). Essa è il vero culmine dello spartito e non sfigurerebbe al confronto con le più celebrate pagine di Giovanni Sebastiano. Tornando alla fisionomia individualissima dell’opera, della quale non ci si stancherebbe mai di illustrare la singolarità, vorremmo segnalare il carattere prevalentemente intimistico, quasi di oratorio da camera. Infatti Mendelsshon non mira qui ad effetti di grandiosità nei cori o di forte spicco nelle arie. Il suo oratorio è una serie di gemme amorosamente sfaccettate dalla sapiente mano di un prezioso orefice dei suoni, la cui misura è veramente mozartiana. Non c’è la voce dello storico a guidarci nei meandri dell’azione ma entriamo subito e agevolmente in medias res dopo una brevissima introduzione di Elia, seguita da una ouverture. Le arie sono relativamente poche e tendono a confondersi con gli stupendi ariosi (nei quali sono alcune delle più alate riuscite dello spartito) in un tono medio elegiaco ed auletico. Accompagnano caldi gli archi e parsimoniosamente cantano gli strumentini. I tratti descrittivi di marca haendeliana (si pensi alla descrizione delle piaghe nella prima parte di Israele in Egitto) sono relativamente pochi ma discretissimi. Sarà azzardata l’ipotesi di un influsso diretto di questo oratorio su l’Enfance du Christ di Berlioz (1854)? Comunque ci pare indubbio che questi due piccoli capolavori del romanticismo minore siano molto vicini come atmosfera e ne suggeriremmo un ascolto comparativo. Nel ringraziare nuovamente la Decca per la sua iniziativa deploriamo la mancanza assoluta di dati storici e di note illustrative,anche se siamo grati per il testo integrale dell’oratorio, che certo non è facile da reperire. L’incisione è buona anche se i cori non hanno un particolare rilievo. (da «Disclub», n. 9, luglio 1964, a. II, pp. 31-33)
53 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
ANCORA A PROPOSITO DI MAHLER 1
Il saggio di Umberto Eco, Apocalittici e integrati, così penetrante e provocatorio, potrebbe suggerire addirittura un’applicazione delle due categorie cui allude il titolo, ovvero di quei due “concetti generici e polemici”, come l’autore li definisce, alla personalità e all’opera di Gustav Mahler. Cedendo a questa tentazione e usando i due termini in un senso ancor più largo sembrerebbe ovvio definire subito Mahler come l’Apocalittico per eccellenza e non solo per quella “estrema testimonianza in termini di Apocalissi” da lui intonata nella IX Sinfonia e nel Canto della Terra (due grandi meditazioni sui beni terrestri irrimediabilmente perduti) ma per tutto il suo atteggiamento umano, il suo superominismo e il suo modus operandi di artista contro-corrente, inattuale e intempestivo, solitario e fondamentalmente incompreso dai contemporanei. La sua musica verrà subito bollata e respinta. Si ripeterà l’accusa di kepellemeister musik, come se un grande direttore d’orchestra non potesse essere anche un genio creatore (troppo facile sarebbe fare il nome di Richard Wagner). Apocalittico, dunque, il Mahler più appariscente, il costruttore caparbio delle grandi cattedrali sinfoniche dalle vaste navate dalle poderose strutture portanti. Ma anche il più superficiale e frettoloso visitatore di quelle cattedrali coglierà ben presto sotto le loro volte non solo gli echi dei corali bruckneriani (II e V Sinfonia) ma più spesso, e saranno insistenti, gli accordi di violini da musicanti di strada (il Fiedel della IV Sinfonia), i ritornelli delle canzoni popolari (I, III e IV Sinfonia) le volute un po’ Liberty del Ländler viennese (I e IX Sinfonia). È come se, per assurdo, dopo avere ascoltato un coro di frati salmodiare in una cappella di un grande duomo gotico ci trovassimo nella cappella accanto, di fronte ad un’orchestrina tzigana o ad un coretto di monelli irriverenti. L’effetto di shock che provoca ancor oggi l’ascolto di una sinfonia di Mahler (se si esclude l’VIII che è in realtà un grande oratorio in due 1
GUSTAV MAHLER, Kindertotenlieder - Rückert-Lieder. Dietrich Fischer-Dieskau (br) - Orchestra Filarmonica di Berlino - Direttore Karl Böhm. Deutsche Grammophone Gesellschaft LPM 18879.
54 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
pannelli) è una reazione di questo genere. Non sarà lecito allora di fronte a questa scandalosa immissione della musica leggera (il cosiddetto volgare in Mahler) nella austera struttura della sinfonia, cominciare a parlare anche di un Mahler integrato che con violenza radicale (giacobina è stato detto) prende quasi in blocco dei pezzi di musica da consumo e li inserisce, greggi o appena stilizzati in una forma pur sempre nobile ed elevata quale era la sinfonia, come la tradizione e Bruckner suo maestro gliela aveva consegnata? Per rendersi conto della novità e della portata assolutamente rivoluzionaria di questo procedimento, basterà riascoltare gli Scherzi di Bruckner nei quali l’ispirazione popolaresca è risentita ma la stilizzazione è assoluta, la folkmusic è reinventata.2 E, subito dopo, ascoltare quel passo del I movimento della III Sinfonia di Mahler in cui la grande orchestra romantica tronca bruscamente il suo discorso ed irrompe un rullo di tamburi, il quale è talmente tolto di peso dalla realtà bruta che l’effetto è letteralmente quello di una finestra spalancata ad un tratto nella sala da concerto lasciando penetrare un rumore esterno. L’ascoltatore è sottoposto ad un effetto di shock brutale, come potrebbe essere quello di una sirena di officina che si sovrapponesse al canto degli archi nell’Adagio della IX beethoveniana. Se vogliamo scegliere un terzo esempio, per chiarire il discorso, si ascolti ancora la marcetta militare del Wozzeck (I atto, scena III) e sarà subito evidente come tutta la volgarità e il kitsch di quella musica militare siano reinventate e stilizzate da Berg. Nessuna banda potrebbe mai suonare quella marcia, mentre qualsiasi magari modesto complesso di paese potrebbe forse eseguire le marce di cui Mahler costella le sue sinfonie (V e VII). Mahler potrebbe dunque apparirci come l’artista volta a volta apocalittico ed integrato e non sarebbe questa l’ultima delle ambiguità e delle aporie della sua personalità, che la critica più recente va ampiamente segnalando. La inserzione della voce nella sinfonia mahleriana è valore assai diverso da quello che poté assumere un procedimento analogo nel grande finale della IX beethoveniana. Se è innegabile che l’esempio del Maestro di Bonn servì di avvio a Mahler e lo autorizzò con tutto il peso d’un precedente illustre. ci sembra troppo evidente che i risultati mahleriani derivano da impostazione spirituale quasi antitetica. Si pensi, sempre per assurdo, ad un Beethoven che interrompa il discorso com2
Osservazioni analoghe si potrebbero fare per certo Haydn e certo Schubert “ungheresi”.
55 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
patto e coerentissimo (settecentesco. essenzialmente) di una delle sue prime sinfonie, o magari anche della VII o dell’VIII, con un episodio vocale che sfrutti uno dei suoi Lieder popolari, scozzesi o irlandesi. È esattamente quello che farà Mahler nell’intessere il tema del ciclo giovanile Lieder des Fahrenden Gesellen nella sua I sinfonia, o quando trasferirà di peso nella sua II (Urlicht), III (Es sungen drei Engel), IV (Das himmlische Leben) dei Lieder composti in precedenza. Non solo, ma anche quando la voce non è presente, lo spirito del Lied permea il discorso sinfonico e sono allora le grandi riuscite del III tempo della II sinfonia e dell’Adagietto della V, due grandi Lieder per orchestra sola. Sarà azzardato affermare che l’immissione del Lied popolaresco, come l’uso della musica kitsch da parte di Mahler rispondano ad una esigenza di desecrazione della sinfonia? Sembra di avvertire nella sua musica una volontà rivoluzionaria di democratizzare la forma-sonata austrogermanica, il prodotto più alto di una civiltà che Mahler dovette sentire fino ad un certo punto, se non proprio estranea, perlomeno come una cittadella da espugnare non solo prendendola d’assalto ma anche minandola dall’interno. È forse per questa loro funzione di reagente che i Lieder di Mahler ci persuadono molto meno, isolati. Ci sembra infatti che essi trovino la loro vera destinazione solo nel corpo vivo delle sinfonie, come se il Maestro volesse farsi la mano a comporne alcuni cicli ma solo come un esercizio di stile, a volte un po’ accademico. Il suo Lied isolato dà un po’ sempre l’impressione (anche se non manchino le riuscite) di una pianta sradicata in attesa del suo humus che è quello della sinfonia, dove lo riudremo e lo sentiremo vigoreggiare ed espandersi con tutto il necessario respiro. È un fenomeno di acclimatazione spontanea. Solo in quel dato contesto la canzone prende il suo senso definitivo. Non sapremmo quindi dichiararci propriamente entusiasti di nessuna raccolta di Lieder mahleriani (se si eccettua il Canto della Terra che, in effetti, è una sinfonia con voci e comunque un grande discorso unitario su di un tema capitale: la Morte) e ancor più tiepidi estimatori dobbiamo confessarci di quelle raccolte per i testi delle quali Mahler ha attinto a Friedrich Rückert, poeta non precisamente alato, che oscilla spesso tra l’accademico e il larmoyant. Sono molto noti i 5 Kintertotenlieder (Canti dei Bambini Morti) composti fra il 1901 e il 1904, e i 5 Rückert Lieder, i quali risalgono agli stessi anni che vedranno anche la nascita delle Sinfonie V e VI. A riprova di quanto si affermava sopra, troviamo l’ultimo dei Rückert Lieder, composto nell’estate del 1901, trasferito nella V sinfonia, ma completamente rifuso e trasforma-
56 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
to nell’Adagietto per archi ed arpa ed è istintivo rilevare come quella che è in origine quasi una romanza da salotto un po’ dolciastra si trasforma in un doloroso e contratto canto di dolore, pervaso nella parte centrale da spasimi quasi tristaniani. Nessuno dei due cicli presenta, invece, in sé e per sé, un grande interesse e la lacrimosità un po’ di maniera dei Kindertotenlieder sembra fatta apposta per fornire munizioni ai nemici di Mahler. Per un’antologia ideale sceglieremo solo il primo e l’ultimo dei Kindertotenlieder e il terzo Lied del secondo ciclo. E dobbiamo subito dire che la versione che Dietrich Fischer-Dieskau ci offre ora per la DGG non è purtroppo tale da farci passar sopra alle obiezioni di fondo. Non ci azzarderemo certo a parlare, sulle basi dell’ascolto di una sola incisione, della decadenza di un grande artista quale Fischer Dieskau è stato e vogliamo sperare sia ancora. Sarà doveroso premettere che Karl Böhm, con una direzione quasi soporifera e una notevolmente scarsa affinità mahleriana fa di tutto per raggelare il cantante, ma chi ricordi la precedente interpretazione che il baritono tedesco, nel 1957, aveva dato dei Kindertotenlieder, con la direzione di Rudolf Kempe e la stessa orchestra, stenterà a riconoscerlo in questa più recente incisione. Torniamo a ripetere che sarebbe forse troppo avventato il parlare di deficienze vocali, sulla base di un ascolto non diretto, ma ci sembra comunque che l’interpretazione stessa dei testi sia qui più sfocata, meno intensa e partecipe. Il cantante è qui meno immedesimato e si sorveglia al punto da suonare a volte quasi indifferente. Non è poi da escludere che una diversa posizione dei microfoni abbia accentuato il senso di lontananza della voce che, d’altronde, era forse, nell’incisione precedente, un po’ troppo in primo piano come spesso avviene nelle incisioni della RCA. Resta infine inesplicabile l’esclusione del Lied Liebst du um Schönheit, che completerebbe il disco e, d’altronde, essendo assai breve avrebbe potuto benissimo esservi incluso. Una incisione, questa, che non ci sentiremmo di consigliare né ai mahleriani per la incertezza e la discutibilità dei risultati interpretativi, né ai non mahleriani per la incompletezza testuale. (da «Disclub», n. 11, ott.-nov. 1964, a. II, pp. 16-18)
57 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
MAHLER DIRETTORE
Così il Critico Ludwig Speidel (1830-1906) descrisse Gustav Mahler, per la prima volta sul podio dell’Opera di Vienna. in un articolo pubblicato sul «Fremdenblatt» il 12 maggio 1897: “Ieri sera la ripresa del Lohengrin nell’allestimento dalla stagione in corso ha presentato un motivo di particolare interesse per la presenza sul podio di Gustav Mahler, che per la prima volta abbiamo visto dirigere a Vienna. Il signor Mahler è basso, snello ma tutto fuoco. È un uomo dal viso intelligente con i lineamenti fortemente incisi. Tale l’aspetto, tale il direttore. Vigoroso e sottilissimo interprete, sensibile ad ogni sfumatura. Egli appartiene alla giovane scuola direttoriale che, in polemica con gli atteggiamenti statuari dei vecchi Kapellmeister, si avvale di un gesto più vivace. Questi giovani parlano con le braccia e con le mani, con tutta la persona, se è necessario: il legno secco della bacchetta in mano a loro rinverdisce. Con tali mezzi esteriori, che usati da lui apparvero del tutto spiritualizzati, il signor Mahler diresse il Lohengrin. Si immedesimò mirabilmente nell’atmosfera sognante del Preludio quasi abbandonandovisi, ma arrivato al climax del brano in cui intervengono gli strumenti a fiato con tutta la loro potenza, con rapidissima metamorfosi egli sollecitò perentoriamente tutta l’orchestra e dette 58 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
l’attacco ai tromboni brandendo contro di loro la bacchetta, come se fosse stato un fioretto. L’effetto fu magico. Tutta la sua grande arte direttoriale ebbe modo di rivelarsi e dispiegarsi nella concertazione del I atto dell’opera così ricco e drammatico. Il signor Mahler ha impresso il suggello della sua personalità a tutto lo spettacolo. Orchestra, coro, solisti. Tra lui ed essi vi era un rapporto continuo e strettissimo. Il suo cenno di comando non sfuggiva a nessuno. Né è mancato al direttore l’apprezzamento del pubblico. Dopo il Preludio egli è stato costretto a ringraziare più volte mentre clamori sempre più alti salutavano il nuovo arrivato all’Opera di Vienna. Bisogna aggiungere che il signor Mahler non è solo un eccellente direttore ma anche un notevolissimo regista, anzi si può dire che niente gli sfugge di quanto riguarda il funzionamento di un teatro, neppure i segreti dell’amministrazione. Egli è quindi l’uomo che ci vuole data la situazione in cui versa il nostro teatro. Il signor Mahler, se gli si lascerà libertà d’azione, sarà quel lievito artistico di cui l’Opera di Vienna ha bisogno”. (trad. Giulio de Angelis)
(da «Disclub», n. 11, ott.-nov. 1964, a. II, pp. 16-18)
59 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
GEORG FRIEDERICH HAENDEL, SAMSON 1
Nell’agosto del 1742, dopo nove mesi di trionfi in Irlanda, culminati con la prima esecuzione del Messia a Dublino, Haendel tornava a Londra, città da lui amata, nella quale i suoi rivali e nemici del mondo del teatro lo attendevano a piè fermo. Haendel si era impegnato a fondo, come impresario e come compositore in quella guerra dei teatri che aveva imperversato a Londra per anni, ed aveva pagato di persona. Ora il sassone rientrava senza clamore nella sua casa di Brook Street. Non comparve subito in pubblico, non dette concerti. Gli allori dublinesi sembravano non valessero a riconquistare al compositore il favore del pubblico londinese. Ma il rilancio delle sue azioni, lento e sicuro, non doveva tardare. Pope ne aveva di recente esaltata la grandezza nel quarto libro della sua Dunciad e aveva salutato in lui l’uomo che doveva riscattare la musica dalla schiavitù dell’opera italiana. Aveva alluso alla grandiosità dei suoi cori e si era spinto – con un po’ di fantasia – a dichiarare, in una nota al poemetto, che Haendel aveva usato il cannone per aumentare l’effetto di un coro, cosa che il sassone, in realtà, non aveva ancora fatto. Un cannone sarà impiegato solo sei anni dopo, nella Musica per i Fuochi d’Artificio, (1749). L’influenza del Pope, che del resto conosceva personalmente Haendel fin dal 1713,2 fu determinante nel convincere Londra che quel musico tedesco era un genio. “Il gigante Haendel si erge, come l’audace Briareo, con cento mani; egli viene a scuotere, a smuovere, risvegliare l’anima…” (Dunciad, libro IV, vv. 65 e segg.). Secondo Newman Flower, un biografo di Haendel, si deve dunque ad un poeta, il più eletto e tipico rappresentante della letteratura 1
GEORG FRIEDRICH HANDEL, Samson – Oratorio. Jan Peerce, Tenore (Samson); Phyllis Curtin, Soprano (Delilah); Luise Parker, Contralto (Micah); Malcolm Smith, Basso (Harapha); Roy Samuelsen, Baritono. (Manoah); Jean Preston, Soprano (una fanciulla): Kenly Whitelock, Tenore (un messaggero). Utah Symphonie Orchester - Direttore: Maurice Abravanel - University of Utah Symphonic Chorale. Direttore: Newell E. Weight - Organo e Cembalo: Alexander Schneiner. AMADEO-VANGUARD AVRS 6328/29/30. 2 Nel 1720, Alexander Pope adottò Esther di Racine per Haendel che nel 1732 la fece rielaborare da Humphreys. La prima versione fu il Masque Haman and Morderai. La seconda versione (Esther) è il primo oratorio di Haendel.
60 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
inglese del Settecento, se l’apprezzamento della musica del sassone si diffuse e si radicò definitivamente a Londra. Ma la letteratura inglese doveva, sia pure in modo più indiretto, determinare l’indirizzo della nuova carriera londinese del musicista di Halle nella sua prima presa di contatto con il pubblico della capitale dopo il semi-esilio irlandese. Questa presa di contatto avviene, infatti, sotto gli auspici di una delle più alte voci della poesia inglese, John Milton, cui già Haendel si era accostato con l’Allegro e il Pensieroso, nel 1740. Il 18 febbraio 1743 Haendel presentava al Covent Garden l’oratorio Samson, basato sulla tragedia di Milton, che aveva composto nel 1741 prima della partenza per l’Irlanda ed aveva poi arricchito al suo ritorno di un recitativo, di un aria e di un coro finale. Protagonisti non erano più il Senesino o la Faustina e la Cuzzoni – divi litigiosi e capricciosi – ma cantanti di nome assai meno prestigioso: il Beard (Sansone), Mrs Cibber (Micah), Mrs Clive e la signora Avolio che cantò l’aria finale aggiunta Let the bright Seraphim. Tutta la migliore società londinese assisté alla prima che fu un trionfo e il Re stesso volle onorare Haendel della sua presenza alla replica, sanzionando così ufficialmente il successo del musicista. Si ebbero otto riprese in quella stagione e un grosso successo anche di cassetta. Susanna Cibber (sorella del compositore Arne) che era anche attrice drammatica e aveva cantato nel Messia a Dublino, divenne poi l’interprete prediletta e l’amica fedele di Haendel. Un cronista ci riferisce che Giorgio II tornò al palazzo in carrozza canticchiando un motivo del Sansone come se fosse stata l’ultima canzonetta parigina e il Primo Ministro Horace Walpole nelle sue Memorie registra un suo giudizio restrittivo sul protagonista che, secondo lui, disponeva di una sola nota nella voce e non poteva rivaleggiare con nessuno dei celebri “castrati”. Walpole tuttavia si accorse di un fatto essenziale e cioè che l’oratorio ormai si avviava a sconfiggere definitivamente l’opera italiana in Inghilterra. Il successo del Messia, ripreso a Londra, subito dopo Sansone sarà di ciò una conferma luminosa. Haendel nel musicare il testo di Milton ebbe la fortuna di avvalersi di quella che oggi in linguaggio cinematografico, si chiamerebbe una sceneggiatura di ferro. Il librettista Newburgh Hamilton (al quale il musicista lascerà nel suo testamento solo cento sterline, dimostrandosi così più avaro con lui che non con altri suoi collaboratori, ad esempio il Morell) adattò alla perfezione, forse con l’aiuto dello stesso Haendel, lo schema del dramma miltoniano che ricalcava in forma assai puntigliosa quello di una tragedia greca (intervento del coro, alternarsi di episodi e stasimi,
61 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
epilogo) alle esigenze del genere oratoriale che si era venuto cristallizzando, non meno dell’opera, in una sua forma canonica che prevedeva un certo dosaggio di arie e di duetti e un impiego del coro in funzione di personaggio spesso fortemente caratterizzato. Lo Hamilton gioca abilmente col testo del poeta intervenendovi con mano abbastanza leggera, lasciandolo, dove possibile, intatto o operando suture e giunture abilissime tra verso e verso, sopprimendo la parte del public officer e trasferendone la funzione al personaggio di Harapha, estraendo dall’anonimo coro di ebrei del Milton il personaggio di Micah (il nome è preso dal Libro dei Giudici, 17). Lo spirito dell’arduo testo del Milton è nel complesso rispettato e la padronanza che di esso dovette avere il librettista è attestata da alcuni felicissimi innesti di passi da altre opere dell’autore di Paradise lost che qui vogliamo brevemente segnalare: Atto I, terza aria di Sansone Why does the God of Israel sleep – salmo 81 nella traduzione del Milton; Atto I – Coro Finale – ultimo verso dell’elegia On Time; Atto III – Aria di Sansone, Thus when the sun from his watery bed, dall’Ode on Nativity, strofa 26; Coro Finale della prima versione, Glorious Hero, due brevi citazioni dall’Epitaffio per la Marchesa di Winchester; aria della donna israelita, aggiunta in occasione della prima londinese, Let the bright Seraphim in burning row, i quattro versi sono presi da At a Solemn Music, con lievi modifiche; Atto I, aria di Manoa, ultimi due versi, presi da Ode on the Passion. Con Samson, Haendel non solo riconquista i favori del pubblico londinese ma estende e consolida il suo dominio su un territorio musicale già da lui ampiamente esplorato. Non è qui certo il caso di fare la storia dell’oratorio come genere,3 e di ricordare come Haendel avesse già al suo attivo in questo campo alte riuscite come Saul e Israel in Egypt (ambedue del 1739). Samson appartiene al filone epico-eroico e si avvicina a Saul per la vigorosa energia con cui il musicista profila contro lo sfondo animato e colorito del coro (gli Israeliti che rendono visita al loro eroe, cieco e ridotto in schiavitù) le figure a tutto tondo dell’eroe protagonista, di Dalila, del gigante Harapha, di Micah, di Manoa, padre di Sansone. Ognuna delle singole personalità è felicemente illuminata nelle arie e nei recitativi: Sansone con il suo dolore, la sua vergogna, la sua fede in Dio, la sua fierezza indomita, Dalila con la sinuosa perfidia e la seducente dialettica della donna che vorrebbe farsi perdonare il tradimento, e riconquistare l’eroe, Manoa con la virile sollecitudine del suo 3 Si rimanda il lettore al saggio di D. Borra su Saul, «Disclub», n. 8, giugno 1964, a. II, pp. 27-29.
62 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
affetto paterno. Meno rilevato e più convenzionale il personaggio di Micah il quale è più che altro un corifeo4 e si staglia appena sul gruppo dei suoi compagni accorsi a consolare Sansone. Un discorso a parte meriterebbe Harapha, la cui truculenta superbia unita ad una sostanziale viltà è resa da Haendel con toni ed accenti (specie nella prima delle due arie) che ci ricordano da vicino il Polifemo, più dichiaratamente buffonesco, di Aci e Galatea (1719): alla deliziosa pastorelleria ci rimanda anche, del resto, un certo tono bucolico della scena in cui compare Dalila (metà dell’Atto II). La stessa aria di Dalila With plaintive notes and amorous moan potrebbe fiorire sulle labbra di Galatea. Ma il nucleo poetico vitale dell’oratorio ci sembra da ricercare principalmente nella parte del protagonista e in tutta la cornice corale. A proposito di quest’ultima, sarà da ascoltare il grande coro Fix’d in His everlasting seat (che Shaw prediligeva) in cui Haendel, a chiusura del II Atto, oppone i sacerdoti di Dagon, l’idolo dei Filistei a quelli di Geova, il Dio degli Eserciti, con un impiego sapiente di coloriti vocali e con una maestria di scrittura contrappuntistica che troveranno più tardi l’uguale solo in certe pagine dello stupendo Belshazzar (1745). L’edizione che del testo ci offre la benemerita casa Vanguard-Amadeo cui dobbiamo esser grati per molte altre pregevoli esecuzioni di testi non proprio di routine, è, come nella tradizione della Casa, filologicamente scrupolosa e attendibile. Il maestro Maurice Abravanel, alla testa dei complessi sinfonico e corale dell’Università dello Utah, coglie con mano sicura il senso di salda continuità dell’oratorio: un unico movimento drammatico la cui linea meglio forse si apprezza oggi ad un ascolto radiofonico che non in una sala da concerto, nella quale le convenzioni imporrebbero una o due pause. In effetti, la divisione in tre atti degli oratori di Haendel nelle edizioni così dette da concerto è da condannare, in quanto deleteria per quel particolare taglio drammatico tipico di Haendel, che concepiva la propria opera come un susseguirsi di quadri o blocchi di musica in cui si alternavano recitativi, arie, ariosi, duetti, quartetti, cori. Samson rappresenta l’iter che il protagonista percorre riscattandosi dal più cupo sconforto e dalla vergogna della servitù ingloriosa. Respingendo le offerte tentatrici di Dalila e riscattando sé e il proprio popolo nel sacrificio finale, in cui si offre vittima per la libertà dei fratelli oppressi dai Filistei, (Giudici, 13-18). Il dramma ha dunque un senso ascensionale, è come un lungo crescendo ed il direttore ci sem4
Si ascolti la stupenda aria (con coro) Return, Return, o God of Hosts, all’inizio del II Atto.
63 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
bra abbia colto e messo a fuoco questo carattere fondamentale dell’oratorio forse l’unico in tutto Haendel ad essere scarsamente episodico e tutto fortemente imperniato sulla figura del protagonista. Non minor merito della realizzazione va al tenore Jan Peerce che obbediente come sempre alle evidenti suggestioni direttoriali (come sappiamo delle sue incisioni toscaniniane) scolpisce il personaggio con grande intelligenza interpretativa e varietà di coloriti vocali, dando una lezione di stile e di assoluta immedesimazione col personaggio, senza sfoggio di virtuosismi. Ugualmente efficaci e non prevaricanti il soprano Phyllis Curtin nella parte di Dalila e nelle stupende arie delle donne filistee ed ebree (particolarmente nell’aria finale con tromba obbligata, la celeberrima Let the bright Seraphim, trasformata in pezzo di bravura e molto eseguita in Inghilterra nell’Ottocento)5 e la contralto Louise Parker nella parte di Micah. Precisi e sensibili il baritono Roy Samuelsen (Manoa) e il basso Malcom Smith (il gigante Harapha) abilissimo nel sottotineare discretamente certe lievi sfumature grottesche del personaggio. In conclusione, un’esecuzione integrata e compatta, cui non nuocerebbe un po’ più di mordente e di varietà nello stacco di tempi. Per intendersi, vorremmo un po’ più di attenzione agli insegnamenti di Thomas Beecham che forse peccò di scarsa osservanza letterale nelle sue interpretazioni haendeliane ma resta, a nostro giudizio, insuperato, per la naturalezza e la spontaneità con cui ha reso la sconfinata e sovrana allegrezza, l’energia ritmica sublime e dominatrice, tipiche del mondo sonoro di Haendel. La registrazione è, come sempre nel caso della Vanguard, assai accurata e non lascia a desiderare quanto a prospettive sonore, trasparenza, ambientazione, rilievo dei particolari orchestrali e timbrici. L’edizione stereofonica magnifica gli effetti più spettacolari come quelli del finale dell’Atto II coi suoi due cori contrapposti. Un’incisione, per concludere, da consigliare vivamente non solo a tutti i cultori di Haendel ma anche a coloro che considerano ancora il musicista di Halle un abile e un po’ facile mestierante di altissimo livello e parlano, a suo proposito, di Arcadia, contrapponendogli l’autore della Matthäus-Passion, fatto oggetto di una fanatica e ottusa ammirazione esclusiva. Per gli haendeliani, aggiungeremo che si tratta della prima incisione dell’oratorio, che è cantato in inglese. Se ne annuncia una nuova edizione a cura della Everest ma cantata in tedesco. (da «Disclub», n. 16, ago.-sett. 1965, a. III, pp. 19-21) 5
Fu il cavallo di battaglia di Angelica Catalani.
64 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
LE FONTI DELL’ANELLO DEL NIBELUNGO
Il vasto affresco poetico-musicale al quale Wagner consegnò il suo più articolato messaggio, occupa nella produzione del musicista un posto centrale, come Faust nell’opera di Goethe e tra i due testi pieni di fato si potrebbe istituire un raffronto, non solo come due monumenti al germanesimo sotto specie di allegoria cosmica teatralmente atteggiata, ma per certe analogie della loro stessa storia terrena. I due poemi, che pur mirano all’assoluto ed ambiscono alla dignità di testi definitivi, hanno sofferto una vicenda terrena accidentata e il travaglio della loro composizione si è prolungato per un notevole arco di tempo. Nel caso di Wagner, sono passati circa venti anni tra le oscure intuizioni giovanili, le prime stesure poetiche e musicali della maturità e il lavoro interrotto e tenacemente ripreso nel corso dei lunghi anni d’esilio dalla terra tedesca. Ambedue i testi hanno subito determinanti cambiamenti d’impostazione nella struttura generale e infinite modifiche nei dettagli tanto da presentarsi al lettore-auditore, con un aspetto variegato e composito, che è una delle ragioni del loro fascino perenne e, nel caso di Wagner, si vena di bizantinismo fine secolo. L’Anello dà l’impressione di un mosaico di note, prezioso e allucinatorio, con un colore del suono, con una “ tinta” decadente che furono prontamente messe a fuoco da alcuni dei più alti intelletti europei del tempo, i quali, come Baudelaire e Mallarmé, erano sintonizzati, si direbbe predestinati, al messaggio di quella musica “nuova” che, d’altronde, era tanto osteggiata dai compositori coevi con reazione violenta, istintiva e addirittura combattuta o negata dai critici fin nelle sue ragioni prime. Quelle ragioni che l’autore andava esponendo con dovizia perfino eccessiva di argomentazioni teoriche e con pervicacia inflessibile di combattente per la propria causa, con un’energia che scaturiva da una demonica urgenza vitale. Faust e Anello si potrebbero dunque studiare come analoghi, per la complessità e la ricchezza dei motivi intessuti, per la loro qualità di summae di una visione del mondo, per il loro carattere nobilmente ed altamente composito di opere-cattedrali, ovvero di grandi polittici ai quali abbia messo mano una pluralità anonima di artisti o di artigiani, in un lungo periodo di tempo. 65 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
Nel caso dell’Anello sembra preminente l’aspetto fine secolo del gigantesco poema, che l’autore notoriamente volle destinato ad una realizzazione scenica sacrale in una specie di tempio laico, in un teatro per iniziati e chiuso ad altri spettacoli che non fossero la celebrazione del rito. L’incredibile miracolo di Bayreuth. Al teatro come a messa, ancora oggi a un secolo di distanza. Tale aspetto è accentuato dal carattere di bilancio o liquidazione di una civiltà, di celebrazione rituale e iniziatica di un crollo totale di valori (la catastrofe cosmica) e di successiva rigenerazione-purificazione per l’intervento redentorio di un personaggio chiave del poema: la divina Brunilde, resa donna dall’amore per il biondo eroe, traditore e tradito, contaminato e purissimo. Una sorta di grande messa laica, come preludio a quella messa nera che sarà il Parsifal, suprema delizia di ogni decadente e fatto balenare, come un frutto proibito, in premio ai pellegrini di Bayreuth (fino al 1914) con strategia astutissima dell’autore-impresario. Il carattere composito e compendioso dell’opera wagneriana fu sottilmente colto da Proust in pagine non obliabili ed è degno di nota che lo scrittore, nella penombra della sua camera, andasse anch’egli tracciando un bilancio della propria vita e della propria epoca e stesse anch’egli costruendo una sua cattedrale laica, con pervicacia non meno stoica e inflessibile di quella del musico tedesco. Del resto, come la Recherche è qualcosa di ben diverso dalla semplice somma dei romanzi in cui si articola, anche l’Anello non è un insieme di quattro opere separabili ma una “sagra scenica” in un Prologo e tre Atti. Recherche e Anello si pongono come opere totali, specchi del mondo, sontuose pietre tombali di un secolo ed emittenti inesauribili di messaggi al secolo successivo. Le due summae della narrativa e della musica dell’Ottocento aprono la porta ai narratori e ai compositori del secolo nuovo. A chi si accosti la prima volta al testo dell’Anello non sarà inutile ricordare gli elementi essenziali della grande trama che Wagner poeta drammaturgo (non lo si dirà librettista) trasse con intuito infallibile dal mondo caotico e tenebroso della mitologia scandinava e dell’epopea germanica, un mondo culturalmente a lui affine più di quanto non potesse esserlo la solare civiltà degli dèi omerici, che pure amava e conosceva a fondo. Basterà ricordare le letture e i commenti alle tragedie di Eschilo nella cerchia degli amici, invitati in casa Wagner. Per orientarsi sarà opportuno distinguere i personaggi dalla trama,
66 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
non dimenticando che l’Anello si può anche leggere come un appassionante romanzo dal nucleo centrale incandescente (la bramosia dell’oro, la sete di potere), che suggerisce un’analogia con Balzac, altro titanico costruttore di un libro cattedrale, un romanzo dai cento titoli. Balzac ebbe a dichiarare che i suoi personaggi erano da lui strappati (arrachés) al silenzio e alla notte ed anche Wagner sembra evocare gli dei e gli eroi che affollano il suo cosmo musicale-poetico da uno sfondo confuso e brumoso di leggende. I personaggi dell’Anello arriveranno ad assumere contorni definiti e consistenza poetica indipendente, solo in virtù della musica che ne suggella l’identità. I temi che l’ascoltatore conserverà indelebili nella memoria. Dai poemi dell’Edda,1 limbo tenebroso di una cosmogonia in formazione, Wagner prende i tratti essenziali alla definizione di un suo Olimpo nordico in cui si ravvisano i tipi delle divinità greche. In effetti, già le saghe anonime dei bardi scandinavi (Skaldi) hanno in comune gli dèi con la grande famiglia dei popoli ariani. A Giove o Zeus corrisponde Odino (Wotan), dio delle battaglie e delle tempeste, suscitatore del coraggio eroico, cacciatore selvaggio in contatto con la natura di cui conosce i segreti. Esso regna in una fortezza (Walhalla), circondato da bionde vergini guerriere (Walkirie). A lui sono sacri i corvi e quando erra per il mondo sotto le spoglie di un viandante, spinto da sete di conoscenza, si appoggia su di un’asta di frassino nella quale sono incisi caratteri magici (Rune). Giunone è Fricka, custode del sacro vincolo del matrimonio e dea della fecondità. Vulcano è Donner, dio del tuono e della folgore, nemico dei giganti. Venere è Freya, dea della bellezza e dell’amore. Concupita dai nani e dai giganti, le sono sacri i gatti e Wagner farà di lei la custode dei pomi della giovinezza eterna necessaria agli dei per sopravvivere. Loki o Loge è il personaggio più originale della mitologia nordica. Accolto di malavoglia nella cerchia luminosa degli dei, mezzo dio mezzo 1
L’Edda Antica in versi è una raccolta di brevi carmi norresi e islandesi, risalenti al nono-tredicesimo secolo, che trattano della cosmogonia, della mitologia e delle gesta degli eroi scandinavi. La scoperta del testo si deve al vescovo Sveinsson (1642) che lo attribuì a Saemund il Saggio e dette alla raccolta il titolo di Edda, cioè «antenata». I carmi sono prevalentemente in forma dialogata e parte di essi riferisce la leggenda dei Nibelunghi. L’Edda in prosa, detta anche Edda di Snorri è un trattato di mitologia in tre parti, nel quale l’islandese Snorri Turluson (1178-1241) riprende e sviluppa i vecchi miti con un intento didascalico. I due testi sono la fonte principale a cui ha attinto Wagner, che ne iniziò lo studio a Dresda nel 1848, mentre stava terminando la composizione del Lohengrin.
67 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
demonio, spirito del fuoco, mobile e irrequieto come la fiamma, come la fiamma può confortare con il calore o distruggere. È una specie di Mercurio, un tessitore d’inganni e nell’Oro del Reno Wagner farà di lui una chiave di volta nell’architettura del dramma, essendo il suo intervento risolutivo in un modo molto ambiguo. Loge suggerisce a Wotan una soluzione al suo dilemma (concedere Freya ai giganti in pagamento per il lavoro alla costruzione del Walhalla o mancare alla parola data), ma essa finirà per rendere il dio ancor più schiavo di un fato che ha come sbocco ineluttabile il “crepuscolo degli dei”. Le parole e il concetto stesso che danno il titolo all’ultimo dramma dell’Anello sono anch’essi desunti dall’Edda pagana: gli dei sono soggetti a un destino inevitabile; il crepuscolo2 li attende e il loro mondo verrà distrutto dal fuoco, elemento a cui presiede Loge. In Wagner, il personaggio addirittura sparisce come tale e si trasforma in fiamma alla fine dell’Oro del Reno, pur continuando a vivere con pungente evidenza musicale negli spartiti successivi. Nell’Edda, dopo la catastrofe finale si intravede una rinascita successiva, cui seguirà una nuova età dell’oro. Gli dei luminosi (Lichtalben) sono peraltro in perpetua guerra con i giganti, poderosi figli della terra, ottusi e violenti, simbolo della forza bruta e della cupidigia più cieca, ma essi hanno avversari ben più pericolosi nei nani (i Nibelunghi).3 Essi sono gli abitatori delle viscere della terra, fabbri industri e ingegnosi. Depositari di un tesoro, sanno rendersi invisibili con un cappuccio magico, trasformato da Wagner in elmo. Nell’Anello, queste due schiere di nemici degli dèi si riducono a due coppie di personaggi emblematici. I giganti Fasolt e Fafner, destinato quest’ultimo a trasformarsi in drago per vigilare sul tesoro e sacro alla spada vindice di Sigfrido, l’eroe solare, e la coppia ben più inquietante di Alberico e Mime, due fra i più straordinari personaggi scaturiti dalla fantasia del musico-poeta, che in questo caso è in minima parte debitore delle fonti. Wagner rinverdisce qui il mito dei fratelli nemici. Alberico è il nero principe della notte. Nano lascivo quando corteggia le ondine, diviene terrificante nella maledizione e nell’odio di cui investe i suoi nemici e nel disprezzo per il fratello Mime che tortura sadicamente. 2
La parola ‘Rök’ significa letteralmente oscuramento. Il tema della fine del mondo è trattato nel carme Völuspa (La veggente) dell’Edda, viene ripreso nell’Edda in prosa, e sviluppato nel Nibelungenlied. 3 Nel Nibelungenlied, i Nibelunghi sono i signori di Nibelungenland, Nibelung e Schilbung, al cui servizio è il Nano Alberico. Nella seconda parte del poema, il nome si riferisce ai Burgundi.
68 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
Affronta da pari a pari il re degli dèi e infine tesse un’oscura trama di inganni e di vendetta per interposta persona (il figlio Hagen) irretendo l’eroe solare e Brunilde, la sposa fedele. Dopo aver rinunciato all’amore ed aver perso successivamente l’anello magico forgiato con l’oro del Reno che dà a chi lo possiede il dominio del mondo, Alberico è proteso solo alla sua riconquista e ad un lavoro feroce di annientamento del mondo degli dèi. Mime è un personaggio altrettanto complesso: lagnoso ed ipocrita, sagace ed infido. Nutre intenti omicidi nei riguardi di Sigfrido e sta per raggiungere il suo scopo con la frode quando l’eroe lo sopprime con noncuranza, come si elimina un insetto fastidioso. In una didascalia nella stesura originaria del testo, che Wagner ha poi abbreviato, si sottolineava come non ci fosse niente di caricaturale nella figura del nano, il quale doveva avere quindi una sua terribilità in confronto a quella più nobile (sono parole di Wagner) di Alberico. In effetti, Mime è anche la controparte di Sigfrido e i due nani possono essere visti come personaggi spia delle pieghe meno confessabili della psiche dell’uomo Wagner. Tra le figure minori dell’Olimpo nordico, ricordiamo ancora Froh, divinità legata alla primavera e in stretto rapporto con la sorella Freya, e Erda (Wala), dea della terra e figlia della notte. Quest’ultima prende tuttavia un particolare spicco in virtù della musica in due pannelli del grande polittico che sono essenziali alla comprensione di uno dei temi generatori dell’Anello. Erda è la controparte di Wotan in due momenti decisivi per lo sviluppo psicologico di questo grande personaggio che si può considerare il vero protagonista del poema. Sono i due momenti della verità per Wotan che, la prima volta,4 non tiene conto dell’avvertimento della veggente la quale lo invita a rinunciare all’anello e, la seconda volta,5 dopo un drammatico confronto, prende coscienza della fine inevitabile del suo potere e del tramonto degli dèi. Al mondo della natura, incorrotto ed ingenuo, appartengono le tre figlie del Reno, giocosi demoni delle acque, di cui Wagner ha creato i nomi sonanti, mentre le tre Norne, tessitrici del destino del mondo corrispondono alle Parche romane e alle Moire dei greci. Gli dèi stessi sono soggetti ad un fato ineluttabile, come gli eroi. Prima di passare rapidamente in rassegna i personaggi degli eroi e delle eroine che incontriamo nei poemi successivi all’Oro del Reno (in cui agiscono solo le divinità) è da ricordare come Wagner nello sforzo 4 5
Oro del Reno, IV scena. Sigfrido, Atto III, I scena.
69 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
titanico di imprimere il suggello di un suo personale schema ideologico ed etico ad un materiale così disparato, ma da lui criticamente ripensato, lo abbia condensato e modificato con esiti non sempre felici, sfruttando comunque liberamente tutti gli spunti ricavabili da un’amalgama di leggende che risalgono a varie epoche. Si ricordino alcune date: i carmi dell’Edda appartengono alla civiltà delle grandi migrazioni e furono tramandati oralmente per un lungo periodo di tempo prima di esser fissati nel testo che oggi conosciamo. Quanto alle altre fonti e principalmente quelle relative alla storia degli eroi, l’ambiente è quello del medioevo cortese ben lontano per raffinatezza di costumi da quello dell’età dei Vichinghi. Già in questi testi, che risalgono al tredicesimo secolo, le antiche leggende hanno subito un mutamento profondo anche per l’influsso determinante del cristianesimo e a proposito dei limiti di Wagner drammaturgo si rilegga il giudizio negativo che ne dette D’Annunzio: “Preferirei piuttosto un ritorno all’antico che questa pazza ed illogica innovazione per cui Riccardo Wagner ha invano profusi con abbondanza veramente mirabile tanti tesori di inspirazione e di sapienza”. I testi a cui Wagner si ispirò per questo gruppo di personaggi sono la Saga dei Volsunghi, la Saga di Thidrek (Teodorico) e soprattutto il Nibelungenlied. Quest’ultimo è un capolavoro della letteratura medioevale (medio-alto-tedesco), composto tra il 1195 e il 1205 da un autore austriaco che fuse in un’opera organica due grandi saghe precedenti. È un grande poema epico in 39 canti, in cui si narra una vicenda relativamente unitaria di odii e di vendette con cinque grandi protagonisti: Sigfrido, Brunilde, Krimilde, Hagen, Gunther. L’azione della prima delle due parti in cui si articola il poema (17 canti) corrisponde nelle linee essenziali a quella del Crepuscolo degli Dei e termina anch’essa con la morte e il funerale di Sigfrido. All’inizio siamo a Worms in Burgundia, alla corte di re Gunther. Sigfrido, eroe già famoso per avere ucciso il drago e conquistato il tesoro dei Nibelunghi si presenta al re e chiede la mano di sua sorella Krimilde6 (Gudrun nell’Edda, Gutrune in Wagner) di cui si è innamorato senza averla mai vista. Gunther vuole sposare Brunilde, principessa di Islanda, che anch’egli non ha mai incontrato, pur essendo consapevole di non poter vincere le gare di destrezza alle quali la principessa ha deciso di sottoporre chiunque aspiri alla sua mano. Il nobile Hagen, un’in6 Nel testo di Wagner Krimilde è ricordata come moglie di Gibich e madre di Gunther e Gutrune. Hagen è figlio di Krimilde e di Alberico.
70 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
carnazione del germanesimo puro in questa versione della leggenda, mentre nella tradizione nordica seguita da Wagner è fratello di Gunther, convince Sigfrido a conquistare Brunilde per conto del re. All’eroe verrà concesso di sposare Krimilde. Sigfrido partecipa alle gare, dopo essersi reso invisibile con la cappa magica dei Nibelunghi, a fianco di Gunther che fingerà solamente di combattere e in tal modo Brunilde cade vittima di un primo inganno. I tre ritornano a Worms dove si celebra il doppio matrimonio e, al banchetto nuziale, Brunilde piangerà nel vedere Krimilde seduta accanto a Sigfrido che le hanno detto essere un vassallo del re. Gunther teme di non riuscire a consumare il matrimonio e sarà ancora Sigfrido invisibile ad entrare nella camera nuziale per domare la donna fortissima, senza tuttavia violarla. Tuttavia, prima di cedere il posto a Gunther, toglie a Brunilde l’anello e la cintura che la rendevano inviolabile e li dona alla propria sposa. I due raggiungono i loro feudi. Dopo dieci anni, Sigfrido e Krimilde tornano a Worms. Davanti alla cattedrale, le due donne si affrontano per una questione di precedenza, poiché Brunilde crede sempre che l’altra sia moglie di un vassallo e, quando vede il suo anello al dito dell’altra, scopre con sdegno la trama di cui è stata vittima. Il finale della prima parte del Nibelungenlied corrisponde a quello del Crepuscolo con la scena di caccia e l’intervento di Hagen che uccide Sigfrido a tradimento, dopo aver ottenuto da Krimilde la rivelazione del segreto che rende l’eroe vulnerabile. Per chi conosca il testo wagneriano è evidente quanto Wagner abbia approfondito la psicologia dei personaggi e conferito ampiezza di sfondo al quadro con la grande scena delle Norne nel prologo e col drammatico dialogo tra Brunilde e la sorella Waltraute. Wagner sfronda la trama del poema e inserisce, ricavandolo dall’Edda, l’episodio del filtro d’amore che, su ispirazione di Hagen, viene fatto bere all’eroe, il quale così dimenticherà Brunilde a cui si è già unito secondo l’antica saga e s’innamorerà di Krimilde-Gutrune. Si è già accennato alle difficoltà che Wagner ha incontrato, e solo parzialmente risolto, nel suo lavoro di fusione delle leggende medioevali. Ma dove forse si palesa una carenza nell’economia generale del poema è nel raccordo tutto sommato artificioso ed esteriore tra Brunilde e Sigfrido protagonisti del Crepuscolo e i personaggi che portano lo stesso nome nelle due opere intermedie dell’Anello. In realtà, le fonti erano diverse e lo stesso processo compositivo dell’intero ciclo (il lungo intervallo dal 30 luglio 1857 al 14 giugno 1869) ha comportato un cambiamento di ispirazione e di stato d’animo. 71 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
In realtà, Sigfrido e Brunilde quali ci appaiono nei drammi di cui sono protagonisti a pieno titolo, sono perfettamente coerenti con lo spirito della Edda antica. Nelle antiche saghe precristiane Sigurd (Sigfrido) è un eroe solare, dagli occhi luminosi, uccisore del drago, il cui sangue lo rende invulnerabile, fuorché in un punto delle spalle in cui lo ha sfiorato una foglia di tiglio. Egli sveglia dal sonno magico a cui Wotan l’ha condannata, la vergine Brunilde, guerriera e profetessa. Sigurd è un dio della primavera divenuto eroe, Brunilde è una figlia di dèi che l’amore trasformerà in donna. Per Wagner, l’eroe germanico e la figlia di Wotan stavano a simboleggiare l’unione del mondo germanico con quello scandinavo, un punto di congiungimento tra due mitologie. Ma è da tenere presente che i presupposti di questa fusione erano già in alcune delle antiche sagre. Ad esempio, in quella dei Volsunghi, Sigurd è figlio di Wotan e non un suo discendente come nell’Anello. Come dice lo Schuré: “La grande originalità di Wagner consiste nell’aver resuscitato questi due mondi in forma molto primitiva e al tempo stesso personale, amalgamandoli in un tutto unico di cui Brunilde è l’eroina cosciente che li riunisce. Queste due figure, Sigfrido e Brunilde, si staccano luminose sullo sfondo mitologico del dramma originale, a volte oscuro e selvaggio. Assistiamo ad una specie di teogonia, che finisce in una tragedia umana, duplice dramma parallelo. Gli eroi, nati dal pensiero divino, coinvolgono gli stessi dèi nella loro catastrofe”.7 La prima vittima della tragedia che travolge i personaggi principali è Siegmund, l’eroe più doloroso ed umano dell’Anello che incontriamo nel primo atto di Walkiria. Della stirpe dei Volsunghi o Welsunghi (secondo la grafia wagneriana) e discendente da Wotan, è da questi sacrificato all’inflessibile Fricka, custode del vincolo matrimoniale che Siegmund ha violato unendosi alla propria sorella Sieglinde, andata in sposa ad un nemico. Brunilde disubbidirà a Wotan nel tentativo di salvarlo durante il suo duello con Hunding, il marito oltraggiato, che appartiene ad una stirpe nemica. Nell’antica leggenda Brunilde protegge invece un eroe di nome Agnar e Wotan punisce la figlia pungendola negli occhi con una spina che la farà dormine fino al giorno in cui un altro eroe che non conosce la paura la risveglierà, dopo aver valicato la cortina di fiamme, dietro la quale dorme la vergine guerriera, catafratta nella sua corazza. A completamento di quanto si è accennato circa la lunga elaborazione del testo, riassumiamone rapidamente le tappe principali. 7
E. Schuré, Wagner - La sua opera, la sua idea. Bari, Laterza, 1941, p. 172.
72 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
La prima versione del 1848 è un abbozzo in prosa di circa sessanta pagine, che inizia con la scena sulle sponde del Reno e termina col funerale di Sigfrido.8 Wagner pensava di ricavarne una sola opera in tre atti. Vista l’impossibilità di condensare tutta la materia in così breve arco di tempo, dette inizio a quella rielaborazione del materiale che attraverso la fase intermedia articolata in due drammi, la Morte di Sigfrido e Il Giovane Sigfrido (corrispondenti approssimativamente ai due testi in seguito intitolati Crepuscolo e Sigfrido) lo portò alla decisione di risalire agli antefatti delle vicende drammatizzate, aggiungendo Walkiria e Oro del Reno ai due poemi del progetto primitivo. La decisione relativa allo schema in un prologo a tre parti risale al novembre del 1851 e la parola fine fu scritta in calce all’ultima pagina del manoscritto il 15 dicembre 1852. La versione del 1848, per quanto riguarda la condensazione del materiale delle saghe è già un risultato notevole, anche se manca in essa il tema fondamentale del conflitto tra l’amore e il desiderio dell’oro. È invece messo nitidamente a fuoco il motivo dell’eroe che muore assumendosi la colpa degli dèi: il tema della morte-espiazione. Nel testo del 1852 la figura di Wotan, di scarsissimo rilievo drammatico in quella precedente, diviene il perno dell’azione e il conflitto che nasce nell’intimo del re degli dèi, con la consapevolezza del fatto che non si possono possedere contemporaneamente oro ed amore, diventa l’asse portante dell’intera struttura. Anche Alberico con la rinunzia all’amore assurge a statura di protagonista. Infatti, in una lettera a Theodor Uhlig (14 ottobre 1851) Wagner dichiarò: “Questa rinuncia genera l’intero dramma fino alla morte di Sigfrido”. Ma il ribaltamento di prospettiva determinante per la comprensione del senso complessivo del poema riguarda l’ultima scena. Nel 1848, Brunilde ridivenuta Walkiria. annuncia a Wotan e agli dèi la riconferma della loro eterna potenza e conduce Sigfrido nel Walhalla, mentre Alberico e i Nibelunghi ridiventano liberi e l’oro ritorna alle figlie del Reno. Nel finale definitivo, com’è noto, Brunilde incendia il Walhalla, suggellando col suo gesto l’accettazione della catastrofe cosmica da parte degli dèi, in quanto “la più profonda sofferenza d’amore le apre gli occhi”. (da 42° Maggio Musicale Fiorentino, 2 V/ 3 VII, 1979, n. unico, pp. 44-50) 8
Il personaggio di Sigfrido (Sigurd) compare nei seguenti canti dell’Edda: Canto di Regin, Canto di Fafnir, Canto di Sirgdrifa, Canto breve di Sigurd, Carme frammentario, Vaticinio di Gripi, Viaggio di Brunilde nell’Ade.
73 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
PUSHKIN E LA MUSICA RUSSA
Ripensando alla carriera breve e rapinosa di Pushkin, (1799-1837), due grandi scene teatralmente emblematiche si impongono alla memoria. Nel 1815, un giovanissimo alunno del liceo di Zarskoe Selò dette lettura in pubblico di una sua poesia che iniziava con questi versi: Il velo di una notte malinconica si stende Sulla volta del cielo addormentato. Calmi e silenti riposano la valle e il bosco Una grigia foschia avvolge la foresta lontana.
Tra i presenti c’era il vecchio poeta di origine tartara Derzavin, ultimo rappresentante della scuola classica, che aveva conosciuto i fasti del regno di Caterina. Derzavin, entusiasta e commosso, consacrò, imponendogli le mani sulla testa, il poeta sedicenne che, in un primo momento, era fuggito dalla sala, intimidito dagli applausi. Fu questo il primo riconoscimento (non si saprebbe immaginarne uno più solenne e sacrale) di colui che sarà ufficialmente considerato il principe dei poeti russi, il padre della poesia nazionale, la cui fama non conoscerà eclissi neanche negli anni dello stalinismo, durante i quali taluno vorrà vedere capziosamente in lui un antesignano del realismo socialista. Ma il poeta-narratore sarà canonizzato non solo come modello supremo di miracoloso equilibrio di contenuti tempestosamente romantici e di forme classicamente cristalline, quindi tanto meno inquietante e tanto più solare del tenebroso contemporaneo Gogol, la cui opera cosi ricca di risvolti problematici darà più di un grattacapo ai discepoli di Zdanov, per la difficoltà obbiettiva di incasellarla e castigarla. A Pushkin sarà anche serbato il destino di assurgere al rango di poeta-profeta, voce della santa madre Russia, e portavoce del popolo ortodosso, popolo eletto e vocato da Dio al fatidico compito di rigenerare l’Europa corrotta, il mondo. È in questa fase della vicenda extratemporale del poeta (morto prematuramente nel 1837) che si situa il punto più alto della sua parabola ed assistiamo alla seconda scena emblematica. Un altro grande tenebroso, un artista del caos, discepolo di Gogol, viene invitato a tenere il discorso celebrativo per l’inaugurazione di un monumento a Pushkin, che la Società degli Amici della Letteratura Russa aveva fatto erigere a Mosca. Siamo nel 1880 e la vicenda umana di Dostoievski sta per con-
74 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
cludersi. Il vecchio scrittore malato infiamma la folla nel nome del poeta di un’altra epoca che egli addita come l’esempio altissimo di un russo che ha saputo aprirsi all’Europa, realizzando e vivendo nella sua opera un ideale di pan-umanità. Il romanziere consacra definitivamente Pushkin, da lui sempre amato e venerato, come universale in quanto artefice di una mirabile fusione di nazionalismo e universalità. Un intellettuale europeo con le radici ben salde nella terra russa, una voce russa che parla al mondo intero. “Essere un vero russo – dice Dostoievski – non significa altro che essere fratello di tutti gli uomini, essere cittadino del mondo”. La scena, alla quale forse il compianto Ripellino avrebbe voluto esser presente, ci viene cosi descritta dallo scrittore alla moglie: “Quando alla fine del discorso, ho proclamato l’unione universale degli uomini si sono alzate grida di entusiasmo che mai riuscirò a descriverti. Persone che piangevano, singhiozzavano, estranei che si baciavano e si giuravano amore eterno – Profeta! Profeta! mi gridavano”. Turgheniev, che non amava il pericoloso rivale e non ne era riamato, lo abbracciò piangendo. Una delegazione di dame gli offrì una corona di alloro che lo scrittore a notte tarda andò a deporre ai piedi del monumento, inchinandosi fino a terra. Aksàkov, il capo degli slavofili, definì il discorso un avvenimento storico. Un prestigio, così autorevolmente conclamato e avallato da firme tanto illustri, giustifica ampiamente – sorprenderebbe il contrario – l’interesse sostenuto e pertinace dei musicisti russi dell’800 per Pushkin, fonte inesauribile di soggetti per libretti d’opera per quei compositori tutti coerentemente votati all’ideale dell’opera nazionale, ad un rigoroso “specifico” della forma del melodramma.1 Appare quindi fatalmente predestinato l’incontro felicissimo di Pushkin con il maggiore esponente di quella Scuola dei Cinque, che dell’ideale slavofilo e dell’adesione viscerale alla realtà della terra russa storicamente concretizzata nei secoli aveva preso lucidissima coscienza come linfa vitale di ogni ispirazione. L’altezza del risultato musicale (si parla, è chiaro, di Mussorgski e del Boris Godunov) attesta luminosamente la profonda congenialità del musicista con il testo del poeta-dram1
Elenchiamo le principali voci del catalogo: Glinka, Ruslam e Ludmila (1842); Dargomiski, Il Convitato di pietra (1830); Rusalka (1856); Mussorgski, Boris Godunov (1874); ¢ajkovskij, Eugenio Onieghin (1879), La Dama di picche (1890); RimskiKorsakov, Mozart e Salieri (1898), La leggenda dello Zar Saltan (1900), Il Gallo d’Oro (1909); Rachmaninov, Aleko (1893), Il Cavaliere avaro (1906); Stravinsky, Mavra (1922).
75 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
maturgo, un testo da lui investito con così sostenuto vigore di fantasia ricreatrice da elevarlo su di un piano ancor più alto ed universale, pur rispettandone la struttura portante, cosi ariosamente articolata nell’alternarsi scespiriano di prosa e di versi, fino ad illuminare le zone più segrete del grande polittico: tragedia, cronaca, commedia, storia. Anche Mussorgski dunque tanto più genio europeo quanto più genio russo. Si torna sempre a Dostoievski e alla sua formula critica. Se la vicinanza ideale di Mussorgski e di Pushkin sembra un caso di affinità elettiva, oltre che di appartenenza alla stessa tradizione del realismo russo, un realismo sui generis tanto imbevuto di spiriti romantici da richiedere definizioni ad hoc (realismo romantico, super-realismo) il caso di Glinka è diverso. Anzitutto si tratta di un contemporaneo del poeta, essendo il musicista nato nel 1804 e Pushkin nel 1799.2 I due vissero durante il regno di Alessandro I al tempo della campagna di Napoleone in Russia e dell’incendio di Mosca. Entrambi vissero, non nell’atmosfera semi-barbara e ancora medioevale di Mosca, ma nella brillante San Pietroburgo cosmopolita, città di cortigiani e di ambasciatori, uno strano incrocio (per dirla con il critico musicale inglese Martin Cooper) di Venezia e di Stoccolma. Questa capitale del Nord, questa finestra sull’Europa, che un atto di volontà proterva dello Zar Pietro aveva magicamente fatto sorgere dalle paludi, invitava ad acclimatare in Russia elementi di cultura occidentale, per le caratteristiche ambientali e per il genere di vita non provinciale che vi si conduceva nell’orbita della corte imperiale. Ed ecco Glinka, reduce da un lungo viaggio in Germania e in Italia, introdurre in Russia Mozart e il gusto della musica strumentale tedesca ed importare la musica di Rossini, che quasi si ritrovava a casa sua sullo sfondo dei maestosi scenari neoclassici, opera di architetti italiani, che abbellivano la Palmira del nord. Il musicista sfoggerà nelle sue composizioni uno stile occidentale colto e calerà entro moduli italiani e tedeschi una ispirazione popolaresca attinta alle antiche melodie russe, linfa vitale della sua musica, come lo sarà di quella dei compositori che verranno dopo di lui e si rifaranno al suo esempio. Glinka non musicò mai un testo di Pushkin, con il quale ebbe molti amici in comune ma la sua operazione nel campo musicale è singolarmente analoga a quella del poeta. Pushkin si nutri dei racconti della njanja e porse l’orecchio alle favole della vecchia Russia contadina per poi stilizzarle con gusto euro2
Mussorgski é nato nel 1839, due anni dopo la morte di Pushkin.
76 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
peo, rifacendosi soprattutto alla lezione di Byron, il poeta coevo clamorosamente famoso nella cui opera lo attiravano le predilezione per i temi romantici trattati in uno stile ancora essenzialmente settecentesco, l’alternanza di una maniera colloquiale e piana con il grande stile della poesia coturnata, un misto di cinismo audace e di immaturo idealismo, l’interesse per i motivi orientaleggianti e – non ultimo elemento di affinità – l’appassionato amore per la libertà e l’odio per i tiranni. Dobbiamo tuttavia rilevare che, se il bardo inglese ebbe, tutto sommato, una vita abbastanza facile e le sue sofferenze furono sempre un po’ spettacolari e recitate dinanzi ad un pubblico che amava essere scandalizzato, il poeta russo visse invece in un paese in cui l’autocrazia e la censura erano più occhiute e vessatorie di quanto non lo fosse la pubblica opinione dei benpensanti inglesi sfidata da Byron. L’inglese ha tranquillamente pubblicato le sue opere e ha vagabondato a suo piacimento – esule di lusso – in Europa e in Oriente, mentre il russo conosce una prima volta l’esilio in patria nel 1820 per certi epigrammi politici ed è inviato in Crimea dove, come dice il Lo Gatto, “visse tristemente”. Qualche tempo dopo, la polizia intercetta una sua lettera in cui si discute di ateismo e il poeta viene confinato nella tenuta della famiglia materna. Con l’ascesa al trono di Nicola I, che gli fa l’onore di istituirsi suo unico censore, Pushkin seguita ad essere sottoposto al controllo della polizia. La tragedia Boris Godunov non piace all’imperiale lettore e ne viene autorizzata una pubblicazione molto parziale nel 1827. Il poeta si rassegna poi ad una vita di cortigiano in libertà vigilata ed è significativo il fatto che la polizia, dopo la sua morte, due giorni dopo la ferita mortale riportata durante un duello per questioni d’onore, abbia ordinato il trasporto della salma di notte per evitare manifestazioni popolari. Una vita travagliata, con il risvolto di una serie di esperienze sentimentali tempestose o poco felici e un matrimonio disastroso. Esperienze, comunque, autentiche e una vicenda esistenziale profondamente sofferta. Siamo ben lontani dalla continua recita del bardo claudicante e troppo volutamente luciferino, con i suoi amori incestuosi ai quali verrebbe voglia di non credere. Del resto, quanto Pushkin fosse consapevole della sua distanza da Byron come modello esistenziale, lo rivelano alcuni suoi versi del terzo capitolo dell’Eugenio Onieghin: Ben seppe, con capriccio soggiogante, Vestir lord Byron di romanticismo Perfino l’insanabile egoismo.
77 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
Ma sarà proprio questo testo pushkiniano cosi autentico, anche se apparentemente più vicino a Byron (Don Juan) per la forma prescelta (il romanzo in versi) a fornire a ¢ajkovskij, musicista di ispirazione e orientamento quasi antitetici a quelli di Mussorgski, lo spunto per una delle sue creazioni più personali, un’opera tra le più atipiche. Se già un romanzo in versi può sembrare una sfida al lettore, quasi una contraddizione in termini, un’opera lirica che si presenta col sottotitolo “scene liriche” e rinuncia in partenza si direbbe per programma – non solo al dramma, all’azione, ma addirittura agli effetti esteriori e a tutto ciò che può fare spettacolo, appare addirittura una scommessa col destino. ¢ajkovskij ha perseguito accanitamente un suo ideale di opera, ma solo i due incontri con testi di Pushkin, secondo i giudizi critici più codificati, hanno dato risultati vitali, anche se da tempo è in atto una serie di recuperi e rivalutazioni del ¢ajkovskij operista, la cui fama era rimasta un po’ in ombra rispetto a quella fin troppo sottolineata dell’autore delle logore, eseguitissime sinfonie. L’aspetto più singolare della Dama di picche (1890) penultima opera del compositore, è di essere un omaggio vorremmo dire “oggettivo” ad un Pushkin sensibile alla lezione di Hoffmann. Il poeta russo-europeo aveva recuperato atmosfere protoromantiche tedesche proiettandole su di uno sfondo pietroburghese allucinato, anche se la sua San Pietroburgo neoclassica, bianca e oro, non è ancora la città stralunata di Gogol, né quella degli impiegatucci dostoievskiani (la tana degli uomini del sottosuolo) né tantomeno l’alveare dei burocrati-marionette Belgi. Omaggio oggettivo, si diceva, resa totale del testo con un gusto modernissimo del pastiche (la musica settecentesca) ma con due gran colpi di teatro e di genio che forse sbilanciano l’equilibrio dell’opera: la scena onirica della contessa e la scena stregata della caserma, nella quale il musicista anticipa il Wozzeck. Quando invece parliamo di omaggio soggettivo in riferimento all’opera precedente, Eugenio Onieghin (1877-78), vogliamo sottolineare il tipo diversissimo di rapporto instaurato da ¢ajkovskij con il testo. Se è vero, come dice Borges, che ogni grande scrittore talvolta riscrive o trascrive opere cambiandone la natura e mostrandocele sotto altra luce, ci permettiamo di prendere in prestito l’immagine, applicandola al lavoro in profondità che fa ogni musicista, rivestendo di note un testo, quando, ben s’intende, non si limiti a fornire una sorta di colonna sonora. Il musicista rilegge il testo, lo rivive e, qualora intervenga in fase di stesura del libretto (Mozart, Verdi) già conferisce un suo taglio alla materia
78 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
privilegiandone certi aspetti. Qualora il testo di partenza sia un’opera teatrale, l’attaccapanni della musica di cui parlava Barilli è più o meno pronto. Quando invece il testo, come nel caso nostro, e un monstrum, un romanzo capriccioso e svagato, certo più vicino a Tristram Shandy o a Jacques Le Fataliste che non a un qualsiasi romanzo tradizionale francese o inglese di quelli che le dame russe dell’epoca prediligevano, la soluzione del problema è più ardua. Eugenio Onieghin, memore del Don Juan3 di Byron, ci restituisce un quadro sociologicamente esatto della vita dei nobilotti di campagna e delle due capitali (Mosca, Pietroburgo) nel decennio 1820-30 ed è incentrato su di un personaggio disgustato della vita che respinge l’amore di una ingenua fanciulla. Un quadro d’ambiente con due protagonisti fortemente rilevati e una folla di personaggi minori. La tecnica del verso, di una suprema raffinatezza, permette a Pushkin di svariare, con sovrana naturalezza e con un virtuosismo vertiginoso, dal tono colloquiale al tono elevato degli squarci lirici o al tono amaramente satirico del gentiluomo blasé. Romanzo-conversazione e romanzo-saggio, anticipazione dell’“opera aperta” per la sua stessa struttura apparentemente disarticolata, ma in realtà sottoposto al controllo di un’intelligenza affilatissima e pervaso da un gusto della parola e da un senso musicale, ai quali qualsiasi traduzione in altra lingua rende solo in parte giustizia. Questo testo chiave della sua produzione impegnò il poeta dal 1823 al 1831 e fu continuamente ripreso e rimesso in cantiere ad intervalli di tempo. Il romanzo poematico si articola in otto capitoli, in un crescendo sapiente dall’inizio idilliaco e gioioso alla concitazione drammatica del finale. I due protagonisti Eugenio e Tatiana sono due prototipi essenziali di tutta la letteratura russa dell’Ottocento: il nobile orgoglioso, inappagato, egocentrico è il primo di una galleria di “eroi del nostro tempo”, personaggi che ritroveremo in Gonciaròv e in Turgheniev, per tacere dei maggiori. Sono i cosiddetti “uomini superflui”.4 La fanciulla è invece una eroina positiva, la cui più illustre discendente sarà Natascia in Guerra e Pace. Ma il testo incatena il lettore anche per il fascino di una narrazione accattivante. Per citare una specialista, Serena Vitale: «Nell’Onieghin... l’unità romanzesca si attua e si 3
Byron lavorò al poema dal 1818 al 1823: il testo, non finito, si divide in 17 canti ed é in ottava rima (modello ariostesco). Eugenio Onieghin, è in stanze di 14 versi, con gli ultimi due a rima baciata. 4 Il Diario di un uomo superfluo è un racconto di Turgheniev. La definizione si riferisce agli idealisti russi degli anni ’40 e a quelli delle generazioni successive.
79 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
rispecchia nell’unità della singola strofa, sorta di compiuto microcosmo, di monade perfetta che con il suo sviluppo interno allude e rimanda al progetto globale della narrazione. Il tempo romanzesco è scandito dal tempo poetico”.5 Passare dal testo di Pushkin a quello di un libretto d’opera deve quindi aver posto in partenza problemi di un carattere particolarissimo, per risolvere i quali ci sarebbe voluta ben altra penna che non quella piuttosto maldestra del musicista, e tanto meno di suo fratello Modesto, la pecora nera della famiglia, studente in legge fallito e divorato da ambizioni letterarie sproporzionate, vissuto quasi sempre a carico del compositore, che si è ostinato a servirsi di lui come fornitore di libretti6 malgrado i ripetuti fallimenti di Modesto come autore di teatro. Tra le singolari imprese, nelle quali il pittoresco personaggio si avventurò, la più bizzarra fu il tentativo di far curare a Lione nel 1878 un ragazzo sordomuto, del quale Modesto era diventato precettore per pagare dei debiti di gioco. I giudizi che il musicista dà del fratello sono spesso impietosi, come in questa lettera a lui diretta nello stesso anno: “Mi dicono che hai fatto qualcosa di brutto e di disonorevole. Non so che cosa sia ma ti conosco bene e so che sei privo di spina dorsale e incapace di fare altro che divertirti. Son seriamente preoccupato. Non pensi mai a dare uno scopo alla tua vita”. Ma il peggior servizio che Modesto doveva rendere all’illustre fratello è la biografia da lui scelta nel 1901-1902 che ci dà del musicista un’immagine distorta, quasi come se il mediocre scrittore ci avesse dato inconsapevolmente un ritratto di se stesso, quale avrebbe voluto essere se fosse stato più dotato. Il cliché di un ¢ajkovskij nevrotico e sentimentale, che ha avuto largamente corso fino al momento in cui la pubblicazione integrale delle lettere del compositore ha consentito una conoscenza più approfondita dei dati di fatto, risale in larga parte al libro di Modesto, che era stato tradotto in inglese nel 1906 e aveva avuto larga diffusione. Il legame di ¢ajkovskij con il testo di Pushkin era qualcosa di più profondo e viscerale di quello di un qualsiasi russo colto con uno dei capolavori delle patrie lettere. Il poeta era stato amico del decabrista Davydov, un discendente del quale aveva sposato la adorata sorella del compositore. Ed è a Kamenka, tenuta dei Davydov dove spesso ¢ajkovskij trascorreva lunghi periodi di riposo lontano da Mosca, che il 5 6
Introduzione a Romanzi e Racconti di Pushkin. Garzanti, Grandi Libri, 1973. La Dama di picche.
80 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
musicista nel 1877 si era lasciato ammaliare dalla musica dei versi di Pushkin. Nel giardino della villa c’era una grotta artificiale nella quale cinquant’anni prima si erano tenuti sontuosi banchetti. Un’orchestra di servi della gleba allietava i pranzi che Davydov offriva agli ospiti, tra i quali spesso si era trovato Pushkin. Nell’ombra della grotta ¢ajkovskij aveva più di una volta evocato commosso le ombre del cinico Onieghin e della ingenua Tatiana, sorridente al suo braccio. E ne aveva discusso a lungo con Elisabetta, una vecchia signora figlia del decabrista e sopravvissuta all’epoca in cui si svolge l’azione del romanzo. Pare che il musicista intendesse modificarne il finale, facendo abbandonare a Tatiana il marito, per rifugiarsi nelle braccia di Onieghin. Ma la dama lo scongiurò di non commettere un sacrilegio del genere contro il poeta che era stato un amico di famiglia. ¢ajkovskij riusci a superare i limiti di un libretto letterariamente non eccelso7 perseguendo un suo ideale di opera intima, di anti-opera in polemica dichiarata con l’estetica del grande spettacolo. Ne fanno fede sue dichiarazioni epistolari: “Che felicità essersi liberati dai noiosi faraoni, dalle incredibili principesse etiopi... quali ricchezze di poesia vi sono nell’Onieghin! Riconosco che ha dei difetti, non offre spunti ad effetti teatrali, ma lo splendore della poesia, l’umanità e la semplicità del soggetto espressi nei versi ispirati di Pushkin compensano tutte le manchevolezze!” L’allusione a Verdi è abbastanza chiara, e il musicista la ribadisce in un’altra lettera: “Ho composto l’opera perché mi sono sentito sollecitato ad esprimere in musica tutto ciò che nel poema chiede imperiosamente di essere espresso. Al diavolo l’efficacia teatrale! Che cosa sono mai gli effetti? Se l’Aida è un’opera di effetto allora ti dico che non comporrei un’opera su di un soggetto del genere, per nessun tesoro al mondo. Voglio creare esseri umani. non burattini”. Il risvolto più oscuro di un coinvolgimento così passionale con il testo, quasi un fatto personale, e rivelato da un passo di un’altra lettera a Modesto: “Sono innamorato di Tatiana”. Fino a quel momento, pare che il musicista vedesse nella romantica eroina una proiezione ideale della sorella Alexandra e forse vedeva in parte se stesso come Onieghin. Ma quando l’opera ancora non era maturata, arrivò la lettera fatale di Antonina Miliukova, l’ignota che dichiara eterno amore a ¢ajkovskij, professandosi fervida estimatrice della sua musica. Su questo episodio, oggi fin troppo noto e sfruttato nel film provocatorio di un regista non 7
Firmato da lui stesso e da S. K. Scilovski.
81 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
privo di talento, non converrà sostare più del necessario, per un senso di buon gusto, se non di pietas. La biografia onesta ed equilibrata che Lawrence e Elisabeth Hanson8 hanno dedicato al musicista ci dà la più ragionevole esposizione dei fatti. Una vicenda triste ma, dopo tutto non squallida, come può essere autorizzato a pensare chi abbia visto il film di Ken Russell. Ciò che preme a questo punto sottolineare è l’ulteriore coinvolgimento del musicista che vede fatalmente realizzarsi nella vita l’episodio centrale del testo da lui tanto amato (la lettera di Tatiana, a cui Onieghin rispose con un rifiuto mentre il musicista, per sua sfortuna, sposò la ammiratrice), e finisce per rimanere impigliato al punto da non riuscire a riscattare del tutto il groviglio torbido dei grezzi dati biografici. Se mai opera si presta a diventare terreno di caccia per critici psicanalisti, niente di più invitante di questa dolente e a volte querula elegia (un susseguirsi di “scene liriche”) che trova miracolosamente una sua unità di tono, anche se si intravedono oscuri retroscena nei quali, per altro, ogni schietto intenditore di musica si rifiuterà, per decenza, di gettar luce troppo cruda. Resterà se mai, da sottolineare la riuscita sul filo del rasoio, l’equilibrio precario di un musicista cosi personalmente e soggettivamente implicato nella sua materia musicale che mai come in questo caso sembra esser materia viva, sangue del suo sangue. Opera intima, certo, ma di un intimismo chiuso, soffocato, pervasa da una malinconia che, come dice bene Fedele D’Amico, stempera i conflitti drammatici in lirismi. Il risultato, dice sempre D’Amico, è un “lirismo quartettistico” che, per essere adeguatamente esplicitato nell’esecuzione, richiede direttori sottilmente congeniali a questo tipo di musica. ¢ajkovskij, in vita sua, non si dichiarò pienamente soddisfatto che di una esecuzione, colta a volo durante una breve permanenza ad Amburgo nel 1892. In un piccolo teatro di quella che allora era una città di provincia l’opera era stata affidata per la prova generale ad un promettente maestro trentenne. Era un suddito boemo di Francesco Giuseppe. Si chiamava Gustav Mahler. (da 43° Maggio Musicale Fiorentino, 8-V/7-VII, 1980, pp. 76-84)
8
Tchaikowsky, The man behind the Music. Dodo, Head & Co. New York, 1965.
82 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
NOTERELLA IN MARGINE AL RING 1976 PROFONDITÀ E CHIAREZZA
Per ogni wagneriano, sarebbe sicuramente auspicabile che l’estate del 1976 passasse alla storia soprattutto per un evento che si presentava come prevedibilmente clamoroso: la celebrazione sacrale del centenario della prima esecuzione del Ring sulla verde collina di Bayreuth, con un teatro esaurito da un anno come di rito e ascoltatori di tutto il mondo civile bloccati per quattro sere alla radio. E il clamore indubbiamente ci fu fin dalla cerimonia inaugurate, nel corso della quale Walter Scheet, presidente della Repubblica Federale, proclamò di non essere wagneriano, dimostrando di avere il senso diplomatico di chi sbandierasse la sua avversione per Verdi nel loggione del Regio di Parma, durante un intervallo. I fischi e gli ululati chiaramente udibili attraverso le trasmissioni in diretta sono consegnati ai nastri degli amatori e le recensioni della stampa, mobilitata al completo,1 riferirono allora di scontri non solo verbali dentro e fuori il teatro fra francesi e tedeschi, impegnati i primi a sostenere i due connazionali Boulez e Chéreau, artefici dell’impresa, e scatenati i secondi nel deplorare il presunto scempio di una secolare prassi scenica ed esecutiva.2 Un arguto critico inglese Harold Rosenthal ebbe a dire che forse tutta l’operazione aveva voluto essere una specie di rivincita ritardata per la sconfitta di Sedan, da parte dei francesi. A ripensarci oggi, sembra che in quella battuta ci fosse una parte di verità. In quel torrido luglio-agosto si era infatti voluto (in modo radicale e con un’arroganza intellettuale tutto sommato meritoria) non solo offrire una nuova lettura del Ring, non sappiamo quanto in polemica sotterranea con quella a suo tempo altrettanto reclamizzata attraverso canali così “giusti” dall’Incantatore di Salisburgo, ma soprattutto si era tentato di celebrare le problematiche nozze fra Kultur germanica e Civilisation francese. Due culture antitetiche da sempre, sotto il segno 1 Sul «Corriere della Sera» (8 agosto 1976) intervenne Bruno Visentini, in qualità di non addetto ai lavori. 2 Un giornale intitolò lapidariamente: Applausi francesi, fischi tedeschi. Titolo che sarebbe piaciuto a Victor Hugo.
83 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
di due paole cariche di fato: Tiefe (profondità) e Clarté. I due inquietanti sostantivi sono un po’ il marchio di fabbrica da cui distinguiamo a colpo d’occhio i prodotti di quelle due pregiate, solidissime ditte. La parola Tiefe evoca subito Gole di Lupo frequentate da demoni, squallide segrete dove gemono prigionieri di stato in attesa di una moglie virago che venga a liberarli, lotte di nani, giganti, dèi, eroi sullo sfondo del cosmo e catastrofi – appunto – cosmiche. Ma ci fa anche pensare ai sistemi filosofici ponderosi, alle summae di pensiero onnicomprensive e totalizzanti, di ardua decifrazione. Non si può affermare che la faculté maitresse dei geni germanici sia la divina levitas. Sia detto col massimo rispetto – mai un lampo di frivolezza. Piuttosto una pervicace predilezione per l’ombra. Del resto come concepire una profondità luminosa? Sarà superfluo sottolineare quanto i manufatti immessi sul mercato dell’industria concorrente siano radicalmente diversi per il peso specifico e per le caratteristiche essenziali e quanto, da Cartesio in poi, si sia insistito dall’altra parte del Reno sull’inestimabile pregio delle idee chiare e distinte. La Civilisation si propone di mettere ordine, etichettare, strutturare, comunque e sempre far “luce”. Non a caso la parola che più spendono i francesi in tutte le operazioni promozionali del loro patrimonio culturale è rayonnement che etimologicamente significa irradiazione. Luce quindi non ombra. Sarebbe quasi offensivo per l’intelligenza del lettore insistere su Carmen, opera assolata se mai una ve ne fu, nonostante un atto irrimediabilmente notturno. Per tornare al nostro discorso, nessuno vorrà dunque negare che le idee interpretative di Boulez siano quanto di più chiaro e distinto dar si possa anche se qualche malevolo potrebbe spericolarsi a sostenere che sul caso Wagner le idee del direttore francese sono un po’ come quelle di Donna Prassede, che, come tutti ricordano, erano poche e quelle poche storte. Comunque, la trovata di affidare a quel preclaro, puntigliosissimo musico il timone della nave del Ring centenario, è stata poco meno che geniale. Chi più di lui era rappresentativo dell’odierna cultura francese, antiromantica e strutturalista, con la sua presenza di antidivo, si direbbe quasi di antidirettore, che non si sognerebbe mai di troneggiare sul podio a occhi chiusi come la Pitonessa appollaiata sul tripode e che addirittura si presenta a ringraziare il pubblico con gli occhiali sul naso, come l’abbiamo visto alla Scala alla fine di una mirabolante esecuzione di Lulu? E quale choc deve essere stato per
84 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
l’ascoltatore tedesco il suo approccio “moderno” e antiretorico ad un testo tra i più alti in cui il germanesimo è programmatico se non provocatorio e che da sempre impone un ascolto rituale. Non spettacolo, ma Erlebnis, esperienza vitale. Per un wagneriano l’ascolto del Ring, è, deve essere, non può non essere ogni volta altro che un primo ascolto, con partecipazione fidente e totale abbandono. Il che non esclude affatto, anzi impone confronti che dovrebbero far tremare i polsi ad un nuovo interprete. Doveva essere più che scontato il carattere antitradizionale che avrebbe assunto la lettura di Boulez, per chi conoscesse le esperienze precedenti e la personalità del musicista, spregiatore, fiero ed esplicito di Verdi e del melodramma italiano ed invece frequentatore assiduo e sottilissimo fino alla adesione totale dei conterranei Debussy e Ravel nonché dei tre grandi della Seconda Scuola Viennese. È infatti difficile rivisitare intensamente gli alti luoghi della musica del Novecento, senza finire per aderire anche alla poetica che ne è stata la matrice, come osservava già Giorgio Vigolo in una sua cronaca musicale3 nella quale, a proposito di un Tristano e Isolda diretto da Ferdinand Leitner a Roma, il criticopoeta parlava di un suono leggero, di un suono inibito e ad esso contrapponeva il suono pieno di altri interpreti, facendo i nomi di Toscanini, De Sabata, Marinuzzi. Il maestro francese non è peraltro stato il primo ad alleggerire il suono wagneriano, a smorzare una presunta enfasi, a far scendere dai loro coturni i cantanti attori, a deromanticizzare, a perseguire quella dimensione cameristica che per primo coerentemente impostò Rudolf Kempe a Bayreuth nel 1960, dato di fatto che troppi hanno oggi dimenticato. Ma la novità radicale della visione interpretativa di Boulez ci sembra piuttosto consistere nella spietata analisi strutturale di un’oggettività ingegneristica, di una coerenza inflessibile e di una ostinazione quasi maniacale nel ricondurre ad una visione unitaria le infinite funzioni del testo. Nel suo Ring non ci sono temi conduttori, non ci sono personaggi, forse, come dice Franco Serpa, non c’è neppure il dramma. In compenso abbiamo una visione chiara e distinta e quasi allucinante di come il Ring è fatto. Boulez ne ha smontato i congegni. Ha 3
«Il Mondo», 5 aprile 1955. Vigolo parlava allora di un “complesso Wagner” da cui molti direttori sarebbero afflitti e di cui sicuramente mai ebbero a soffrire Furtwängler, Klemperer, Knappertsbusch, Krauss che sapevano darci la “cosa in sé” e senza inibizioni.
85 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
anatomizzato l’oggetto musicale, lo ha rimontato e ci ha fatto sentire come “funziona”. Sembra questo il senso ultimo dell’operazione gemellaggio Francia-Germania e se di rivincita su Sedan si può parlare essa è consistita essenzialmente in questo: un’intelligenza francese si è imperiosamente impadronita di un capolavoro germanico, permeandolo di clarté.4 Per concludere si dovrà francamente dire che una proposta del genere non era forse la più accattivante per un pubblico tradizionalmente cosi restìo alle novità e tanto composito da aver potuto includere tra i suoi membri nel corso degli anni due signore cosi diverse tra loro come Agatha Christie nella realtà (1958) e Madame Verdurin nella finzione. Se si aggiunge l’effetto urto della regia di Chéreau, della quale non abbiamo cognizione diretta, la reazione di rigetto doveva essere messa in conto preventivamente. La legittima curiosità di un dilettante digiuno di musica sarebbe a questo punto quella di sapere dagli addetti ai lavori se, e in che misura, l’interpretazione di Boulez apra o meno una nuova strada e se contenga le premesse di un Ring degli anni Ottanta. Si attende con interesse una risposta. (da «Auditorium», marzo-aprile 1982, p. 2)
4
Per completezza d’informazione, si tenga presente che l’idea di Boulez non risultò cosi messa a fuoco nel 1976 ma si è andata precisando nel corso delle repliche (l’allestimento è stato in cartellone cinque anni) ed oggi è consegnata attendibilmente alla registrazione integrale, a cura della Philips, che risale al 1979.
86 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
IL SETTECENTO DI PROKOFIEV
Nella variegata carriera del Prokofiev operista, Il Matrimonio al convento (prima esecuzione 1946) e l’Amore delle tre melarance (prima esecuzione 1921) sono le uniche due opere ispirate da soggetti non russi. Il musicista, scegliendo la fiaba del Gozzi e la commedia di Sheridan in due momenti diversi del suo itinerario creativo, ha fatto due precise opzioni ed operazioni culturali, allontanandosi in qualche modo dalla strada maestra dell’opera russa, da quel filone nazionale e popolare (Mussorgski) o liturgico-intimistico (¢iajkovskj) nel quale si doveva reinserire negli ultimi anni con Guerra e Pace, che sembra una sintesi dei due aspetti fondamentali di quella secolare tradizione, sotto il segno di un omaggio a Tolstoi, epitome e culmine della russicità. Il Matrimonio al convento, nella sua posizione un po’ defilata e atipica di commedia in musica, è almeno per il soggetto riconducibile ad un gusto occidentale. Risulta che l’autore lo considerasse un po’ il suo Cavaliere della rosa e il carattere dell’opera di Prokofiev, nel quale le parole “contano” e le battute devono “arrivare”, fa veramente pensare a Strauss, collaboratore di Hofmannsthal.1 Ma la scelta del testo del commediografo inglese in quegli anni può suggerire altre osservazioni di ordine diverso. Semiòn Kotko l’opera scritta da Prokofiev nel 1939 avrebbe dovuto filare sul binario del più rigoroso realismo socialista, ma risultò un lavoro di compromesso che non soddisfece i censori. Tratta da un romanzo di Valentin Kataev intitolato Io, Figlio del Popolo Lavoratore (1937) doveva essere un’opera patriottica, popolare, con eroi positivi. Ricordiamo che due anni prima c’era stato l’incontro del musicista con Eisenstein per il film Alexander Nevski anch’esso “positivo”, e “patriottico”, con un protagonista privo di dubbi, esemplare. Semiòn Kotko è il primo lavoro teatrale composto da Prokofiev dopo il ritorno definitivo in Russia dall’occidente nel 1933 e se il musicista doveva farsi perdonare il lungo soggiorno all’estero e le pericolose scorribande “modernistiche” ormai condannate dall’estetica ufficiale, di 1
Un’analogia esteriore sarebbe da sottolineare nell’ambientazione settecentesca. Manca comunque totalmente nei due musicisti il gusto intellettualistico del pastiche del ritorno a..., della musica al quadrato.
87 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
ben altro doveva fare ammenda l’irrequieto regista: la spericolata avventura messicana e il formalismo sperimentalistico del Prato di Bezin, un film di cui siamo stati irrimediabilmente defraudati. Ed è singolare come la carriera dei due artisti prosegua da allora negli anni di ferro dello stalinismo e della guerra contro la Germania nazista con una specie di pervicace, sotterraneo lavoro all’interno del sistema (culminante nel secondo incontro per le musiche di Ivan il Terribile) tra altalene e capriole per adeguarsi almeno formalmente a dettami, che tutti sappiamo quanto fossero cogenti ed in obbedienza a imperativi che definir categorici risulta eufemistico.2 Se si tiene presente il fatto che l’irlandese Sheridan è l’epigono della amorale e cinica commedia inglese della Restaurazione ed è comunque una voce, sia pur minore, di quella civilissima Età dei Lumi britannica, ancora intrisa di puritanesimo, che riconosceva nel dottor Johnson un dittatore del gusto, può sembrare a prima vista un atto di colpevole frivolezza evasiva da parte di Prokofiev la scelta di un testo che –danov, un dittatore del gusto ben più temibile, non doveva considerare adatto come soggetto di un’opera destinata al popolo russo, impegnato nella costruzione del socialismo. Sheridan è stato un personaggio abbastanza avventuroso e pittoresco. Figlio di un attore e di una scrittrice, fu mandato a studiare a Harrow, dove si anglicizzò, acquistando una solida cultura umanistica che gli permise di affermarsi non solo come commediografo ma come brillante oratore alla Camera dei Comuni. Si ricordano di lui le roventi accuse a Warren Hastings, ex-governatore dell’India, incriminato per concussione. Fuggì in Francia con Elisabetta Linley, una cantante il cui padre era maestro di musica e compositore. Rientrato a Londra dopo aver legalizzato la sua posizione col matrimonio, si affermò come commediografo nel 1775, presentando sulle scene del Covent Garden I Rivali (The Rivals) cui fece seguito nello stesso anno La Governante (The Duenna),3 commedia con musiche di scena composte dal suocero e dal cognato4 e che costituisce la base dell’opera di Prokofiev. (Il titolo verrà trasformato in 2
Semión Kotko ebbe comunque un successo di pubblico ma ci fu chi accusò Prokofiev di modernismo e l’opera sparì dal repertorio. Vedi per maggiori informazioni R. TEDESCHI, I Figli di Boris, Milano 1980 e –danov l’immortale, Firenze 1980. 3 La grafia inglese è scorretta lo spagnolo suona Duena. 4 Thomas Linley senior (1733-95) e Thomas Linley junior (1756-78). La Duenna fu musicata nel 1779 col titolo La Governante da F.G. Bentoni (1725-1813).
88 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
Il Matrimonio al convento poiché a quanto sembra la parola spagnola duenna (governante) sarebbe stata improponibile ad orecchie russe per il suo stesso suono). Nel 1776 Sheridan si associò al celebre attore David Garrick nella direzione del Drury Lane e per quel teatro scrisse il suo lavoro più apprezzato ed ancor oggi vitale: The School for Scandal (La scuola della maldicenza). Nel 1780 abbandonò il teatro per una carriera politica e parlamentare, militando nelle file dei Whigs e ricoprendo successivamente cariche importanti come Segretario al Tesoro, Sottosegretario agli Esteri e Tesoriere della Marina. Sarà anche intimo di Fox e consigliere privato del reggente, il futuro Giorgio IV. Perduto il seggio a Westminster nel 1812 e subiti una serie di rovesci finanziari (il nuovo Drury Lane da lui fatto costruire fu distrutto da un incendio nel 1809) Sheridan trascorse gli ultimi anni afflitto da malattie, gravato di debiti, tormentato dall’insonnia. Ma alla sua morte nel 1816 ebbe funerali solenni e l’onore di una tomba all’Abbazia di Westminster, forse più che per meriti letterari per le brillanti doti di statista e di oratore.5 Quanto al suo contributo al teatro, a giudizio della critica più recente esso sarebbe modesto e si limiterebbe ad un particolare gusto per il dialogo scintillante nel quadro della più tradizionale e codificata commedia di costume che farebbe di lui l’anticipatore di tutto un filone della commedia inglese che si prolunga fino a Wilde, Maugham, Coward. In particolare La scuola della maldicenza si segnala anche per la raffinata complicazione dell’intreccio. Cerchiamo di riassumere quello della Governante, chiedendo venia per la sommarietà. L’azione si finge a Siviglia; Mendoza, un vecchio commerciante portoghese di pesce marcio, progetta di associarsi con il nobile don Gerolamo che vuol fargli sposare la figlia Luisa. La giovane è innamorata di Antonio, nobile squattrinato, sgradito al padre ed è disposta a tutto pur di mandare a monte le progettate nozze servendosi dell’aiuto di Margherita, una poco avvenente e non più giovane governante che a sua volta aspira alla mano e alle ricchezze di Mendoza. La vecchia viene licenziata da don Gerolamo, perché sorpresa a recapitare a Luisa lettere dell’innamorato. Luisa scappa di casa e si presenta a Mendoza che non l’aveva mai vista, spacciandosi per l’amica Clara e proclamandosi innamorata di Antonio. Prega il vecchio di combinarle un incontro con l’innamorato e Mendoza acconsente. Intanto la gover5
Oltre alle opere citate Sheridan ha scritto per il teatro St. Patrick’s Day, A Trip to Scarborough, The Critic. I suoi discorsi alla Camera dei Comuni sono raccolti in cinque volumi.
89 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
nante, travestitasi da giovane e facendosi passare per Luisa, si presenta a Mendoza venuto in visita da don Gerolamo e gli propone di fuggire insieme per anticipare le nozze. L’intrigo si complica per la presenza di una terza coppia: Clara e il di lei innamorato Ferdinando, fratello di Luisa. Clara è fuggita di casa e si è chiusa in un convento di Orsoline, attiguo ad un monastero. Il monastero diventa la sede deputata in cui le fila si aggrovigliano sempre di più e gli equivoci alla fine si chiariranno. Antonio e Luisa, Clara e Ferdinando faranno benedire il sacro vincolo dai frati ubriaconi e lussuriosi, i due vecchi beffati prendono atto della situazione e dei due chi starà peggio sarà Mendoza, rimasto tra le grinfie della governante, sposa sgradita. Gli archetipi di questo plot sono riconoscibili a vista. Sheridan era uomo di buone lettere, conosceva Plauto e la Commedia dell’Arte e questi personaggi sono tutti facilmente etichettabili come funzioni o “maschere”: il vecchio balordo e autoritario, l’anziano innamorato e ridicolo, la coppia o le coppie degli innamorati contrastati che riescono sempre ad averla vinta, il servitore (in questo caso la governante) truffaldino e astuto che sta dalla parte dei giovani e regge le fila dell’intrigo ai danni dei vecchi, traendone un profitto personale.6 Le intenzioni di Prokofiev nei confronti della commedia di Sheridan, che era stata messa in scena negli anni ’30 in Russia, sono chiarite in una dichiarazione rilasciata al Sovinform Bureau il 26 Marzo 1943: “Quando ho iniziato l’opera sul soggetto di Sheridan avevo due possibilità: la prima era di sottolineare nella musica il lato comico dell’opera, la seconda di accentuarne l’aspetto lirico. Ho scelto la seconda soluzione... La costruzione del lavoro di Sheridan che contiene numerose canzoni mi ha permesso, senza arrestare il corso dell’azione, di scrivere tutta una serie di piccoli pezzi, di serenate, di ariette, di duetti, di quartetti, e di pezzi d’insieme, numerosi testi sono stati scritti da Mira Mendelssohn ispirandosi a Sheridan”.7 In effetti la commedia di Sheridan era un perfetto supporto per una specie di ballad opera alla maniera di John Gay e Samuel Pepusch, autori della fortunatissima Beggar’s Opera (1728) che è il prototipo più illustre del genere in Inghilterra. E la commedia con musica chiamata Singspiel sul continente. Alle parti dialogate si alternano brani musicali 6
Alcuni di questi archetipi risalgono a Menandro. In realtà la traduzione della Mendelssohn è molto libera e l’unico song tradotto quasi testualmente è quello della duenna nel II Atto: When a Tender Maid (Quando intorno a una fanciulla vergine). 7
90 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
solistici, duetti, terzetti, pezzi d’assieme e cori. Nelle parti solistiche si distinguono i songs dalle arie. Nella ballad opera i songs sono brani di origine o ispirazione popolare, nella comic opera sono distinti dalle arie formalmente operistiche e di tono più sostenuto ed elevato per un carattere più cantabile, un tono più basso che definisce in qualche modo uno status diverso del personaggio. Si pensi alle parti di Papageno e Papagena nel Flauto magico in contrapposizione alle arie sostenute dei personaggi “alti” oppure si consideri nel Fidelio lo status di Marcellina, Jaquino, Rocco, in confronto a quello dei due protagonisti. La distribuzione dei pezzi cantati nei tre atti della Governante rivela negli autori un gusto sicuro delle simmetrie interne oltre che della caratterizzazione dei personaggi: Primo atto: otto arie, due songs, due terzetti, un duetto, tre brevi assolo. Secondo atto: cinque songs, due terzetti, un duetto, nessuna aria. Terzo atto: quattro songs, un terzetto, un duetto, due cori, un finale vaudeville (vedi i finali del Ratto dal serraglio e di Fidelio). È agevole notare come le arie si addensino nel primo atto mentre i songs e i pezzi d’insieme prevalgono via via che la trama si infittisce. L’interesse per il plot predomina su quello per il personaggio. Ma Prokofiev non mirava ad un’opera a pezzi chiusi, non intendendo scrivere un altro Figaro ma piuttosto un Cavaliere della rosa e non a caso insiste, come si è visto, sull’esigenza di non arrestare il corso dell’azione. La librettista gli fornì un adeguato attaccapanni (per dirla con Barilli) usando abbastanza fedelmente le battute di Sheridan per i dialoghi ma terremotando le strutture del testo teatrale, smontandone e rimontandone il “congegno” con la sapienza con cui i critici formalisti russi in quegli stessi anni operavano sui testi letterari e con lo spregiudicato virtuosismo con cui Mejerchold leggeva i suoi classici in spettacoli apparentemente infedeli alla lettera, ma di una penetrante fedeltà allo spirito. Del resto Mejerchold aveva impostato la regia di Semión Kotko, prima di cadere definitivamente in disgrazia e scomparire in un campo di concentramento, e aveva attirato a suo tempo l’attenzione del musicista sulla fiaba del Gozzi. I personaggi sono rispettati in quanto “funzioni”: il vecchio balordo e sordido, l’innamorato ardente e spericolato, la ragazza ribelle,8 la vec8
Si noti come già in Sheridan le prime tre funzioni siano duplicate: due vecchi, due innamorati, due ragazze.
91 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
chia intrigante e smaniosa, con statuti da protagonisti chiaramente distinti dagli statuti dei personaggi subalterni che sono l’amico e confidente di Mendoza, il servo del giovane, le servette delle due ragazze, l’amico e il servo del vecchio don Gerolamo. Perfino il quartetto buffo dei frati ha un suo prolungamento in tono ancor più basso nei due novizi. Si noterà come la librettista abbia inventato cinque personaggi nuovi, tre frati dai nomi allusivi alla loro devozione per Bacco (frate Elisir, frate Chartreuse, frate Bénédictine) le due cameriere (Lauretta e Rosina) oltre a due parti mute (l’amico di don Gerolamo, suonatore di cornetta a pistoni e il servo Sancio suonatore di grancassa). Prokofiev si è trovato dunque a disporre di un libretto sapientemente articolato e predisposto ad un tipo di commedia musicale Durchkomponiert, in cui le parti solistiche si inseriscono senza soluzione di continuità nel discorso che è sempre sorretto da un’orchestra onnipresente e ammiccante con interludi ed episodi anche cameristici (un trio per clarinetto, cornetta a pistoni e grancassa). La raffinatezza dell’operazione della Mendelssohn si rivela non solo in certe piccole battute aggiunte (Don Giovanni e Don Chisciotte con sua moglie nella lista degli invitati alla festa di nozze)9 o nella scena totalmente inventata del trio di dilettanti che esegue un minuetto composto da don Gerolamo e sarà poi eseguito in onore degli sposi, sviluppato e ripreso alla fine dell’opera, permettendo così al musicista un sottile raccordo tra due scene, ma si evidenzia soprattutto nella scioltissima articolazione della materia drammatica, una serie di segmenti di varia lunghezza saldati da una linea serpentinata. Basta confrontare sommariamente il primo atto nelle due stesure. Quello di Sheridan si articola in cinque scene: Prima scena – Strada di fronte alla casa di don Gerolamo Seconda scena – Una Piazza Terza scena – Stanza in casa di don Gerolamo Quarta scena – Cortile della casa di don Gerolamo Quinta scena – Una Piazza Le prime due scene sono brevi, la terza è un po’ più estesa, la quarta un breve monologo di don Gerolamo, la quinta è molto estesa. Nella prima scena apre Lopez con un monologo, sopraggiunge Antonio con le maschere per fare la serenata a Luisa che risponde affac9
La battuta è stata inspiegabilmente sacrificata nella versione italiana (Atto IV, scena 9).
92 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
ciandosi alla finestra. Appare alla finestra anche don Gerolamo irritato che scaccia i seccatori. Mendoza appare solo nella quinta scena, verso la fine dell’atto, in compagnia dell’amico Don Carlos ed incontra don Gerolamo solo nella prima scena del secondo Atto. La Mendelssohn ha totalmente ribaltato il piano dell’azione, rimandando l’ingresso delle maschere alla scena quarta e presentando immediatamente i due vecchi che stringono il pactum sceleris. Le scene sono otto, tutte relativamente brevi e l’articolazione molto libera consente l’inserimento (scena sesta) di un intermezzo orchestrale di carattere orientaleggiante (danza delle maschere). Dopo un brevissimo assolo di don Gerolamo le maschere chiudono rapidamente l’atto. Si noterà anche come la governante che è la protagonista in titolo secondo Sheridan entri in azione solo nella prima scena del secondo Atto dell’opera anziché nella terza scena del primo Atto, come nella commedia. Del resto la titolarità era già stata tolta al personaggio motore dell’azione e ideatore dell’intrigo, spostando l’accento sul “matrimonio al convento” quindi sul congegno stesso che diventa in tal modo il tema centrale. Non che Prokofiev rinunzi ad una caratterizzazione strumentale delle sue “maschere” ma si ha l’impressione che l’interesse primario del musicista sia altrove e si appunti essenzialmente sul plot e su tutti gli appigli che i suoi risvolti gli offrono: il trio strumentale, la danza delle maschere, il coro delle pescivendole (manca in Sheridan). Merito del commediografo è la trovata della simmetria speculare (mantenuta dalla Mendelssohn) tra i duetti amorosi di Antonio e Luisa. Una prima volta i due innamorati sono chiusi in camera e spiati da Mendoza che commenta con l’amico Don Carlos l’azione intravista dal buco della serratura (scena di voyeurismo singolarissima nella storia del teatro in musica); la scena si ripete nel giardino del convento e questa volta la spettatrice è Clara, titolare di una funzione drammatica (la seconda amorosa) rovesciata rispetto a quella del vecchio gabbato.10 Tornando a considerare i personaggi è interessante sottolineare la scomparsa totale dell’antisemitismo sgradevolmente presente in Sheridan che non lascia dubbi su chi sia Isaac Mendoza (Hebrew Scoundrel)11 di cui si sottolinea il ripugnante aspetto fisico con violenza quasi scespiriana: 10
Atto II, scena quarta e Atto III scena terza della commedia; Atto III, scena seconda e scena settima dell’opera. 11 Canaglia di ebreo. Atto II, scena terza.
93 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
“Un corpo gonfio per l’idropisia! Un paio di occhi che paiono due scarafaggi morti spiaccicati in un blocco di pastafrolla! Una barba che pare un carciofo, con due gote risecchite e grinzose da far arrossire la mummia di uno scimmiotto!” (Atto III, scena settima). Insomma, un discendente di Shylock e di Barabas, l’ebreo di Malta del Marlowe. In linea generale si può notare come il tono satirico piuttosto acre del commediografo inglese si ingentilisca soprattutto in virtù della musica. Si è visto del resto come l’intento esplicito del musicista fosse quello di privilegiare l’aspetto lirico. Ma ciò che più sorprende l’ascoltatore è l’equilibrio raggiunto tra divertimento e abbandono sentimentale, una fusione di commedia e di lirismo che nel teatro del Novecento sono caratteristiche dello Strauss più felice, quello del Cavaliere della rosa e di Arianna a Nasso.
(da 45° Maggio Musicale Fiorentino, 27-II/4 VII, 1982, n. unico, pp.71-78)
94 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
LETTERATURA E MUSICA POUND E IL RINASCIMENTO VIVALDIANO
Poesia e musica, l’incanto della parola incastonata nel verso e la magia del suono, scrittori e musicisti. Argomento tra i più inquietanti ed ardui, tema proteico tra i più elusivi e seducenti. Gli esempi si affollano alla memoria, disordinatamente. Baudelaire, archetipo della poesia moderna e profeta del wagnerismo in Francia che intuisce e proclama la grandezza del trageda d’Oltre-Reno avendone ascoltato solo poche pagine, e non delle più alte, quando ancora in patria Wagner era parzialmente noto o misconosciuto o addirittura pervicacemente osteggiato. Mallarmé, che saluta “le dieu Richard Wagner” come un modello ideale e se ne appropria il Klang nuovo e misterioso, i singhiozzi sibillini, integrandoli nella sua poesia: “Trompettes tout haut d’or pamé sur les vélins”. André Gide che suona per se stesso il suo Chopin e, quando si azzarda a scriverne nel suo francese terso, affilato, verrà morso dagli specialisti che lo accuseranno di superficialità. Sono tre esempi di lettura-interpretazione soggettiva, splendidamente unilaterale. Un esempio principe di lettura oggettiva e impietosa è invece quello di Thomas Mann, wagneriano dall’intelligenza così acuminata, si vorrebbe dire tagliente, che i suoi saggi sul musicista amatissimo e diuturnamente frequentato attirarono sulla sua testa le folgori del funesto Imbianchino ed ancor oggi sono letti dai wagneriani più ortodossi con qualche sospetto e riserva. Mai amore fu più vigile e smagato di quello del narratore di Lubecca per il musico sassone del quale si appropriò la tecnica in quel grandioso Ring steso in una prosa sontuosa, musicalissima e intessuta di Leitmotive che è Giuseppe e i suoi fratelli. Un caso atipico è quello del provocatorio G. B. Shaw. La sua drammaturgia è quanto dar si possa di più lontano dal sistema wagneriano, ma l’irlandese intuisce e definisce la novità e il peso specifico dell’operazione wagneriana. 95 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
Shaw è un wagneriano ironicamente “perfetto”. Anche se la sua interpretazione “di tanto mal fu matre”, avendo in qualche modo ispirato molte recenti regie socio-politiche, siamo pur sempre debitori a Shaw di molte osservazioni da non sprezzare, con buona pace dei bidelli del Valhalla. Ma in un certo periodo della sua vita Shaw è anche ed essenzialmente un critico professionista, un cronista di cose musicali (Corno di Bassetto era il suo nom de plume) e siamo pertanto di fronte ad uno scrittore che parla di musica con un bagaglio di conoscenze tecniche adeguato. Non si limita a privilegiare un solo autore ed estende il suo interesse ad una gamma molto vasta di musicisti, non disdegnando neppure Gilbert e Sullivan. Per gli altri scrittori di cui si è fatto rapido cenno l’orizzonte musicale si restringe di volta in volta a Wagner o a Chopin, come per Stendhal la musica era stata Mozart, Rossini, Cimarosa. Si tratta pur sempre di dilettanti, di una classe superiore, s’intende, ma per i quali la musica era, non si osa dire irrispettosamente un hobby, ma certo un vizio segreto, un interesse collaterale, qualcosa di privato, il che nulla toglie alla felicità di certe intuizioni che talvolta hanno anticipato i giudizi dei musicisti, sempre pronti peraltro a sottolineare la mancanza o la scarsezza di basi tecniche dei dilettanti. La posizione di Shaw è omologa a quella da cui è partito Ezra Pound nel suo approccio al mondo della musica, in quanto anche il poeta americano si dedicò alla critica militante di cose musicali dal 1917 al 1921, curando con lo pseudonimo William Atheling una rubrica quindicinale sulla rivista inglese «The New Age» e collaborando anche ad altri periodici. Le sue prime esperienze di critico risalgono peraltro al 1908, anno in cui da Venezia si trasferisce a Londra che era allora una capitale letteraria ma non poteva vantare una vita musicale paragonabile a quella di Parigi o di Vienna. Il ventitreenne Pound collabora dunque ad alcune riviste scrivendo anche di arti figurative. Non aveva fatto regolari studi musicali, ma il suo forte interesse per la musica era stato alimentato dalle intense discussioni con amici musicisti e lo scrittore si era gradualmente impadronito di un linguaggio non troppo tecnico, ma tanto preciso da permettergli di evitare errori troppo gravi. Murray Schafer, lo studioso che ha ordinato sistematicamente gli scritti musicali di Pound, in appendice ad un ampio ed informato saggio,1 afferma 1
R. MURRAY SCHAFER, Ezra Pound and Music, Londra, Faber & Faber, 1978.
96 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
che già in quei primi anni di esercizio della professione, il “dilettante” era già ad un livello di gran lunga superiore a quello della media dei collaboratori dei grandi giornali. Ma vediamo quali erano i suoi interessi, diciamo pure le sue inclinazioni umorali, i parametri del gusto. Vaughan Williams e John Ireland, due compositori contemporanei di fama consolidata e pacificamente accettati, sembrano interessarlo poco e Pound si orienta subito verso una scelta molto personale e nettamente divaricata. Da una parte la lirica elisabettiana (Dowland, Lawes, Campion) che sarà la musica prediletta del suo grande protetto James Joyce e verso la quale lo indirizzerà un amico, il musicista Arnold Dolmetsch. Dolmetsch era uno studioso di musica antica, costruttore di clavicembali, esecutore e teorico delle tecniche esecutive. Il suo manuale The Interpretation of the Music of the XVII and XVIII Centuries (Londra 1915) è un libro fondamentale sull’argomento. Dolmetsch era anche un talento pratico, un animatore culturale e fondò nel 1925 a Haslemere un festival di musica antica eseguita su strumenti costruiti dalla sua ditta che aveva sede nella stessa cittadina del Surrey. Il musicologo e il poeta si legarono di una forte amicizia tanto che Dolmetsch regalò a Pound il suo clavicordo originale che Pound portò sempre con sé a Londra a Rapallo e a Brunerburg (Merano). Quel modo di far musica, di divulgarla organizzando concerti deve essere stato determinante per il Pound di un periodo successivo quando diverrà l’instancabile animatore di un’attività analoga nel Golfo del Tigullio e infine a Siena. È questo aspetto pratico, fattivo degli interessi di Pound, che fa di lui quello che oggi chiamiamo un organizzatore culturale. Ma si parlava di scelta divaricata: da una parte i liutisti e i virginalisti elisabettiani, dall’altra certa musica di avanguardia. E per questo versante del gusto di Pound, la figura chiave è quella del pianista e compositore americano di origine polacca George Antheil che definirà se stesso “il ragazzaccio della musica” come suona il titolo della sua autobiografia pubblicata nel 1945. In molti dei suoi articoli Pound si occupa della musica di Antheil e, nel 1924, pubblica un saggio di una certa ampiezza su di lui. Ma il poeta nutriva anche ambizioni di compositore e sarà sempre Antheil
97 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
ad aiutare l’amico dilettante per l’orchestrazione dell’opera Le Testament che verrà eseguita il 19 giugno 1926 nella Salle Pleyel a Parigi. Della piccola orchestra faceva parte la violinista Olga Rudge che sarà personalità ancor più determinante per gli orientamenti del gusto di Pound e per quella che forse si può definire la sua educazione musicale. Già nel 1920, il poeta aveva recensito con entusiasmo un suo concerto londinese («The New Age», 25 novembre), ma le fu presentato solo in seguito a Parigi. La giovane violinista, figlia di un cantante, era venuta in Europa a nove anni, aveva studiato a Parigi e si era esibita riscotendo successi di critica a Londra, Parigi, Vienna, Roma. Aveva un gusto aristocratico e non amava il virtuosismo di Sarasate che definiva “volgare”. Coltivava peraltro la musica contemporanea e, tra i suoi autori, troviamo Pizzetti, Respighi, Malipiero, Castelnuovo Tedesco, Nadia Boulanger. Al suo incontro con la violinista, Pound dedicherà nel 1933 un articolo sul giornale di Rapallo («Il Mare», 30 settembre), durante la sua permanenza in Italia, negli anni ’30. L’11 dicembre 1923, Antheil e la Rudge, alla Salle du Conservatoire di Parigi inseriscono in un loro concerto due pezzi di Pound: l’arrangiamento per violino solo di un’aria del XII secolo di Gaucelm Faidit, un trovatore limusino, e una breve composizione originale intitolata Sujet pour violon. Quest’ultimo brano verrà eseguito sempre dalla Rudge il 10 maggio 1924 alla Aeolian Hall di Londra insieme ad un altro pezzo intitolato Fiddle Music, First Suite. Altri brani di Pound furono presentati dalla Rudge a Parigi il 7 luglio 1924. Un particolare significato assume la presentazione a Roma alla Sala Sgambati, di un Hommage à Froissart con un complesso che vide al pianoforte Alfredo Casella: Rudge e Casella sono infatti i nomi che ritroveremo lungo il cammino di Pound musicista fino al periodo di Siena. Olga Rudge segue il poeta a Rapallo nel 1933, si stabilisce a Sant’Ambrogio un paese vicino e sarà sua co-audiutrice e l’animatrice della preziosa serie di concerti che Pound organizzerà nel Golfo del Tigullio dal 1933 al 1936. Come è noto, diventerà in seguito una figura chiave del Rinasci-
98 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
mento vivaldiano a Siena, come segretaria dell’Accademia Chigiana e fondatrice del Centro di Studi vivaldiani. Facendo in qualche modo il punto su questo primo periodo, si può; dire che Pound, partito come i suoi due grandi conterranei James e Eliot alla conquista dei Vecchio Continente, nell’intento di appropriarsene i valori perenni, senza rinnegare un’americanità di fondo, non si accosta alla musica come ad un violon d’Ingres, un interesse marginale. Essa è un’attività per la quale si è attrezzato tecnicamente, avendo anche ambizioni di compositore, e come critico il suo gusto è ben orientato. Opera scelte molto nette e giudica motivatamente. Ma vediamo come lui stesso presenta (nel 1924) il suo doppio William Atheling: “W.A. scriveva ogni due settimane su «The New Age»; era in sintonia con le opinioni di Arnold Dolmetsch e, a suo avviso, la musica finiva con Bach […]. Scriveva nella speranza di rendere possibile e più facile ai migliori esecutori dare sempre il meglio di sé di fronte al pubblico e non il peggio o il mediocre. Egli amava ascoltare Mussorgskij e preferiva la spoglia grandezza dei russi alla tappezzeria dell’Europa ottocentesca. Amava la musica dotata di una forte azione orizzontale, preferendola a quella che sembra sgorgare dalla terra. Aveva in comune con me l’interesse per le composizioni in cui musica e parola si adattano l’una all’altra […]. Rimpiangeva la civiltà perduta di Henry Lawes”. Pound, in sostanza, si contrappone al gusto insulare cioè provinciale dell’Inghilterra di quegli anni e non mostra eccessiva simpatia per quella che veniva definita la tradizione teutonica, il che significava mettere fra parentesi larga parte della produzione strumentale dell’800, da Beethoven a Brahms. Il suo interesse di critico va prevalentemente a concerti di quello che definisce Bel Canto2 o di pianisti, anche se per il pianoforte sembra avere quello che Murray Schafer definisce un complesso di amore-odio. Anche la sua attenzione per la musica contemporanea è, a dir poco, selettiva se si pensa che non ritiene di dover parlare di alcune importanti prime londinesi fra le quali: 2
Caccini, Caldara e Vivaldi sono indicati come esponenti del Bel Canto in un articolo su «The New Age» (25 novembre 1920).
99 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
Skrjaban, Prometeo, 1913. Schoenberg, Cinque pezzi per orchestra, 1912. Ravel Valses nobles et sentimentales, 1913. Stravinskij, Le Sacre du Printemps, 1913 Quest’ultima composizione fu eseguita in forma di balletto da Thomas Beecham.3 Se si ripercorrono rapidamente i nomi dei ‘suoi’ autori di quel periodo e se si ricorda anche una sua sprezzante definizione della Sonata Chiaro di Luna di Beethoven (a bore, più o meno una barba) troviamo quasi un preannuncio dell’atteggiamento mentale di quel capriccioso puritano della musica che fu Glenn Gould, con il quale Pound forse sarebbe andato abbastanza d’accordo. E forse il pianista canadese avrebbe volentieri sottoscritto questa sua affermazione programmatica, “La funzione della critica musicale [...] è di rendere possibile ai migliori esecutori presentare il loro lavoro al meglio; dare concerti nelle condizioni attuali senza fare concessioni di sorta all’ignoranza e al cattivo gusto”. È negli anni 1928-1941 che Pound, stabilitosi a Rapallo, dopo aver lasciato Parigi nel 1924 per l’Italia, in cui risiederà circa vent’anni, diviene il punto di riferimento di un gruppo di intellettuali e musicisti, nonché l’animatore di una serie di concerti (1933-1939) i cui programmi, tutt’altro che casuali, portano l’impronta della forte personalità di quello che gli abitanti di Rapallo chiamavano il “Signor Poeta”. Pound che si dedica ora soprattutto alla stesura dei Cantos, nei quali molti dei suoi amici avranno l’onore di una menzione4 è un nome prestigioso e tra i suoi visitatori abituali troviamo poeti e musicisti, tra i quali Yeats, Zukofskij, Serly, Ronald Duncan. La sua presenza fa di un paese, che negli anni ’30 contava circa 5.000 abitanti, una piccola capitale delle lettere e della musica. Il poeta riceve i suoi ospiti nell’appartamento al quinto piano dell’Albergo Rapallo, in Via Marsala, con le finestre che danno sul mare e, intorno a lui, si forma gradualmente un piccolo cenacolo di fedeli.
3
Al Sacre, Pound accennerà in un articolo sul «New English Weekly» del 28 marzo 1935 in cui afferma di aver presenziato alla prima esecuzione inglese. Ma il suo apprezzamento va piuttosto ai Tre Pezzi per Quartetto d’Archi, uditi il 9 aprile 1919. 4 Dolmetsch, Cantos LXXX, LXXXI, XCIX; Antheil, LXXIV.
100 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
Pound stesso ci dice come nacque in lui l’idea di organizzare una serie di concerti. Trovandosi a Cesena, per uno studio sulla vita di Sigismondo Malatesta, fu invitato ad un concerto organizzato da Manlio Dazzi, un bibliotecario appassionato di musica che lo aveva aiutato nelle sue ricerche. “Era un programma composto di musica di altissima qualità e un avvocato del posto (al pianoforte) dette un contributo più interessante di quello dei musicisti professionisti importati da fuori per l’occasione. Cesena non è certo una grande città, ma Szigeti ci aveva suonato qualche settimana prima […]. Cesena mi ha fatto capire come si può far eseguire musica di primissima qualità in una piccola città”. Tra i primi ad affiancare Pound nell’impresa troviamo la fedelissima Olga Rudge e Gerhart Munch, un pianista e compositore di Dresda. Ad essi si uniscono Luigi Sansoni, che dirigeva una piccola orchestra locale al “Kursaal”, dove si eseguiva anche del jazz, e Marco Ottone, un violoncellista di Chiavari. C’è una frase lapidaria del poeta in un saggio intitolato Civilization, del 1937: “La civiltà ha inizio quando la gente comincia a preferire il poco fatto bene al molto fatto male”. In un articolo dell’11 aprile 1936, pubblicato su «Il Mare», sul quale la firma di Pound comparirà con una certa frequenza, le intenzioni sono inequivocabili: “Ho detto parecchie volte che è inutile fare su scala più piccola a Rapallo quello che si fa splendidamente e con gran dispendio altrove”. L’ideale quindi non è certo un’altra Salisburgo; ma piuttosto qualcosa di simile a quello che, ai giorni nostri, è il festival di Adam Pollock a Batignano. Professionismo, programmi non banali, la qualità della musica prima di tutto. Un altro criterio sarà quello dell’esclusione drastica dei grandi virtuosi, che rischiano di oscurare con la loro personalità prevaricante il pensiero originale del compositore. Scrive ancora Pound: “I concerti di Rapallo sono stati un laboratorio per un esame oggettivo della musica”. E il termine “laboratorio” ricorre spesso in uno de suoi saggi più importanti (The ABC of Reading, 1934). Quindi, un atteggiamento oggettivo, scientifico, che pone anche l’esigenza di un’organicità nella composizione di programmi. Un concerto utile, secondo Pound, è quello il cui programma per-
101 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
mette di mettere a fuoco un particolare “pensiero” (thought) musicale o di afferrare sfumature di un certo numero di pensieri musicali analoghi. Ci si può fare un’idea precisa di che cos’è una sonata per piano e violino di Mozart, solo quando “gli stessi” artisti eseguono molte di quelle sonate, articolate in una serie. Lo stesso può dirsi dei concerti di Vivaldi e dei quartetti di Bartòk. Pound insiste sull’importanza dei confronti e pensa ad una esecuzione dei quartetti di Ravel e Debussy nello stesso concerto. Il reverendo Desmond Chute, un fedele frequentatore ed occasionalmente recensore dei concerti di Rapallo, li definisce “preziosi e indimenticabili”. Programmi molo ricchi e variati, a considerarli oggi nel loro insieme. Gli autori prescelti vanno dalla musica medioevale a Chopin, da Mozart a Bartòk (uno degli autori contemporanei che più hanno interessato Pound, che ne ha paragonato l’importanza nel panorama della musica del Novecento a quella di Beethoven, nel suo secolo). Un esempio significativo di questi programmi organici è l’esecuzione integrale del Clavicembalo Ben Temperato in tre pomeriggi consecutivi, di cui non si trova la recensione su «Il Mare», essendo stati dei récital per invito. I concerti di Rapallo furono tenuti in due periodi: due stagioni iniziali consecutive, fino al momento in cui Munch lasciò la Liguria nel luglio 1935, e una seconda serie dalla primavera del 1936 fino allo scoppio della II Guerra Mondiale, caratterizzata dalla presenza di un maggior numero di artisti ospiti e un interesse più accentuato per la musica contemporanea,5 e per Vivaldi. In questa seconda fase, si invita anche qualche nome famoso, ma sempre come esecutore e mai come “divo”. “Quando abbiamo avuto dei nomi celebri, essi non sono stati sollecitati da grossi cachet ma sono stati invitati solo in quanto musicisti”. Tra i principali collaboratori, oltre ai nomi già ricordati, incontriamo il violinista e compositore americano di origine ungherese Tibor Serly. A lui va il merito di aver sollecitato Pound ad occuparsi di Bartòk, di cui era amico personale.6 5
Pound cercherà di entrare in contatto personale anche con Hindemith e Stravinskij che non verranno mai a Rapallo, ma alcune oro composizioni saranno inserite nei programmi. 6 Serly completò e orchestrò il Concerto per viola e orchestra.
102 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
L’organizzazione familiare dei concerti merita un cenno, perché anche in questo Pound sembra anticipare il gruppo di Batignano. Il ricavato dei concerti andava agli esecutori, escluse 10 lire destinate alla maschera. Il comune cedeva gratuitamente la sala del consiglio e gli aveva fatto installare a sue spese un calorifero. Dal 1933 i concerti si tennero anche al cinema “Teatro Reale” preso in affitto. Pound non solo si occupava delle locandine, ma scriveva recensioni, a partire da un certo periodo direttamente in italiano, e curava i programmi di sala che distribuiva lui stesso, oltre a vendere i biglietti. Dorothy Pound così descrive il pubblico: “Arrivava a volte ad un massimo di 80 persone, ma era un pubblico di élite, molto entusiasta”. Ben presto la vicina Chiavari ebbe un’iniziativa analoga, di cui Pound fu ben lieto e che riuscì a richiamare circa 300 ascoltatori. E quando, nel 1939, l’Accademia Chigiana di Siena si propose di concentrare la sua attenzione su Vivaldi in modo sistematico, il poeta vide in questa iniziativa, alla quale sia lui che Olga Rudge contribuirono (anche per il loro legame con Alfredo Casella), come la realizzazione pratica di un suo ideale della musica e del modo di far musica. L’anno 19367 segnò l’inizio di un interesse continuativo per la musica strumentale di Vivaldi, che comportava anche una serie di ricerche musicologiche in un campo che fino allora non era stato esplorato a fondo.8 Il poeta mandò Olga Rudge a Torino a catalogare 309 composizioni di Vivaldi, i cui manoscritti (27 volumi) erano conservati alla Biblioteca Nazionale e ordinò nel 1937 i micro-films di tutto il materiale vivaldiano conservato la Biblioteca Sassone di Dresda. Parecchi di quei micro-films furono poi ceduti al conte Guido Chigi Saracini nel l938 andando ad arricchire il fondo della Biblioteca dell’Accademia ed alcuni concerti furono eseguiti nel 1939 nel corso della Settimana Musicale, sotto la direzione di Casella, data ufficiale dell’inizio del Rinascimento Vivaldiano, per quanto riguarda l’esecuzione dal vivo.
7
Pound inaugurò gli studi su Vivaldi con un articolo su «Il Mare» (14 marzo 1936), al quale seguirono due articoli (in aprile e maggio) della Rudge sempre su quel giornale. 8 Tra i predecessori di Pound e della Rudge, troviamo Arnold Schering, Marc Pincherle e Alberto Gentili.
103 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
Noel Stock nella sua biografia del poeta (The Life of Ezra Pound, 1910) così definisce il ruolo di Pound in questa occasione: “La parte che Pound ha avuto nel Rinascimento vivaldiano può essere considerata duplice. Egli fu un personaggio chiave come organizzatore in un primo periodo, ma più importante, nella lunga durata, furono probabilmente il costante incoraggiamento e il sostegno da lui dato ad Olga Rudge.9 Egli le trasmise il suo entusiasmo e la aiutò a superare vari ostacoli, col risultato di farle portare a termine un difficile lavoro di ricerca musicologica che era al di fuori della portata dello stesso Pound”. E vorremmo aggiungere,che nel campo della musica, il poeta rimase in qualche modo fedele a quella sua vocazione o funzione di “catalizzatore” che gli riconoscono i critici letterari. Il corista che dà il la, dirà Mario Praz. Non si potrà mai dimenticare che fu lui a mettere in mano all’editore Heinemann il manoscritto di Ulysses e a farne pubblicare in anticipo larga parte sulla rivista «The Egoist», né si potrà non ricordare il lavoro di drastico sfrondamento e rielaborazione a cui sottopose The Waste Land, divenendone quasi il coautore. Salutiamolo, dunque, grati con l’epiteto dantesco “il miglior fabbro”, con cui gli si rivolse T.S. Eliot, nella dedica di The Waste Land. (da «Chigiana», vol. XLI, anno 1989, pp. 41-52)
9
Olga Rudge, poi, diventa Segretaria dell’Accademia Musicale Chigiana e nel 1928 curerà in seguito la pubblicazione dei testi.
104 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
UN CRITICO PIÙ SOTTILE DEL SUO TEMPO Sandro Bernardi
Ho scoperto tardi che Giulio de Angelis non era solo un letterato squisito, ma era anche uno spettatore prezioso e un ricercatore inesausto per il cinema. Conoscevo da sempre il suo nome. Mio padre era un insegnante d’inglese, appassionato lettore di Joyce e mi aveva insegnato a compitare lo straordinario intreccio di riferimenti grazie alla guida scritta dal traduttore, il mitico Giulio de Angelis che lui non aveva mai avuto l’occasione di conoscere. Era per me un’Arianna che ci guidava attraverso quel labirinto e ce ne svelava la meravigliosa complessità. La prima volta che lo incontrai, grazie a un amico comune, in una delle più belle librerie fiorentine, rimasi a bocca aperta: non credevo che mi sarebbe mai capitato, avevo troppo sognato di lui. Eppure era lì, un professore semplice riservato e modesto, come se non avesse mai fatto niente d’importante. Poi mi chiese subito una cosa che cercava da tempo, da ricercatore a ricercatore. Si trattava di alcuni versi del seicento francese, una piccolissima poesia “preziosa” che veniva pronunciata in un certo film in costume del 1976, da una dama immersa in una vasca da bagno. Confesso che rimasi sconvolto, il compito mi sembrava impossibile da risolvere, ma ci avessi impiegato il resto della mia vita sarei riuscito a dargli una risposta, se lui se l’aspettava da me. Sapevo che aveva scritto cose di cinema, glielo avevo chiesto, ma lui non ne voleva parlare, erano cose “senza importanza”, diceva. Ora sono qui, leggo e rileggo queste pagine di «Cinema» e di altre riviste, e ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, prendo atto del fatto che la cosa più bella è guardare con gli occhi di un altro. Questi film di cui parla, che conosco quasi a memoria, leggendo le sue parole mi sembrano opere nuove, sconosciute. Soprattutto mi colpiscono le straordinarie riletture di grandi classici, scritte fra il 1952 e il 1953, nella rubrica intitolata “Filmoteca”, che gli servono per impostare une vera e propria estetica, spesso in polemica con i suoi contemporanei.
105 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
Così è per esempio con Vampyr, («Cinema» del 30-4-1953), dove de Angelis sottolinea l’esattezza e la libertà delle immagini che si susseguono con un ritmo ipnotico e la conclusione improvvisa che sembra venire da sola, senza che il protagonista muova un dito, lasciandoci ancora più stupefatti e spaventati che mai. De Angelis in questa pagina ha colto quello che solo molti anni dopo si sarebbe potuto comprendere meglio: che Vampyr è un film sull’atto del guardare, che lo stato catatonico e sonnambulesco del protagonista, trascinato avanti e sempre più avanti dai suoi stessi occhi, verso scoperte sempre più paurose, inefficiente e impotente, rappresenta semplicemente e terribilmente la nostra condizione di spettatori. È un film che parla a noi di noi stessi, che ci mostra il nostro volto, e per questo ci fa paura ancor oggi. De Angelis sottolinea le contraddizioni, i paradossi del film. Il dottore che nega l’evidenza (“Qui non ci sono né cani né bambini” mentre si ode un vagito e un latrato), il suono della campana che sembra una cosa solida attraverso la nebbia, il ballo delle ombre, che sembra tolto di peso da un film di Clair, ma rovesciato di segno, perché quelle che vediamo sono ombre senza corpo, il guardiacaccia che cade fulminato senza ragione, il dottore che precipita nella macina del mulino, quelle in cui Gray vede se stesso. Sono tutte scene sul cinema, su quell’inquietante doppio del mondo che è il cinema. Oppure mi colpisce la rilettura di un’opera oggi quasi dimenticata come Il tesoro di Arne, un film di Stiller del 1919, in cui de Angelis viene colpito dall’uso della sovrimpressione e parla di “montaggio interno all’inquadratura”, usando un’attenzione al linguaggio e ai procedimenti filmici in un periodo in cui l’attenzione della critica cinematografica si dirigeva quasi esclusivamente ai contenuti e ai temi delle opere, cosa che lo avrà certamente reso sospetto di formalismo agli occhi dei suoi contemporanei (la recensione è del 15 gennaio 1953). O ancora la rilettura del film di Stroheim Merry-Go-Round (1922), una pagina del 31 luglio 1952 in cui commenta le considerazioni di André Bazin sul “cinema della crudeltà”, proponendo di sostituire la crudeltà con la nozione di “intransigenza”, dato che la stessa onestà artistica e morale rese Stroheim insopportabile ai produttori del suo tempo e rese per lui insopportabile il suo tempo. Oppure Que viva Mexico! in cui, sempre nel 1953, elogia il realismo eisensteiniano, commenta la durezza di quelle immagini e la confronta con l’edulcorata visione della guerra nel cinema americano. Anche in un’altra rubrica, “Biblioteca”, che credo sia la prima rubri-
106 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
ca dedicata a libri di cinema in Italia, troviamo un lavoro di grande impegno, insolito per quei tempi in cui la definizione “critico cinematografico” era quasi sinonimo di “ignorante”. Per esempio la tempestiva segnalazione del libro di Marie Seton su Eizenstein, ancora inedito in Italia, subito dopo la sua uscita in USA nel 1952, o del libro di Spottiswood sulla tecnica del film («Cinema» n.112, 30 giugno 1953) o ancora del libro in tedesco di Kleiner e Leutenegger che per primo tracciava una topografia dei generi nella storia del cinema. Sono tutte pagine in cui si nota non solo una straordinaria vitalità di pensiero, ma anche una tempestività nel segnalare al lettore italiano gli studi più importanti pubblicati in tutto il mondo. Ora questo è più facile, ma la maggior parte delle nostre riviste, chiuse nello snobismo dei festival o nella spocchia dell’università, non sa praticare il connubio di ricerca e gusto di spettatori, che neppure allora era poi così comune. De Angelis come critico modello, come esempio da seguire ancora oggi? Non so. Molte cose sembrano certamente datate, ma lo scintillio di alcune grandi intuizioni mi fa pensare che guardare è un’attività sempre nuova e che non si guarda mai un film con gli stessi occhi. Tuttavia, poiché di questi film ormai non parla quasi più nessuno, e poiché è divenuto ormai difficile anche vederli, dobbiamo contentarci se questi film possiamo almeno “leggerli”, nelle sue descrizioni. Descrivere è una cosa difficile, e nella straordinaria semplicità con cui de Angelis evoca davanti a noi alcune scene in modo indimenticabile, mi sembra d’intravedere un’ombra dello stile del suo grande scrittore-padre, quando evocava con poche parole scene di vita della sua lontana Dublino, che ci sembra di vedere, mentre le leggiamo. E forse de Angelis, quando rileggeva questi vecchi film, aveva in mente il piccolo cinema che Joyce aveva tentato di aprire a Dublino all’inizio del secolo, iniziativa subito fallita per i film inconsueti che il poeta aveva scelto di programmare, manco a dirlo, così com’erano desueti i film che de Angelis recensiva negli anni Cinquanta, e troppo breve fu la sua attività di critico cinematografico. Il piacere di essere inattuale, per un critico, è purtroppo una condanna a priori. Ma è anche, con il passare degli anni, una qualità.
107 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
108 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
IL TESORO DI ARNE 1
In Italia non si può certo dire di avere a disposizione un’ampia documentazione del cinema svedese muto e più precisamente di quella scuola in cui primeggiano i nomi di Sjöström e di Stiller e di cui le storie del cinema parlano, accanto alle scuole russa e tedesca, come una tra le più ricche di felici riuscite. Abbastanza nota è la produzione russa, almeno per quel che riguarda i due maggiori registi, e i più importanti film tedeschi espressionisti e post-espressionisti sono ormai familiari ai frequentatori dei circoli del cinema. Altrettanto non si può affermare dei film svedesi del periodo dal 1916 al 1923: la copia assai ridotta del Carretto Fantasma di Sjöström, la sequenza del Vecchio Castello di Stiller inclusa in Film and Reality di Cavalcanti, la versione mutila della Leggenda di Gösta Berling dello stesso Stiller, presentata a uno degli ultimi festivals di Venezia, formano un ben magro bilancio. Il tesoro di Arne, realizzato da Stiller nel 1919, ci interessa quindi particolarmente non solo in quanto opera compiuta ed espressiva di un mondo personale fortemente individuato, ma come esempio di quella che dové indubbiamente essere una produzione nazionale di altissimo livello e di forte impegno spirituale oltreché tecnico e stilistico. Fu Victor Sjöström ad affidare al collega la realizzazione della leggenda di Selma Lagerlöf, che in un primo tempo egli aveva vagheggiato di curare personalmente. Sappiamo che Stiller aveva una certa diffidenza per le opere letterarie come fonti di un’opera filmica, e questa sua posizione ci spiega la decisa originalità di fronte al testo di partenza che vediamo liberamente rivissuto in funzione di personali esigenze espressive. Se Sjöström fu sempre incline a partire da testi letterari (anche in America uno dei suoi film più significativi sarà La Lettera Scarlatta, dal romanzo di N. Hawthorne), Stiller inclina fino dalle prime opere a un personale realismo il quale, anche se assume i colori della leggenda con 1
Titolo originale: Herr Arne’s Pengar; Soggetto: dalla leggenda omonima di Selma Lagerlof; Sceneggiatura: G. Molander e M. Stiller; Regia: Mauritz Stiller; Scenografia: H. Dahlstrom e A. Bako; Fotografia: J. Jaenzon; Interpreti: Hjalmar Selander, Richard Lund (Sir Archie), Mary Johnson (El-salil), Concordia Selander, Wanda Rothgardt.
109 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
una morale implicita e un giudizio che si ricava dallo svolgersi degli eventi, non lo porta mai a cadere nella illustrazione oleografica o nella letteratura filmata. È altamente significativo che alcune scene del suo film più maturo, La leggenda di Gösta Berling (1923), che pure era tratto da un’opera della Lagerlöf, abbiano fatto rammentare per la loro audacia e crudezza il nome di Erich Von Stroheim. Non vorremmo, d’altronde, che si equivocasse sul termine di realismo, che è da intendere per lo Stiller del Tesoro di Arne nel senso di una visione precisa di un periodo storico (il XVI secolo) che non esclude una sapiente stilizzazione pittorica di ambienti e costumi; di un’attenzione ai personaggi psicologicamente approfonditi, ma non tanto da perdere una loro emblematicità morale: di un senso acutissimo della natura e dei suoi rapporti coi protagonisti dell’azione, del suo condizionarne azioni e riflessi psicologici. È il realismo di una leggenda con personaggi credibili, mossi da passioni umane, e non esclude, anzi include senza stridori stilistici, il soprannaturale (e basti come esempio la visualizzazione sovrimpressa dei tre banditi che arrotano i coltelli e la scena del sogno di Elsalil con l’apparizione del fantasma della sorella che, nella scena in cui insegue lo scozzese assassino, diviene un’immagine vivente del rimorso). Siamo quindi lontanissimi dal mondo ferocemente chiuso di Dreyer, in cui i personaggi, siano essi Giovanna d’Arco o il giovane entomologo protagonista del Vampyr, sembrano dolorosamente ossessionati anzitutto dalla macchina da presa che li imprigiona in quei primi piani col solo sfondo o di un muro dal bianco accecante o di una atmosfera brumosa e sfumata carica di misteriosi e imponderabili influssi. Quel senso di dolorosa ossessione dei protagonisti, che il grande regista danese esprime nei suoi film con una coerenza figurativa e ritmica che forse non ha l’eguale, e rende i suoi due capolavori simili a due incubi (si potrebbe sostenere che anche Giovanna d’Arco, come parte del Vampyr, è una grande ininterrotta soggettiva, e che i volti implacabili dei giudici divengono man mano proiezioni della coscienza di Giovanna) è in Stiller un sentimento del fato, altrettanto tragico e pessimistico. Ma i suoi personaggi vivono all’aria aperta, sferzati dalla tormenta sulle distese di neve, e la natura è protagonista di primo piano. Si pensi alla nave costretta dai ghiacci, che impedisce la fuga dei tre predoni, e al valore delle inquadrature finali con lo sciogliersi dei ghiacci. La tragedia è ormai consumata, i colpevoli sono puniti, e un corteo di donne è
110 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
venuto a raccogliere il cadavere della vittima: lo sgelo e l’ultima inquadratura col mare aperto sono come un’affermazione trionfale di vita, hanno un valore di purificazione finale. Il confronto con la chiusa del Vampyr ci porta a precisare la differenza tra le due personalità e a meglio definire la visione del mondo di Stiller. Il giovane protagonista si avvia lungo il fiume verso la luce; l’oppressione dell’incubo è finita con l’annientamento del vampiro. Ma come il parco del castello era un’emanazione mefitica quasi palpabile dello spirito della vecchia, così ora i due innamorati si avviano attraverso la stessa densa cortina di nebbie malefiche verso una luce che appare tanto lontana e filtrata da lasciare il dubbio se mai essi vi arriveranno. Giovanna d’Arco termina con il rogo, Le Vampyr, con una liberazione e uno sfogo così problematici e appena accennati che la visione di Dreyer ci si rivela ancora una volta radicalmente negativa e la accettiamo solo per la sua sincerità, la sua forza espressiva, la sua lucida consequenzialità. Nel mondo di Stiller non vi sono prigionieri di un fato così crudele: Elsalil si innamora di Sir Archie, ma quando riconosce in lui l’assassino della sorella non esita a denunciare i suoi compagni; vorrebbe sfuggirlo, ma infine tenta di farlo mettere in salvo e va volontariamente incontro alla morte in questo suo tentativo. Sir Archie ruba ed uccide insieme ai compagni ma, innamoratosi della fanciulla e perseguitato dalla sua stessa coscienza, sente di essere ormai diverso da loro (si veda la scena dell’osteria). Vi è una possibilità quindi di sfumature psicologiche e di mutamenti interiori, come vi è un’azione esterna, condotta con ritmo vigoroso e serrato dal principio alla fine. È da sottolineare che il senso pittorico e plastico dell’inquadratura non scade mai al senso di quadro fisso o di natura morta, come nell’ultimo Dreyer (Dies Irae); e basterà richiamare ancora la scena dell’osteria, che prelude al finale ed è veramente risolutiva nell’economia del racconto, così splendidamente coloristica eppure così mossa e vivace. Caratteristica saliente del linguaggio di Stiller è poi un uso personale del montaggio in funzione narrativa, che fa pensare a Griffith. Ma felice e personale intuizione è la sovrimpressione dell’immagine dei tre banditi che arrotano i coltelli; abbiamo già visto la scena ripresa oggettivamente in un’inquadratura precedente e il montaggio della sequenza prosegue alternato, alla Griffith. Ma nell’inquadratura della moglie del pastore, che ha come una visione del destino che aspetta tutta la famiglia, l’immagine ritorna sovrimpressa; si ha così una sorta di montaggio interno all’inquadratura. Le azioni procedono sempre parallele. In quel
111 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
solo momento paiono fondersi e in un’immagine è condensato uno dei nodi dell’azione drammatica. Abbiamo voluto accennare solo ad alcune caratteristiche del mondo espressivo di un regista la cui opera dovrebbe essere meglio conosciuta per poterci permettere un discorso più lungo e meglio circonstanziato sulla sua personalità. Comunque il Tesoro di Arne appare opera coerente e compiuta in ogni suo aspetto e uno dei pochi classici della storia del cinema in cui non si avverte il gusto del tempo; ogni elemento vi concorre a un risultato unitario. E vogliamo concludere rilevando la sobrietà e l’equilibrio della recitazione, appena incrinati da qualche atteggiamento teatrale del protagonista (Richard Lund). (da «L’Eco del Cinema», a. IV, fasc. 40, 15 gennaio 1953 n. 1)
112 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
L’ULTIMA RISATA 1
Carl Mayer può a buon diritto essere considerato, forse ancor più di Erich Pommer, la vera eminenza grigia del cinema tedesco muto. Questo giovane austriaco irrequieto e sognatore, figlio di un commerciante fallito, cacciato di casa a sedici anni, incontrava a Berlino, nel dopoguerra, Hans Janowitz. Dalle animate discussioni dei due doveva nascere la sceneggiatura di un film: Il gabinetto del Dottor Caligari. La personalità di Mayer fu la più forte tra quelle che tennero a battesimo l’espressionismo cinematografico. E dal 1920 in poi troveremo il suo nome associato a quello dei registi maggiori e minori a testimonianza di una sua precisa coerenza intellettuale. Il Kracauer ha sottolineato il sostanziale apporto dello sceneggiatore Mayer ai film di Wiene e di Lupu Pick e ha convincentemente sostenuto come il legame di parentela che unisce l’espressionista Genuine (1920) agli intimisti Hintertreppee (1921), Scherben (1921), e Sylvester (1923) sia appunto da ricercarsi nella visione del mondo di Carl Mayer. Il Kracauer definisce in massa queste opere: “film dell’istinto”. Il mondo che ci fanno conoscere è quello di una società disintegrata, o meglio di quel residuo di una società in sfacelo che è la piccola borghesia i cui personaggi sono preda dell’istinto e abbandonati in balìa del fato. Si tratta di drammi in sordina, “drammi da camera” (kammerspiele), con pochi personaggi, ognuno dei quali incarna un istinto. Semplicità di costruzione psicologica e struttura formale rigorosa sono le caratteristiche salienti dei “film di Mayer”, come finisce per chiamarli il Kracauer. Lo sviluppo spirituale che portò Mayer dall’espressionismo all’intimismo meriterebbe di essere studiato a fondo sui testi, ma quanto ricaviamo dagli storici del cinema è già di per sé sufficiente a spiegarci la riuscita perfetta di Der letzte Mann. È infatti con questo film che culmina la serie iniziata nel 1921. Avrebbe dovuto dirigerlo Lupu Pick ma 1
Titolo originale: Der letzte Mann - Regia: F. Wilhelm Murnau - Soggetto e sceneggiatura: Karl Mayer - Fotografia: Karl Freund - Scenografia: Robert Herlt e Walter Roehrig - Interpreti: Emil Jannings (Lui) Mary Delschaft (sua figlia) Kurt Hiller (lo sposo della figlia), Emilie Kurtz (la zia), Hans Unterkircher (il direttore), George John (il guardiano notturno). Produzione: U.F.A. 1924.
113 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
per divergenze sorte tra lui e Mayer, il film veniva affidato a F. W. Murnau. Si realizzava così il felice incontro tra un grande regista tedesco, proveniente dall’esperienza espressionista di Nosferatu, con uno dei santi padri dell’espressionismo e il risultato della loro collaborazione fu un’opera che di quel movimento artistico doveva rappresentare il superamento e il suggello. La trama del film è lineare. Il portiere dell’albergo “Atlantic” presta servizio davanti alla porta girevole. È ormai vecchio e il lavoro di scaricare i bauli per i clienti è divenuto per lui faticoso. Ma la divisa gallonata da portiere lo rende felice, lo fa sentire una persona importante, e la sera, quando rientra a casa, tutti lo salutano con grande deferenza. Il direttore dell’albergo si accorge che il portiere non è più in grado di fare il suo lavoro e lo trasferisce ad un altro servizio, il più infimo nella scala gerarchica: la custodia e la pulizia del gabinetto dell’albergo. Il portiere apprende la notizia della sua destituzione, quando vede un altro al suo posto, con la sua divisa. Cercherà invano di convincere il direttore a restituirgli il posto. Il portiere è diventato l’ultimo degli uomini. Tutti i vicini adesso lo dileggiano, vedendolo senza la divisa a cui la sua autorità era indissolubilmente legata. Una notte il vecchio torna all’albergo, scende nel sottosuolo e si accascia sul pavimento del gabinetto. Laggiù lo troverà il guardiano notturno, in attesa della morte. Così il film ha fine per noi e scarsa importanza ha la sequenza finale, imposta da esigenze commerciali, in cui vediamo il portiere che, diventato ricchissimo in seguito a un colpo di fortuna, torna all’albergo come cliente, è ossequiato dai camerieri coi quali scherza bonariamente largendo loro mance vistose. Si è conquistato, in un certo senso, un’altra divisa. Mayer e Murnau avevano concepito il film senza questo finale ottimistico. Il loro personaggio, così concreto (si vedano le scene dell’intimità familiare) eppure così terribilmente simbolico doveva scendere fino in fondo all’abisso (ironicamente raffigurato dai muri gelidi del gabinetto) e aspettarvi la morte. Quella morte che aveva già rappresentato per lui il doversi togliere la divisa fiammante. Tutto il significato del film è racchiuso nella contrapposizione della hall dell’albergo, piena di movimento e di vita, (la porta girevole diventa il simbolo visivo della vita del grande albergo), all’ambiente chiuso, deserto in cui il portiere ingloriosamente termina la sua carriera. Sono i due estremi della parabola percorsa dal personaggio, i punti di riferimento della sua tragica emblematicità in “modo minore”. I realizzatori hanno colto nel dramma dell’uomo finito una volta toltagli la divisa, la tragedia del crollo di una
114 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
facciata dietro la quale forse non c’era che il vuoto. È una tragedia tipicamente tedesca e qualche anno dopo un altro regista ce ne presenterà una versione non molto dissimile. Il fattore esterno che provocherà il crollo della rispettabilità, questa volta “borghese”, si chiamerà Lola-Lola; e il professor Unrat non è altro che una seconda figurazione dell’uomo legato a una uniforme, a una facciata. Anche lui crolla col crollare di questa. Un confronto tra i due film non può non richiamare un altro e ancor più significativo parallelo. Alludiamo al personaggio del pagliaccio che non parla mai (in Der blaue Engel) e a quello del guardiano notturno nel film di Murnau. Sono infatti due personaggi chiave: quasi il simbolo del destino a cui i protagonisti non potranno sfuggire. Tutti ricordano il pagliaccio dalla maschera fissa in un eterno sorriso che Unrat si trova sempre davanti ogni volta che mette piede nel locale; il protagonista non sa ancora di doversi degradare a quel punto. La maschera sembra volerlo avvertire della sorte che lo attende. In Murnau il simbolo è ancor meno definito e tanto più efficace. Vediamo il guardiano vagare lentamente per i corridoi dell’albergo, sfiorare il portiere come se non lo vedesse. È una figura quasi di genius loci o di angelo della morte, l’unica in tutto il film che faccia ancora pensare all’espressionismo. All’ambiente espressionista possono anche richiamare la scenografia e l’illuminazione, ma il risultato complessivo e il tono dominante ci pongono davanti a un’opera che rivela una sensibilità registica e figurativa autonoma; una sensibilità matura, indipendente da una scuola e da una maniera ormai filtrate e superate, attraverso ad essa. Al contrario degli espressionisti, Murnau è anzitutto un narratore; pochi film sono serrati e incalzanti come Der letzte Mann. Le inquadrature iniziali danno il ritmo di tutto il film; la macchina da presa è piazzata in un ascensore che sta scendendo nella hall dell’albergo, vediamo i clienti andare e venire, vediamo la porta girevole, e attraverso i vetri, nella strada intravediamo la sagoma enorme del protagonista con l’ombrello aperto. Siamo di fronte a una varietà di piani che fa quasi pensare a quello che sarà l’uso del pan-focus. E il ritmo iniziale sarà sostenuto in tutto il film che, come è noto, è privo di didascalie, eccettuata quella precedente la sequenza finale. È una didascalia che riafferma velatamente la coerenza del regista; suona testualmente: “Qui la storia dovrebbe realmente finire. Il vecchio portiere avrebbe avuto ben poco da aspettarsi se non la morte. L’autore ebbe però pietà di lui e provvide ad un epilogo del tutto improbabile”. Non c’è davvero bisogno
115 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
di leggere tra le righe per capire quanto poco Murnau credesse a quel lieto fine. Murnan ha dimostrato nel modo più radicale, con il suo film, come si possa raccontare una storia per sole immagini e il risultato non tradisce il minimo sforzo. L’ispirazione è sempre felicemente sostenuta, senza ricorsi a surrogati intellettualistici, e l’invenzione è continua. Ad esempio, durante la festa per lo sposalizio della figlia del portiere uno degli ospiti assorda gli altri con un trombone. Murnau è riuscito a far “sentire” allo spettatore il suono dello strumento importuno avvicinando rapidamente la macchina da presa all’uomo col trombone; lo strumiento luccicante è proiettato così in primissimo piano e si ha l’impressione di un acuto improvviso e stonato. Né è da dimenticare la valentia di Murnau nel dirigere gli attori; basterà ricordare come questo sia uno dei non molti film in cui Emil Jannings sia ridotto entro limiti sopportabili. Der letzte Mann è veramente un’opera fondamentale nella storia del cinema tedesco. E se in essa sono ancora avvertibili le tracce di un determinato gusto, non si può d’altronde disconoscere il suo valore di anticipazione della corrente realista. L’anno seguente comparirà Die freudlose Gasse (La via senza gioia): Pabst e Dupont sono alle porte. (da «Cinema», a. VI, n. 15, fasc. 119, ottobre 1953)
116 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
FEMMINE FOLLI 1
Femmine Folli è il terzo capitolo dell’opera di Erich von Stroheim. È la più compiuta e concentrata e persuasiva “puntata del suo complesso romanzo ciclico” per citare le parole di Gianni Puccini («Cinema» v. s., n. 57). È un film estremamente indicativo e se può suggerire un discorso abbastanza definitivo sullo stile e sulla visione del mondo di Stroheim, può d’altronde aiutare a precisare i limiti della sua personalità. Qualsiasi discorso su un film di Stroheim deve per forza partire da una premessa. Non solo l’opera complessiva del regista è difficilmente accessibile agli studiosi ma lo stato stesso di conservazione di ogni singolo film lascia molto a desiderare. E questo per due motivi. È noto che il regista nella sua spietata ricerca del tempo perduto e nella redazione del suo atto d’accusa contro una società e un mondo che lo avevano respinto, considerò sempre l’opera filmica con la stessa spregiudicatezza con cui il romanziere tratta la pagina. Stroheim ha voluto sempre dire “tutto” quanto egli sentiva necessario a esprimere e precisare la sua visione, senza tener conto che la pellicola è materia assai più labile e in vari sensi più incendiaria della carta. Da questa sua posizione e dal non voler piegarsi a nessun compromesso derivarono le liti clamorose coi produttori e il fallimento definitivo di Merry-go-round (1922), di Greed (1923), di The Wedding March (1927), di Queen Kelly (1928). Ognuno di questi film è stato sottratto, in fase più o meno avanzata di lavorazione, alla responsabilità definitiva del regista. Il loro montaggio fu affidato ad altri, e nel caso di Merry-go-round la mano del regista è riconoscibile solo nelle primissime sequenze; il resto è dovuto a Rupert Jullian, 1
Titolo originale: Foolish Wives. - Regia soggetto e sceneggiatura: Erich von Stroheim. Fotografia: Ben Reynolds e William Daniels - Scenografia: Richard Day e von Stroheim - Interpreti: Erich von Stroheim (Conte Vladislao Sergio Karamzin), Maude George (Principessa Olga), Mae Busch (Principessa Vera), Dale Fuller (La cameriera Marussia), George Christians (Andrew J. Hughes, diplomatico americano), Miss Dupont (Elena, sua moglie), Cesare Gravina (L’usuraio Ventucci), Malvine Polo (sua figlia), C. J. Allen (Alberto I, Principe di Monaco), Edward Reinach (Segretaro di Stato del Principato di Monaco), Louis K. Webb (Dr. Judd), Mrs. Kent (Sua moglie), Al Edmunsen (Pavel Pavlich, maggiordomo). Produzione: Universal, 1921.
117 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
autore del commerciale Fantasma dell’Opera. Di nessuno di essi Stroheim ha riconosciuto la paternità. A questo vizio di nascita, che dovrebbe rendere sempre prudente lo studioso di fronte a film che, per quanto suggestivi e ricchi di parti pienamente riuscite, sono pur sempre dei “tronconi” o comunque non rappresentano compiutamente il pensiero dell’autore (e basterebbe il fatto di esser stati montati da altri) si aggiunga lo scempio operato dai produttori per ragioni di morale, e in seguito dalle varie censure. Nel caso di Femmine folli sappiamo che l’opera come l’aveva concepita il regista aveva un’ampiezza tale di sviluppi da richiedere circa cinque ore di proiezione. Le esigenze commerciali fecero ridurre di molto il metraggio del film che doveva poi essere, con The Merry Widow (1925), l’unico successo di cassetta di Stroheim. Le pretese della censura fecero il resto e il film come ci appare oggi nella copia disponibile in Europa è da considerarsi quasi come opera “non finita” anche se nulla ha perso della sua violenza e della sua attualità. Tutti i film di Stroheim rappresentano dunque una battaglia da cui l’uomo esce sempre sconfitto, almeno per metà, mentre il creatore riesce a dire con opere mutilate una sua parola che impressionerà profondamente gli spettatori. Sono la sua forza di poeta e di moralista intransigente, la sua crudeltà, la sua onestà artistica e morale a dare coerenza stilistica alle sue opere. Quel suo modo di guardare a un mondo e a un tempo perduti, amati e odiati con uguale passione e rigore, lo porta a narrare lentamente e implacabilmente storie che ci consegnano un’immagine ben definita della vita, con implicito un giudizio morale. È lo sdegno del moralista quello che gli fa scrutare impietosamente un volto con la luce, fino a cogliervi l’ultima risonanza di un moto interiore. La coerenza di Stroheim si manifesta inoltre nella presenza al centro di tre dei suoi grandi film di una figura sempre più approfondita: l’ufficiale cinico, vuoto e gaudente, simbolo ed esponente di tutta una classe sociale. In Femmine folli la figura del protagonista è già pienamente realizzata, un ritratto a tutto tondo, e anche se il suo nome è Sergio Karamzin e la scena è Montecarlo sono trasparenti le allusioni a una realtà mitteleuropea. Il sedicente nobile Karamzin recita impeccabilmente la sua parte di brillante ufficiale, campione di tiro e giocatore di poker e di roulette. Frequenta la buona società in compagnia della due cugine, la principessa Olga e la principessa Vera. Dà nella sua villa feste sontuose. In realtà è un imbroglione e un baro, le due principesse sono due avven-
118 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
turiere e Olga è la sua amante; egli sfrutta la serva Marussja a cui ha promesso di sposarla e cerca avventure galanti con qualsiasi donna gli capiti a tiro. All’inizio del film tenta di corteggiare perfino la figlia demente dell’usuraio che periodicamente viene a fargli visita. Arriva a Montecarlo un diplomatico americano con la moglie e il principe Sergio fa di tutto per esserle presentato. La sua galanteria si fa sempre più pressante fino al giorno in cui i due si rifugiano in un casolare, colti da una tempesta durante una gita, e qui l’opera del seduttore sta per compiersi quando arriva un monaco alto ed ossuto che, senza aprir bocca, si siede in un angolo e lo fissa, implacabile, per tutta la notte. Fallito questo tentativo, il nobile, indebitato fino ai capelli, fissa di nuovo un appuntamento alla bella americana e recita ancora una volta per ottenere da lei del denaro, facendo richiamo alla legge dell’onore e alla pietà della signora. Il gioco sarebbe riuscito se la serva Marussja, ingelosita, non desse fuoco alla torre in cui ha luogo il convegno. I due si salvano ma il nobile ufficiale ha perso la faccia e dovrà affrontare il marito dell’americana che lo percuote e lo sfida a duello. Nella copia disponibile in Italia c’è qui un salto nella narrazione. Le due false principesse sono arrestate dalla polizia e il sinistro eroe che, nel frattempo si è rivelato anche un vigliacco (sarà lui il primo a gettarsi dal balcone della torre in fiamme) trova la morte durante la sua ultima impresa galante. Lo vediamo arrampicarsi fin dentro la stanza della figlia demente dell’usuraio; la ragazza muore dal terrore appena lo vede avvicinarsi e il padre, accorso all’urlo inumano della figlia, lo pugnala e lo trascina, alla luce di un’alba livida, fino a una fogna nella quale lo getta. L’eroe muore con indosso la sua divisa bianca; ha portato fino all’ultimo la sua maschera. Nella copia italiana mancano alcune sequenze e molti particolari significativi: a) Il film si apriva in camera di Olga, amante di Sergio. Si assisteva a una scena di gelosia con Vera, dopo la quale Sergio si ritirava in camera sua per la toilette. Qui Sergio si schiacciava un foruncolo (scena soppressa dalla censura che non ammetteva un primo piano cosi realistico). Sergio usciva dalla sua camera e andava dalla serva; Olga lo spiava mentre usciva dalla camera di Marussja e si avviava verso il mare con la pistola. A questo punio inizia l’edizione italiana. Vengono così a mancare elementi atti a definire i rapporti dell’ufficiale con le tre donne che vivono insieme a lui. b) Una seconda sequenza mancante è quella in cui Sergio, di ritorno
119 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
dal trattenimento, frusta Vera in camera sua. È superfluo sottolineare l’importanza della scena ai fini di un discorso sul sadismo di Stroheim. c) Durante la festa in casa di Sergio l’americano sorprende Vera che bara al poker e Olga che manovra la roulette con un pedale. Si spiega così l’intervento finale della polizia e si chiarisce meglio la losca attività della combriccola. Questi particolari mancano come manca il finale della sequenza in cui l’americano dopo aver percosso Sergio lo invita a sgombrare il campo, promettendogli di non denunciarlo se farà come gli è stato detto. d) L’ultima sequenza è la più sacrificata. Manca un primo piano dell’espressione stravolta della mentecatta e la visione della stessa riversa sul letto, fulminata dal terrore. Manca la morte di Sergio, che, colpito alle reni da un coltellata, fa tre passi prima di stramazzare. Qui evidentemente è intervenuta di nuovo la censura, che ha tagliato anche il finale del film in cui, stando alla testimonianza del Sadoul, nella sua Storia del Cinema, si vedeva il cadavere di Sergio trasportato al mare dalle acque della fogna, tra le bottiglie di spumante e le stelle filanti. Il crollo dell’eroe era così seguito fino all’ultimo e il materiale plastico in questo caso doveva essere violentemente simbolico. Esprimeva il disfacimento di un mondo e di un modo di vita. Il cadavere era accompagnato nella fogna dai residui delle feste che avevano costituito il fondale della sua carriera nel bel mondo. Il film rivela in Stroheim un vigoroso maestro della narrazione e un solido costruttore di personaggi anche se le figure secondarie appaiono sempre un po’ in secondo piano e si definiscono via via nell’evolversi dei loro rapporti col protagonista cui Stroheim presta una maschera che renderà il personaggio immortale, come quello del vagabondo di Chaplin. È noto lo slogan dell’“uomo che vorreste odiare”. La figura dell’ ufficiale dal sorriso fatuo e glaciale, nell’immacolata divisa, è contrapposta più volte nel corso del film a quella nobile e dolorosa del mutilato cieco. Per due volte l’ufficiale cui mancano le braccia sembra offendere le regole della cavalleria quando, sulla veranda dell’albergo e in ascensore, non raccoglie un oggetto caduto alla signora americana. Il principe Sergio fulmina con lo sguardo il mutilato, non rendendosi conto dei motivo di tanta scortesia e sarà solo quando la mantellina cadendo dalle spalle del cieco rivelerà la sua mutilazione, che si manifesterà compiutamente il contrasto tra il cialtrone nei panni dell’eroe e il soldato valoroso. È una delle scene giustamente più ammirate del film e in essa lo Stroheim satirico e moralista si rivela con commossa intensità. Le due figure sono
120 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
contrapposte in un chiaroscuro violento e il soldato da parata rimane inchiodato, dal confronto, alla sua meschina vuotezza. Altra figura rivelatrice di quella “umanità” del regista, studiata da Ugo Casiraghi, è quella della serva Marussja. Sergio le ha promesso di sposarla e le porta via gli ultimi risparmi. Si pulisce la bocca dopo averla baciata. E basterebbe questo particolare per stabilire l’acutezza dell’intuizione psicologica del regista-attore nel costruire la figura del falso aristocratico, sdegnoso e volgare. Non la degna di uno sguardo quando si reca al convegno con l’americana. Ma sarà Marussja che deciderà della sorte del padrone, quando in un impeto di gelosia darà fuoco all’appartamento, rivelando così la bassezza e la vigliaccheria del brillante ufficiale che aveva appena finito di recitare la sua commedia con la moglie del diplomatico. La trasformazione psicologica di Marussja che da serva umile e sottomessa diventa amante gelosa e ribelle è espressa in un estenuante primo piano, con la macchina da presa che si avvicina sempre più al volto della donna. È uno dei momenti più intensi del film oltre al finale e alla scena centrale di seduzione nella capanna, culminante con l’arrivo del monaco dagli occhi di fuoco che è quasi una materializzazione della voce della coscienza. A questo proposito, si dovrebbe sottolineare in Stroheim, oltre allo scrupolo del realismo senza compromessi (la toilette di Sergio, la sua prima colazione, la ricostruzione meticolosa di Montecarlo, la visita dei diplomatici al principe), anche la forza di trasfigurazione fantastica che conferisce a certi elementi valore di veri e propri simboli. Ad esempio, l’opera del seduttore, troncata definitivamente dall’arrivo del monaco, è disturbata più volte da una petulante capretta che si trova nella capanna. A parte l’umorismo della scena, è da sottolineare la scelta della capra come emblema tradizionale della lascivia (si pensi a Shakespeare, Othello III, 3, 403). E nella scena della tempesta lo scatenarsi degli istinti di Sergio si rispecchia nella furia degli elementi. Un giudizio complessivo sul film, (quando si siano sottolineati i pregi di una fotografia splendidamente plastica e la modernità di una recitazione sobria e ben orchestrata) resta tuttavia problematico. Si è già accennato allo stato di incompiutezza dell’opera che rende difficile lo stabilire quale dovesse esserne la linea e il ritmo complessivo. Rimane pur sempre un dubbio, avvalorato dall’opinione del Rotha che si dimostra assai cauto di fronte agli entusiasmi degli ammiratori di Stroheim (tipica in questo senso la posizione di Peter Noble, che del
121 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
regista è appassionato biografo ed estimatore). Il dubbio, cioè, se Stroheim non fosse portato dal suo genio di moralista e di fustigatore dei costumi a sentire più la sequenza che il film: a concepire ogni suo film per blocchi narrativi ben squadrati ma ognuno conchiuso in sé e a sé stante. E di conseguenza, a sentire più fortemente l’inquadratura che non la sequenza; ad addensare nell’inquadratura stessa particolari significanti fino a conferirle una particolare densità, talvolta a detrimento del ritmo di montaggio. Da questo punto di vista, la necessità che Stroheirn aveva di impressionare chilometri di pellicola (le 42 bobine di Greed) e la sua anticommercialità rappresenterebbero un suo preciso limite. Osserva il Rotha che ad altri pur grandissimi registi è bastato, per esprimere il proprio mondo, il metraggio normale. Non ci sentiremmo di dare senz’altro ragione al Rotha, senza una conoscenza più approfondita ed esauriente dell’opera di Stroheim (Greed non è mai stato presentato in Italia); tuttavia è innegabile che Femmine folli, con i suoi acmi drammatici e le sue parti più distese, lascia pur sempre l’impressione di un film disarticolato dal punto di vista del ritmo complessivo. Con questo non si vuol certo sminuire la portata del film ma accennare a quella che potrebbe essere una revisione del giudizio su Stroheim “narratore”. È stato detto che il suo spirito, sotto l’influenza di Griffith, sarebbe in ultima analisi ancora “vittoriano”. L’affermazione non è così paradossale come potrebbe sembrare a prima vista. E la generosità narrativa di Stroheim, la sua mancanza di misura, il suo raccontare senza articolazioni strutturali ben definite potrebbero, una volta analizzate su vari testi, (Greed, soprattutto) servire a meglio precisare e confermare un altro lato del suo “vittorianesimo”. (da «Cinema», a. VII, n. 31, fasc. 130, marzo 1954)
122 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
M
1
Vi sono dei films che nella carriera di un regista non solo segnano la riuscita perfetta sul piano della raggiunta conquista di un mondo interiore, ma rappresentano anche talvolta una pietra miliare, una svolta nella carriera stessa. È questo il caso di M di Fritz Lang, la cui personalità risalta oggi abbastanza sistemata da un punto di vista critico. Si può anzi dire che sia stata definitivamente riportata alle sue giuste proporzioni. Si sono infatti riconosciuti il magistero stilistico e la singolare padronanza dei mezzi espressivi, manifestati da opere quali Le tre luci, I Nibelunghi, Metropolis e dai films americani almeno fino alla Strada scarlatta e Anche i boia muoiono. E fatta la dovuta parte al pesante gusto teutonico di Thea von Harbou, l’inseparabile soggettista e sceneggiatrice, all’epoca dei migliori films di Lang, ci si è pur trovati d’accordo nel riconoscere il segno della individualità del regista in un senso di terrore, talvolta espresso esasperatamente. È il terrore che si presenta come senso di un fato misterioso in Le tre luci, o come fatalità immanente nella saga dei Nibelunghi. Lang è senza dubbio una personalità di secondo piano, tuttavia sarebbe ingiusto insistere sui dati esteriori e meramente tecnici dei suoi films e fare di lui un Hitchcock più cupo e sanguigno. C’è nel motivo cui abbiamo accennato una certa coerenza che finisce per farci riconoscere come dovute alla stessa mano opere a prima vista disparate. E solo negli ultimi anni il regista sembra aver ceduto le armi e minacciare di affogare in una produzione anonima. Un esame generico della produzione muta del regista rivela due filoni abbastanza bene individuati. Il filone più ambizioso è quello della saga o del film comunque allegorico e avveniristico in cui Lang si rivela regista dotato di un senso insuperabile della composizione pittorica (si pensi ai Nibelunghi e alle migliori sequenze di Metropolis). In questi 1 Origine: Germania; Anno: 1931; Regia: Fritz Lang; Soggetto e Sceneggiatura: Fritz Lang e Thea von Harbou; Fotografia: Fritz Arno Wagner; Scenografia: Emil Hasler, Karl Vollbrecht; Interpreti: Peter Lorre, Inge Landgut, Güstav Gründgens, Rudolf Klein Rogge, Theo Lingen; Produzione: Lang-Nero Film.
123 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
films il pittore-architetto prevale sul narratore per immagini. Un secondo filone è quello sotterraneo, forse più genuino e in un certo senso marginale rispetto alla corrente espressionista, e ci porta dal lontano Mabuse (l922) a Spione (1928), a M (1931), e al Testamento del Dottor Mabuse (1932). È da rilevare come per alcuni di questi films si sia potuto perfino parlare di realismo e forse non a torto si può far risalire ad essi una certa maniera americana di Lang, che può farlo considerare un maestro dei recenti neo-realisti d’oltre-oceano. Si pensi più che allo scarno documentarismo di Dassin nella Città nuda, alla sapienza luministica di Dmytryk in Odio implacabile, che è vicino almeno per questo aspetto alla Strada scarlatta. Tornando a M, è da notare anzitutto che Lang abbandona per la prima volta trame complicate e risibili degli antecedenti films polizieschi. Spione, con quell’organizzazione di spie internazionali dietro la facciata di una grande banca e l’immancabile avventuriera dal nome, manco a dirlo, slavo, resta un modello di cattivo gusto e di macchinosità tipicamente teutonica, in cui non riusciamo a vedere come fa il Kracauer, significati inconsci o reconditi. M, invece, si basa su un fatto di cronaca. Come è noto il film è ispirato alla serie di atroci delitti del mostro di Düsseldorf, un maniaco sessuale. In questo senso si può già parlare di un realismo di Lang. Tuttavia chi si attendesse dal film una storia terrorifica dominata dalla maschera ossessionante di Peter Lorre, che ci consegnerà qui la sua più bella interpretazione, resterebbe deluso. E del pari resterebbe deluso chi volesse vedere in M la tragica vicenda dell’assassino in preda a un istinto che farà di lui al finale un animale braccato. Potrà sembrar paradossale il dire che la vicenda del “mostro” è rimasta quasi in margine al film che (visto oggi) risulta opera di prodigiosa abilità tecnica (un vero campionario di effetti di montaggio) ma lascia lo spettatore con un senso di vuoto di fronte a un’ispirazione irrimediabilmente superficiale, a una occasione sostanzialmente mancata. E questa impressione non è cancellata dalla bravura del regista che qui diventerà finalmente un narratore serrato e incalzante. È questo l’unico aspetto per cui il film rimarrà esemplare (non vorremmo essere accusati di pretendere dal regista quanto egli non si è mai sognato di darci). Tuttavia rivedendo M si deve concludere che l’impressione dominante è quella di una storia poliziesca in chiave prevalentemente satirica, in cui non riuscendo la polizia ad acciuffare il delin-
124 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
quente, si decidono ad agire i mendicanti e il mondo della malavita. Saranno essi e non gli agenti a mettere in trappola il “mostro” e sarà un tribunale irregolare a giudicarlo. Sappiamo che l’ultima inquadratura con la mano che piomba sulla spalla del mostro e la voce fuori campo che pronuncia le parole “in nome della legge” è stata dettata da esigenze di censura. Il tono prevalente del film è improntato a una vena satirica robusta che trova i suoi migliori effetti nella contrapposizione dell’attivo intervento della malavita alle chiacchiere e ai sistemi scientifici della polizia. Si ricordi il montaggio alternato delle brevi inquadrature in cui vediamo i ladri, offesi nel loro onore al pensiero che il “mostro” possa essere considerato uno dei loro, organizzare la battuta che stringerà sempre più da vicino il criminale, mentre i poliziotti discutono all’infinito di indizi e piste false. Dal confronto con la malavita i tutori dell’ordine escono malconci. In questa che è la parte centrale del film l’orrore della vicenda che dà lo spunto alle indagini viene totalmente dimenticata e non a caso troviamo tra i malviventi il comico Theo Lingen. La pittura del mondo della malavita e dei bassifondi rivela un Lang magistrale tratteggiatore di caratteri e acuto osservatore di ambienti. Basti ricordare la lunga carrellata che introduce nel refettorio pubblico, un pezzo classico che meriterebbe di esser citato a fianco del troppo celebrato inizio di Fortunale sulla scogliera. In sostanza Lang ci ha dato con M una specie di suo Dreigroschenoper davanti al quale a un certo punto quasi ci dimentichiamo del “mostro”, che ricomparirà al finale; e non è senza significato che a Lorre venga affidata allora una lunga tirata. L’attore, in inquadratura fissa, ha modo di recitare il suo pezzo di bravura che lascia, tutto sommato, piuttosto freddi. Rimane il sospetto che il regista, dopo aver brillantemente orchestrato le immagini della caccia al “mostro” si sia ricordato del dramma spirituale che avrebbe dovuto scaturire dalla vicenda e abbia voluto rimediare in extremis, affidandosi alla bravura dell’attore e facendogli “dire” ciò che il film fino allora non aveva espresso. Ma la fiacchezza del finale non fa che ribadire il senso di posticcio. In fondo, tutto il film non mantiene la promessa della prima sequenza, già più volte segnalata dalla critica; in essa Lang valendosi del montaggio e soprattutto del sonoro, a cui si accostava per la prima volta, rende mirabilmente l’atmosfera di sospensione in casa della bambina che non tornerà più, e, il senso di sgomento che si impadronisce pian piano della madre. È questa un’altra sequenza esemplare in cui la scelta
125 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
dei particolari (il cortile vuoto, la tavola apparecchiata, con il posto della bambina ripreso sempre più da vicino, le scale deserte riprese dall’alto) e il tono gelido della fotografia si fondono con gli effetti sonori (la voce della madre che chiama la piccola Elsa sempre più angosciosamente). È l’unico momento in cui Lang riesce veramente a far sentire la presenza del “mostro”, a comunicare un brivido di orrore che non ritroveremo più neppure quando vedremo la maschera allucinata di Lorre. È questa specie di contraddizione interna al film che ci faceva parlare di “occasione mancata”. Ma sarà più esatto dire che Lang conferma con questo che è senz’altro il suo capolavoro, da un lato, la sua perizia e la sua facoltà di assimilazione dei mezzi espressivi, dall’altro, la sostanziale genericità della sua ispirazione, in una parola, il suo raffinato virtuosismo da artigiano di altissimo livello. (da «Eco del cinema», a. IV, n. 13, fasc. 52, 15 luglio 1953, p. 2)
126 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
A PROPOSITO DI MERRY GO ROUND 1
È difficile parlare di Erich von Stroheirn per chi, pur interessandosi attivamente di cinema, non ha avuto modo di seguirne costantemente la storia e i molteplici sviluppi fino dal 1920. Dei due films, che gli storici del cinema ci additano come altrettante pietre miliari sul cammino dell’arte ultima e novissima, Foolish Wives e Greed solo il primo è praticamente disponibile in Italia e fa ogni tanto una fugace comparsa nei festivals organizzati dalla Cineteca italiana; Greed, la vittima forse più cospicua e deplorata, insieme al mitico Que viva Mexico!, dell’ignoranza dei produttori e della cecità dei censori, non è mai stato visto in Italia. Dobbiamo quindi ritenerci fortunati di aver visto almeno Merry-goround. Il film, che è del 1922, segue immediatamente Foolish Wives e costituisce un altro capitolo di quella ricerca del tempo perduto che il grande regista austriaco, indubbiamente una delle personalità creatrici più forti del nostro tempo, ha consegnato alla celluloide, materia purtroppo assai più labile e in vari sensi incendiaria, della carta. È notissimo il fatto che Proust dové combattere le sue prime battaglie con gli editori che pretendevano da lui un alleggerimento dei periodi e una diversa e più riposante sistemazione dei capoversi. A chi volesse abbordare un paragone Proust-Stroheim da questo punto di vista tutto esteriore, non mancherebbero gli appigli per far notare come il regista abbia considerato l’opera filmica pressappoco con la stessa spregiudicatezza con cui il romanziere francese ha trattato il romanzo, un genere già codificato e ricco di esempi illustrativi. Stroheim infatti presenta ai produttori chilometri di pellicola impressionata; è costretto a ridurre abbondantemente il metraggio di Foolish Wives, che fu poi il suo unico successo sul piano commerciale: per Greed arrivò, si dice, a 42 bobine, a un’opera, quindi, che non poteva esser presentata su nessuno schermo in un circuito normale; si vide tagliare in due episodi e alleggerire sensibilmente il suo ultimo film, che venne a suo tempo presentato anche in Italia. A questi casi, per non parlare di The merry Widow da lui mai riconosciuto come opera sua e considerato un’offesa gettata in bocca ai produttori, sono da aggiungersi le fortunose vicende della nascita e della morte prematura per soffocamento di Merry-go-round e di Queen Kelly.
127 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
Nel caso del primo film si dice abbia influito, oltre agli interessi del produttore, spaventato dalle folli spese del regista, non sappiamo fino a che punto leggendarie, il timore di fronte all’arditezza del soggetto e dell’impostazione; quanto a Queen Kelly, alle solite complicazioni, causate anche dalla inflessibilità di Stroheim che, come sempre, rifiutò di capitolare, pare essersi aggiunto un dissidio con Gloria Swanson, interprete del film, per quanto lo stesso Stroheim lo abbia recentemente voluto smentire. È singolare che quasi tutti i films di Stroheim rappresentino una battaglia da cui l’uomo esce quasi sempre sconfitto, almeno per metà, mentre il creatore riesce a dire, seppure con opere mutilate, o parzialmente sfigurate, una sua parola che impressionerà profondamente gli spettatori; è forse questo un primo tratto della sua fisionomia di poeta dello schermo e non del tutto esteriore, come può apparire a prima vista. Uno dei più sensibili critici cinematografici francesi, André Bazin sottolinea in un suo acutissimo saggio, dove pur confessa di aver visto solo una volta Greed, tre aspetti del mondo di Stroheim: la forma, l’uniforme, la crudeltà. Tralasciando i primi due termini vorremmo accennare al terzo, sostituendo però al termine “crudeltà” quello più appropriato, ci sembra, di “intransigenza”. È la stessa onestà artistica e morale che fa sbattere a Stroheim la porta in faccia ai produttori, che ritroviamo nel creatore, in quel suo modo di guardare a un mondo e a un tempo per lui perduti, amati ed odiati con uguale passione e rigore; in quel lento e implacabile narrare storie che ci consegnano una immagine ben definita della vita, con implicito un giudizio quasi da moralista; in quel suo scrutare implacabilmente un volto con la luce, fino a cogliervi l’ultima risonanza d’un moto interiore. Ed è quasi superfluo il rilevare la sintomaticità di una figura centrale approfondita di volta in volta in almeno tre dei suoi films: l’ufficiale cinico, vuoto e gaudente, simbolo ed esponente di tutta una classe sociale. Lo stile di Stroheim regista e la forma rivoluzionaria delle sue opere sono stati già più volte analizzati e definiti nei loro caratteri originali, e non vogliamo qui diffonderci su di essi. Semmai vorremmo ricostruire una immagine del regista attraverso la visione di una sua opera, di cui la critica ci dà scarsissimi ragguagli. Sappiamo con certezza che Merrygo-round fu tolto di mano a Stroheim a metà lavorazione e affidato al mediocre Rupert Jullian, autore di films di successo tra cui ricordiamo Il fantasma dell’opera, un pasticcio commerciale che sfruttava la ‘gigioneria’ di Lon Chaney. La trama del film è difficilmente ricavabile
128 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
nei suoi particolari dall’edizione italiana intitolata Donne viennesi, in cui si ha l’impressione siano stati sacrificati alcuni momenti essenziali dell’azione. Nella Vienna, corrotta e spensierata dei primi del secolo, vivono la loro vita di residui anacronistici di un mondo destinato a sprofondare nell’abisso aperto dalla guerra del 1914-18, i nobili, gli ufficiali e i diplomatici che gravitano attorno all’astro, che sta per estinguersi, dell’ultimo imperatore degli Asburgo. Uno di essi, il principe di Homburg, è costretto a un matrimonio di casta, per volontà dell’imperatore, con una donna del suo rango che egli non ama e da cui probabilmente non è riamato. Il brillante ufficiale la sera si veste in borghese e va con li amici a caccia di avventure al Prater. Là, vicino alla ruota che nel suo continuo girare vuol essere quasi il simbolo della vita vacua della capitale, il principe incontra per caso Mitzi, una popolana che lavora a una giostra. Tra i due si intreccia un idillio, dapprima quasi scherzoso (il principe si finge un commerciante), poi più impegnativo fino al punto in cui il principe, sempre in incognito, viene presentato al padre della ragazza come fidanzato ufficiale. Due mondi sembrano avvicinarsi in quest’amore dei due protagonisti, a dispregio delle barriere invalicabili che separano l’ufficiale dell’imperatore dalla figlia di un burattinaio. La crisi precipita quando le attenzioni del padrone della giostra presso cui lavorano Mitzi e il padre si trasformano in brutale aggressività; il padre difende la figlia, ma perde il posto e finisce in carcere. Una volta uscito, suscita di nuovo l’ira del padrone di un tempo che vede sfuggirsi la clientela attratta dal suo ex-dipendente al baraccone vicino, dove lavora come pagliaccio. Il proprietario della giostra tenta di uccidere il pagliaccio durante una sua recita, facendogli cadere in testa un pesante vaso da fiori; e sarà all’ospedale, dove questi è assistito dalla figlia, che, durante una visita dell’imperatore col suo seguito, avverrà l’incontro col principe ormai sposato. A questo punto la vita dei protagonisti è sconvolta dallo scoppio della guerra, che in questa versione del film appare sintetizzata in pochi tratti descrittivi. Al suo ritorno il principe trova Mitzi che stava per sposare un giovane compagno di lavoro, il gobbo Bartolomeo, le annuncia che sua moglie è morta e si lascia intendere che nel crollo di tutte le impalcature marce della società travolta dalla guerra, il sogno d’amore dei due potrà forse essere coronato e forse Mitzi abbandonerà il gobbo che l’ha finora aiutata. Questo ultimo è la figura forse più convenzionale e cartacea di tutto il film e sembra veramente tratto da un romanzo di appendice. Comunque si ha l’impressione che in tutta l’ultima parte, inferiore an-
129 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
che come qualità fotografica (si noti la sovrimpressione della giostra, giochetto alieno dal neorealismo di Stroheim), la responsabilità del regista sia minima; e purtroppo non ci possiamo neanche rendere esattamente conto di quanto Rupert Jullian abbia influito sull’impostazione della versione definitiva. Resta perciò difficile il giudicare un’opera di cui non si può dire che abbia il fascino del “non finito”, ma che si presenta con un nucleo originario ben riconoscibile sotto numerose incrostazioni e che esigerebbe quindi un vero lavoro di “restauro”, basato su un raffronto ampio di testi e su una lettura prolungata, il che purtroppo nel campo del cinema è quasi sempre praticamente impossibile. Così, l’idea che possiamo ricavarne della personalità di Stroheim deve essere per forza approssimativa e basata, anziché su una conoscenza completa della sua opera nel suo sviluppo e un suo articolarsi di aspetti e arricchirsi di motivi, piuttosto di una vivacità di impressioni dirette, che almeno le prime sequenze del film non mancano di suscitare. Il film si apre su alcune inquadrature staccate che riassumono Vienna cogliendone subito lo spirito: uno stemma, una visione panoramica del Prater, il portone di una casa nobiliare davanti a cui sostano carrozze e cavalli. E subito dopo assistiamo al risveglio e alla toilette del principe. La sequenza rivela subito una mano di primo ordine, che ha bene imparato l’arte di dare tutto l’essenziale e niente più. I particolari ambientali (il bagno, l’organo nel salotto, la grande scalinata pesante e fastosa) sono colti senza che la macchina da presa indugi mai su di essi. Così bastano pochi gesti del principe, un primo piano dell’attendente, e il particolare del cane che entra ed esce dalla vasca prima che vi entri il padrone e senza che questi se ne accorga, per definire una atmosfera e il carattere dei personaggi. È da notare ancora l’inquadratura del principe già quasi pronto con l’elmo in festa ma ancora col piegabaffì, che in virtù della luce assume una violenza caricaturale degna di un Grosz. In questa prima sequenza c’è già tutto il mondo e l’atmosfera di Stroheim; il racconto è serrato, non ci sono virtuosismi, né di montaggio, né movimenti complessi di macchina, ma l’inquadratura pregnante e l’uso dell’illuminazione ci testimonia la mano del regista di Greed. Caratteristico di Stroheim, e rilevato più volte dalla critica come un preciso limite del suo gusto, è un simbolismo talvolta pesante. Si pensi alla giostra ed alla ruota del Prater - quintessenza dello spirito di quella Vienna - attorno a cui ruotano i protagonisti che nella loro sete di piacere quivi si incontrano, si scontrano, si separano e si ritrovano; o al fantoc-
130 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
cio vestito da ufficiale che il padrone della giostra getta per terra, quasi a presagio dell’impossibilità di un amore sincero tra il corrotto rappresentante di una classe in sfacelo e la giovane popolana. Più genuino e meno voluto ci sembra viceversa il particolare dei cuori di cartone del tiro a segno centrati uno dopo l’altro dall’ufficiale in borghese, che si ritrova alla sera al Prater in caccia d’avventure, inconscio di quanto sia prossimo un incontro destinato a modificare sensibilmente la sua vita. Un’altra sequenza di inconsueta forza espressiva è quella della seduzione nell’ambiente della giostra, in cui ogni elemento, dalla luce al taglio dell’inquadratura, dal montaggio serrato all’angolazione sottile, concorre ad un risultato unitario. Non altrettanto può dirsi della scena d’amore nel parco dove Stroheim, anche per un certo tono cartolinaceo della fotografia, paga, se ne è responsabile, il suo tributo al gusto dell’epoca. All’attivo del regista è infine da segnalare la guida degli attori e l’orchestrazione complessiva della recitazione. La visione di Merry-go-round anche in questa copia italiana, permette almeno di rendersi conto della novità della narrazione in Stroheim: regista per cui il metraggio non conta e che indugia in un racconto talvolta lento ma di ritmo sempre serrato, e folto di personaggi, pur di mettere a fuoco situazioni e figure in quel modo inconfondibile per cui ben ha potuto dire, in una recente conferenza, di aver sempre mirato non a ricreare ma a “captare” la vita stessa. È questa la lezione definitiva del suo “realismo”, così concreto e personalmente stilizzato, così rigoroso ed aperto al di fuori di ogni schema o formula. (da «Eco del cinema», a. III, n. 14, fasc. 29, 31 luglio 1953, p. 2)
131 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
QUE VIVA MEXICO!
Il capitolo forse più doloroso di tutta la storia del cinema è quello che ha per titolo Que Viva Mexico! Chi dedichi un articolo a Thunder over Mexico e a Time in the Sun non può non tener conto dell’immenso scarto tra la visione di Eisenstein e i due raffazzonamenti di uno splendido materiale mal capitato tra le mani di Sol Lesser, un mestierante in mala fede, e quelle di Marie Seton, una devota interprete dell’idea del maestro, neppur di troppo modesta levatura. Perciò chiunque parli delle due versioni incomplete ed opache deve a un certo punto sospendere il giudizio critico e, a seconda del temperamento, fantasticare su quello che l’opera avrebbe potuto essere o elevare alte proteste per lo scempio irreparabile. Quello che è certo è che siamo di fronte a un “film che non vedremo mai”: nessun realizzatore, per quanto fedele e scrupoloso, e direttamente informato, ci renderà più il senso intimo di una opera gigantesca, il cui ritmo segreto è sparito per sempre con colui che l’aveva concepita. Il magro risultato di Time in the Sun insegni. Riconosciuta quindi la dolorosa realtà di trovarsi di fronte a un film fantasma (anche se potrà parere paradossale definire così svariati chilometri di pellicola) sarà forse più onesto vedere con precisione quale fosse la impostazione dell’opera e che cosa Eisenstein intendesse di fare. L’autore del Potemkin era stato attirato al Messico dalla civiltà figurativa di quella terra (aveva conosciuto a Mosca Diego Rivera); si era da tempo interessato alla sua storia ricca di aspri contrasti sociali nonché a certi aspetti della religiosità messicana e in quest’ultima direzione lo aveva sollecitato la lettura di un libro di Anita Brenner: Idoli dietro gli altari. La sua visione si era venuta man mano cristallizzando attorno ad alcuni temi che lo impegnarono totalmente come uomo, come artista e come pensatore. È noto che il film avrebbe dovuto essere una “storia vivente” del Messico divisa in quattro episodi (Eisenstein li chiamava “racconti”) inquadrati da un prologo e da un epilogo; ogni episodio doveva avere un suo carattere, rappresentare “gente, animali, alberi e fiori” diversi da quelli che apparivano negli altri tre. Il tutto sarebbe stato tenuto insieme dall’unità di una costruzione ritmica e musicale che avrebbe espresso lo sviluppo dello spirito e del carattere messicani.
132 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
Una sceneggiatura completa è uscita nel 1934 in Experimental Cinema, e nel 1947 Eisenstein ne mandò una copia, con una introduzione, a Armand Panigel che doveva curare l’edizione francese delle sue opere teoriche. L’edizione si è per il momento arenata ma l’introduzione alla sceneggiatura di Que Viva Mexico! scritta espressamente per l’occasione, è stata pubblicata in appendice alla biografia che la Seton ha dedicato al Maestro ed è un documento di alto interesse umano. Non solo Eisenstein chiarisce in modo definitivo le sue intenzioni, ma leggendo queste poche pagine vi si avverte come un brivido di commozione che l’artista dové provare nel prender congedo dalla più cara delle sue creature. Si ha la netta impressione che il regista tentasse disperatamente di rendere con la penna una minima parte della visione inespressa, che, ormai stanco e vicino alla morte, non sarebbe forse più riuscito a render altrimenti. Attraverso lo stile nervoso e scattante, pronto all’immagine e memore dell’inquadratura, rivive l’entusiasmo creativo di un tempo e balena a tratti un sarcasmo tagliente contro tutti coloro che uccisero la creatura prima che nascesse. Nel Prologo dominava imponente il tema della morte e del tempo, “prologo dell’eternità”. Gli abitanti di Yucatan ne erano i protagonisti al pari delle divinità di pietra che conservano le fattezze dei loro antenati, la gloriosa stirpe dei Maya. A una cerimonia funebre seguiva una scena d’amore: il primo incontro nella foresta di un indio con una giovanetta. La vita trionfava temporaneamente sulla morte e l’eterno circolo pareva momentaneamente chiuso. Il primo episodio si intitolava ironicamente Fiesta. La sua cornice era costituita dal barocco coloniale spagnolo e la composizione dell’episodio avrebbe dovuto essere estremamente complessa ed elaborata. I suoi protagonisti erano il torero Baronito e la dama da lui amata. Il materiale girato per l’episodio si riferisce alle danze rituali messicane e alla corrida. Pare che Eisenstein fosse stato colpito dal carattere rituale della tauromachia e soprattutto dalla processione che intendeva rappresentare simbolicamente l’ascesa al calvario. Al regista non fu però permesso di riprendere dal vero la processione dei Penitentes, la cerimonia sacra tipica del Messico, e dové limitarsi a ricostruirla liberamente. La crocifissione aveva un significato simbolico che in un ulteriore episodio Maguey, doveva calarsi nella realtà della passione terrena dei tre peones giustiziati barbaramente nel giorno del Corpus Domini. Il secondo episodio, Sandunga, era ambientato a Tehuantepec, una
133 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
regione in cui il colonialismo spagnolo era penetrato appena, tanto che il sistema matriarcale degli indiani Tehuana vi era ancora vivo. Il “racconto” avrebbe dovuto essere tutto un inno in lode dell’amore e della vita primitiva; nella storia di Concepcion e di Abundio, i due promessi sposi, il tema della vita avrebbe ancora una volta trionfato. Maguey invece era ambientato in una Hacienda, all’epoca della dittatura di Porfirio Diaz (1905-1906). La morte prendeva il sopravvento e la tragica storia di Sebastian terminava con il calvario dei tre peones, massacrati dagli zoccoli dei cavalli. Quello che abbiamo visto in Lampi sul Messico, rappresenta una falsificazione e un tradimento degli intenti di Eisenstein che si riprometteva nel montaggio definitivo di alternare alle inquadrature della morte dei peones, la processione del Corpus Domini, traendo da tale contrapposizione tematica e figurativa un significato poetico e umano scomparso totalmente nella piatta realizzazione “d’ufficio” di Sol Lesser. La Seton ha tentato di rimediare nel suo Time in the Sun, ma il montaggio vi manca di mordente e dovremo ancora una volta contentarci di immaginare cosa avrebbe ricavato il regista dal materiale girato. Il lato mistico della personalità di Eisenstein si sarebbe certo espresso in modo assai significativo in questa parte dell’opera in cui il regista intendeva mostrare, ironicamente contrapposti, il lato formale e chiesastico del mistero e il mistero vivente nella morte dei tre peones giustiziati il giorno stesso del Corpus Domini. Sarebbe così risultato approfondito il tema degli “idoli dietro gli altari”, della religione primitiva non soffocata da quella imposta dai conquistatori spagnoli. L’ultimo episodio, Soldadera, era realistico quanto a forma e concezione. Il regista non poté girare una sola inquadratura del quarto “racconto” che era dedicato alla rivoluzione del 1910. Nella protagonista, Pancha la moglie del soldato, Eisenstein riviveva la sua esperienza rivoluzionaria. Il figlio di Pancha sarebbe nato durante una battaglia in cui Juan, il padre, trovava la morte. I vagiti del bambino stavano a significare, in mezzo alla battaglia, la nascita del Nuovo Messico dalla rivoluzione vittoriosa. L’epilogo, la cui prima idea era stata suggerita dal libro della Brenner, riprendeva tutti i temi degli episodi precedenti e vi prevaleva il tema della morte unito definitivamente a quello della vita, ambedue trionfanti nelle cerimonie del giorno dei morti. La visione di Eisenstein si concludeva con una danza macabra in cui ricomparivano tutti i protagonisti degli episodi precedenti ridotti a scheletri e l’allegria del popolo
134 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
messicano, che attraverso i secoli aveva sempre vinto gli oppressori, era espressa nell’inquadratura finale dal largo sorriso di un bambino che, toltasi la maschera macabra a forma di teschio, era il simbolo vivente dell’avvenire del Messico nuovo che sì è conquistata la sua libertà. Il film sarebbe dovuto finire con la vittoria della vita sulla morte, sul passato. La vita avrebbe dovuto prorompere imperiosa da sotto la maschera e la morte si sarebbe dovuta ritirare pian piano, svanire nell’ombra del passato con gli scheletri del Presidente, del generale, del Vescovo, del padrone dell’hacienda. Non importa ricordare a chi abbia visto il breve montaggio intitolato, Death Day (Kermesse Funèbre) quanto poco sia rimasto anche in questo caso della concezione di Eisenstein. Basterà rileggere le parole del regista, con cui si conclude l’introduzione di cui si è parlato. Dopo aver sottolineato l’importanza che aveva per lui la presentazione dei personaggi ridotti a scheletro (“cadaveri di una classe socialmente morta”) e la contrapposizione con il primo piano del bambino (“forse il figlio di Pancha?”) Eisenstein deplora che da quel materiale sia stato tratto un banale documentario. E conclude: “Nella Danse Macabre che io vedo nella mia mente si inseriscono, turbinandomi davanti agli occhi, altre facce. Le facce di coloro che non permisero la completa realizzazione del mio film. E loro non fanno cadere la maschera”. A distanza di quindici anni non si poteva dare una più bella risposta a Upton Sinclair, l’inintelligente puritano superficialmente tinto di un marxismo d’accatto. (da «Eco del cinema», a. IV, n. 11, fasc. 50, 15 giugno 1953)
135 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
SOFOCLE, GREENE E COMPAGNI 1
È comparsa notizia di un ventilato progetto di Billy Wilder: girare in Grecia, naturalmente in technicolor, un film dall’Edipo re. Non si dice se il testo sarà quello di Sofocle o se sarà rammodernato da un volonteroso sceneggiatore. Si annuncia invece che come protagonista è stato invitato Charles Chaplin. Sembra che il Grande per ora non abbia risposto. A leggere il comunicato abbiamo trasecolato. La nostra stima per Billy Wilder è sempre stata scarsissima e sempre ci eravamo chiesti come questo astuto mestierante d’alto bordo fosse riuscito finora a darla a bere a molti valenti critici. Ma francamente non credevamo si arrivasse a tanto. E attendiamo il film con gioiosa trepidazione. I produttori hanno sempre avuto una predilezione per la letteratura, intesa in un certo modo. Di qua e di là dall’Atlantico le biblioteche sono state saccheggiate in cinquant’anni e passa di cinema. Molte mani maldestre ma sicure han preso a bersaglio le più auguste e venerande teste. Da Shakespeare a Dickens, da Flaubert a Tolstoij, da Manzoni a Thackeray a Victor Hugo giù giù fino ai contemporanei di ogni specie e levatura, nessuno è rimasto indenne. E non è certo il caso di ricordare, ché meglio varrebbe dimenticare, cosa sono state certe riduzioni, hollywoodiane o meno, di opere drammatiche o narrative. Non mancano eccezioni del genere di Oliver Twist, che il gusto e la misura di David Lean, e la sua amorosa intelligenza del testo, hanno salvato dalla consueta illustrazione sbiadita o opacata o difforme. Ci eravamo, comunque, consolati al pensiero che almeno alcune opere, più o meno tutto il “repertorio” classico, si sarebbero sottratte allo scempio. Era vana illusione. Ritornano infatti i progetti per l’Odissea (a colori, naturalmente) e Billy Wilder ci darà un Edipo re. Attendiamo con pazienza. Solo ci contenteremmo che a nessuno venga mai in mente di darci un Paradiso Perduto, magari con Laurence Olivier nella parte di Satana (il valente attore potrebbe rinverdire gli allori del satanico Heathcliff di La voce nella tempesta) e il buon Ralph Richardson in quella dell’Eterno Padre. Voglia il cielo poi, che mai a nessuno venga in mente di rispolverare
136 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
il progetto di cui si ebbe sentore, se non andiamo errati, attorno al 1943, di una Divina Commedia per lo schermo. Certo non mancherebbe la proposta di affidare il ruolo del “ghibellin fuggiasco” a Raf Vallone e quello di Beatrice alla Pampanini. E chissà che non si trovi una particina anche per Walter Chiari. Magari quel burlone di Farfarello. E certo Fabrizi accetterebbe di buon grado la parte di “Caron dimonio”, forte dell’esperienza del tiranno Niccolaio, nel Giullare di Dio. Benedetta, tre volte benedetta sia l’ignoranza. Sta di fatto che mai si sono visti tanti brutti films come da quando produttori e registi son stati presi da smania di cultura. L’incapacità assoluta di creare, concepire, anzi pensare in immagini, porta gran parte dei registi di oggi a cercare di appoggiarsi a dei testi illustri, nei casi di maggior presunzione, o a delle buone sceneggiature, nei casi di santa umiltà. Dobbiamo confessare, a costo di attirarci la taccia di insensibili alle cose della cultura, che preferiamo nettamente i secondi. E non si ricorderà mai abbastanza come Stroheim, Chaplin, Eisenstein, Clair, Dreyer abbiano sempre pensato anzitutto in termini filmici. Stroheim si accostò a Norris per Greed, ma il film risultò quanto di più coerente al suo mondo si potesse immaginare. L’essenziale, ovviamente, è il punto d’arrivo e nessuno si sogna di negare al regista di ispirarsi a un romanzo più o meno illustre. Ma il regista se è una personalità genuina e creatrice saprà sempre fare qualcosa d’altro e di suo. Basti citare La Bête Humaine, in cui Renoir parte da Zola per darci uno dei suoi films più tipici e riusciti. Ben diverso è il caso del regista che ha bisogno del suo sceneggiatore inseparabile (Carné-Prévert) o in altre parole, di una persona che dia ai suoi films quelle ossa che altrimenti non avrebbero. Per tornare a Hollywood e alle riduzioni cinematografiche di capolavori massimi e minimi che vi si sfornano, si tratta in tal caso quasi sempre del desiderio di sfruttare un titolo affermato. E tutto fa brodo. Oggi Romeo e Giulietta, domani Madame Bovary, dopodomani La Saga dei Forsyte. Si taglia, si sfronda, si pota, più spesso si aggiunge e si modifica. Con i contemporanei la corsa all’accaparramento dei diritti si fa sfrenata. Il libro esce fresco di stampa, il nome dell’autore è affermato, tra pochi mesi avremo il film. Forse si studierà anche il sistema di passare subito le bozze o il manoscritto agli sceneggiatori in modo che il film esca prima del libro.
137 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
È così che, appena finito il confezionamento delle Nevi del Kilimangiaro, ci si appresta a filmare Il vecchio e il mare. Pare voglia occuparsene Hemingway di persona. La cosa potrebbe rallegrarci se non avessimo già avuto qualche saggio dell’abilità che dimostrano gli scrittori dietro la macchina da presa. Anche qui non resta che pazientare e augurarsi che non succeda il peggio. Un caso singolare è quello di Graham Greene che ha esercitato per vari anni la critica cinematografica e quindi avrebbe dovuto un po’ interessarsi di come erano andate le cose a proposito dei molti films tratti da sue opere. Non sappiamo quale sia la sua opinione e ne saremmo invece curiosi. Greene è uno tra gli scrittori inglesi più autentici e ogni sua opera porta il segno di una personalità inconfondibile. Anche la sua tematica, arricchita di libro in libro, è coerente e significativa della nostra epoca. La si può riassumere, in due parole, nel motivo dell’uomo inseguito. L’inseguito e l’inseguitore sono i due poli tra i quali si accende la scintilla della sua fantasia. Ognuno dei suoi grandi romanzi o di quelli che egli chiama “divertimenti” è una variazione sul tema della fuga, il mondo che il romanziere ci descrive è sempre ossessionato, ma meschino, popolato di figure grigie, di peccatori di mezza tacca. Prevalgono i toni cupi, le tinte smorte. È pertanto interessante passare in rivista le versioni cinematografiche dei suoi libri. Se ne trae una lezione su quanto si possa tradire o sfigurare un’opera di narrativa che pur non presenti grandi complessità e non goda ancora dell’aureola di una consacrazione tradizionale. Di marca hollywoodiana sono Il fuorilegge del mestierante Frank Tuttle e L’Agente confidenziale, non sappiamo di qual altro imbrattaschermi. Nel primo il disperato gun-man, l’uomo pagato per uccidere su commissione, sfregiato dal labbro leporino e disperatamente cacciato fino alla morte come un animale, si è tramutato in Alan Ladd. E non ci sarebbe da aggiungere altro. Naturalmente il tema della fuga, dell’inseguimento spietato si è appiattito in varie corse disseminate lungo il film, fino alla maratona di chiusura che va ad affiancarsi alle altre innumerevoli che devono aver già messo a dura prova i garretti di più di un attore americano. Nell’Agente Confidenziale, il triste e mediocre agente impari al compito affidatogli, braccato non solo dai nemici ma dai compagni che non
138 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
si fidano di lui, solo in terra straniera, ha assunto le sembianze di Charles Boyer. E la fatidica vena del romantico amatore trova il modo di palpitare qui ancora una volta prima che l’attore vada ad adagiarsi in parti di “padre”, nelle quali lo preferiamo nettamente. The Ministry of fear, un altro divertimento, doveva attirare Fritz Lang. Lang è un vecchio esperto del terrore. E forse ai tempi di M e del Testamento del Dr. Mabuse avrebbe ritmato in ben altro modo la fuga del protagonista davanti a coloro che vogliono impossessarsi delle preziose fotografie di cui non sa neppure lui di essere in possesso. Qui l’inseguito non sa neanche perché gli corrono dietro. E il senso del terrore è più sottile. Per quanto Il prigioniero del terrore non sia il migliore dei films americani di Lang, bisogna riconoscere che il regista austriaco, pur rimanendo estraneo al mondo di Greene, ha reso a suo modo un certo senso di incubo. Ha anche trovato in Ray Milland un collaboratore abbastanza sensibile. Ma il terrore è rimasto sempre qualcosa di esteriore e di superficiale. Non sappiamo poi qual genio maligno abbia suggerito a John Ford di lasciare le predilette diligenze o la natia nebbiosa Dublino per trasferirsi armi e bagagli al Messico. Il più ingombrante bagaglio è stato senza dubbio l’operatore Figueroa. L’ammirazione che nutriamo per Ford ci spinge ad addebitare all’intemperante messicano il più pretenzioso e brutto dei films girati dal regista di Ombre Rosse, anche se il regista stesso sembra essere di parere contrario. La carità cristiana ci suggerisce di parlare il meno possibile della Croce di Fuoco, film tratto da un grande romanzo di Greene (The Power and the Glory) e che portava perfin nel titolo originale un emblema di tutta l’opera dello scrittore: The Fugitive. Chi ha letto il libro può vedere da sé quanto del prete ubriacone, vigliacco, donnaiolo e nonostante tutto “santo”, sia rimasto in quel fantoccio che neppure Henry Fonda è riuscito a rendere credibile. Resterebbe da parlare del Terzo Uomo. Qui Greene è più direttamente parte in causa. Il racconto fu scritto in origine per lo schermo e l’autore ha curato la sceneggiatura. Il mestiere altissimo di Reed ne ha cavato un film assai piacevole, con le carte in regola, gradevole come spettacolo, dignitoso come fattura. Sono stati scoperti certi aspetti di Vienna notturna e non è mancata una spettacolosa fuga, questa volta nelle fogne. Ma in questo caso ci è parso che Greene si sia limitato a fornire solo un ben congegnato canovaccio, dosando effetti, e predisponendo colpi
139 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
di scena. L’unica volta che poteva seguire di persona un film tratto da una sua opera, l’ispirazione gli è calata di tono. Un equivalente filmico dell’emozione che ci han comunicata le sue opere lo stiamo ancora aspettando. Per concludere, il caso di Greene ci sembra molto indicativo per le varietà delle soluzioni offerte ai fini di un chiarimento dei rapporti tra opere letterarie compiute di un certo livello e il cinema. Se impossibile è stato per un regista come Ford abbordare The Power and the G1ory, che dopo tutto non è Guerra e Pace, non vorremmo davvero essere nei panni di Billy Wilder alle prese con Sofocle. Ma ci auguriamo, per lui e per noi, che ne nasca un capolavoro e che dobbiamo riconoscere il nostro eccessivo pessimismo. (da «Eco del cinema», a. IV, fasc. 45, 31 marzo 1953, n. 6)
140 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
LE VAMPYR OU L’ETRANGE AVENTURE DE
DAVID GREY
Le Vamypr, realizzato da Dreyer in Francia nel 1931, segna l’incontro con il sonoro del grande regista danese che aveva già al suo attivo svariati films, tra i quali quella Giovanna d’Arco che ha una posizione nella storia del cinema, tale da resistere, almeno per ora, anche alle furie inconsulte dei cosiddetti “revisionisti”. Personalità singolarissima, quella di Dreyer, autore veramente assoluto, e si dice dispotico, dei suoi films che certo portano l’impronta di una individualità primaria. Non un professionista di cinema, ma un reporter, specializzato nella cronaca giudiziaria, che di tanto in tanto e talvolta dopo lunghi intervalli di tempo, ci ha dato almeno tre films che segnano altrettante tappe, come oggi è di moda dire. Tre opere che rivelano una coerenza interiore e una costanza di ispirazione che forse nessun altro regista può vantare e ci testimoniano altrettante profonde esperienze spirituali. Si ha veramente l’impressione che il creatore Dreyer obbedisca alle stesse necessità espressive di un poeta e di un musicista e con la stessa libertà; non viene neanche fatto, di fronte a una sua opera, di pensare a necessità commerciali o a obblighi di produzione. Molti grandi films sono stati realizzati più o meno su commissione, ma Giovanna d’Arco, Le Vampyr, Dies Irae sono come pagine segrete di un diario intimo, ci aprono degli spiragli su un mondo ferocemente chiuso, con sue leggi incommensurabili. Le Vampyr è senz’altro la più atroce di queste confessioni e forse il capolavoro di Dreyer. Si tratta di una strana avventura, come suona il sotto-titolo, che ci pare più indicativo a chiarire subito il clima dell’opera. Il testo che ha servito di base alla sceneggiatura è il romanzo In a Glass Darkly di Sheridan Le Fanu, un tardo erede vittoriano della tradizione del romanzo nero inglese, che stempera i colori di una Radcliffe e di un Lewis. Niente di più lontano dallo spirito di Dreyer, a prima vista. Tuttavia il regista ha colto e potenziato a un grado altissimo di espressività quegli elementi che meglio si inquadravano nella sua mitologia per1
Sceneggiatura e regia: C.T. Dreyer; Scenografia: Hermann Warm; Fotografia: R. Maté, L. Née; Musica: Wolfgang Zeller: Interpreti e personaggi: Julian West (David Grey), Sybille Schmitz (Léone), Rena Mandel (Gisèle), Maurice Schutz (Il castellano), Hieronimko (Il dottore).
141 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
sonale. Dreyer ha dichiarato che in un film, si tratta soprattutto di dar l’impressione della vita vista da un buco di serratura. E questa ci sembra veramente la chiave della sua poetica. Si tratta di un mondo spaventosamente chiuso, senza aria, e i suoi personaggi abbacinati da qualcosa al di fuori di loro (i giudici agli occhi di Giovanna, tutte le persone con cui viene a contatto David Grey) sembrano captati e pietrificati nei primi piani. Giovanna si muove ed è infine schiacciata sotto il peso di un giudizio di cui non comprende la motivazione; c’è uno schermo tra lei e i suoi giudici, anche il più pietoso di essi non entra in comunicazione con lei. La sua immagine, attonita o dolente, è circondata dal muro bianco come da una terribile aureola. E il rogo è quasi una liberazione e un trionfo. David Grey si aggira per il paese, nella casa del guardiacaccia, nel parco del castello e sembra un automa; i suoi occhi sono quelli di un ipnotizzato e non sappiamo fino a che punto si renda conto del senso ultimo della sua tragica e strana vicenda. È in un mondo così lontano e senza analogie con quello quotidiano, che Dreyer ci introduce per la sola forza di una macchina da presa che ci obbliga quasi dolorosamente a vedere sempre e solo quel che il regista vuole e dal punto di vista da lui scelto. Da un buco di serratura, appunto. E la consequenzialità del racconto è tale che siamo costretti a seguire le immagini, tutte indispensabili e necessarie, nel loro fluire dal ritmo di un’esattezza e di una libertà tali da far pensare a una composizione musicale. David Grey ci trasporta, dunque, dietro di sé nella sua strana avventura. E i toni che prevalgono nella prima metà del film mirano a definire le dimensioni di un mondo normale in cui tutto a un certo momento diventa possibile. Il paesetto e l’albergo dell’inizio sono normalissimi, ma quel misterioso barcaiolo con una falce che sembra quella della morte, e quel suono di campana che sembra venire attraverso alla nebbia, sono estremamente conturbanti. Il giovane entomologo torna in camera sua dopo una giornata che sembra come tutte le altre, ma subito è preso tra le ruote di un ingranaggio misterioso. Quasi normale è a prima vista anche il dottore, ma la sua enigmatica dichiarazione: “Qui non ci sono né cani né bambini” è smentita immediatamente da un vagito di bambino e da un latrato di cane. In un mondo del genere tutto potrà accadere ormai a David Grey. E sempre normalissimo sarebbe quel balletto di signori in tuba e di dame che sembrano tolti di peso da un film di Clair, solo che ne vediamo le ombre proiettate sul muro della casa del guardiacaccia e ci accorgiamo che è un balletto di fantasmi, guidato da un violino diabolico.
142 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
Poste le premesse e preso contatto con questo mondo estremamente concreto ma pieno di trabocchetti e di valori che cambiano segno, l’azione precipita (non sappiamo immaginare Le Vampyr altro che proiettato senza interruzione); il castellano è ucciso, David dovrebbe essere difensore delle due figlie, ma cade preda del vampiro. Ad un tratto, quasi per magia, la maledizione sembra rivolgersi contro la vecchia e i suoi complici: il guardiacaccia cade fulminato dalla visione della strega e il dottore è soffocato dalla farina nel mulino. Il cerchio è chiuso e Grey si allontana con la figlia del castellano verso una luce lontana, filtrata dalla nebbia. Ci rendiamo conto dell’assoluta impossibilità di “raccontare” Le Vampyr. Non è possibile render conto di un film in cui il tono della fotografia, l’angolazione di un fotogramma, la musica che lo accompagna, e l’espressione o il gesto dell’attore, formano un tutto unico e l’intero commento musicale sembra nascere dalle esigenze espressive del regista a un tempo col ritmo del montaggio. Resterebbe semmai da sottolineare la figura del vecchio servitore e la sua funzione risolutiva. È infatti un personaggio che appare, fino a un certo punto, marginale. Ma sarà lui a leggere la storia del vampiro in un vecchio libro e diventerà così il vero deus ex machina della tragedia. Molto si è scritto sulla lunga sequenza soggettiva di Grey nella bara, un capolavoro di angolazione e di montaggio; come pure il montaggio è usato magistralmente nella sequenza finale in cui l’immagine del dottore soffocato nella farina è alternata a quella degli innamorati che sul fiume si avviano verso una nuova vita, e alle voci dei due sembra fare eco lo stridore degli ingranaggi del mulino. Vorremmo invece sottolineare un esempio di angolazione semplicissima e tuttavia di effetto sconvolgente nell’atroce rictus della donna posseduta dal vampiro. Dicevamo all’inizio che il film ci afferra per un suo carattere enigmatico, ma ci pare essenziale ribadire come l’impressione definitiva sia quella di una vicenda avvenuta, di una paurosa esperienza del regista che ha qui approfondito quello stesso dramma oscuro, già proiettato nella stanza del tribunale che condanna Giovanna; è un dramma che ha per protagonista l’uomo solo, con un suo peccato che egli non sa di aver commesso e per cui non c’è remissione. Il finale del Vampyr ha un senso di liberazione così problematico e disperato quanto disperata nella sua furia è la sommossa dei contadini che protestano contro la condanna della martire, schiacciati dalla ferocia dei soldati inglesi. (da «Eco del cinema», a. IV, n. 8, fasc. 45, 30 aprile 1953)
143 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
VISIONI E REVISIONI
A partire da un articolo di Guido Aristarco sul n. 48 di «Cinema» (nuova serie), che ha provocato una serie di risposte consenzienti da parte dei maggiori critici e saggisti italiani, si è cominciata ad avvertire la necessità, l’urgenza di una così detta “revisione” dell’indagine critica. Crediamo inutile riassumere i dati del problema, dato che oggi sono a tutti noti, essendosi ingrossata la questione per i molti interventi. Ci sembra che alcuni motivi essenziali siano da sottolineare: il temuto “isolamento della letteratura sul film” e la necessità proclamata che alla cultura si accostino gli scrittori di cose cinematografiche; tra gli equivoci conseguenti da questa condizione primo e più grave sarebbe poi “quello di giudicare un film soltanto da un punto di vista cinematografico”. Rimanendo fermi a certi criteri non si potrebbero giudicare films come quelli di Olivier, Miciurin, Ivan il terribile, Francesco giullare di Dio, se non risalendo alle diverse fonti – storiche e letterarie, sociali e teatrali – da cui sono partiti i vari autori; non risalendo inoltre, “alle diverse condizioni ambientali nelle quali queste opere sono nate”. Non si può non concordare con alcune posizioni dell’Aristarco come quando afferma che lo specifico filmico è da ammettersi come tendenza “e che i films sono valutabili col metro dell’estetica che vale per tutte le arti”. Però non possiamo nascondere la nostra diffidenza di fronte a certe premesse e a molte delle conclusioni a cui si è giunti. Il dire che non si possa giudicare un film “se non” risalendo alle diverse fonti (non si vede bene cosa voglia dire “fonti sociali”, però) implica un rischio; ce ne danno la prova molte delle recensioni di Aristarco, così ricche di note testimonianti ed esibenti una brillante seppur un po’ ingombrante cultura, che dimostrano solo come a forza di informarsi e di leggere in margine si finisca per allontanarsi sempre più dal film in quanto tale, come un tutto organico e articolato che vive ormai di vita indipendente; questa non è più quella della sceneggiatura e neppure quella dell’opera a cui si è ispirato il regista, il quale, se è personalità viva e primaria, avrà creato certo qualcosa di molto diverso e di sostanzialmente altro dall’opera, teatrale o letteraria, di origine. Non neghiamo che la conoscenza del romanzo di Flaubert aiuti a sottolineare meglio la pesantezza e la piattitudine dell’ultima sua versione cinematografica americana; ma anche uno spettatore cinematograficamente educato, che per avventura non conoscesse il romanzo, si accorgerà benissi144 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
mo della bruttezza del film. E il confronto col testo non gli gioverà gran che, e se vorrà chiarire a se stesso o ad altri la mediocrità dell’opera filmica le sue argomentazioni dovranno più o meno riferirsi sempre a quest’ultima. Può darsi che l’Aristarco intenda riferirsi solo a fonti letterarie particolarmente nobili (Shakespeare ad esempio), ma nel caso di queste eventuali gerarchie che francamente non possiamo ammettere, non vediamo come lo si possa seguire. Inoltre ci pare di rilevare nelle più recenti note dell’Aristarco una tendenza ad allontanarsi sempre più dal film, cosicché leggendo ad esempio le recensioni di Umberto D. e di Due soldi di speranza, tolte alcune osservazioni pertinenti, molto marginali, si ha l’impressione che si parli di un romanzo, di un dramma, di un’opera lirica, di tutto insomma meno che di un film. E ci confermano in questa impressione le abbondanti citazioni di brani di dialogo che non si vede in che modo possano costituire materiale per il critico cinematografico. Il critico dovrà essere colto: e va bene; giudicare un film solo da un punto di vista cinematografico è un equivoco: potrà anche darsi; parlando di un film, “in quanto tale”, si metterebbe in pericolo l’unità dell’arte: ammettiamolo per un istante. Ma vorremmo chiedere all’Aristarco se ha pensato a cosa capiterebbe a un ipotetico critico musicale che avesse impostato la sua critica, poniamo, sul Wozzeck di A. Berg (recentemente eseguito alla Scala) su un’esauriente analisi sul testo di Büchner da cui è derivato il libretto; e dopo aver compiutamente inquadrato Büchner nel movimento romantico e citato e richiamato Goethe e Schiller si fosse dilungato sul testo del libretto di Berg; e infine, discusse a fondo le implicazioni sociali del dramma, avesse concluso che nell’opera di Berg vi sono “alcune notevoli trovate lessicali, grammaticali e sintattiche”. Se questo stesso malavvisato ipotetico critico avesse in precedenza stroncato violentemente il Trovatore in base alle ridicolaggini e alle incongruenze del libretto e alla poca “presa” sociale del medesimo, nutriamo certi timori che, oltre a destare una sana ilarità, lo si inviterebbe a scegliersi un qualsiasi onorato mestiere manuale. Se i films sono valutabili “col metro dell’estetica che vale per tutte le arti” non vediamo come l’Aristarco non rischi spesso, nel trarre le rigorose conseguenze delle sue premesse, di finire a far compagnia all’ipotetico musicologo. L’esigenza della revisione critica è stata poi intesa da critici meno provveduti e specificamente meno preparati dell’Aristarco in un senso assai diverso e più drastico. Si avverte, e anche in questo caso ammettiamo la giustezza dell’esigenza, la necessità di una risistemazione storica, 145 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
di una revisione vera e propria di valori. Molti films classici sono stati per diverse ragioni mitizzati. Si tratta di riscrivere un’ideale storia dei cinema dove molti di quelli che apparivano in base a giustificazioni entusiastiche e affrettate dei capolavori inconcussi, dovranno essere ridotti alle doverose proporzioni. È cominciato così un processo di sfoltimento della foresta in gran parte vergine della storia del cinema, da parte di dotte e benintenzionate persone che han posto vigorosamente mano alle coltella e si son date a potare e a tagliare a destra e a sinistra, a dritto e a rovescio. Plaudiamo all’opera degli animosi e ne condividiamo in parte i moventi, ma cominciamo già a preoccuparci di dover un giorno trovare al posto della foresta qualche sparuto alberuzzo alla cui ombra mal potremo ripararci. Glauco Viazzi affermava con ammirevole modestia («Cinema» n. 23 pag. 174): “siamo molto ignoranti noi gente di cinema”. Ora, posto il principio che per rivedere è necessario prima aver visto e visto bene, chiediamo a tutti quei critici che decapitano Vidor, fan giustizia sommaria di Pabst, processano per direttissima Dupont, (scelgo tre esempi clamorosi di registi un tempo sugli altari e oggi sempre più respinti nella polvere), chiediamo a tutti loro: Chi di voi ha una conoscenza completa, integrale, basata su ripetute visioni o letture, come è di moda dire, di “tutta l’opera” dei tre registi? Quanti hanno visto The Crowd? Baruch? Die Liebe der Jeanne Nev? Vorremmo che prima di proclamare crociate o guerre sante ci si rendesse conto che lo studioso del cinema, almeno in Italia è nelle condizioni di uno studioso di provincia che oltre ai pochi libri che con sacrificio notevole riesce a procurarsi, deve basarsi su una piccola biblioteca comunale e spesso deve attendere anni per prendere visione di un testo. E quale altro esempio di modestia ci piace citare quello di A. Bassin, critico tra i più acuti ed equilibrati, che confessa in un suo articolo recente su E. Von Stroheim di aver visto “solo” una volta Greed. In questo stato di cose il liquidare per le spiccie ci pare piuttosto avventato, ma ci si potrà facilmente opporre che di fronte a determinati “testi” determinate conclusioni si impongono e si possono legittimamente trarre. Verissimo. Ma è qui che di fronte a certe critiche e alle loro motivazioni dobbiamo dissentire, non solo, ma domandarci se questi processi che sembrano essere istruiti sempre dalla stessa parte e giungono a sentenze analogamente motivate non destino gravi sospetti. Callisto Cosulich («Cinema» n. 46) propone una revisione di Vidor. Avendo visto Hallelujah! e “in un controtipo mancante di qualche parte
146 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
significativa (come si fa a dire che è significativa se non la si è vista?)... nulla possiamo dire del ritmo complessivo dell’opera e della sua drammaticità”. Così il Cosulich; e ci sembra che qui ci si dovrebbe fermare. Non si può fare una critica, poniamo, dei Promessi Sposi, avendone letto abbondanti passi e un riassunto che dia un’idea della trama, e nessun musicista serio parlerà di una nuova sinfonia che abbia ascoltato in una trasmissione radiofonica difettosa, tanto più se la radio gli si è guastata e ha perso l’ultimo tempo. Invece il Cosulich ci parla della “sostanza” del film (ma se l’ha visto male e non tutto, che idea può avere dell’opera, ci domandiamo ancora?) e basa le sue stroncature sul fatto che la descrizione del mondo dei negri sarebbe superficiale. “Vidor si è perso dietro i facili richiami poetici di certi usi e costumi (e Flaherty nell’Uomo di Aran, allora?), non ha intrapreso una seria ricerca etnologica, non ha previsto le possibilità di una evoluzione verso forme più elaborate di civiltà, non ha visto sopratutto gli ostacoli che a questa evoluzione si oppongono”. Cioè i limiti gravissimi del film starebbero essenzialmente nel fatto che King Vidor non si è posto nel 1929 quelle istanze perentorie che il Signor Cosulich si impone e gli impone il 15 settembre 1950. Andando avanti di questo passo si potrebbe arrivare a stroncare Ludovico Ariosto perché nel suo poema così vacuo e formalista canta, beatamente irresponsabile del travaglio civile e sociale dell’Italia dei suoi tempi. Ci piacerebbe davvero sapere il parere di Vidor e prevediamo la sua meraviglia nell’apprendere che suo dovere era quello non di fare un film, come noi ingenui formalisti patiti del cinema e forse anch’egli nella sua aberrazione credeva, bensì di intraprendere “una seria ricerca etnologica”. Glauco Viazzi crede poi di limitare definitivamente il valore di Kameradschaft affermando che col finale del film Pabst dice che “non c’è nulla da fare, la solidarietà internazionale della classe operaia è rotta..., la reazione ha sempre l’ultima parola”. A parte il fatto che anche qui si ha la buffa pretesa di imporre al regista una visione del mondo che è poi quella stessa del critico, ci pare di rilevare (e si veda tutto l’articolo del Viazzi in «Cinema» n. 12) una tendenza non a giudicare il film nelle sue realtà e consistenze filmiche, ma a criticare il contenuto del medesimo, astratto arbitrariamente e quindi distorto. Non sarà mai abbastanza ripetuto che tali critiche si possono benissimo muovere alla sceneggiatura del film e non si può nascondere l’impressione che ai critici di questa tendenza basti un riassunto della trama
147 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
per farsi un’idea della tematica, dell’impostazione, ecc. Tutto il resto è formalismo. E chi si azzarda a parlare di inquadrature, di ritmo, è un “teorico da cineguf”. Vorremmo opporre che con tale metodo proprio questi critici tanto assetati di dialettica e di concreto a tutti i costi ci appaiono in definitiva i più astratti e dogmatici, e sissignori, formalisti. Ed è ridicolo prendere per bersaglio, non l’opera viva e concreta nella realtà delle immagini in movimento, ma l’idea che ci si è fatta confrontando il film con un modello astratto “a priori”, che magari è quello del cosiddetto realismo socialista. Tutto ciò che corrisponde alle formule è “bello”, il resto no. Quindi nella riscritta storia del cinema non più Pabst, Dupont, Murnau, Flaherty e Clair, ma Aleksàndrov di Incontro sull’Elba e i registi di Anna Szábo e Matteo, guardiano d’oche. La revisione promossa dall’Aristarco è, diciamo così, comprensiva, cioè mira a fare accogliere paternamente opere che come i films di Olivier non avrebbero avuto grande diritto di entrare nella storia del cinema oppure cerca di fare ingozzare rospi grossi come Miciurin. L’altra invece si presenta come radicalmente esclusiva. Vorremmo fosse chiaro che non riteniamo affatto neanche noi Die Dreigroschenoper, Fortunale sulla Scogliera, Metropolis, Hallelujah!, dei films immortali; tutti d’accordo che le opere ad esempio di Eisenstein, di Chaplin, di Stroheim hanno ben altri titoli. Ma non ci sentiamo di accettare critiche che partano da certi presupposti e approdino a giudizi per noi irrilevanti. Viazzi osserva:1 “Westfront 1918 termina con la didascalia: Fine?” e quindi non dice apertamente: abbasso la guerra! E noi abbiamo il dovere di rispondergli che vorremmo vedere il film e che di questo lui ci parlasse. Quanto poi all’imporre a tutti i costi sempre una conclusione, e “quella” determinata conclusione, ci pare una pretesa davvero eccessiva. Si limiti il critico a entrare nel mondo personale del regista, a parlarci delle sue opere, ad analizzare i mezzi espressivi individuali dell’autore e a giudicare il film che “vede” senza fare processi alle intenzioni. Se poi richiede dovunque e sempre films “ottimisti, concreti, costruttivi” allora non faccia il critico, ma li faccia lui questi films e noi li andremo molto volentieri a vedere. (da «Eco del cinema», A IV, fasc. 44, 15 marzo 1953, n. 5, pp. 6-7)
1
Art. cit.
148 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
TABULA IN MEMORIAM
Alessandrini Gherarelli Maria Alessandrini Lidia e Alessandro Ballerini Anita e Carlo Baranelli Luca e Fiamma Becattini Andrea e Cristina Becattini Marco e famiglia Becattini Umberto Bellini Alfredo Borselli Orazio Boschetti Maria Bria Gerardo Cappellini Franco e famiglia Celestini Clorinda Chiappini Gaetano Ciampolini Teresa Cristiani Andrea Crocetti Luigi Cuccuini Burdassi Annamaria Dazzi Gianfranco De Angelis Ugo e famiglia De Sarlo Francesco Degl’innocenti Annunziata Del Bufalo Luciano Fregola Barsanti Annamaria Fucile Antonino e Signora Gensini Ermanni Laura Gherardini Renzo e Brunetta Giovannozzi Ceccatelli Cristina Leggeri Berta Lombardelli Angela Luzi Loretta Martellone Annamaria
Martinelli Renzo Masi Giacinta Messina Claudio e Lulli Micheli Piero Navarri Giuliano Nencioni Sergio e famiglia Nicolodi Fiamma Orselli Cesare Pampaloni Martelli Annapaula Panajia Alessandro Poggesi Gilberto e famiglia Polito Piero e Titti Renzoni Danilo e Elisabetta Rolle Pastacaldi Marussia Rossi Giuseppe e famiglia Sabatini Gianpaolo Sablich Sergio Salmon Silvia e Serafini Lisa Sani Vasco Sperenzi Mario Spini Daniele Tamino Antonio e Signora Tassinari Luigi Tiburzi Luciana Todros Valeria Rossella Toti Paris e Laura Vasarri Valentino Venturi Giorgio Venturi Giuliana e Claudio Vitali Giovanni ditta Fenice Diffusione Musicale
149 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
www.logisma.it Finito di stampare per LoGisma editore da Imprima Unigraf di Firenze nel novembre 2001 ***** *** *
150 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
151 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
ETRURIÆ Musica e Letteratura Collana diretta da Marcello de Angelis
1. Il Lohengrin di Wagner a Firenze. a cura di Giovanni Vitali. Contiene “Lohengrin à Florence” di Georges Noufflard [trad. Ilaria Tommasi] 1999. 120 p., ill., 17x24 - ISBN 88-87621-04-7 Euro 12,91 [Lit. 25.000] 2. Giulio de Angelis, scritti di musica e di cinema. a cura di Marcello de Angelis e Aldo Serafini. 2001. 152 p., ill., 17x24 - ISBN 88-87621-19-5 Euro 12,91 [Lit. 25.000] 3. GIOVANNI VITALI, Musica a Firenze. Avvenimenti e personaggi tra Settecento e Novecento. 2001. 152 p., ill., 17x24 - ISBN 88-87621-21-7 Euro 12,91 [Lit. 25.000]
152 www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.