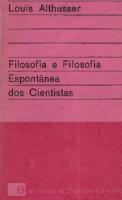Filosofia '93. La filosofia tra pubblicità e segreto
259 52 11MB
Italian Pages 259 Year 1994
Recommend Papers

- Author / Uploaded
- Gianni Vattimo (a cura di)
File loading please wait...
Citation preview
INTRODUZIONE di Gianni Vattimo e Maurizio Ferraris
Platone chiedeva al suo interlocutore principesco di bruciare la lettera che gli aveva inviato, perché la filosofia non sopporta la divulgazione; Aristotele, a un altro interlocutore principesco, scriveva che dalla filosofia non si esce, la negazione della filosofia essendo ancora filosofica. I due aneddoti illustrano, quasi per reciproca antitesi, una condizione che la filosofia si è portata appresso, e che è intimamente aporetica. Esigere il rogo della lettera e rivendicare l'universalità della filosofia sono due forme di pubblicità, e già qui si disegna un complicato intreccio tra richiesta di universalità e bisogno di esoterismo. Il diffondersi dell' alfabetizzazione - di cui Platone aveva diagnosticato con esattezza le promesse e i rischi - non farà che accrescere l'aporia, visto che gli interlocutori dei filosofi non saranno più soltanto principeschi o curiali. Questo non riguarda solo l'essenza della filosofia, ma anche la struttura dell'insegnamento e della ricerca. Ancora Kant poteva considerare normale il fatto di non professare a lezione la filosofia critica. I corsi erano destinati all'esposizione della filosofia di scuola (cui Kant non si riferisce mai con disprezzo), e la risposta alla domanda «Che cos'è l'illuminismo?» o simili erano destinate a una circolazione di tutt'altro tipo. Dunque a rigore ci sono, nella prassi kantiana, almeno tre livelli di comunicazione: la filosofia trascendentale; i manuali di Wolff spiegati e postillati; gli scritti popolari. A che livello si situa la filosofia? E se questa esiste a tutti e tre i livelli, che cos'è la filosofia? Qui certo ci troviamo in una situazione pre-humboldtiana. Ma anche quando le università prenderanno il posto delle accademie, non saranno ancora a lungo istituzioni di massa; i Discorsi alla nazione tedesca e i ragionamenti che Fichte, cacciato dall'Università, inV
dirizza a Berlino a un pubblico «politecnico», sono un'altra cosa rispetto alla Dottrina della scienza. Però, quando il giovane Hegel dello iiltestes Systemprogramm rivendica l'esigenza di una nuova mitologia come mitologia della ragione, un monoteismo della ragione e del cuore e un politeismo della immaginazione e dell'arte, lo fa per un motivo che esorbita oramai dall'orizzonte sin qui descritto: «Finché non renderemo estetiche, ossia mitologiche, le idee, il popolo non vi troverà alcun interesse, mentre, per converso, finché la mitologia non sarà razionale, il filosofo dovrà vergognarsene». Adesso è necessario che il popolo possa trovare interesse nelle idee. Il sistema essoterico-esoterico vien meno, almeno in apparenza, e l'idea vale solo nella misura in cui possa risultare comunicabile. La filosofia tiene però qui il ruolo della redenzione, e dunque il rapporto con la rivelazione e il mistero non si è interrotto. Tanto più che, d'altra parte, lo Hegel maturo intenderà di nuovo la filosofia come rifiuto della sensibilità, dunque anche dell'allettamento sensibile, pubblicistico, propedeutico e pedagogico. Di modo che gli ultimi due secoli di filosofia sembrano aver conosciuto le iperboli antitetiche dell'esoterismo assoluto e dell'incondizionato riferimento al pubblico, con intrecci d'altra parte istruttivi (l'asserto heideggeriano secondo cui noi non abbiamo ancora incominciato a pensare sembra richiamarsi ad entrambe le istanze, eccitando l'interesse pubblico proprio attraverso il richiamo dell'occulto; valide solo sino a un certo punto per comprendere il testo di Heidegger o di Derrida, le analisi di Pierre Bourdieu sulla distinzione sociale e la sociologia della cultura risultano invece persuasive per quanto attiene alla sociologia, ben nota, dell'occultismo di massa e dello pseudo-elitarismo in molta pubblicistica contemporanea). Tornando alla filosofia, la ricerca di una filosofia pubblica e quella di una mitologia politica, che attraversano Otto e Novecento, non sono che la risposta a questa richiesta di pubblicità nuova nelle sue forme ma antica nelle sue esigenze. Che lo Zarathustra sia un libro per tutti e per nessuno indica l'acuirsi del1' aporia di una filosofia che si vuole insieme profetica (esotericoinattuale) e politica (essoterico-effettuale). Ammesso che si possa indicare alcunché di pienamente riconoscibile come «filosofia», per contrapposto all'oratoria, alla persuasione sociale, alla filodossia e alla mistagogia, bisogna bruciare i giornali? (o, almeno, VI
far sì che i giornali non si occupino di filosofia?). D'altra parte, senza i giornali la filosofia può esistere? (È risaputo, per le scienze, che senza un apparato di pubblicità e di socializzazione non si troverebbero i fondi per costruire apparecchi costosi e per pagare ricercatori competenti). Ma non si tratta solo di un problema di fatto, se è vero che la filosofia, anche quella platonica, si scrive, sicché fra il trattato e il giornale non ci sarebbe che una differenza nel numero dei lettori; e se è vero che anche il logos scritto nell'anima di chi sa è proteso verso il dialogo. Altri diranno che questo modo di impostare il problema è pregiudicato da una idea di filosofia (perché porre al centro la questione essoterico-esoterico? non è un punto rilevante solo per I' ermeneutica, la filosofia del dialogo, l'orizzonte della comunicazione o della non-comunicazione?). Ma non esiste un vero problema del cominciamento in filosofia. È forse partendo di qui, da questo problema o da questa aporia, che ci si può provare a rispondere a una domanda sull'essenza della filosofia, se ce ne sia mai stata una, se ce ne sia comunque una oggi. Per mettere il problema nella forma dell'antinomia, la tesi sarebbe la seguente: nata come secolarizzazione del mito, la filosofia deve dissolversi con il mondializzarsi della ragione (ma la dissoluzione del mito non è, forse, ancora un mito, o addirittura la semplice ipotesi storiografica dal-mito-al-/ogos?). Questa invece l'antitesi: il filosofo è, come la famiglia ateniese degli Eumolpidi, il guardiano del fuoco dello spirito; la secolarizzazione non è affar suo (ma come distinguere questa filosofia da una teosofia?). Il problema non è solo di principio, ma si ripercuote sulle decisioni che quotidianamente si prendono nella filosofia come professione. Mimando la Metafisica: c'è chi ritiene che la filosofia sia narrazione, ma si tratta forse di un asserto dogmatico; perché mai la filosofia, adesso, dovrebbe essere racconto o metafora? Non sarà un caso di ignava ratio? Bisogna esplicitare la filosofia della storia che fonda questo giudizio; e, se lo si fa, come non sottrarsi all'impressione che proprio questa giustificazione sia la filosofia, e non lo scavo sulle metafore o altro? Così pure c'è chi ritiene che la filosofia si risolva nella sua storia, ma anche qui c'è una filosofia della storia soggiacente, dunque lì si annida la vera filosofia, e qui invece, nella pratica storiografica, un esercizio filologico che non è più filosofico che qualunque altra filologia. Lo stesso si può dire della filosofia come scienza. Ma poi ancora VII
il problema si complica, perché lo storico avrebbe buon gioco a rilevare che questa definizione residuale della filosofia, come ciò che mette in questione il racconto, la storia, la scienza, non è che una posizione storica, quella socratica. La prima sezione vuole affrontare il problema in modo prevalentemente storiografico (indicando cioè momenti topici del rapporto tra la filosofia, il pubblico e il segreto). Ma, visto che qui ne va dell'identità della filosofia, a venir messo in questione è anche il problema dei rapporti che questa intrattiene con la sua storia e con la storiografia filosofica. Non si tratta di cose equivalenti, ricorda nel suo contributo Carlo Augusto Viano, e lo storico, anche della filosofia, non è necessariamente un filosofo che si sa o che si ignora, come vorrebbe l'argomento della inevitabilità della filosofia. Esiste un interno e un esterno della filosofia - un esterno pre-filosofico, metafilosofico o semplicemente extra-filosofico (proprio ciò che non viene ammesso dalla tesi, retorica o speculativa, della inevitabilità della filosofia). Questo esterno non è soltanto la natura o un irriflesso mondo della vita, ma anche un ambito di tecniche e di saperi in cui rientra, per esempio, la storiografia filosofica. E qui è da rivedersi una visione diffusa per cui al filosofo spetta l'esoterico, e allo storico la trasparenza pedagogica dell'esposizione e della scienza. Malgrado le apparenze, e tenuto conto della difficoltà di tracciare dei confini (dal momento che anche la filosofia si è voluta scienza, per distinguersi dalla magia, e si è misurata con la retorica per contendere il campo ai sofisti e ai letterati), vero è piuttosto il contrario. Ai filosofi va, a parere dello storico, il grande pubblico - un pubblico vasto come le loro questioni -; agli storici il pubblico degli specialisti, cioè altri storici, che possono a buon diritto revocare in dubbio, con la loro sola esistenza, l'argomento della inevitabilità della filosofia. Ma questa inevitabilità - per venire al saggio di Pietro Kobau - non è solo la risorsa retorica di Aristotele, o il rituale argomento antiempiristico, bensl anche l'esito della filosofia popolare e della pretesa, protoilluminista, di pensare con la propria testa soltanto, che attribuisce a chiunque · il possesso di un pensiero, come tale - e se seguiamo questo argomento - filosofico. Ma d'altra parte, tra Kant e Hegel si ripropone l'idea che la filosofia non è affatto alla portata di tutti; essa infatti, al culmine della modernità, comunica con il regno delle ombre, con lo spirito in quanto si discosta dalla evidenza VIII
immediata, dalla pubblicità irriflessa, dalla sensibilità universalmente fungibile. La filosofia è un lavoro, cioè anche una professione e una tecnica, e la pubblicità filosofica non coincide affatto con l'opinione pubblica. L'inevitabilità della filosofia si ripropone, ma a un altro livello: non si tratta di una universalità di fatto, che troverebbe la sua giustificazione troppo debole nella universale esperienza del cogito; si tratta invece di una universalità di diritto, che fa riferimento piuttosto a un ideale di umanità e di ragione che impone di riformulare (o meglio di invertire) la vecchia dicotomia tra un essoterismo universale e popolare e un esoterismo idiomatico e aristocratico. L'esoterico, come ragione e come diritto, è la vera universalità. È quanto si tenta di articolare anche nel saggio su Kant e il problema della pubblicità. Coerentemente con l'illuminismo fredericiano, per Kant è legittima la censura verso l'insegnante o il predicatore, quale tutela degli interessi privati del sovrano, ma questa non può estendersi sino all'attività privata dello studioso, che è la vera attività pubblica, rivolgendosi non a sudditi, ma a un ideale di umanità che, in quanto ideale, non ha alcunché di visibile o di sensibile. La naturalità della ragione, la sua universalità, è strutturalmente il contrario del senso comune; l'inevitabilità della filosofia richiede una laboriosa propedeutica. Seguendo il saggio di Tonino Griffero, anche in Schelling (l'autore che, nella non benevola definizione di Hegel, avrebbe svolto tutta la sua evoluzione filosofica in pllbblico), non è questione che di segreto: il segreto come base della comunità filosofica (di qui le accuse di aristocratismo che si rivolsero a Schelling molto di buonora); il segreto come principio della interpretazione di un autore (e anzitutto di Kant) secondo lo spirito. Nino Chiurazzi, in una transizione dal discorso storico al discorso teorico, si interr~ga sul riferimento al segreto implicito nella definizione della filosofia come esposizione del fondamento, ossia come esibizione assoluta. Il fondamento, infatti, non può mai essere esplicitato per intero; c'è una incoscienza strutturale in ogni fondazione e in ogni istituzione, che non può compiere l'anamnesi completa della propria genesi. Con questo, però, siamo fuori sia dalla essotericità assoluta, che resta un ideale (ossia, kantianamente, la rappresentazione in concreto di una idea della ragione, come tale invisibile) sia dalla esotericità mistificante. Siamo forse nella pretesa di super-sapere congenita alla filosofia, che non è imputabile a semplice malafede, ma che IX
si può ricondurre al problema essenziale dello speculativo, come rapporto con se stesso e con l'altro, ossia come meno e più che sapere. Alla popolarità del senso comune come falsa universalità, cui si contrappone una popolarità e una universalità di diritto, come universalità della ragione, lo speculativo aggiunge un giro supplementare: proprio questa universalità di diritto dovrà farsi carico (ossia superare e conservare, includere nell'esclusione, attraverso una dialettica del dialettizzabile e del non dialettizzabile che è l'essenza della dialettica) la stessa universalità di fatto. Questo concetto dello speculativo orienta, a parer nostro, il saggio di Vincenzo Vitiello che apre la sezione teorica, e che prende l'avvio dall'accusa di separatezza dal mondo, che fu tradizionalmente un buon motivo per ridere dei filosofi - quando non un rimprovero ai filosofi, non tanto di essere fuori del mondo, quanto piuttosto di fingere di esserlo per ragioni pubblicitarie, cioè mondane. Quale è, dunque, la casa del filosofo? Proprio qui si precisa il problema dello speculativo, di un sapere che è tanto più presso di sé quanto più è fuori di sé (ossia, insieme, tanto più essoterico di diritto quanto più esoterico di fatto; e che viene chiamato a includere riflessivamente il fatto nel diritto). Di qui, per esempio, la circostanza che l'intreccio tra filosofia speculativa e filosofia dell'esistenza non risulti accidentale, l'alterità essendo in questione per entrambe; è ciò che viene portato a tema da Mario Ruggenini. L'esoterico è l'assoluto, il pensiero essenziale. Ma nel momento in cui ci si porta verso la finitezza, la questione si complica: da una parte, la filosofia deve incarnare una istanza di radicalità - ma proprio questa istanza vuole che si faccia conto del finito. Pensare la finitezza come finitezza significa pensare oltre l'assoluto: dunque, non volgergli le spalle ma, in modo determinato, svilupparne l'iperbole, secondo la logica immanente dello speculativo. L'esistenza è più vasta dell'essenza; bisogna concluderne, ancora una volta e con un dubbio omaggio alla pubblicità storica e al senso comune, che la ragione (e il suo fondo morale) è consensuale, che il diritto del diritto si nasconde nelle pieghe del fatto, e che la perfetta realizzazione della protensione dialettica verso l'altro è la filosofia delle visioni del mondo, apparentemente tollerante, di fatto dispotica, perché consente all'individuo di esprimersi come individuo, ma gli vieta di avere ragione, quando con «ragione» si intenda alcunché di universalmente valido e non l'espressione di una idiosincrasia? È X
da questo problema che prende l'avvio il saggio di Marco Santambrogio. Che si possa giustificare una teoria della verità non puramente consensuale, è già un punto a vantaggio della possibilità di avere ragione contro la propria epoca. Il fatto che, per Kripke, non sia solo per motivi tradizionali che 68 più 57 è uguale a 125, spiega la moralità della scienza. Si potrebbe aggiungere che questa moralità non è solo retrospettiva. Secondo una prospettiva kantiana e husserliana, il semplice sostenere che 2 più 2 fa 4, anche se questo non fosse mai stato detto prima, è un impegno per l'avvenire, il vincolo che impone a ogni umanità futura, anche nel caso che non ci fossero più l'umanità o il mondo, di assumere che esiste una verità che è vera adesso solo in quanto potrebbe esserlo dopo ogni tipo di sparizione. Questo significa che la pubblicità trascendentale può prescindere dalle forme della sua trasmissione? Seguendo il saggio di Pier Aldo Rovatti, non è vero che le circostanze estrinseche siano veramente e semplicemente tali, ossia che si possa isolare l' empirico-fattuale ut sic, e che si possa distinguere nettamente tra assoluto e storico, come tra interno ed esterno della filosofia. Esemplare è il ruolo della scrittura nella filosofia, che non offre il semplice supporto espressivo del pensiero, ma lo condiziona in modo vincolante. Che la chiarezza sia insieme avvertita come un bisogno e un rischio per la filosofia è testimonianza eloquente della intrinsecità dello stile per il pensiero, cosl come della tensione tra essoterico ed esoterico in cui la filosofia trova una delle sue motivazioni di fondo. De te fabula narratur: la filosofia non è il trascendentale contro l'empirico (o viceversa), l'esoterico contro l'essoterico (o viceversa), l'interno di una comunità senza mondo o la colorata esteriorità del mondo della vita. Questo è ciò che si fa chiaro proprio nel momento in cui si parla di post-filosofia o (più motivatamente) di filosofia post-metafisica. «Sepolta la cosa in sé sotto un'omerica risata» (secondo una delle sentenze di Nietzsche), la filosofia si è davvero consegnatà a una trasparenza senza misteri? È difficile sostenerlo. C'è, seguendo il discorso articolato in Il paradigma e l'arcano, una propensione costitutiva della filosofia verso il mistero, che non vien meno, ma anzi si acuisce, nella universale trasparenza. Lo dimostra per l' appunto la riduzione, proposta ad esempio da Richard Rorty, della filosofia ad una atomistica visione del mondo di individualità isolate, e come tali idiomatiche e ineffabili. Ma una ricostruzione XI
della razionalità dovrebbe andare oltre, e la scelta heideggeriana di riferire il mistero all'essere e non all'uomo potrà fungere, più che da semplice scuola di esoterismo, come terapia che, senza annullare il mistero, ma anzi mettendolo in primo piano, si contrapponga al culto narcisistico del mistero che ognuno è per sé e per gli altri.
FILOSOFIA '93 LA FILOSOFIA TRA PUBBLICITÀ E SEGRETO
STORIA
Carlo Augusto Viano
SCRITTURA E PUBBLICO DEI FILOSOFI
l. Tra esibizione e scrittura
La storia, buona o cattiva che sia, è andata così: i filosofi si sono trovati a far parte della famiglia dei dotti nelle grandi scuole dell'Occidente, a dividersi il pubblico colto con scienziati e letterati. Potevano finire al margine o fuori di quel mondo, dalla parte dei santoni, dei maghi, dei guaritori o dei cultori di spiritismo. Non che non abbiano corso quel rischio o che ne siano del tutto immuni. Oggi però sembra che letterati e filosofi siano buoni amici, almeno là dove sono forti la tradizione tedesca e quella francese. Ma non sempre è stato così. Nel mondo antico erano rivali, ed erano proprio i letterati a dire le cose più crudeli sui filosofi. Forse erano anche concorrenti nel disputarsi il pubblico e nella pretesa di educare i giovani. I letterati consideravano spesso strampalate le cose che i filosofi dicevano o raccomandavano; e talvolta narravano la loro vita facendo finta di prendere sul serio il loro insegnamento. Come se un biografo raccontasse che Rousseau andava a recidere reticolati e abbattere paletti. Però cose strane effettivamente i filosofi ne facevano (o ne dicevano). I socratici attribuirono non poche stramberie al proprio maestro e essi stessi dovettero farne. Platone era assai preoccupato di distinguersi da loro e cercò di trasfigurare molti aspetti del socratismo. Accontentandosi di rendere rispettabile Socrate, evitò con cura di parlare di Pitagora, che qualcuno stava trasformando in eroe di una filosofia da santoni; poi i suoi scolari dovettero trasfigurare Pitagora come lui aveva trasfigurato Socrate. Finley ha detto che nella lotta tra Isocrate e Platone ha vinto Isocrate, imponendo un modello di scuola nella quale gli adolescenti studiano essenzialmente la letteratura. Forse è vero. Al5
meno la mia generazione ha ancora studiato in una scuola dominata dagli studi letterari, che Platone voleva cacciare. E tuttavia Platone ha ottenuto un mucchio di cose. Non è riuscito a imporre né una letteratura né una società controllata da filosofi, ma ha modellato non poco l'immagine della filosofia. Lui aveva fatto propria la tendenza dei suoi colleghi socratici a esibirsi come atleti di prestazioni spirituali, capaci di dominare le ricchezze, di resistere a donne ammalianti e a bei giovani, di sostenere paradossi con ragionamenti capziosi: buoni strumenti per farsi propaganda e avere seguaci. Aveva fatto propria anche la polemica contro la scrittura, un atto accorto per chi si contrapponeva ai letterati. Cosl consegnò alla scrittura l'immagine del filosofo che si esibisce fino a morirne, ma che non scrive. Lui, Platone, naturalmente, scrisse, dicendo che non bisogna scrivere, e ai seguaci impose le proprie opere, fino a ridurli al silenzio o al commento. Platone perdette forse la battaglia con Isocrate, ma vinse quella con i filosofi, perché li costrinse ad avere un rapporto con il testo letterario suggerendo, attraverso il culto delle sue opere e il loro commento, la possibilità di scrivere e contemporaneamente di rifiutare la scrittura. Fu lui che rappresentò le esibizioni che pitagorici e socratici praticavano e ne fece una faccenda colta, fino a persuadere tutti, anche gli estranei, a usare la parola «filosofia», che significava semplicemente una forma superiore di cultura, per designare la disciplina specifica che pretendeva di coltivare e che riteneva superiore a tutte le altre. Platone non esorcizzò del tutto la tendenza all'esibizionismo e alla ciarlataneria, che aveva subito avvertito. I filosofi che si richiamavano a lui ogni tanto davano nel meraviglioso, facevano miracoli, levitavano, tanto da riuscire alla fine a presentarsi come alternativa ai cristiani. Ma non perdettero mai il collegamento con, la scrittura, con il culto e la trasmissione dei testi, con il loro commento. Non riuscirono neppure mai a uguagliare il maestro, o non tentarono, o diedero l'impressione che fosse impossibile. Tuttavia in un'attività nella quale occorreva esibirsi, in un mondo senza televisione, dove una breve distanza sottraeva alla vista, il legame con la scrittura stabill un rapporto con un pubblico vasto, sostituì l'esibizione diretta con quella rappresentata e diede l'impressione che, conservandosi nel tempo, il nuovo sapere che si chiamava «filosofia» fosse anche attendibile e avesse un contenuto realmente universale. 6
Platone riusd anche a costruire, o a lasciare che altri costruissero, la leggenda della sua amicizia con la matematica. In realtà dovette temerla e non poco, se non smise mai di costruire classificazioni del sapere nelle quali essa veniva sempre sottoposta alla filosofia. Il fatto è che stava nascendo un nuovo tipo di compilazione, che metteva in ordine nozioni matematiche, e Platone disse subito che mai la filosofia avrebbe potuto esprimersi in quella forma. Fu buon profeta. Aristotele capì quanto c'era di nuovo nell'ordine in cui nel manuale si stavano collocando le nozioni matematiche, e forse cercò anche di scrivere un trattato di filosofia che potesse competere con quelli di matematica. A me piace credere che il divino e subdolo Platone, morendo con le Leggi già tutte stese sulle tavolette di cera, si sia preoccupato di non lasciare inediti, per essere sicuro di essere stato il solo a costruire il proprio mito. Aristotele, che pare avesse un carattere puntuto e ironico, era un ingenuo: lasciò un mucchio di 'inediti' sui quali scolari, editori e dotti di ogni genere si cimentarono a costruire il trattato filosofico-scientifico che forse lui non aveva mai tentato di mettere insieme e che comunque gli sfuggiva da ogni parte. Ci guadagnò Platone: a lui venne, e viene, attribuita una forma di sapere sublime e perfetto, del quale gli 'inediti' aristotelici conterrebbero solo le rovine. Però la sottomissione della matematica funzionò. Platone non si azzardò mai a dire di essere stato il fondatore della geometria e dell'astronomia. Forse non lo dicevano neppure i suoi scolari, e anzi Aristotele lo rimproverò di aver imitato male la matematica, lui che pensava di aver trovato la strada per imitarla bene; ma non parlò mai della pretesa di Platone di aver generato quella scienza. L'immagine di Platone che suggerisce ai matematici i problemi da affrontare si trova tra le carte degli epicurei i quali, come Aristotele, distinguevano nettamente tra matematica e filosofia ed erano ben contenti di liquidare il platonismo come una dubbia estensione della matematica: e così contribuirono a costruire un altro pezzo del mito di Platone. Perfino Proclo, matematico e platonico autentico, preferì evitare quella leggenda. Che invece ha avuto un'immensa fortuna: si trova su tutti i libri e manuali e qualche tempo fa, in un sonnolento consiglio di facoltà, un collega richiamava quella leggenda osservando, nel corso di un ragionamento burocratico, che dalla filosofia sono nate tutte le scienze, come se fosse una cosa pacific::a. 7
È un inizio un po' strampalato. Ma nel nostro casuale mestiere si incomincia sempre rovistando nella soffitta di casa e se si trova una vecchia mola non si resiste alla tentazione di farla girare. Dunque dalla soffitta vien fuori una forma di sapere che asserisce di essere un supersapere, promette di parlare di cose meravigliose ma poi, molto sfuggente sul proprio contenuto, parla quasi solo di sé e dei propri pregi, pretende di essere una cosa difficilissima, riservata a pochi, ma in realtà è leggibile da parte di tutti. Chi non ha conosciuto filosofi convinti che la filosofia speculativa sia difficile, per eletti, ma ansiosi di avere molti studenti, promossi tutti agli esami con voti altissimi?
2. Il manichino neokantiano
Nella soffitta di un filosofo europeo della mia generazione c'è anche una tenuta da neokantiano. È facile che in passato l'abbia indossata, quasi senza accorgersene, come le uniformi di scuola che gli uomini della mia età hanno ancora portato quando erano bambini. Ora quella tenuta filosofica è tutta sforacchiata, perché i neokantiani sono diventati un bersaglio di moda. A un laureando che si occupi di qualcosa di cui si sono occupati anche loro sarà bene consigliare di mettere subito una severa reprimenda contro l'impostazione neokantiana del problema. Benissimo: ce n'era bisogno e, almeno per ora, in attesa che qualcuno li riscopra, i neokantiani non suscitano neppure la simpatia che si tributa ai perseguitati. Però essi hanno messo in giro miti ai quali è comodo riferirsi, come a un manichino. I neokantiani hanno fabbricato una loro storia su come andarono le cose tra Hume e Kant: un brutto momento nel quale la filosofia rischiò di perdere davvero la sistemazione che si era procurata. La minaccia veniva dalla scienza moderna e Kant si accorse che non ci sarebbe più stato spazio per una conoscenza filosofica se lui non avesse inventato la critica: un modo per impedire che la filosofia, non potendo accertare fatti né scoprire teoremi matematici, diventasse una faccenda da visionari. Lasciamo stare Hume, anche perché Kant conobbe più la paura di Hume che Hume stesso. Lasciamo stare l'abitudine, dalla quale non riusciremo mai a liberarci, di mettere Kant al centro della nostra storia intellettuale. Però qualcosa di significativo in quella 8
leggenda c'è. Si direbbe che davvero Kant o i costruttori neokantiani della sua leggenda abbiano colto il pericolo che il compromesso platonico tra filosofia e scrittura non tenesse più. Kant temette davvero che la filosofia sarebbe diventata cosa più da visionari che da scrittori rispettabili. Il bardarne tecnico dentro il quale Kant si muove come un ragno nella tela ha occultato molti tratti della storia. In fondo recitare tutto il dramma della paura di Hume, con sonno dogmatico e trauma del risveglio, andava benissimo perché ormai Hume arrivava in Germania con l'antidoto scozzese, che poteva servire contro i timori suscitati dalle idee provenienti dalla Francia e dall'Inghilterra: pericoli mortali per l'attendibilità della Bibbia come libro storico. Perché alla fine della Bibbia come descrizione dell'universo astronomico sembrava che ci si fosse ormai abituati. In realtà I' effetto dello shock astronomico si sentiva ancora. Lo so che a richiamare la vecchia storia di Galileo uno fa la figura del massone e dell'anticlericale fuori moda, ora poi che Papa Wojtyla lo ha perdonato, bacchettando un poco perfino i teologi che si erano tanto intestarditi. Naturalmente le cose non stanno come dice Papa W ojtyla. Galileo non voleva fare nessun compromesso e i teologi avevano ottime ragioni per tener duro, perché tra i tanti regali che Platone aveva fatto al cristianesimo c'era lo stretto collegamento tra filosofia, religione e una certa immagine del cielo. Adesso l'ingrato Wojtyla snobba i fedeli teologi che allora presero la cosa sul serio, perché non capirono subito che si poteva mollare Tolomeo: facile ora, dopo che per più di trecento anni la cultura europea ha lavorato a incorporare la nuova immagine del cielo. Eppure nonostante tutti i nuovi pericoli profilatisi per la Bibbia dopo che Galileo era stato accolto nella cultura europea, Kant riprendeva ancora la «rivoluzione copernicana» e la trasformava nella scoperta del soggetto. La formula è diventata canonica nella storia della filosofia: anziché guardare al cielo si guarda al soggetto-che-scopre-il cielo e nel soggetto si ricostruisce l'edificio andato in pezzi nella cosmologia copernicana. E cosl nella storia eroica della filosofia, nella quale Platone è il padre della matematica e una «grande catena» unisce Pitagora al cristianesimo, anche Cartesio, che ha distolto lo sguardo dal cielo per appuntarlo al modo in cui si conosce il cielo, si assicura un buon posto. Se era difficile rimettere la terra abitata dall'uo9
mo al centro dell'universo, si è provato a mettervi l'uomo senza terra, il soggetto paragonato direttamente al sole. Adesso i professionisti della storia della filosofia sono molto più diffidenti di quegli eroi e delle loro novità, spesso tirate fuori anch'esse dalla solita soffitta filosofica. Traslocando, o facendo finta di traslocare, gli scolastici vi avevano lasciato un mucchio di cose. Tra queste anche gli strumenti per ridurre a termini familiari il modo in cui si conoscono i cieli. Come abbiano fatto più o meno lo sappiamo. Cartesio, Mersenne, Hobbes, Spinoza, Locke si industriarono tutti di mostrare che la vecchia immagine del cielo, così familiare, era in realtà il prodotto di un'illusione: sembrava familiare perché gli uomini avevano introdotto dappertutto entità fittizie, complici Aristotele e gli scolastici. Era possibile invece tornare al modo naturale di conoscere: la vecchia immagine del cielo sarebbe scomparsa o sarebbe apparsa incongrua e la nuova si sarebbe delineata con facilità. Il nuovo sapere sarebbe apparso come una prosecuzione spontanea del modo consueto di conoscere: ci si sarebbe accorti che trovare l'ordine del sistema solare richiedeva l'uso delle stesse capacità con le quali si escogita un modo acconcio di disporre in ordine gli oggetti familiari o si gusta lo zucchero. Naturalmente ognuno intendeva a modo suo «il modo naturale di conoscere»: Bacone pensava a delle liste, Cartesio a qualcosa come il problem solving, Locke a un gioco di costruzioni, Spinoza alla dimostrazione euclidea o semplicemente all'ordine del manuale di geometria. Quei personaggi hanno dato un'immagine eroica di sé, hanno asserito di non aver avuto maestri, hanno nascosto gli strumenti con i quali avevano costruito i propri edifici filosofici, si sono rivolti direttamente al pubblico o a nobili protettori senza passare attraverso le scuole e le università nelle quali avevano studiato, talvolta insegnato e presso le quali le loro opere si diffondevano. L'ottocentesca storia eroica della filosofia, che credeva nella grande catena del pensiero, la cui fiaccola passa da eroe a eroe, li ha presi sul serio e ha lasciato sullo sfondo l'ingente materiale scolastico che gli eroi del pensiero solitario utilizzavano. Il titanismo di quei filosofi, che spesso si mascheravano dietro la retorica della modestia, ha lasciato nel1' ombra la persistenza della filosofia scolastica moderna, ampiamente diffusa almeno per tutto il Seicento, ma non solo, ché essa giunge fino ai collaboratori dell' Encyclopédie e permea ampia10
mente la cultura tedesca del Settecento. Purtroppo di questa cultura filosofica si sono occupati storici spesso pallidi e devoti, intenti solo a difendere la tradizione religiosa. Troppo poco per scrollarsi di dosso il mito di un Rinascimento che avrebbe eliminato per sempre le cattedrali scolastiche. Del resto gli stessi innumerevoli libri scritti dai professori di filosofia tra Ottocento e Novecento qualcosa lasciavano trasparire. Dopo l'esalta;,;ione d'obbligo vi si trovava quasi sempre l'osservazione che l'eroe di turno del pensiero moderno non si era «ancora» totalmente liberato del bagaglio scolastico. Spesso quel1' «ancora» evocava Kant, che stava lì ad aspettare che la lunga attesa finisse, per venire a sistemare le cose. L'osservazione, quasi sempre presentata come una critica, non era mica sbagliata; ciò che quegli storici canonici non dicevano è che i loro eroi si proponevano proprio di ricollocare all'interno del modo di parlare scolastico quello che il nuovo quadro del cielo tendeva a presentare come una novità e una rottura, e per questo usavano un linguaggio almeno in parte scolastico. Era stato proprio Kant a costruire la leggenda di se stesso come prodotto della storia della filosofia moderna. I neokantiani presero per buona la leggenda e vi impiantarono una storiografia. Essi ritennero che Kant si fosse completamente liberato da ogni residuo di filosofia scolastica e da questa convinzione furono indotti a riformulare i concetti kantiani scimmiottando il modo di esprimersi degli scienziati loro contemporanei. In realtà celarono il fatto più importante: Kant aveva fatto un uso amplissimo e sistematico dell'apparato scolastico, espungendo tutti quegli elementi estranei dei quali i «filosofi moderni» si erano serviti per rimediare allo strappo astronomico~ Circola ovunque la diceria che Kant abbia elaborato una filosofia modellata sulla scienza newtoniana. Qualcuno oggi sa che questo non è vero ma, se prendiamo per buona quella leggenda, potremmo dire che Kant ha cercato nel modo più sistematico di riesporre la scienza moderna nei termini scolastici. Quando ormai l'immagine aristotelica dell'universo fisico si era dissolta Kant cercava di formulare quella che l'aveva sostituita nel linguaggio che era stato di Aristotele. Paradossalmente i neokantiani fecero di fatto un lavoro inverso al suo, ritraducendo il suo aristotelismo in una specie di simulacro di concetti scientifici moderni. 11
3. Il soggetto naturale e il soggetto trascendentale Quando dicevano che dopo la Critica della ragion pura l'unica conoscenza attendibile è quella scientifica forse i neokantiani travisavano Kant; e forse iniettavano in quell'opera il fantasma del positivismo che li tormentava. Probabilmente è proprio questa loro interpretazione di Kant che li rende insopportabili a tanti filosofi contemporanei. Eppure partendo da quella deformazione della filosofia kantiana essi arrivarono a rivendicare alla filosofia uno spazio autonomo costituito dalla critica. La critica neokantiana consisteva essenzialmente nell'esprimere i concetti scientifici fondamentali in un linguaggio generale più o meno modellato sull' a priori originario di Kant. Ma passando attraverso quell' apparato i neokantiani soprattutto intendevano stabilire collegamenti tra quella che ritenevano scienza vera e propria, modellata sulla fisica matematica, e gli altri campi culturali, come la morale, il diritto, il mondo dell'arte e la politica. Tutto ciò avveniva nel momento in cui la scienza andava configurandosi come un sistema chiuso, di difficile accesso a chi non disponesse di strumenti adeguati. Questo era il punto veramente dolente. La nuova immagine astronomica dell'universo ormai era stata assorbita; era invece il sistema dei concetti con i quali quell'immagine era stata costruita ad apparire adesso come il vero e proprio corpo estraneo difficile da assimilare. La cosa poteva sembrare paradossale. Locke, il quale già non si sentiva più in grado di giudicare i Principia, pur scritti da Newton con un apparato matematico volutamente semplice, elaborava la propria filosofia per mostrare che la conoscenza attendibile della natura è un prolungamento della conoscenza naturale, e per far questo interpretava la conoscenza della natura, quella dei numeri e quella delle regole morali come costruzioni di un medesimo io. Anche per i neokantiani la conoscenza era la costruzione di un fo, ma di un io trascendentale che non aveva più nessuna delle caratteristiche dell'io di Cartesio o di Locke. Non che Cartesio o Locke concepissero l'io «in modo naturale», ma credevano di farlo, mentre i neokantiani non si proponevano neppure di farlo: per questo essi trasferivano le forme kantiane della sensibilità alle categorie dell'intelletto. Cartesio pensava di poter rivolgersi a prelati saggi e illuminati, a magistrati ingegnosi, a matematici e meccanici; Locke a gentiluomini industriosi e ad accademici de12
siderosi di sfoltire il proprio linguaggio scolastico. I neokantiani avevano come teatro le università tedesche dell'Ottocento e il quadro del sapere che ne costituiva l'intelaiatura: attraverso quel quadro essi pensavano di parlare alla nazione, forse soprattutto attraverso i suoi funzionari. Già con Kant il rapporto con il pubblico era diventato un problema esplicito e aperto. Si dice spesso che le università tradizionali, mentre decadono in Francia e Inghilterra a partire dalla seconda metà del Seicento, restano vive in Scozia e Germania. Le cose probabilmente non stanno del tutto così, e questa impressione dipende in parte dalla storia della filosofia moderna eroica e semplificata costruita dallo stesso Kant e poi avvallata dagli idealisti tedeschi. Però in Scozia e Germania le università ebbero una parte importante nel controllo del modo di pensare di quei paesi; e Kant, riformulando in termini aristotelico-scolastici i concetti della scienza moderna, pensò a un sapere per i dotti che hanno nelle università il loro teatro naturale. Egli riteneva però anche che da quella trascrizione si sarebbe poi potuto ricavare un modo per parlare a tutti. I neokantiani, con le loro ossessioni positivistiche, gettarono forse una luce troppo cruda sulla filosofia di Kant e compromisero definitivamente il sottile compromesso che egli aveva costruito. Essi mostrarono che se si traduce il linguaggio scientifico in linguaggio filosofico non si ottiene la continuità tra il linguaggio scientifico e quello naturale, ma anzi si produce una frattura. Per questo danno l'impressione di parlare solo ai maestri dell'università. Qualche anno fa si sarebbe detto che essi avevano mandato in malora la «riscoperta del soggetto» riducendolo a un soggetto trascendentale rinsecchito dal primato concesso alla conoscenza. Sarà anche stato giusto fare quella polemica per liberarsi dai feticci neokantiani; però con quella polemica andò distrutta la possibilità di capire che i neokantiani avevano trovato un trascendentale depurato della base naturale che la filosofia moderna aveva cercato di ricuperare.
4. Voltar le spalle alla scienza
Non è detto che la cosa sia accaduta per via del neokantismo, ma certamente la distorsione neokantiana della filosofia di Kant
13
esprime assai bene quello che accadde. Da qualche parte si incominciò a pensare che bisognava trovare un «modo innaturale» di mettere le cose e che per questo si poteva guardare alle teorie scientifiche, che erano esse stesse un modo innaturale di mettere le cose. La matematica fu di grande aiuto: su di essa si modellò una simbologia logica che era tutta diversa da quella tradizionale e che cominciò a proporre oggetti inconsueti. Non si osserva di solito che tra la fine del secolo scorso e l'inizio del nostro, mentre la letteratura, e forse le arti in generale, avvertono una crisi di invenzione e incominciano a vivere della propria storia e delle proprie tradizioni, gli scienziati si mostrano fervidamente immaginosi. L'immaginazione sembrava e sembra cosa riservata ai filosofi, oltre che ovviamente agli artisti: dire che la speculazione filosofica è opera dell'immaginazione è un modo per uscire dall'imbarazzo prodotto dalle venerabili costruzioni della filosofia speculativa, magari non molto solida, ma frutto di una sorta di fantasia intellettuale. Quasi sempre in realtà l'immaginazione dei filosofi è libresca ma, a partire dalla metà dell'Ottocento, in filosofia come nelle arti è diventata esplicita la tendenza a vivere della propria tradizione. Invece nel frattempo matematici, fisici, biologi, naturalisti hanno cambiato non solo il modo di spiegare, ma anche quello di immaginare il mondo. Questo è un aspetto che i neopositivisti, spesso considerati i vati della scienza contemporanea, non hanno mai colto: erano filosofi essi stessi e ritenevano che nel paese dell'immaginazione si incontrassero solo poeti e metafisici. Quando misero in giro la formula che bisogna diffidare del linguaggio naturale e guardare dentro il linguaggio scientifico artificiale credettero di aver trovato quello che la tradizione scolastica chiamava «esperienza» e «sensibilità»; invece avevano incontrato l'immaginazione. , I neopositivisti furono pochi, le loro opere rappresentano una piccola parte degli scritti filosofici che hanno circolato, molti di loro erano personaggi marginali e un po' strani. In compenso hanno fatto prendere un grande spavento e hanno sulla coscienza tutto quello che si è scritto per confutarli. Apparentemente lo spavento fu generato proprio dal loro richiamo a esperienza e sensibilità, da quello che nella loro filosofia appariva «riduttivo». Del resto ai neopositivisti, filosofi, avevano risposto altri filosofi, che parlavano lo stesso linguaggio e che, paradossalmente, dalla filosofia neopositivistica potevano ricavare suggerimenti per
14
esorcizzare il mondo immaginato dagli scienziati e mettersi al riparo una volta per tutte dallo sgomento che si provava ogni volta che questi mettevano in giro le loro orribili creature. Il tentativo dei filosofi moderni di addomesticare le nozioni scientifiche, di mostrare che erano i figli naturali della nostra mente era sbagliato, perché era andato bene con il sole al centro dell'universo, ma non si poteva continuare così. I neopositivisti insegnavano che la scienza è un linguaggio artificiale, il contrario del linguaggio naturale; allora bisognava tornare a ciò che è naturale, un «naturale» da cui può essere espunto tutto quel calcolare e mettere alla prova che vi avevano ficcati i filosofi moderni prima di Kant, senza accorgersi che quelle cose portano con sé mostruose entità. Si potrebbe dire che questo è un modo un po' curioso di raccontare la faccenda. D'accordo, d'accordo. Ma prendiamo la vicenda di Husserl: esemplare. Era partito polemico contro lanaturalità, quando aveva ancora un piede nel paradiso di Cantor. Si doveva sentire una specie di nuovo Kant, con tutta quella matematica aggiornata e con la scolastica di Brentano nella testa. Poi qualcosa andò storto. Nel paradiso di Cantor gente come Hilbert impiantò efficacissime macchine che producevano simboli e che non funzionavano meglio se uno oltre al simbolo aveva l' Erlebnis, mentre Husserl era sempre tutto avvolto di Erlebnis, immerso nella loro corrente che lo portava con sé facendolo mulinare e ruotare su se stesso. Lui si offese, se la prese con Galileo (per questo abbiamo dato spazio a Galileo nella nostra storia), disse che dopo di lui la scienza aveva deformato quel che voleva rivelare e decise che la corrente di Erlebnis dalla quale ora si faceva dolcemente portare era la Lebenswelt. Husserl finì con il trovarsi vicino a Dilthey, che aveva trattato con tanta sufficienza nei tempi in cui si credeva ancora l'angelo della «scienza rigorosa». Bisogna dire che Dilthey l'aveva capito. Si doveva dirlo subito che la scienza pretende di conoscere perfettamente le cose che sono fuori di noi: ma come? non conosciamo meglio oggetti che sono identici a noi, fatti come noi, quali gli eventi storici? Questa è solo una delle storie, che furono di diverse specie. «Vado verso la vita!» furono in molti a dirlo prima del nostro vate. Più o meno però bisognava voltare le spalle a un mondo sul quale, come diceva Bergson, il nostro progetto di utilizzazione delle cose stendeva un velo ingannatore. Secondo Bergson l'in-
15
tuizione era una buona guida, anche se egli non fu mai preciso nel dare istruzioni in merito: quando qualcuno insisteva con le domande diceva che se ci fossero state istruzioni non si sarebbe più trattato di intuizione e che comunque chi obiettava dimostrava semplicemente di non averla esercitata. Di fatto Bergson scriveva trattati molto tradizionali, come quelli di Aristotele e di gran parte dei suoi colleghi: organizzava le vedute degli altri filosofi in coppie di contrari e mostrava che avevano un presupposto comune, da eliminare. L' Evolution créatrice è esemplare: Bergson riesponeva le teorie scientifiche dell'evoluzione in termini di finalismo e meccanicismo e mostrava che entrambe erano teorie causali. Poi dava una propria versione filosofica dell'evoluzione con la quale trasformava il processo evolutivo in qualcosa di simile alla durata psicologica, cioè la assorbiva nell'immagine dell'interiorità che i filosofi avevano lungamente praticato. Poteva anche sembrare che Bergson riprendesse così il compito di acclimatare le novità scientifiche entro un linguaggio colto tradizionale, che la filosofia moderna classica si era assegnato; ma per lui questo significava non mostrare che la scienza è un prolungamento della conoscenza naturale, bensì voltar le spalle alla scienza. Bergson aveva separato le due componenti che costituivano l'armamentario con il quale la filosofia moderna classica aveva tentato di riassorbire l'immagine copernicana del mondo: i fatti interni della coscienza e la struttura fatta di sostanze, proprietà e così via. Bergson utilizzava i soli fatti di coscienza: lo faceva nel modo più brillante, ma non era il solo né era stato il primo. Prima di lui i filosofi tradizionalisti francesi avevano sviluppato questo aspetto dell'ideologia settecentesca. D'altra parte anche quei neokantiani per i quali la fissità delle categorie usate da Kant era diyentata imbarazzante, si misero, come Dilthey, sulla strada dell'interiorità e finirono con il costituire il grosso dello storicismo. Ma, da Brentano a Husserl, c'era chi alla struttura concettuale della filosofia tradizionale non era disposto a rinunciare, e pensava che essa potesse essere ricuperata con un nuovo modo di collegare quella struttura con l'interiorità, un modo esplicitamente ripreso da fonti scolastiche che la filosofia moderna classica aveva trascurato. Anche questi filosofi però presentarono la filosofia come un'alternativa alla scienza moderna. In un certo senso la scienza moderna aveva «impoverito» il mondo privandolo 16
dei molti oggetti dei quali l'esperienza quotidiana, l'immaginazione, la letteratura, il mito, la filosofia lo aveva popolato. La scienza moderna aveva certamente introdotto nuovi oggetti, come spazi più che tridimensionali, figure geometriche più varie rispetto a quelle familiari anche agli studenti di ginnasio, forze, campi, atomi, elettroni e così via; ma rischiavano di scomparire sostanze, attributi, idee, ideali, fini, beni, atti di coscienza, intenzioni e così via. E se i matematici si battevano per non rinunciare ai paradisi di Cantor, i filosofi si batterono per non rinunciare ai paradisi popolati di queste entità. Russell amava presentare la propria logica come una liberazione dall'interpretazione della proposizione data dalla logica aristotelica. Una liberazione che non fàccia cadere la testa di un re che liberazione è? Non era facile trovare un re da sopprimere nei mondi accademici europei del Novecento, e Russell sacrificò «l'attuale re di Francia». Dietro quel sacrificio si avvertì un attentato ai molti oggetti inesistenti che popolano i nostri discorsi. E molti filosofi si assegnarono il compito di difendere «l'attuale re di Francia» e tutta la sua corte immaginaria. La rivolta antirusselliana che caratterizza buona parte della filosofia contemporanea è la rivendicazione delle creature dell'esperienza comune contro i personaggi alternativi delle teorie scientifiche. Opere lontane tra loro come Esperienza e natura di Dewey, il Concetto della mente di Ryle o le Ricerche filosofiche di Wittgenstein paiono da questo punto di vista sorprendentemente vicine. Il linguaggio ordinario, l'uso, le forme di vita sono solo modi diversi di interpretare lo stesso programma. I tipi di esperienza, dalla morte al mito, che Dewey vuole introdurre nel concetto filosofico di esperienza, sono solo la versione più altisonante dei discorsi dei maestri di scuola e degli istruttori di ginnastica ai quali ama riferirsi Ryle o del modo di contare i mattoni dei muratori di Wittgenstein.
5. Il gran fiume della storia Una delle strade più invitanti per voltare le spalle al mondo arido e poco familiare della scienza passava attraverso la storia. Dilthey aveva visto nella conoscenza storica la realizzazione della conoscenza di sé, garantita dall'identità di soggetto e oggetto, che egli considerava così soddisfacente, come uno che preferisca
17
guardarsi allo specchio anziché scoprire paesaggi inconsueti. Vista attraverso lo schermo della storia la stessa scienza poteva essere interpretata come una forma di azione umana, e così perdere la propria peculiarità, proprio come le cose perdono la propria estraneità se sono assorbite nell'intreccio di rappresentazioni, propositi, valori nel quale sono coinvolte. Gli storicisti indicarono un modo per sottomettere a circostanze locali anche i contenuti che le scienze presentavano come generali e indipendenti da condizioni circostanziali: Spengler pretendeva che perfino la matematica subisse l'attrazione del campo storico e che le medesime proposizioni matematiche fossero in realtà diverse se appartenevano a periodi storici diversi. «Storicizzare» diventò così, spesso, un modo per ricondurre i concetti scientifici a condizioni totalmente alternative rispetto a quelle operanti nelle spiegazioni scientifiche, evitando tuttavia l'esangue io trascendentale kantiano o neokantiano. Espresso così lo storicismo potrebbe anche apparire una generica ricetta relativistica. Del relativismo esso condivide la dichiarazione di preferenza per le spiegazioni locali; ma, al di là delle sue preferenze programmatiche, esso è costituito da un gruppo di ben precise interpretazioni della storia universale, fortemente ispirate dai problemi posti dalle culture nazionali europee, in particolare della Germania e dell'Italia, due paesi impegnati a costruire la propria cultura nazionale, spesso inventando storiograficamente tradizioni culturali unitarie anche dove non c'erano. Anche lo storicismo diventò così un modo per costruire l'alternativa alla scienza moderna che, sprofondando verso la vita o l'interiorità o tornando alle entità inventate dagli scolastici, la cultura europea stava delineando. Questa volta il «ritorno dalla scienza» passava attraverso la sostituzione del linguaggio chiuso della scienza con un linguaggio che potesse parlare ai popoli e alle nazioni, ricuperando i riferimenti locali che l'universalità della scienza aveva smarrito. C'è una storia esemplare, come quella di Husserl, che si svolge più o meno nello stesso momento. Tra Ottocento e Novecento anche l'economia diventava una teoria chiusa, con un numero sempre minore di riferimenti intuitivi, un linguaggio tecnico di una qualche complessità e strumenti di calcolo non solo elementari. I valori, ai quali gli economisti si erano riferiti e che tanti filosofi dell'economia avevano cercato di mettere dietro ai prezzi, 18
stavano scomparendo del tutto: al momento di chiudersi dentro la propria disciplina gli economisti si erano portati via i prezzi lasciando i valori ai filosofi. Dapprima questi se ne fecero una ragione pensando di essere rimasti con la parte più importante del patrimonio di famiglia. Poi risultò che il patrimonio non era facile da sistemare, perché con i prezzi gli economisti si erano presi le etichette con le quali si poteva tentare di dare un ordine ai valori. I filosofi rimasero con termini che senza etichette era perfino difficile distinguere l'uno dall'altro: come se si dovessero indicare delle cose nascoste dietro una parete, non si sa se una sola o molte, facendo cenni da dove si può, da sopra, di fianco, dal basso ... Lo storicismo diede coraggio di fronte a questa impresa, e un personaggio importante come Max Weber cercò di ripercorrere a ritroso il cammino dell'economia contemporanea, ritornando dai prezzi ai valori. E dire che Weber era uno degli storicisti più sobri, rispettoso dei procedimenti propriamente scientifici, anche se tendeva a confonderli con le formule dei giuristi e simulava il calcolo matematico con lunghe frasi gergali, come uno che volesse esporre l'algebra in parole. Lo storicismo di W eber non fu mai così corrivo come la teoria delle visioni del mondo che servì a mettere qualcosa sulle spalle delle teorie scientifiche e a negare che esse fossero pienamente comprensibili senza aggiungervi qualcosa, sostanzialmente quei valori che, privati dei prezzi, sembravano maneggiabili solo con le dubbie e impervie generalizzazioni paragiuridiche di W eber. Qui stava la differenza rispetto ai tentativi di «naturalizzazione» della filosofia moderna classica: questa supponeva che la nuova immagine dell'universo fosse corretta e cercava di adattare a essa i vecchi strumenti. Ora bisognava dire che la scienza, presa in sé, può essere comoda, ma è scorretta. Lungo questa direzione, pensando di scorgere nelle visioni del mondo e nei valori quello che la scienza cela, si arrivò a fare della scienza, sempre più feconda di tecniche, un elemento non solo parziale, bisognoso di essere reintegrato nelle visioni del mondo, ma un vero e proprio fattore di deformazione e di inganno. Alle sottili analisi che svuotavano le teorie scientifiche del loro contenuto proprio e cercavano di cancellare la chiusura che era un loro elemento caratteristico, si sostituivano l'invettiva e le catastrofiche previsioni sulla fine dell'Occidente o del capitalismo o della società industriale. La fine dello storicismo dava luogo alla profezia sulla storia.
19
6. Il cambiamento delle alleanze L'antica rivalità tra scienza e filosofia di cui parlavamo all' inizio era anche legata alla pretesa della filosofia di mettersi dalla parte del sapere, anzi di essere un supersapere. Ci sarebbe da aspettarsi che dopo aver voltato le spalle alla scienza la filosofia abbia stipulato un'alleanza con la letteratura. In un certo senso questo è avvenuto: molti filosofi hanno incominciato a pensare che l'arte potesse essere la forma di conoscenza alternativa alla scienza della quale la filosofia andava in cerca. Si è trattato spesso di un semplice «teorema filosofico» senza grandi conseguenze pratiche. Ci si può anche domandare se il «cambiamento delle alleanze» abbia condotto a cambiare lo stile comunicativo dei filosofi, il genere letterario da loro praticato e il loro pubblico. Perché molta della letteratura filosofica oggi corrente sembra la continuazione del trattato filosofico inventato da Aristotele come sviluppo del dialogo platonico: il procedimento più usato è pur sempre la confutazione di posizioni assegnate a interlocutori più o meno ipotetici. Si dice di solito che Socrate si limitasse a confutare i propri interlocutori; ma già Platone dovette avere il sospetto che la cosa non potesse funzionare, perché non solo dalla confutazione non si può ricavare nessuna conclusione indipendente, ma non si può neppure confutare senza assumere delle premesse. Per questo Platone cominciò a mettere le proprie discussioni in un «pieno filosofico», cioè le fece muovere tra opinioni filosofiche che riteneva condivise da qualcuno; e Aristotele rese sistematica la cosa. I filosofi contemporanei hanno dovuto ripetere questo percorso. Abbandonato il commento e cercando di battere la via del trattato i filosofi moderni classici dovettero credere di avere dei fatti a portata di mano, per non trovarsi di fronte al vuoto che Platone e Aristotele avevano riempito con il loro «pieno filosofico». Adesso bene o male i fatti sono diventati monopolio di tecniche di accertamento che sfuggono al controllo dei filosofi. Per difendersi gli stessi filosofi hanno avuto interesse a ridurre i fatti a credenze, riportando tutta la faccenda a uno scontro di opinioni filosofiche dominabili con la confutazione. Ridotti i fatti a credenze è tuttavia rimasto il problema delle tecniche argomentative, che dovrebbero costituire una base comune neutrale sulla quale erigere le confutazioni. Oggi i filosofi sono divisi an-
20
che sulle regole argomentative, che non considerano un tutto chiuso e neutrale accettato da tutti. È sempre comodo riferirsi a Kant e, vista con il senno di poi, la sua filosofia sembra adesso l'ultimo tentativo di tenere tutto insieme: i fatti sono preceduti da credenze e queste sono costituite dall'uso produttivo delle stesse regole della confutazione. Non tutto è passato attraverso Kant; ma la dissoluzione della sintesi kantiana o di altre equivalenti ha sempre più spesso condotto i filosofi a riferirsi al linguaggio depurato da qualsiasi connessione necessaria con fatti o con gruppi di regole prèdeterminate. In questo è consistito uno degli aspetti di quella che è stata chiamata la «svolta linguistica» in filosofia. Gli scritti filosofici che ne sono scaturiti, apprezzabili spesso per acutezza o accuratezza, si rivolgono principalmente a un pubblico formato da altri filosofi, e continuano a essere costituiti dalla confutazione o correzione di punti sostenuti da altri filosofi. Gli autori che appartengono a questa famiglia si offenderebbero se qualcuno li volesse inglobare in una tendenza generale caratterizzata da qualche «contenuto» filosofico. Ma si può tentare lo stesso di farlo. Quasi sempre essi cercano di reintrodurre molti concetti filosofici tradizionali che certe interpretazioni del linguaggio scientifico avevano provato a escludere, al punto che questo modo di fare filosofia si è talvolta esplicitamente presentato come una forma di neo-aristotelismo. Da questo complesso di lavori filosofici, fatto di scambi tra filosofi professionali, emergono tuttavia immagini filosofiche esportabili, che in modi diversi possono arrivare al grande pubblico. Una è un'immagine benevola e un po' ciarliera. Se da Cartesio a Bentham i filosofi sembravano essersi ostinati nel tentativo di convincere gentiluomini illuminati che il mondo è fatto di vortici o di sensazioni e che decidere è come addizionare e sottrarre, se i filosofi impressionati dalla scienza contemporanea sembravano propensi a sostituire gli oggetti familiari con insiemi, modelli, campi, metri che si accorciano, dimensioni che si moltiplicano paurosamente, i filosofi del linguaggio mandano a dire che si può stare tranquilli, non occorre cambiare l'arredamento, perché tutto è a posto cosl com'è. Le cose, il nostro corpo e il nostro cervello possono sl avere strutture complicate, ma questo non getta dubbi sui nostri modi casalinghi di rivolgerci alle cose, di parlare dei nostri gesti e dei nostri pensieri, perché le parole e le credenze ven21
gono prima delle cose e delle conoscenze e la mente è irriducibile al corpo. Esce di qui una letteratura filosofica che rivaluta le «intuizioni morali» correnti, riabilita l'io, fa delle cose termini secondari di processi nei quali interagiscono persone e offre schemi semiologici con i quali generare formule di interpretazione rapida di molte cose, di fatti lontani e mal conosciuti o di fatti globali che è difficile conoscere esattamente.
7. Il silenzio filosofico
Dalla svolta linguistica è uscita non solo una filosofia ciarliera, ma un caso emblematico di silenzio filosofico. Agli inizi Wittgenstein aveva scritto un Tractatus, che non era un libro di filosofia nel senso tradizionale e che conteneva una specie di intimazione a tacere. Si è scritto fin troppo su quel monito, ma più o meno esso diceva che, se le cose stavano come la logica delle proposizioni rivelava, il linguaggio filosofico tradizionale andava abbandonato e molte cose non si potevano più dire. Wittgenstein ne fece un dramma, ma era un'impressione che molti provavano anche se non la prendevano così tragicamente. Poi, quando ormai il peggio sembrava passato e lo stesso Wittgenstein si era messo a praticare un'intensa filosofia parlata, quando ormai pareva che si potesse riprendere a scrivere di filosofia in modo tradizionale, lui si rese conto che non sarebbe mai riuscito a scrivere il libro di filosofia al quale lavorava e per giustificare il quale aveva fatto quella che molti ritenevano una rivoluzione in filosofia, o almeno nella sua filosofia. In filosofia, come altrove, le cose vanno poi diversamente da come uno si aspetta. Wittgenstein non riuscì a scrivere il libro e diventò un santone della chiacchiera filosofica; ma sulle rovine della sua impresa è nato un genere letterario filosofico, costituito dalle glosse agli esercizi orali di Wittgenstein, che così è diventato un filosofo popolare anche per chi non fa della filosofia una professione. Il confronto tra Wittgenstein e Heidegger è un crocicchio frequentatissimo della filosofia contemporanea, un esercizio al quale moltissimi si sono dedicati, tanto che vien da vergognarsi anche solo a ricordarlo di nuovo. Se si prendono le cose dal lato del silenzio vien proprio da domandarsi «ma perché Wittgenstein e Heidegger?». Wittgenstein ha fallito come scrittore, men22
tre Heidegger ha pubblicato libri, eccome. E tuttavia in un certo senso anche Heidegger ha vissuto l'esperienza fatta da Wittgenstein: la minaccia che di colpo il linguaggio filosofico tradizionale fosse diventato obsoleto, che l'arredamento al quale i filosofi erano abituati fosse stato messo sotto sequestro. A tutto questo Wittgenstein reagl con il silenzio, mentre Heidegger «diede voce» al silenzio filosofico, sostenendo che o non pensiamo più o non abbiamo ancora incominciato a pensare, immersi come siamo in un periodo dominato dall'ossessione per la correttezza del pensiero e per il dominio sulle cose. Heidegger trasformò lo smarrimento nell'attesa di un ritorno, un'attesa alla quale più che la parola si addice un ascolto profeticamente loquace. Si capisce anche perché Wittgenstein abbia dovuto limitarsi a ostentare il proprio silenzio mentre Heidegger ha potuto far parlare il silenzio filosofico. Wittgenstein osservava che non si può più far filosofia se non conversando con un interlocutore, che deve essere connivente perché il filosofo che gli pone domande non sembri «pazzo». Egli aveva l'impressione che si può far filosofia solo parlando il linguaggio della gente comune, ma rispondendo a domande che la gente comune non si pone: era ancora sotto l'impressione della fine del linguaggio filosofico tradizionale, di quello che alla buona potremmo chiamare l' «effetto Russell», quello che i filosofi che civettano con la psicoanalisi chiamerebbero la «scena primaria» della sua storia. Heidegger non cercò mai di entrare nella cittadella straniera della quale uno come Russell aveva creduto di disegnare la carta topografica, e si mantenne fedele alla tradizione filosofica, cioè a quel «pieno filosofico» nel quale Platone aveva collocato la confutazione socratica. Per molto tempo quel pieno era stato garantito dalla presenza di testi filosofici canonici, oggetti di commenti continui. Poi il tramonto dell'immagine dell'universo presupposta da quei testi e dai loro commenti sembrò inaugurare il trattato autonomo tipico della filosofia moderna classica, da Cartesio a Hume. In qualche modo era stato Kant a riprendere il commento, non nella forma tradizionale, ma costruendo l'argomentazione filosofica attraverso l'uso di quadri storici. Qui prendono corpo le categorie di «razionalismo», «idealismo» ecc., e la filosofia critica di Kant è la continuazione del tentativo socratico-platonico di ricavare qualcosa di positivo dalla confutazione di due posizioni contrapposte. La stessa dialettica ottocentesca non sarà altro da 23
questo: essa non pratica più il commento tradizionale, ma come il commento permette di produrre testi filosofici a partire da altri testi filosofici. Forse nella nota disputa avevano ragione quelli che non volevano applicare la dialettica alla natura. In natura nulla si ricava dal nulla, bisogna rispettare i principi di conservazione e non accadono i miracoli, mentre la dialettica è una macchina che fa miracoli, fa a meno del principio di non contraddizione, produce conclusioni senza premesse adeguate, ricava verità da credenze e così via. Heidegger (non si direbbe) è prudente ed evita la trasgressione vistosa delle leggi naturali: per questo non usa la macchina dialettica. Egli ritiene che il succedersi dei quadri storici riveli un percorso interrotto, che occorra attendere il ritorno a un'epoca che non c'è ancora e che nel frattempo si possa non parlare, ma soltanto interrogare, ascoltare, accennare. Il risultato di tutto questo è stato che il testo stesso di Heidegger è diventato oggetto di commento come se, in attesa del ritorno al futuro, ci si potesse soltanto far suggestionare dagli accenni presenti nei suoi libri. Anche qui c'è un certo parallelismo tra un «effetto Heidegger» e un «effetto Wittgenstein»: entrambi sono diventati oggetti di commento e i loro testi vengono considerati punti di partenza dai quali si procede con svolgimenti più o meno liberi. Il rifiuto della macchina dialettica dovuto a Heidegger ha però anche rimesso di moda un'altra maniera di trattare la tradizione filosofica. Dialettici e Heidegger erano stati un po' drammatici e avevano visto nella tradizione filosofica o una vergine feconda che produce testi come una fontana o una cosa che ti mette freddo al cuore. Un modo dolce di trattare la tradizione filosofica, senza dialettica e senza troppe fratture, poteva venire dallo storicismo riportato alle sue origini religiose, che erano ben 'presenti in Dilthey. I padri cristiani, poveretti, avevano dovuto mettere insieme cose ben distanti, interpretando i testi, trovandoci quello che non c'era, aggiungendo significati improbabili: così avevano costruito l'immagine di una tradizione unitaria, che non esisteva in sé, ma che era il prodotto della complicità degli interpreti. Per ricostruire la Germania dell'Ottocento, dopo che era stata invasa dalle idee e dai soldati francesi, Schleiermacher aveva pensato che si dovesse tornare a quei metodi. E lo storicismo fu anche una ripresa di quel suggerimento, che poteva tornar utile dopo che Heidegger ebbe gettato un sasso nella mac24
china dialettica: si poteva tornare all'idea di tradizione come grande oggetto nel quale tutti si ritrovano, nel quale non c'è da conoscere ma solo da interpretare, dove ci sono solo persone e libri e sono sparite le dure, odiate cose. Se Heidegger aveva cercato di ridare le carte, mettendo furbescamente nel mazzo degli scienziati l'imbarazzante metafisica, ora si poteva essere più leali e irenici, lasciare il gran vecchio profetizzare, scrivere commenti sui suoi accenni e, in attesa di poter incominciare a pensare, interpretare testi, lasciando per sempre la natura ad altri. Magari si poteva fare ancora un dispetto agli scienziati, riprendendo la trovata di Agostino che anche la natura è un libro, e sostenere che gli scienziati o sbagliano del tutto o senza saperlo interpretano; che è solo sbagliare un po' meno. Viene spontaneo domandarsi «come avrà fatto Heidegger ad avere sia pure solo brevi lampi di luce sull'essere? perché proprio lui, che scriveva le sue rivelazioni anche per vincere un concorso da professore?». Poi la cosa si capisce: usava pezzi di manuali di storia della filosofia correnti ai suoi tempi, magari intrisi dell' aborrito neokantismo. E aveva ragione di fare così: dopo che Kant e Hegel avevano adoperato concetti storiografici per costruire discorsi filosofici, la storia della filosofia era diventata un genere letterario con il quale si faceva della filosofia. È una tradizione che si è mantenuta fin quasi ai nostri giorni. Se in Inghilterra e negli Stati Uniti dopo la svolta linguistica un filosofo doveva sembrare un matematico che procede senza regole precise e che non fa conti o perfino Rorty doveva far finta di infilare elettrodi in un cervello, in Germania, in Francia e in Italia per molto tempo i filosofi si sono camuffati da storici della filosofia. Molta di questa storia della filosofia era finta, rientrava nel genere letterario dell' «elogio» o dell' «invettiva» e intendeva proporre una «morale» filosofica; ma era il modo corrente di esprimersi dei filosofi. Non è escluso che soprattutto in Germania e in Italia questo modo di scrivere di filosofia sia stato stimolato dalla «missione pubblica» di cui si sono sentiti investiti i filosofi, che hanno ritenuto di dover contribuire alla costruzione di una storia dell'umanità nella quale collocare la storia del proprio paese. Adesso la popolarità della storia della filosofia come genere letterario praticato dai filosofi si è un poco attenuata. L'ermeneutica ha costruito una teoria della tradizione molto più potente di quella inclusa nello storicismo diffuso che ispirava molta storia 25
della filosofia corrente. L'ermeneutica filosofica ha in gran parte sostituito la storia della filosofia nel lavoro di apologia della filosofia che essa svolgeva. Oltre tutto essa asserisce esplicitamente il carattere alternativo della filosofia rispetto alla scienza e il primato della prima sulla seconda. In questo senso si inquadra perfettamente in quel rovesciamento dell'acclimatazione della conoscenza scientifica del mondo che aveva caratterizzato la filosofia moderna classica. L'idea di una grande tradizione filosofica che va da Platone e Aristotele fino a Kant e a Hegel, costruita dall'ermeneutica filosofica, si concilia perfettamente con il ritorno alla tradizione che emerge nella filosofia linguistica come nella filosofia pratica e in gran parte della filosofia morale, cui ha dato il via il «ritorno all'etica» oggi tanto popolare.
8. Breve appendice italiana
In Italia più che altrove la storia della filosofia è rimasta il genere letterario più praticato dai filosofi, forse perché più forte si è fatta sentire la tentazione di intrecciare la filosofia alle vicende politiche del paese e perché in questa direzione hanno spinto lo storicismo nostrano e la versione nazionale del marxismo. Molti colleghi filosofi protestano contro l'egemonia degli storici della filosofia. Una volta la lamentela era soprattutto dei filosofi cattolici osservanti, che si richiamavano al tomismo oppure a quella che essi chiamavano la «metafisica classica» o a una forma di spiritualismo di marca francese; adesso si sono aggiunte anche la filosofia dell'essere e l'ermeneutica filosofica. Si contesta che far della storia della filosofia sia fare della filosofia davvero: altro ,è esporre le dottrine filosofiche altrui altro è fare della filosofia in proprio. C'è anche un'altra obiezione che sembra più elaborata: gli storici della filosofia non solo non fanno una filosofia in proprio, ma presuppongono una filosofia che non riconoscono e della quale non vogliono e spesso non sanno dare ragione. Non è una grande obiezione e appartiene alla famiglia degli argomenti che attribuiscono una filosofia anche a chi la nega e fa di tutti gli uomini dei filosofi, come se fossero prosatori gli autori delle circolari ministeriali. Paradossalmente è vero il contrario, non in via di principio ma per come di fatto sono andate le cose. Infatti I' as-
26
serzione «ogni filosofia presuppone una storia della filosofia» sarebbe come l'altra, «ogni storia della filosofia presuppone una filosofia», soltanto un proclama o un'intimidazione. È vero invece che gran parte delle costruzioni filosofiche dopo Kant e Hegel, soprattutto quelle oggi di moda, presuppongono esplicitamente un quadro impegnativo della storia della filosofia. Allora può esser vero che a condizionare la storia della filosofia è spesso la filosofia speculativa e i quadri storici che essa manovra. Infatti molta storia della filosofia tradizionale si limita a riesporre quei quadri e a tessere l'elogio di ciò che essi contengono. In questo senso i filosofi speculativi hanno ragione di rivendicare a se stessi il coraggio di dire esplicitamente ciò che gli storici suggeriscono copertamente. Ma proprio questo stato di cose può stimolare una storia della filosofia che, evitando le strade tradizionali, metta in discussione qualche particolare dei quadri storici presupposti dalla ~