L'impero che non c'è. Geopolitica degli Stati Uniti d'America 8883356322, 9788883356322
Esperto di politica estera americana, collaboratore della rivista "Limes", David Polansky offre una sintesi di
232 68 1MB
Italian Pages 227/207 [227] Year 2005
Recommend Papers

- Author / Uploaded
- David Polansky
File loading please wait...
Citation preview
00 layout 1-22
4-04-2005
17:19
Pagina 1
00 layout 1-22
4-04-2005
17:19
Pagina 2
Magdi Allam, Roberto Gritti, Islam, Italia. Chi sono e cosa pensano i musulmani che vivono tra di noi Giulietto Chiesa, Roulette russa. Cosa succede nel mondo se la Russia va in pezzi Giulietto Chiesa, Vauro, Afghanistan anno zero, in collaborazione con Emergency, introduzione di Gino Strada Comitato Cecenia, Cecenia. Nella morsa dell’Impero, presentazione di Olivier Dupuis Comité Vietnam pour la Défense des Droits de l’Homme, Vietnam libero? Le voci della dissidenza vietnamita (in preparazione) Guillaume Dasquié, Jean Guisnel, Il complotto. Verità e menzogne sugli attentati dell’11 settembre, introduzione di Lucia Annunziata Marta Dassù (a cura di), Oriente in rosso. La Cina e la crisi asiatica Mario Deaglio, Pier Giuseppe Monateri, Anna Caffarena, La globalizzazione dimezzata Ileana de la Guardia, Nel nome di mio padre. Ideali e tradimenti, privilegi e disonori, ricchezze e miseria: storia privata della repressione castrista, prefazione di Pierluigi Battista Jean-Dominique Durand, Storia della Democrazia cristiana in Europa. Dalla Rivoluzione francese al postcomunismo, prefazione di Oscar Luigi Scalfaro Emergency, Medici di guerra, inviati di pace. Un altro Afganistan, prefazione di Ennio Remondino Marcella Emiliani, Leggenda nera. Biografia non autorizzata di Saddam Hussein Renzo Guolo, Avanguardie della fede. Ideologia e politica del fondamentalismo islamico Renzo Guolo, Il partito di Dio. L’Islam radicale contro l’Occidente Renzo Guolo, Terra e redenzione. Il fondamentalismo nazional-religioso in Israele Ong Thong Hœung, Ho creduto nei khmer rossi. Ripensamento di un’illusione, presentazione di Renzo Foa Marco Impagliazzo, La nazione cattolica. Chiesa e società in Italia dal 1958 a oggi Roberto Morozzo Della Rocca, Albania. Le radici della crisi Roberto Morozzo Della Rocca, Kosovo: la guerra in Europa. Origini e realtà di un conflitto etnico Reporter senza frontiere (a cura di), Il libro nero della Cina, presentazione di Piero Ostellino Reporter senza frontiere (a cura di), Il libro nero di Cuba, presentazione di Michele Farina Andrea Riccardi, Mediterraneo. Cristianesimo e islam tra coabitazione e conflitto Pierre Rigoulot, Corea del Nord. Fame e atomica, presentazione di Emma Bonino Souvannavong V., La giovane prigioniera. Diario di una vittima del Laos comunista (in preparazione) Roberto Toscano, Il volto del nemico. La sfida dell’etica nelle relazioni internazionali Vauro, Principessa di Baghdad, prefazione di Gino Strada
00 layout 1-22
4-04-2005
17:19
Pagina 3
SGUARDI SUL MONDO ATTUALE
00 layout 1-22
4-04-2005
17:19
Pagina 4
© 2005 Edizioni Angelo Guerini e Associati SpA viale Filippetti, 28 – 20122 Milano http://www.guerini.it e-mail: [email protected] Prima edizione: aprile 2005 Ristampa:
V
IV
III
II
I
2005 2006 2007 2008 2009
Printed in Italy ISBN 88-8335-632-2
Le immagini di copertina sono riprodotte per gentile concessione di www.theodora.com/maps e www.theodora.com/flags Le riproduzioni a uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, via delle Erbe, 2 – 20121 Milano, tel. e fax 02809506, e-mail: [email protected].
00 layout 1-22
4-04-2005
17:19
Pagina 5
David Polansky
L’IMPERO CHE NON C’È Geopolitica degli Stati Uniti d’America
prefazione di Lucio Caracciolo
traduzione di Mario Baccianini e Elisabetta Rispoli
GUERINI E ASSOCIATI
00 layout 1-22
4-04-2005
17:19
Pagina 6
00 layout 1-22
4-04-2005
17:19
Pagina 7
INDICE
9
PREFAZIONE
Un altro mondo è possibile? di Lucio Caracciolo 17
INTRODUZIONE
La superpotenza non geopolitica PARTE PRIMA IL RAPIDO APPRENDISTATO AMERICANO 24
CAPITOLO PRIMO
Una tradizione fondata sull’antimachiavellismo 37
CAPITOLO SECONDO
Le prime lezioni 37 47
Il monito di Washington L’educazione di Thomas Jefferson
61
CAPITOLO TERZO
Il continente senza ostacoli 61 64 77
La grande strategia di John Quincy Adams Le lezioni della frontiera La casa divisa
80
CAPITOLO QUARTO
Orizzonti di gloria 80 85
Il miraggio dell’impero Theodore Roosevelt e l’ascesa del prestigio americano
95
CAPITOLO QUINTO
L’età dell’idealismo 95 La riforma di Woodrow Wilson 105 L’ascesa: l’era di Franklin Delano Roosevelt
00 layout 1-22
4-04-2005
17:19
Pagina 8
8
PARTE SECONDA IL RUOLO GLOBALE 112
CAPITOLO SESTO
L’alba della Guerra Fredda 132
CAPITOLO SETTIMO
Il tallone di Achille 132 La lezione del Vietnam 138 L’establishment s’incrina
144
CAPITOLO OTTAVO
Henry Kissinger e l’emergere della geopolitica 154
CAPITOLO NONO
La risposta idealistica 159 Carter 163 Reagan
168
CAPITOLO DECIMO
L’egemonia 174 Gli anni della locusta
PARTE TERZA L’AMERICA OGGI 186
CAPITOLO UNDICESIMO
La scena politica americana dopo l’11 settembre 190 Beghe interne
196
CAPITOLO DODICESIMO
L’America e il mondo 205
CAPITOLO TREDICESIMO
La guerra sulla guerra 216
CAPITOLO QUATTORDICESIMO
E poi? 223
CONCLUSIONI
Le nostre virtù e il nostro difetto
00 layout 1-22
4-04-2005
17:19
Pagina 9
PREFAZIONE
U N ALTRO MONDO È POSSIBILE? di Lucio Caracciolo
1. Oggi le élite europee sono conservatrici, quelle americane rivoluzionarie. Noi siamo saturi di sconvolgimenti, loro alla ricerca di un mondo migliore – più americano. Eppure il XX secolo è stato il secolo dell’America. Forse solo il primo di una serie, a dar retta ai cantori dell’«impero» a stelle e strisce. Perché allora rovesciare il tavolo quando si sta vincendo? Nella storia, le potenze perdenti inclinano di norma al revisionismo, i vincitori organizzano lo status quo. Non l’America. Si può attribuire questo paradosso all’11 settembre? In parte è così. Quel trauma ha spinto gli Stati Uniti a pensare fuori dagli schemi – out of the box – e a concepire l’impensabile: una guerra potenzialmente infinita contro il terrorismo e per la democratizzazione del Grande Medio Oriente, impresa piuttosto improbabile, se non nefanda agli occhi di molti europei. Per i più febbrili fra gli attuali leader americani, come il vicepresidente Dick Cheney, quella che nel Vecchio Continente passa per «iperpotenza» (Hubert Védrine) sarebbe minacciata nella sua stessa esistenza dai terroristi islamici e dai loro sponsor dell’«asse del Male»: Corea del Nord, Iran e – fino a ieri – Iraq. Se fosse vero, dovremmo accettare un altro paradosso: quanto maggiore la potenza di uno Stato, tanto più minacciata la sua sopravvivenza. Dunque, chi tiene alla vita non deve essere superpotente. Sta forse qui la chiave del conservatorismo veterocontinentale. Paesi come Francia, Italia, Germania, Spagna, Austria, Olanda e Gran Bretagna hanno variamente occupato nella storia i gradi alti della gerarchia mondiale. Sempre in competizione tra loro – anche quando erano alleati. Dopo le guerre suicide del Novecento europeo, nessuna di quelle potenze può aspirare all’egemonia globale. Quanto al dominio continentale, dopo il 1945 vi abbiamo tutti ri-
00 layout 1-22
4-04-2005
17:19
Pagina 10
10
nunciato di comune accordo. E su impulso americano abbiamo costruito la casa di questo compromesso, l’Unione Europea. Che poi essa appaia piuttosto barocca – quando non incomprensibile – agli americani e ad alcuni europei, è perché le nostre élite ne hanno sempre gelosamente custodito il progetto. Al punto da legittimare il sospetto che non esista. Rispetto alla potenza, noi europei abbiamo aderito al motto di Lenin: meglio meno ma meglio. L’abbiamo fatto guardando alle lezioni del passato. Il futuro è quasi scomparso dal nostro orizzonte, perché si presume che potrebbe risultare solo peggiore del presente. Come ammoniva Adenauer: «Niente esperimenti». A torto o a ragione, molti europei sono convinti che il nostro sia il miglior continente possibile. Quanto al resto del mondo, esaurita la stagione delle colonie, oggi conviene guardarsene. Tenerlo il più lontano possibile dall’Europa. Se George W. Bush è da noi uno dei presidenti americani più impopolari della storia, oggetto di scherno e insieme di paura, è perché appare come un pericoloso rivoluzionario. Afflitto dal «cieco egotismo della democrazia in guerra», per citare un vecchio saggio, George F. Kennan, superstite della generazione degli wise men che attorno a Truman disegnarono gli equilibri del secondo dopoguerra. L’avversione europea per il modo in cui il leader americano ha reagito all’aggressione del terrorismo islamico ha sconfinato talvolta nella paranoia. Sono stati evocati il Mossad o la stessa Casa Bianca come autori di un complotto culminato nell’attacco alle Torri Gemelle. Obiettivo: espandere l’impero americano. Un impero senza limes, perché votato a dominare il mondo. 2. Ma il fossato che divide oggi le due coste dell’Atlantico – molto più, l’America da quasi tutto il resto del pianeta – non è solo frutto dell’11 settembre. Quella tragedia ha portato a galla profonde differenze culturali, di mentalità, destinate a produrre conseguenze geopolitiche tuttora imprevedibili. Nei quarant’anni della guerra fredda noi occidentali, uniti dal nemico sovietico, le avevamo nascoste per comune interesse strategico. Le avevamo seppellite talmente bene da averle quasi dimenticate. Durante la guerra fredda la comunità atlantica ha prodotto una retorica ufficiale che prospettava lo scontro con l’Unione Sovietica in termini ideologici: democrazia liberale contro dittatura comunista, economia di mercato contro socialismo di Stato. Ma l’ideolo-
00 layout 1-22
4-04-2005
17:19
Pagina 11
11
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
gia era solo una faccia della guerra fredda. Sotto scorreva il fiume carsico delle contese geopolitiche, fra Est e Ovest e persino all’interno dei due campi. Lo stesso termine «geopolitica» era bandito dal discorso pubblico. Solo dopo l’89, a partire dalle guerre di successione jugoslava, si scoprì che la geopolitica continuava a contare e ad agire. L’America se n’è accorta tardi. Per tutti gli anni Novanta, pur impegnandosi in varie spedizioni militari – dall’Iraq ai Balcani – gli Stati Uniti si sono illusi, e molti con loro, che la guerra fredda fosse stata l’ultima di tutte le guerre, per di più incruenta. George Bush senior parlava di «nuovo ordine mondiale», inconsapevolmente echeggiando uno slogan hitleriano, ma non ha mai spiegato in che cosa quest’ordine consistesse. Bill Clinton coniava il fortunato slogan «è l’economia, stupido!», quasi che uomini e donne in tutto il mondo fossero mossi ormai solo da logiche contabili. Il politologo americano Francis Fukuyama si ergeva a nuovo Hegel per proclamare la «fine della storia», mentre un altro guru degli anni Novanta, il giapponese Kenichi Ohmae, si accontentava di annunciare la fine dello Stato nazionale. Alcuni, in Europa, erano convinti che l’America fosse ripiombata in uno dei suoi lunghi cicli isolazionistici. Quasi tutti, in America, pensavano che l’Europa fosse un non-problema: un continente sufficientemente stabile e insieme incapace di sfidare la potenza americana. Le guerre balcaniche e i terremoti di assestamento postsovietici erano episodi, parentesi da chiudere al più presto, non sufficienti a confutare la tesi della «fine della storia». 3. Già nelle crisi dei primi anni Novanta si potevano cogliere i sintomi della divaricazione transatlantica. Se ne fossimo stati più consapevoli, forse avremmo potuto contenerne gli effetti. Ma qui interviene il problema maggiore: americani ed europei si conoscono poco. Molto poco. E se non ci si conosce, è difficile mettersi d’accordo. Anzi, si può credere di essere d’accordo quando non lo si è affatto. O viceversa. Se non si conosce una persona o un paese, è per incapacità, impossibilità o scelta. Nel caso dei rapporti euro-americani, l’ignoranza è soprattutto una scelta. Ma se, al limite, si può comprendere perché dall’altra parte dell’oceano l’attenzione per un continente considerato non problematico e declinante sia scarsa, la superficialità con cui molti europei guardano all’America, se non la igno-
00 layout 1-22
4-04-2005
17:19
Pagina 12
12
rano del tutto, non ha giustificazioni. E contribuisce a indebolirci. Perché ci impedisce di cogliere il modus operandi della principale potenza mondiale. Vale soprattutto per noi italiani: l’America sembra ci basti averla scoperta. È sufficiente contare le righe che un qualsiasi manuale di liceo dedica alla storia e alla geografia americana, e paragonarle alla centralità degli Stati Uniti nella nostra vita quotidiana, per stabilire che in Italia la superpotenza a stelle e strisce è terra incognita. Peggio: ne abbiamo una percezione superficiale, epidermica, quasi esotica. Quella che ci piomba in casa ogni ora attraverso i media. Qualche fotogramma a colori. Ma il resto del film? E il backstage? L’ignoranza dell’America riguarda purtroppo anche i decisori. Non solo italiani. Gente che per ufficio incrocia quotidianamente le mille facce del potere americano, ma che per difetto di analisi non può decodificarne compiutamente intenzioni, limiti e possibilità. Quanto più scarsa la conoscenza dell’America, tanto più forti le opinioni al riguardo. Si può essere fervidamente antiamericani o filoamericani senza sapere bene che cosa si odia o si ama. Cercare di mettersi nella testa degli altri è faticoso e talvolta fastidioso. Ma illudersi che l’oggetto della nostra analisi sia compribile in qualche stereotipo è pericoloso. Nel caso di un decisore politico, irresponsabile. Eppure è accaduto e continua ad accadere. Molti leader europei o asiatici vengono colti di sorpresa dalle scelte della Casa Bianca perché non padroneggiano l’abc del modo americano di pensare il mondo – e l’America. Fatto è che la storia cambia molto più rapidamente delle mentalità. La strapotenza americana è recente. Per le generazioni di italiani e di europei nati nella prima metà del secolo scorso, l’America esisteva come gigante economico; per i poveri o per gli avventurieri, come meta di emigrazione; per le élite come fabbrica del cinema e del jazz. Ma nessuno, o quasi, la pensava come potenza planetaria. Tra il 1776 e il 1917, e in qualche misura financo tra le due grandi guerre – mondiali in quanto coinvolsero gli americani, che ne decisero l’esito – le cancellerie europee non includevano gli Stati Uniti nell’equazione di potenza globale. A fine Ottocento la marina a stelle e strisce era più debole di quella italiana e, quanto a esercito, quello USA era il quattordicesimo al mondo, dopo la Bulgaria. A testimoniare lo snobismo veterocontinentale, nel 1880 capitava che un diplomatico tedesco a Madrid accettasse di ridursi lo stipendio piuttosto che trasferirsi a Washington1.
00 layout 1-22
4-04-2005
17:19
Pagina 13
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
13
Oggi non dovrebbe essere più così. Da oltre mezzo secolo l’America è dovunque, dentro e fuori di noi. La sua cultura di massa non sarà pervasiva come negli anni Cinquanta e Sessanta, ma continua ad attrarre uomini e donne a ogni latitudine. È più facile segnare su un planisfero i paesi dove i militari USA non sono presenti, piuttosto che quelli in cui dispongono di basi. La superiorità tecnologica delle forze armate statunitensi è schiacciante e crescente. Un terzo del prodotto lordo globale è americano (come all’inizio della prima guerra mondiale, meno che alla fine della seconda, quando toccava il 50%). La maggior parte delle cosiddette «multinazionali» continua ad avere il quartier generale in America. Il dollaro, pur indebolito, resta la valuta determinante. E se alcuni preconizzano un’incombente crisi fiscale, altri invece sono convinti che l’«impero americano» viva la sua età augustea, promessa di future espansioni. Che l’America sia sul viale del tramonto o all’alba del trionfo, tutti siamo convinti che il nostro destino dipenda largamente dal suo. Allo stesso tempo, mai come oggi l’America è stata odiata. Odiata dai suoi nemici, a cominciare dai seguaci di Osama bin Laden e dai fondamentalisti islamici. Odiata, o almeno non amata, anche da molti europei e asiatici, cittadini di paesi formalmente amici o alleati. Non sappiamo quando e come finirà la guerra al terrorismo. Ma il suo lascito più pesante e duraturo sarà probabilmente un’epidemia globale di antiamericanismo, dal Canada al Brasile, dall’Europa all’Estremo Oriente, dal Nordafrica al Medio Oriente, dalla Russia alla Turchia. Tanto disprezzo sarà forse l’inevitabile corollario della potenza. O, per quanto concerne noi europei, il riflesso di un invincibile senso di superiorità, superiore persino alla nostra verticale caduta di potenza. Ma anche il peggior nemico dell’America non dovrebbe evitare di conoscerla. Eppure continuiamo a non pensare l’America. Certo, i suoi nemici mortali la pensano fin troppo, ne sono ossessionati quanto i suoi adoratori. Ma qui intendiamo il verbo «pensare» in senso critico. Un pensiero che vuole conoscere, prima e più che giudicare. Questo libro di David Polansky è un contributo inestimabile a pensare l’America. È raro imbattersi in opere altrettanto originali e rivelatrici sulla politica estera americana, se escludiamo il capolavoro di Henry Kissinger, Diplomacy, di dimensioni peraltro assai più
00 layout 1-22
4-04-2005
17:19
Pagina 14
14
vaste. Vi sono certamente illustri trattati politologici che confezionano schemi in cui il lettore potrà inserire i fatti passati e futuri, senza peraltro capirne granché. Qui abbiamo, invece, un’eccellente sintesi di taglio storico-geopolitico. Scritta da un americano per il pubblico italiano – e speriamo presto disponibile per lettori in altri paesi, a cominciare dagli Stati Uniti. Grazie a quest’opera il lettore italiano scoprirà probabilmente che la politica estera degli USA è diversa da come l’immaginava, a causa soprattutto delle sue diverse premesse culturali. C’è del vero nella tesi di Margaret Thatcher per cui «noi europei siamo figli della nostra storia, gli americani della loro filosofia». Ma Henry James ci ha insegnato che è vano cercare la chiave nel tappeto. Chi cerca la clavis universalis, il Sacro Graal dell’«impero americano», può tranquillamente fermarsi qui e passare ad altro genere letterario, come quello oggi assai in voga che tutto spiega in base ad affascinanti teorie del complotto. Chi invece è mosso dal fecondo scetticismo che rifugge l’assoluto e non si stanca di indagare il relativo, può continuare con profitto.
NOTE 1 Kissinger H., Diplomacy, Simon & Schuster, New York-London 1994, p. 37. L’edizione italiana più recente è L’arte della diplomazia, Einaudi, 2004, pp. 708-19.
00 layout 1-22
4-04-2005
17:19
Pagina 15
To the Kenyon College Political Science Department
The American vision… transcends, despite the parochialism of its means of expression, the barriers of nationality and race and differences of outlook, in a big, sweeping, single view. It notices things rather than persons, and sees the world in terms of rich, infinitely moldable raw material, waiting to be constructed and planned in order to satisfy a world-wide human craving for happiness or goodness or wisdom. And therefore to it the differences and conflicts which divide Europeans in so violent a fashion must seem petty, irrational, and sordid, not worthy of self-respecting, morally conscious individuals and nations; ready, in fact, to be swept away in favor of a simpler and grander view of the powers and tasks of modern man. To Europeans this American attitude, the large vista possible only for those who live on mountain heights or vast and level plains affording an unbroken view, seems curiously flat, without subtlety or color, at times appearing to lack the entire dimension of depth…, and so America, which knows so much, to them seems to understand too little, to miss the central point. Isaiah Berlin «Mr. Churchill», The Atlantic Monthly, September 1949
00 layout 1-22
4-04-2005
17:19
Pagina 16
00 layout 1-22
4-04-2005
17:19
Pagina 17
INTRODUZIONE
LA SUPERPOTENZA NON GEOPOLITICA
In un recente numero di Limes1, gli Stati Uniti vengono definiti il paese «meno geopolitico del mondo»: una ben strana affermazione, se si pensa che la geopolitica è uno di quei campi in cui il loro predominio resta un fatto indiscusso. Solitamente i suoi critici, ostili o amichevoli che siano, rimproverano all’America le sue carenze culturali, morali, intellettuali, giuridiche e legislative, per non parlare di quelle economiche e sociali. Ma tutti sembrano riconoscere, volenti o nolenti, la sua supremazia in questa particolare sfera. Nel medesimo editoriale, in effetti, si rileva al tempo stesso che gli Stati Uniti sono anche la nazione più potente, nonostante il loro carattere non geopolitico: un’affermazione ancor più sorprendente e, almeno in apparenza, contraddittoria rispetto alla prima. Come a dire che la fattoria più prospera della Campania è anche la meno agricola. Da che deriverebbe allora il suo successo? Secondo una famosa battuta, l’impero britannico venne creato in un momento di distrazione. Un analogo spirito sembra generalmente animare la maggior parte delle discussioni sulla politica estera americana, anche da parte dei suoi critici meno ostili. Pensatori e statisti del calibro di Henry Kissinger, George Kennan, Winston Churchill e Reinhold Niebuhr sono tutti convinti che il primato geopolitico degli Stati Uniti sia più il frutto del caso che non di un consapevole disegno. In effetti, i successi della loro politica estera si spiegano non già in virtù della condotta di chi li ha governati bensì malgrado i loro sforzi, come se le regole immutabili della geopolitica fossero rimaste sospese per la nazione eletta. Probabilmente, questo paradosso conferma semplicemente la convinzione di Bismarck secondo la quale «Dio ha una speciale predilezione per gli sciocchi, gli ubriachi e gli Stati Uniti d’America». Ma per chi ha meno fede, questo mistero esige un esame più approfondito. I tentativi di comprendere razionalmente i come e i perché della politica estera americana ben difficilmente sono destinati a buon esito,
00 layout 1-22
4-04-2005
17:19
Pagina 18
18
specialmente per gli stranieri. In un momento di stizza (come spesso gli accadeva), Charles de Gaulle osservò causticamente: «Potete star certi che gli americani commetteranno tutte le sciocchezze che passano loro per la testa, più altre che vanno oltre ogni immaginazione». Con un simile spirito, Gamal Abdel Nasser ebbe a dire una volta: «La genialità di voi americani sta nel fatto che non fate mai mosse chiaramente stupide, ma stupidamente complicate per cui ci costringete a chiederci se per caso non ci è sfuggito qualcosa». Comunque la si pensi sulla saggezza del suo panarabismo, di certo ha detto una mezza verità. Non c’è nessuna grande strategia alla base delle politiche seguite dagli Stati Uniti né si può dire che il comportamento di questo paese sia dettato in modo coerente dai suoi interessi nazionali. Vi è sempre stato invece un divario fra ciò che gli americani dicono e quello che fanno, e questo rende le loro mosse ancor più difficili da prevedere. In ogni caso, molto prima dell’esplosione delle recenti controversie, l’America e le sue motivazioni sono rimaste enigmatiche per la maggior parte degli osservatori esterni, cosa questa esacerbata dal fatto che moltissimi americani – nonostante la loro eccezionalità – sono inconsapevoli di quanto possano apparire diversi e, quel che più conta, di quanto in realtà possano esserlo. E sebbene queste differenze tendano a manifestarsi sotto innumerevoli aspetti in un’ampia gamma di categorie, è soprattutto nei rapporti dell’America con gli altri paesi, ovvero nelle questioni della pace e della guerra, e in tutte quelle intermedie fra questi due poli, che esse sembrano avere le conseguenze più decisive. Gli Stati Uniti costituiscono un paradosso. Occupano uno spazio mentale diverso da quello di qualsiasi altra nazione o istituzione nel mondo. La loro massiccia presenza svolge un ruolo anche nella vita di coloro che abitano all’altro capo del mondo, che non li hanno mai visitati né intendono farlo. Ma nonostante la loro ubiquità, restano stranamente oscuri agli osservatori esterni. Le motivazioni rimangono misteriose; le finalità sono ambigue. E la combinazione della loro grande potenza e delle loro dimensioni con questa imperscrutabilità dà luogo naturalmente a una certa apprensione da parte delle altre nazioni. Ma, al tempo stesso, la maggior parte degli americani è del tutto inconsapevole dell’importanza che il loro paese ha per il resto del mondo, per la semplice ragione che nessun’altra nazione svolge una simile funzione per essi. Le critiche semplicistiche spesso attribuiscono questo fatto all’ignoranza, ma è un errore. In realtà, esso è il risultato di un tentativo, coronato dal successo, di creare un sistema
00 layout 1-22
4-04-2005
17:19
Pagina 19
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
19
politico interno che dà molto valore alla vita privata dei singoli cittadini e li protegge dalle vicissitudini del mondo esterno. Gli americani hanno sempre trovato più interessanti le loro vicende interne che non quel che accade oltre gli oceani. Così è ancor oggi, come lo è stato prima che il loro paese diventasse una grande potenza. In parole semplici, il mondo è altrettanto confuso di fronte all’America quanto la maggior parte degli americani è dimentica di esso. Ecco allora che emerge un’altra contraddizione: l’America è orgogliosa di essere diversa, ma al tempo stesso è profondamente convinta che tutti gli esseri umani siano simili. Rafforzata dalla sua struttura multietnica, questa tendenza parte dal presupposto che le differenze fra le persone siano in definitiva superficiali. Gli americani di solito non vedono o non vogliono vedere ciò che li divide dagli altri, specialmente quando non si tratta solo di fenomeni esteriori bensì dell’essenza stessa di una cultura, che costituisce l’orizzonte entro cui vivono le persone. In questo senso, se la tradizione americana è unica, lo è soltanto a causa della sua universalità. Ma questa presunzione impedisce di comprendere i motivi per i quali le politiche degli Stati Uniti spesso appaiono poco chiare per gli altri paesi. Se gli americani danno per scontata l’eccezionalità del loro paese, ben di rado riescono a riconoscere gli effetti del suo reale comportamento e considerano le sue politiche del tutto ovvie, anche quando sono in realtà rivoluzionarie. Il divario fra ciò che l’America è e quel che il resto del mondo è sempre stato lo si vede in effetti, più chiaramente che altrove, proprio nei suoi rapporti con gli altri paesi. Viene perciò da chiedersi se questa confusione o questo profondo travisamento della realtà esterna non portino necessariamente a compiere errori irrimediabili, condannando il paese che li commette all’ignominia e alla disfatta o precludendo quanto meno la possibilità stessa che esso assurga al rango di grande potenza. Il fatto che così non è stato, ma è accaduto anzi il contrario, esige delle spiegazioni. Cosa s’intende per «geopolitica»? L’antico filosofo e geografo greco Strabone disse che la geografia è un destino, fornendone un’interpretazione estrema. Bismarck sostenne che è «l’arte del possibile, la scienza del relativo». Ma, tralasciando la retorica, non si tratta né di un’arte né di una scienza. Con quest’affermazione, egli intendeva dire semplicemente che per far politica occorre una buona dose di rude pragmatismo combinato con una fredda valutazione dei rapporti di forza e degli interessi all’interno di un determinato spazio, scevra da teorie astratte
00 layout 1-22
4-04-2005
17:19
Pagina 20
20
o da principi morali. Gli Stati Uniti sono sorti nel periodo di massima fioritura dell’Illuminismo, i cui pensatori sostenevano che un regime dotato di leggi fondate sulla ragione avrebbe potuto alla lunga superare gli ostacoli frapposti dall’accidentalità delle tradizioni culturali e delle realtà geografiche. Su quali presupposti si basa la politica estera di un paese fondato sulla teoria dell’assoluto (ovvero non relativo) predominio del diritto naturale? Questo libro intende far luce sul modo in cui la nazione più potente del mondo cerca di affrontare il problema della geopolitica senza mai venirne a capo. Ovviamente, non mancano gli studi sull’argomento, che cercano di spiegare il profondo e oscuro mistero dell’America agli europei colti e sconcertati. Sedicenti esperti offrono aneddoti in gran quantità a sostegno di una qualche teoria generale che riesca a condensare l’essenza di una società in una forma comprensibile. Un atteggiamento simile a quello degli autori di racconti di viaggio che esaltano le virtù dei nostri alleati d’oltreatlantico ai quali viene attribuita una cultura superiore. Spesso, questo tipo di scritti scade in superficiali elogi sperticati del fascino rurale della Toscana, o della grandeur un po’ sbiadita, ma ancor fortemente suggestiva, della «città eterna». I dialoghi culturali sono fatti di banalità del genere. L’America appare così uno strano circo e l’Europa un museo, e si tralasciano le persone reali che vivono in entrambi i luoghi. Chi vuol apparire aggiornato legge questi libri e poi li mette da parte, contento di aver acquisito un minimo di conoscenza sull’argomento, prima di dedicarsi al passatempo successivo, come il tennis o la pittura. Esistono inoltre opere più inquietanti e perniciose, scritte solitamente nello stile di un giallo mozzafiato, che hanno la pretesa di rivelare il marciume nascosto dietro qualcosa di apparentemente tranquillo. In guardia, dunque. Le teorie della cospirazione abbondano e se l’autore, o il lettore, iniziano a indagare in attesa di scoprire turpitudini o cupidigie, raramente saranno delusi. Non c’è bisogno di dire che gli Stati Uniti sono spesso il bersaglio di opere di questo tipo, che siano scritte da stranieri o da connazionali, il cui campione del momento è rappresentato da Michael Moore. Se in effetti il potere può corrompere, in quale altro luogo è più prevedibile una corruzione endemica se non nella nazione più potente del mondo? Queste rivelazioni sono forse altrettanto soddisfacenti nel loro genere quanto le oziose divagazioni dei racconti di viaggio, ma non per questo, in ultima analisi, meno superficiali. In entrambi i casi, infatti, i preconcetti del lettore non vengono quasi mai scalfiti e un’unica rappresenta-
00 layout 1-22
4-04-2005
17:19
Pagina 21
21
zione semplificata prende il posto della realtà. L’aspra denuncia e la visione elegiaca sono egualmente distanti dalla complessità delle cose così come sono. E la morale è che non si può ridurre un paese a una singola immagine né attribuire ai suoi abitanti un’unica motivazione. Questo libro, come già si può evincere dalla sua brevità, non intende offrire un inventario esaustivo delle imprese diplomatiche e militari dell’America nel corso della sua storia. Né gli eventi di cui parla e gli esempi che fornisce vengono trattati tutti con la stessa attenzione. Non mi pento delle scelte fatte, poiché penso siano quelle più utili a illustrare le tendenze della politica estera americana. Non cerco di esporre una teoria organica che spieghi ciascun caso qui trattato, ma tendo piuttosto a trarre dalla loro varietà un orientamento generale possibile. Non si tratta pertanto di un’opera storica propriamente detta, bensì di un tentativo di fornire spunti di riflessione utili a chiarire come e perché l’America si comporta in un certo modo, alla luce della sua breve tradizione, in un momento in cui le sue iniziative in campo internazionale sono oggetto di attento esame e di vivaci discussioni, come mai prima era accaduto. L’unico presupposto da cui parto è che la politica internazionale degli Stati Uniti e il modo in cui essi affrontano il mondo circostante sono completamente diversi da quelli di qualsiasi altro paese, per ragioni intrinseche alla loro stessa natura. Cercherò di spiegare il perché di questa tendenza e, soprattutto, come si è manifestata nella tradizione diplomatica americana, dimostrando così che gli eventi attuali non sono poi tanto sorprendenti come possono apparire in questo momento. Ma ciò comporta non soltanto un’analisi di quel che l’America è oggi bensì esige, almeno provvisoriamente, un ritorno alle origini.
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
NOTE 1
Cfr. «Il sogno di Bush», Limes, 2/2004 (numero monografico dedicato al tema «L’impero senza impero». Nel suo editoriale, Limes definisce gli Stati Uniti «il paese più potente e meno geopolitico al mondo». E spiega il paradosso in questi termini: «La geopolitica si fonda sull’analisi dei conflitti di potere in determinati spazi. Convoca approcci diversi, storia e geografia in testa. È un ragionamento su casi singoli, non un’arte aruspicina, tantomeno una scienza. Gli americani preferiscono i modelli. Non studiano tanto il caso in sé quanto la sua riproducibilità. Nel dibattito strategico adattano i casi ai modelli, si concentrano sui parametri economici, su tutto ciò che appare formalizzabile, in grado di ridurre al minimo la complessità. Rischiano quindi di slittare fuori del tempo e dello spazio, o meglio in un tempo e in uno spazio assoluti in quanto solo americani», ivi, p. 9 [N.d.T.].
00 layout 1-22
4-04-2005
17:19
Pagina 22
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 23
PARTE PRIMA IL RAPIDO APPRENDISTATO AMERICANO
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 24
CAPITOLO PRIMO
U NA TRADIZIONE FONDATA SULL’ANTIMACHIAVELLISMO
L’organizzazione dello Stato era in origine completamente militare, costruita in funzione della guerra. OTTO H INTZE1
Nell’esaminare il carattere della politica estera degli Stati Uniti, sarebbe prudente partire dall’inizio. Ma il fatto stesso che vi sia un inizio è già istruttivo in sé e per sé. Sebbene possa apparire ironico nel caso di una nazione che presta così poca attenzione alla storia – non solo alla propria, ma a quella di qualsiasi altro paese – è impossibile esagerare l’importanza della fondazione per la politica estera americana e, più in generale, per il modo in cui l’America interpreta la politica stessa. Gli Stati Uniti sono infatti l’unico paese la cui fondazione non è stata preceduta da una significativa storia nazionale o culturale, ma costituisce di fatto l’inizio effettivo della nazione. Detto più semplicemente, prima che divenissero un’entità politica reale vi erano ben pochi elementi che potessero caratterizzarli come una realtà potenziale. Nel loro caso, Stato e nazione erano quasi la stessa cosa e in origine erano entrambi estremamente deboli. Non esisteva insomma alcuna tradizione su cui si fonda normalmente una nazione, non soltanto a causa delle circostanze, ma per scelta, e oggi è in gran parte ancora così. Quando Georges Clemenceau divenne capo del governo del suo paese durante il periodo forse più critico della prima guerra mondiale, fece coraggiosamente appello al popolo, dichiarando: «Qualsiasi cosa in Francia testimonia della sua gloria... È giunta l’ora di sentirsi francesi e nient’altro, con l’orgoglio di poter dire che questo basta». Alludeva chiaramente a una ricca tradizione vivente, ben al di là delle sue definizioni giuridiche o anche filosofiche, che si poteva invocare chiamandola semplicemente per nome, e alla quale i suoi connazionali potevano richiamarsi a loro volta. Ancor oggi sarebbe impossibile
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 25
25
per un presidente americano lanciare un simile appello, improntato a un analogo stato d’animo. Nel 1879, il romanziere americano Henry James scriveva:
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
[...] si potrebbero elencare gli elementi di cui si costituisce la civiltà nelle altre nazioni di cui è privo il tessuto della vita americana, fino al punto in cui verrebbe da chiedersi se rimanga ancora qualcosa. Niente Stato, nel senso europeo del termine, e in effetti appena uno specifico nome nazionale. Niente sovrano, niente corte, niente chiesa, niente clero, niente esercito, niente servizio diplomatico, niente piccola aristocrazia terriera, né palazzi, né castelli [...]2. L’idea è chiara. Thomas Paine disse che «La nostra cittadinanza americana è il nostro carattere nazionale». Ma che diavolo significa? A uno sguardo superficiale, sembra voler dire che la nazionalità potrebbe essere fondata su una semplice distinzione giuridica: l’apparato statale, in una democrazia liberale, ne costituisce di per sé la base. Qual è il senso di tutto questo? È molto semplice. La politica estera serve a proteggere e a promuovere gli interessi di una determinata entità politica, ovvero, in epoca moderna, lo Stato. Ma quest’ultimo è soltanto un’astrazione: una serie di leggi e di istituzioni volte a governare i suoi cittadini. E, a meno di non condividere la pretesa di Luigi XIV, che soleva dire «L’état c’est moi», esso è un guscio vuoto, che ha ben poca sostanza senza una nazione. In Europa, luogo di nascita del moderno Stato-nazione, la nazionalità non è un semplice concetto bensì la somma complessiva di innumerevoli realtà storico-culturali specifiche e concrete che lo caratterizzano e costituiscono il fondamento della giustificazione geopolitica della «ragion di Stato». Un paese di recente formazione, come gli Stati Uniti, con una società civile pienamente sviluppata, ma senza una tradizione comparabile, non poteva definire se stesso né i propri interessi negli stessi termini. Per la maggior parte degli Stati, la valutazione degli interessi nazionali si basa sul presupposto del loro primato e sulla volontà di perseguirli. E ciò presuppone inoltre che questi siano in sé e per sé dei nobili fini. Lo Stato possiede insomma una legittimità in virtù della quale ciò che torna a suo vantaggio può essere ritenuto cosa buona. Ma cosa succede nel momento in cui la definizione stessa di legittimità viene sottoposta a un nuovo esame e lo Stato è costretto a giustificare la sua stessa esistenza?
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 26
26
Quando Cavour osservava che «Se ci limitassimo a fare per il nostro paese quel che abbiamo fatto per noi stessi saremmo delle vere canaglie», stava semplicemente esprimendo il tradizionale concetto (che io condivido pienamente) di raison d’état, ovvero negava l’equazione secondo la quale il bene comune coincide con la moralità personale. Anche se questo concetto è molto indebolito da una filosofia politica che condiziona l’esistenza stessa dello Stato alla sua legittimità. Gli interessi vitali di altri Stati, anche di quelli di grandi dimensioni, sono delimitati, in ultima analisi, dallo Stato stesso. Ma non si può dire la stessa cosa dello Stato che sostiene la libertà dei popoli ovunque e sulla cui forza e il cui benessere si basano le speranze e il futuro della libertà. L’equiparazione della sicurezza e della sopravvivenza dell’America con quella della libertà nel mondo ha non solo conferito all’arte di governo di questo paese una dimensione al di sopra e al di là della tradizionale ragion di Stato, ma l’ha resa in qualche modo qualitativamente diversa3.
L’essenza della nazione americana è costituita dai principi astratti della sua fondazione, e qualsiasi deviazione rispetto a essi significherebbe negare la legittimità della nazione stessa. Se si condivide l’affermazione di Coleridge secondo la quale «una nazione è costituita dall’unità del popolo», come si deve considerare allora un sistema politico che di fatto incoraggia la disunione attraverso l’accettazione del frazionismo, della separazione dei poteri dello Stato e la divisione fra Stati distinti con usanze diverse e ciascuno dotato di proprie leggi e di una propria autorità per farle rispettare? Tutti questi fattori, ritenuti decisivi ai fini del mantenimento della libertà, cospirano contro la creazione di una nazione uniforme. In altre parole, la libertà politica negli Stati Uniti sussiste a spese della «nazione». Ma la cosa più problematica è che i principi fondamentali del sistema americano, anche quando non entrano in diretto contrasto con le esigenze della politica estera, ben difficilmente sono in armonia con esse. Il liberalismo sul quale è stata fondata l’America tende a ridurre e a limitare il potere dello Stato in ogni sfera e in quanto va in direzione esattamente opposta alla storia della maggior parte degli altri Stati che hanno sempre cercato di accrescerlo, solitamente per far fronte alla potenziale anarchia interna e esterna. [...] la principale eredità intellettuale della Rivoluzione, racchiusa nella Dichiarazione di Indipendenza, era un filosofia contraria a qualsiasi concentrazione di potere che, nelle sue forme più estreme, arrivava tal-
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 27
27 volta a dipingere ogni energica affermazione dell’autorità dello Stato come una forza estranea che tutti i cittadini responsabili dovrebbero ripudiare e, se possibile, neutralizzare [...]4.
Da qui deriva l’opposizione che l’America incontra in epoca moderna quando incoraggia solitamente altri paesi a ridimensionare il potere centrale: un atto questo considerato dai governi stranieri un lusso proibitivo, nella migliore delle ipotesi, e, nella peggiore, una minaccia mortale alla continuità del loro regime.
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
[...] gli stessi argomenti usati per giustificare la secessione dall’impero britannico hanno minato anche la legittimità di qualsiasi governo nazionale capace di controllare una popolazione così ampia o di stabilire leggi uniformi che tenessero insieme i tredici Stati sovrani e tre o quattro distinte regioni economiche e geografiche5.
O, si potrebbe aggiungere, di formulare e perseguire una coerente politica estera. Alla fine, ciò solleva una questione essenzialmente politica più che geopolitica: come può un paese privo di una nazione nel senso tradizionale del termine perseguire politiche estere basate sull’interesse nazionale? Meditare su questo significa prendere seriamente l’idea dell’America formulata dai suoi padri fondatori, ovvero l’idea che essa ha di se stessa, per così dire. Se si condivide infatti il punto di vista di Thomas Paine, secondo il quale «l’indipendenza americana [fu] accompagnata da una rivoluzione nei principi e nella pratica di governo», ne consegue allora che le politiche estere del nuovo Stato sarebbero state profondamente diverse da quella di qualsiasi altro regime esistente o fino ad allora esistito. Chi è convinto di questo crede non solo nella superiorità degli Stati Uniti sotto un particolare aspetto – ovvero che siano un paese più forte, più virtuoso, culturalmente superiore – ma che l’intero sistema di valutazione di tali problemi sia completamente cambiato o radicalmente rinnovato. Il presunto carattere fondamentale del nuovo regime e della sua politica estera era il ripudio della guerra come strumento di quest’ultima. Mentre l’ancien régime era bellicoso, il nuovo sarebbe stato invece amante della pace, grazie alla sua universalità e al suo attaccamento alla libertà. Poiché la guerra è il sistema di governo della vecchia società, la reciproca ostilità che le nazioni manifestano le une verso le altre è la sem-
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 28
28 plice conseguenza della politica dei loro governi, volta a rinfocolarla [...] L’uomo non è nemico del suo simile, se non attraverso un falso sistema di governo6. Fra tutti i nemici della libertà, la guerra è forse quello più temibile, poiché racchiude e sviluppa il germe di tutti gli altri. La guerra genera gli eserciti, i quali a loro volta generano debiti e tasse, e insieme tutti questi costituiscono gli strumenti per assoggettare i molti al dominio di pochi7.
Rimasero dei dubbi se la condotta e le future politiche adottate dagli Stati Uniti avrebbero confermato o meno questa convinzione. Padri fondatori del calibro di George Washington, John Jay e, soprattutto, Alexander Hamilton, la pensavano sicuramente in modo diverso. Sparta, Atene, Roma e Cartagine furono tutte repubbliche, due delle quali, Atene e Cartagine, erano repubbliche mercantili; purtuttavia esse erano spesso, quanto le vicine monarchie ad esse contemporanee, impegnate in guerre offensive e difensive. Sparta fu poco più di un campo militare ben organizzato; e Roma non fu mai sazia di stragi e di conquiste. [...] I rappresentanti del popolo costituiscono, nel governo inglese, una delle due branche del potere legislativo. Il commercio è stato per secoli l’attività dominante del paese. Purtuttavia, ben poche nazioni sono state impegnate in più frequenti conflitti; e fu il popolo stesso, in molti casi, a decidere delle guerre in cui il regno si è trovato impegnato8.
È significativo che Woodrow Wilson, figlio del moderno liberalismo internazionale, definisse Hamilton «un grande uomo, ma non un grande americano». Egli rimase sempre convinto che gli Stati Uniti fossero soggetti, in ultima analisi, alle tragiche leggi della storia politica dell’umanità. Non è dunque tempo di svegliarsi dall’ingannevole sogno di un’età d’oro, e di adottare quale massima pratica per l’orientamento della nostra condotta politica, il fatto che noi, come tutti gli altri abitanti del globo siamo ancora ben lontani dal felice regno della perfetta saggezza e della perfetta virtù?9
Ma le differenze vanno oltre le questioni della guerra e della pace. Il concetto di «stato di natura» formulato da Locke, su cui si fondano il pensiero e il regime politico americano ha anche implicazioni geopolitiche. Pochi Stati si sono potuti permettere il lusso di basare la propria raison d’être su principi astratti. La politica non
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 29
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
29
è una scelta bensì una realtà, che può essere ignorata solo a proprio rischio e pericolo. Le sue regole, come quelle della geopolitica, non vengono dedotte da teorie scientifiche, ma faticosamente elaborate attraverso la pratica, ovvero i tentativi ed errori compiuti nel corso della storia. Sia nella politica interna che in quella estera, il potere è la base necessaria della sopravvivenza. Inizialmente, quello che in seguito venne definito il principio dell’equilibrio delle forze non era affatto una teoria, bensì un metodo altamente pragmatico per controbilanciare lo Stato più potente, e quindi più temuto, entro un dato sistema internazionale. Per la maggior parte degli Stati, la pratica precede insomma la teoria. Per questo spesso si parla (giustamente) dell’America come di un esperimento. O, come scrisse il famoso autore de Il federalista, sotto lo pseudonimo di Publius, il quesito era quello di stabilire se «le società umane siano o meno capaci di darsi, per propria scelta e attraverso matura riflessione, un buon governo, o se esse non siano invece condannate a far dipendere dal caso o dall’uso della forza le proprie costituzioni politiche»10. Parlare di un «esperimento» a proposito della Francia o dell’Inghilterra, quasi che alcuni aspetti cruciali della loro esistenza rimanessero indecisi, sarebbe ovviamente risibile. Esse infatti sono nate come realtà politiche, anche se il loro carattere cambia nel corso del tempo. La teoria del contratto sociale, formulata dai grandi filosofi dell’Illuminismo e ritenuta vangelo dai padri fondatori americani, parte invece dal presupposto di uno stato naturale di libertà, al di fuori della sfera politica. Si entra a far parte liberamente di una società politica in base a una considerazione razionale di convenienza personale. E il corollario geopolitico di questa idea è che il rapporto fra l’individuo e lo Stato è essenzialmente lo stesso di quello esistente fra lo Stato e il sistema degli altri Stati: l’impegno è una scelta, non una necessità. Nel frattempo, è necessario comprendere anche in che modo la filosofia politica che ha esaltato la ragione come unica base su cui costruire una società veramente giusta influenza la visione del mondo al di fuori dei confini degli Stati Uniti. Se l’esperimento americano ha avuto successo, ciò dimostra allora che le circostanze accidentali della vita umana sono soltanto ostacoli sulla via della libertà. Gli elementi fondamentali del ragionamento geopolitico – storia, geografia, cultura, nazionalità e religione – vengono sacrificati in definitiva sull’altare della libertà politica. E se questa può prescinderne all’interno, perché non anche all’esterno?
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 30
30
Né, tutto sommato, è necessario che questa convinzione risponda al vero per produrre i suoi effetti. Se il peso attribuito alle necessità politiche, economiche e militari e alle realtà geografiche e culturali contribuisce a determinare più chiaramente una politica, il profondo convincimento che si possa fare astrazione da queste variabili è di per sé sufficiente a contraddistinguere l’orientamento americano in politica estera da quello di altre nazioni più vecchie. Ciò crea una tensione nella mentalità americana che influenza l’analisi geopolitica, rivelando possibilità finora impreviste e mettendo in ombra quanto invece appare evidente ad altri. Nel riflettere sulla tesi secondo la quale gli Stati Uniti sono un regime fondamentalmente diverso, bisogna tener conto anche della natura di altri regimi. Abbiamo parlato del carattere «antimachiavellico» originario di quello americano non tanto per insinuare che tutti gli altri siano stati volutamente creati secondo principi «machiavellici», bensì per richiamare l’attenzione sul ruolo svolto dalla politica estera nel determinare il carattere di un dato sistema politico. «Il conflitto fra le nazioni è stato molto più importante; e nel corso dei secoli, le pressioni esterne hanno esercitato un’influenza determinante sulla struttura interna»11. Le grandi nazioni si sono formate non sulla base di spinte interne, bensì esterne. Solo una politica estera efficace, di alto profilo, può dar luogo a una politica interna feconda che in ultima analisi ha sempre ben poco spessore12.
Non vi era alcun particolare obiettivo nazionale che potesse trascendere la politica estera, con cui quella interna, essendo principalmente una forma di ordinaria amministrazione economica, non poteva sperare di competere. Si potrebbe dire che la più grande differenza rappresentata dalla fondazione degli Stati Uniti – ovvero il suo carattere antimachiavellico – sta nel fatto di non aver deliberatamente riconosciuto il primato della politica estera accettato invece, che lo volessero o meno, da tutti gli altri regimi, non già in quanto scientemente machiavellici (e comunque, anche in questo caso, ben pochi paesi civili si sono lasciati guidare soltanto da istinti di possesso e di predominio), bensì in funzione della necessità fondamentale dell’autoconservazione, che ha dettato il loro comportamento. Non vi è alcun bene politico temporale che si possa an-
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 31
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
31
teporre all’esigenza di sopravvivere nella giungla del «sistema internazionale». Il realismo è in effetti, in un senso abbastanza elementare, una propensione naturale degli Stati, per non parlare delle tribù e degli imperi. Persino quei regimi che non vanno alla ricerca di gloria debbono badare a proteggersi, se vogliono continuare a esistere. Ed anche se in seguito diventano più «evoluti», prefiggendosi finalità superiori, in origine si sono formati sotto la spinta di necessità ben più primitive. Tutto ritorna alla questione essenziale del perché i popoli danno vita ai governi. La risposta ovvia è che, molto spesso, ciò non avviene per spontanea volontà, ma per imposizione. Il potere si consolida nelle mani di un individuo o di un gruppo per due ragioni principali: innanzitutto per impedire che quel che essi possiedono venga loro sottratto e, secondariamente, per poter togliere ad altri quel che essi desiderano. In un certo senso, il rapporto della maggior parte degli individui con lo Stato non è qualitativamente diverso da quello fra i vari Stati. Se quelli che governano non riescono a convincere i governati della legittimità del loro dominio, ovvero del loro diritto di esercitare il potere – solitamente attraverso il ricorso alla religione come i re-sacerdoti dell’antico Egitto – allora sono costretti a fare affidamento sulla forza bruta. La loro posizione appare così simile a quella del vincitore rispetto ai vinti in una guerra (posto che non scelga lo sterminio anziché il dominio). Ciò ripropone l’importante distinzione fra la base della politica estera e quella della politica interna. La repubblica si fonda su un assetto stabile, non soggetto a flussi o cambiamenti poiché si basa sul predominio invariabile della legge, sancito dalla Costituzione, che è in armonia con l’ordine naturale, il quale a sua volta esiste ovunque e in ogni tempo, ed è la causa immediata, non già l’effetto della Costituzione e delle sue disposizioni. Ma quest’ordine non si rispecchia nel mondo in generale, composto invece da un insieme disordinato di Stati le cui leggi e i cui ordinamenti non riflettono necessariamente, almeno per intero, l’ordine morale della natura. E basandosi sulla forza, negano o sopprimono in tal modo la libertà. Ma poiché la repubblica americana riflette un proprio mondo completamente diverso da quello esterno, bisogna tracciare una distinzione fra i principi che guidano la politica interna, dove vige un ordine giusto, prestabilito, e quelli ai quali si ispira invece la politica estera, dove tutto è mutevole. Se è abbastanza ovvio affermare che vi è una differenza fra le
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 32
32
condizioni interne di una data società e quelle esterne, questa distinzione è particolarmente evidente nel contesto storico della politica americana poiché il potere statale non ha dovuto essere costruito, in questo caso, attraverso successive guerre tribali o dinastiche, né si è mai dovuto ricorrere alla violenza come mezzo per conquistare il potere politico all’interno dello Stato. La politica estera non ha mai avuto un’incidenza entro i confini nazionali. Come osserva lo storico John Lewis Gaddis, «L’ideale americano [...] è stato quello di isolare la vita interna da un mondo esterno violento»13. In un certo senso, gli americani mantengono sempre una certa distanza dalle dure realtà geopolitiche. Sebbene una repubblica liberale possa riconoscere la necessità di autoconservarsi e di perseguire gli interessi che ciò comporta, questo non è un suo bisogno primario, ma dipende dalla sua utilità per il bene superiore comune e per la difesa della libertà dei cittadini. Questa devozione per la libertà, bene politico supremo, ha conferito agli Stati Uniti un carattere completamente diverso da quello di altre nazioni, nel senso che la politica estera non svolge una funzione così essenziale e ciò ha modificato anche il significato stesso della ragion di Stato. Vi è una differenza fra l’obbedire a quella che si crede una necessità e il comportarsi in un modo che si ritiene naturale. Nel primo caso, si prendono le distanze da quel che si fa, agendo in base all’esperienza; nel secondo, si è invece completamente spontanei, agendo in base all’istinto. O, per dirla in un modo più pittoresco e buffo, come Walter Russell Mead: «Una democrazia può anche alzare facilmente un po’ troppo il gomito e poi finire tra le braccia di una prostituta, ma è molto più difficile che riesca a mantenere un’amante raffinata in un appartamento elegante»14. Sebbene la democrazia americana abbia un suo carattere particolare, diverso da tutte le altre, possiamo dire tuttavia che nessun altro regime esistente esemplifica i vizi e le virtù peculiari del sistema democratico – soprattutto nel campo della politica estera – per l’ovvia ragione che nessun paese si identifica così fortemente con la democrazia come gli Stati Uniti. E questo in larga misura perché non hanno alcuna tradizione precedente alla quale fare riferimento, per cui il loro regime politico coincide con essa, almeno sul piano pratico, se non sempre su quello ideale. Ciò non dovrebbe tuttavia costituire un alibi per gli Stati Uniti né per la democrazia liberale in generale. Fin dall’epoca dell’antica
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 33
33
Atene, si è sempre detto che gli umori volubili del popolo (demos) rendevano impossibile l’attuazione di una politica estera seria e coerente. E, certamente, la straordinaria serie di errori che portò infine alla sconfitta degli ateniesi in Sicilia all’apice della guerra del Peloponneso fu attribuita in parte da Tucidide ai difetti del loro processo di decisone democratico. La capacità di contemperare gli obiettivi geopolitici e militari è un esercizio difficile anche nelle migliori circostanze, poiché richiede una serena deliberazione e un distacco dalle passioni tumultuose dell’opinione pubblica e dai calcoli politici a breve termine. Proprio per questo Henry Kissinger, per esempio, considera il modello aristocratico del tardo XVIII secolo e degli inizi del XIX come l’apice della diplomazia moderna15. E Alexis de Tocqueville, forse il più acuto e preveggente osservatore degli Stati Uniti, scriveva ne La democrazia in America: «Quanto a me non ho difficoltà a dirlo: nella direzione degli interessi esterni della società i governi democratici mi sembrano decisamente inferiori agli altri»16.
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
La politica estera non ha bisogno dell’uso di quasi nessuna delle qualità proprie alla democrazia e richiede invece lo sviluppo di quasi tutte quelle che le mancano. La democrazia favorisce l’accrescimento delle risorse interne dello Stato; diffonde l’agiatezza, sviluppa lo spirito pubblico, fortifica il rispetto della legge nelle varie classi della società: tutte cose che non hanno che un’influenza indiretta sulla posizione di un popolo di fronte a un altro. Ma la democrazia può solo molto difficilmente coordinare i particolari di una grande impresa, fermarsi su un piano d’azione e seguirlo tenacemente attraverso gli ostacoli. Essa è poco adatta a combinare segretamente qualche misura e ad attenderne pazientemente il risultato17.
La cultura politica americana e la fortuna delle circostanze, entrambe così favorevoli alla stabilità delle istituzioni democratiche, hanno concorso a impedire il costante perseguimento degli interessi nazionali a livello di grande strategia. La condotta presente e passata della politica estera americana dovrebbe pertanto essere esaminata alla luce delle due più forti critiche contro di essa: quella tocquevilliana e quella machiavellica. Secondo la prima, un paese come l’America, nonostante le sue buone istituzioni interne, non sarebbe in grado, in definitiva, di elaborare una politica estera efficace, essendo fortemente impedito, in questo, dalla mancanza, sia pur parziale, di una visione geopolitica. Nella migliore delle ipotesi, ciò frenerebbe la sua tendenza a con-
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 34
34
quistare il posto che le spetta fra le grandi nazioni; nella peggiore, potrebbe esporlo al rischio di venir conquistata o completamente distrutta. Dal punto di vista machiavellico, invece, l’obiezione si può così riassumere: che senso ha tutto questo parlare di giustizia e moralità da parte di una repubblica che si presume pacifica e magnanima, ma è nata, com’è noto, in seguito a una guerra con la Gran Bretagna e grazie a spregiudicati accordi diplomatici con la Francia, le due grandi potenze europee dell’epoca? E avrebbero mai gli Stati Uniti conquistato il controllo e infine l’egemonia su un intero continente con le belle maniere? Né questo, d’altronde, deve stupirci, giacché anche una nazione fondata su principi di libertà deve, in ultima analisi, far fronte alle necessità, proprio come le altre. Per difendersi in un mondo ostile, persino una repubblica è costretta a impiegare gli strumenti della tirannia, se vuole dominare i suoi vicini ed estendere il proprio territorio fino a quando non abbia acquisito una solida sicurezza. La necessità dell’imperialismo è inscritta nel codice genetico della politica estera. Anche se chi rispetta la supremazia della legge della nazione si mette al riparo e acquista la libertà politica, ciò non conta per chi invece preferisce conservare le proprie tradizioni. Qual è stato, in definitiva, il destino degli indiani, abitanti originari del territorio sul quale sarebbero sorti gli Stati Uniti? Nonostante il suo atteggiamento moralistico e strafottente verso le potenze europee, l’America dovrà fare i conti con esse in un modo o nell’altro. (E intanto, l’ironia della storia ha voluto che il suo rapporto con l’Europa occidentale, negli ultimi cinquant’anni, abbia lentamente rovesciato i ruoli tradizionali, con quest’ultima che oggi punta l’indice accusatore sulla politica di potenza degli Stati Uniti.)18 Alla fine, la nuova nazione, per sopravvivere – più che per affermare la sua supremazia – dovrà orientarsi non già in base ai principi astratti del diritto naturale o alle certezze giuridiche della sua costituzione, bensì al comportamento effettivo di altri paesi, e in particolare di quelli europei, alle cui tendenze amorali i padri fondatori degli Stati Uniti avevano sperato di sottrarsi. Secondo queste critiche, l’attuale predominio dell’America è stato raggiunto più grazie alla fortuna che non alla competenza – per cui è destinato a durare poco – o è essenzialmente il risultato di una prudente deviazione dai suoi principi anziché della loro affermazione. Vi è poi una terza e più probabile eventualità: quella che, in as-
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 35
35
senza di una seria strategia, gli Stati Uniti si ritrovino a oscillare malauguratamente fra questi due estremi nella condotta della loro politica estera: ovvero fra il rimanere in balia delle circostanze (e di potenze più spietate) e il soccombere alle tentazioni di una spregiudicata Realpolitik. George Washington lanciò il suo ammonimento proprio per evitare questo pericolo. Tutti i problemi posti alla geopolitica dalla natura della democrazia e l’intrinseca debolezza della giovane nazione sarebbero stati così affrontati nella prima grande dichiarazione sulla politica estera americana, racchiusa nel discorso di commiato del suo primo, e secondo alcuni il suo più grande, presidente.
NOTE
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
1
Hintze O., «Military Organization and the Organization of the State», in The Historical Essays of Otto Hintze, Oxford University Press, 1975. 2 Henry James, Hawthorne, 1879 (trad. it., Hawthorne, Marietti, Milano, 1990, a cura di Luisa Villa, p. 45). 3 Tucker R.W., Hendrickson D.C., «Thomas Jefferson and American Foreign Policy», Foreign Affairs, primavera 1990, vol. 69, n° 2, pp. 135-156. 4 Ellis J.J., Founding Brothers, Alfred A. Knopf, New York, 2001, p. 11. 5 Ibid., p. 7. 6 Paine T., Rights of Man (1791), Citadel Press, Secaucus, 1974, p. 147. 7 Letters and Other Writings of James Madison, Philadelphia, J.B. Lippincott, 1865, vol. IV, pp. 491-492. 8 Hamilton A., «Federalist No. 6: Concerning Dangers From Dissensions Between the States», The Federalist Papers, Mentor, 1961, a cura di Clinton Rossiter (trad. it., Il federalista, nr. 6 «Circa i pericoli che potrebbero derivare dai dissensi fra i vari Stati», Nistri Lischi, Pisa, 1955, a cura di Gaspare Ambrosini, pp. 32-33). 9 Ibid., p. 34. 10 Hamilton A., «Federalist No. 1: General Introduction», The Federalist Papers (trad. it. cit., «Introduzione generale», p. 3). 11 Hintze, op. cit. 12 Ortega y Gasset, Invertebrate Spain, a cura di Mildred Adams, New York, W. W. Norton & Company, [©1937]; New York, H. Fertig, 1974 [©1973] (trad. it., «La Spagna invertebrata», in La Spagna e l’Europa, Napoli, Ricciardi, 1936, a cura di Lorenzo Giussa). 13 Gaddis J.L., Surprise, Security, and the American Experience, Harvard University Press, 2004, p. 9. 14 Mead W.R., Special Providence: American Foreign Policy and How It Changed the World, Routledge, London, 2002. 15 Si veda la sua avvincente ricostruzione del Congresso di Vienna in A World Restored: Metternich, Castlereagh and the Problems of Peace, 1812-22, Houghton Mifflin
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 36
36 Company, 1973 (trad. it., Diplomazia della Restaurazione, Garzanti, Milano, 1973, traduzione di Elena Brambilla, pp. 159-sgg.). 16 Alexis de Tocqueville, Democracy in America, Vol. 1, Ch. XIII, Vintage Books Edition, luglio 1990, testo di Henry Reeve riveduto da Francis Bowen e ulteriormente corretto dal curatore, Phillip Bradley (trad. it., La democrazia in America, Rizzoli, Milano, 1992, a cura di Giorgio Candeloro, p. 236). 17 Ibid. (trad. it. cit., pp. 236-237). 18 Per un’ampia discussione di questo fenomeno si veda Robert Kagan, Of Paradise and Power: America and Europe in the New World Order, Alfred A. Knopf, New York, 2003.
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 37
CAPITOLO SECONDO
LE PRIME LEZIONI
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
Il monito di Washington George Washington è senz’altro una delle figure rappresentative, se non l’icona, della storia americana (specie se si pensa al dollaro come al simbolo originario dell’America), ma ciò non toglie che la sua eredità culturale abbia avuto scarso peso. Inutile cercare scuole di pensiero in materia di filosofia politica o di geopolitica legate al suo nome, come nel caso di molti altri padri fondatori. I nostri politologi e i nostri storici parlano liberamente (e spesso oziosamente) di «jeffersoniani» e di «hamiltoniani», solo per citarne alcuni, ma nessuno fa mai riferimento ai «washingtoniani». Nella storia della politica estera degli Stati Uniti, l’influenza pragmatica del loro primo presidente su quello che sarebbe diventato l’approccio americano, soprattutto nel XX secolo, è minima. Ciò nonostante le politiche da lui auspicate avrebbero guidato gli Stati Uniti per oltre un secolo, fino alla prima guerra mondiale, e per i vent’anni successivi al fallimento del programma di Woodrow Wilson volto a superarne le tendenze isolazionistiche. Ma, pur se le esortazioni contenute nel suo Discorso di commiato sarebbero rimaste il punto di riferimento dei futuri responsabili politici, in tutto quel periodo, dei sentimenti che le avevano animate ben di rado si conserva traccia nelle loro personalità come nelle loro politiche. Questo paradosso è dovuto essenzialmente al fatto che, se da un lato la nazione avrebbe abbracciato la lettera delle sue parole – in qualche caso in modo quasi dogmatico – dall’altro, il loro spirito sarebbe stato sopraffatto e sostituito dalla visione del tutto diversa di Thomas Jefferson. «Vi sono stati due uomini che hanno dato alla politica estera americana una direzione che essa segue ancora oggi: il primo è Washington, il secondo Jefferson»1. Non è un caso che il fondatore, che privilegiava le scelte con-
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 38
38
crete basate sulle esigenze del momento – quelle più realistiche – rispetto alla teoria, avesse pure una grande esperienza della guerra. E anche Alexander Hamilton, aiutante di campo di George Washington durante la guerra d’indipendenza, si sarebbe rivelato uno dei pensatori più realistici della generazione dei padri fondatori nel momento di valutare i rapporti di forza e di interesse tra gli Stati Uniti e le altre nazioni. Mentre altri rappresentanti di quella generazione si preoccuparono soprattutto di garantire la libertà dell’individuo e dello Stato all’interno della nuova repubblica, l’attenzione di Washington si rivolse alle questioni di politica estera legate a loro volta a quelle della sicurezza, messe inevitabilmente a repentaglio da sentimenti individualistici e particolaristici che, pur se essenziali per conservare la libertà in patria, potevano rivelarsi fatali per un paese così giovane e con una posizione ancora così incerta sulla scena mondiale. Nel frattempo, Jefferson e Madison, i due uomini maggiormente associati alla libertà politica nella memoria del paese, avrebbero avuto tempi particolarmente difficili sul fronte della geopolitica. Realista per eccellenza, Washington doveva la sua comprensione delle cose del mondo a una vita spesa in politica e in guerra. Sulla natura degli uomini o degli Stati non si faceva illusioni. Ma, pur rendendosi conto che gli Stati Uniti avrebbero potuto adottare una politica estera diversa da quella degli altri paesi, non pensava che l’ingresso dell’America nel sistema internazionale avrebbe potuto alterarne sensibilmente il carattere tradizionale. Se Jefferson e altri sembravano a volte dare per scontato il successo del progetto americano, anche grazie all’aiuto della provvidenza in nome delle innegabili virtù dei suoi principi rivoluzionari, la posizione di Washington era più pragmatica: Gli uomini possono speculare a proprio piacimento, possono trarre dalla storia antica esempi di grandi imprese portate a termine grazie alla sua influenza; ma chiunque costruisca su questo terreno ritenendolo una base sufficiente per condurre una guerra lunga e sanguinosa alla fine ne sarà deluso… Può darsi che basti, di per sé, per un certo periodo di tempo, a spingere gli uomini all’Azione; a sopportare molto, ad affrontare difficoltà; ma, in assenza di Interesse, tutto ciò non è destinato a durare2.
Joseph Ellis, storico della guerra d’Indipendenza, racconta, in proposito, un aneddoto significativo che vale la pena di riportare integralmente:
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 39
39
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
Poco dopo l’entrata dei francesi nella guerra del 1778, numerosi membri del Congresso continentale cominciarono a premere perché la Francia invadesse il Canada, dove una popolazione a maggioranza francese autorizzava a sperare nella probabilità di un successo militare. Washington era contrario a questo progetto per più di un motivo, di cui avrebbe però confidato le ragioni più profonde a Henry Laurens, presidente del Congresso stesso. A preoccuparlo erano «l’arrivo in Canada di un esercito francese numeroso e il suo insediamento nella capitale di quella provincia, unita ai francesi da legami di sangue, dalle consuetudini, dai comportamenti, dalla religione e dalle precedenti relazioni di governo». I francesi erano certo alleati provvidenziali dell’America, ma, una volta che si fossero insediati in Canada, sarebbe stato assurdo pretendere che si ritirassero: «Temo che sia una tentazione troppo grande per essere respinta da un potere messo in moto in ossequio ai comuni precetti di politica nazionale». Fu davanti al Congresso che Washington pronunciò uno dei suoi discorsi più illuminanti in merito ai criteri che governano le nazioni: «Gli uomini abbracciano facilmente gli estremi», spiegò, «l’odio per l’Inghilterra può indurre qualcuno a riporre una fiducia eccessiva nella Francia… Sono più che disposto a nutrire i sentimenti più favorevoli verso il nostro nuovo alleato e a prediligerlo tra gli altri in misura ragionevole; ma un precetto che si fonda sulla esperienza universale del genere umano ammonisce a non fidarsi di una nazione al di là dei vincoli dettati dal suo proprio interesse, precetto che nessuno statista o politico prudente si azzarderebbe a disattendere»3.
E del resto lo stesso Palmerston affermava: «solo i nostri interessi sono permanenti, gli alleati no». Washington alludeva, in buona sostanza, alla conflagrazione allora in atto che vedeva protagoniste Gran Bretagna e Francia: «…con riferimento alla Francia e all’Inghilterra, questo governo può essere paragonato a una nave che attraversa le acque insidiose di Scilla e Cariddi»4. Da qui, la Dichiarazione di neutralità del 1793, che esprime in modo inequivocabile la filosofia che avrebbe informato la sua presidenza: I veri amici di questo paese non possono non vedere e non sentire che la sua politica non consiste nel farsi coinvolgere nelle questioni di altre nazioni, qualunque esse siano, ma di prendere le distanze dai loro contrasti e dalle loro politiche; e, nel caso di attacchi reciproci, nell’avvalerci della posizione di neutralità che abbiamo adottato. Venti
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 40
40 anni di pace, con un incremento di popolazione e di risorse qual è nel nostro diritto prevedere, aggiunti alla distanza che ci separa dalle potenze in lotta tra loro, ci consentiranno, con ogni probabilità, di essere nella giusta posizione per sfidare tutti i poteri sulla terra5.
Questa strategia avrebbe raggiunto la sua massima espressione nel suo Discorso di commiato in cui, manifestando senza riserve le sue convinzioni, cercò di far leva sul prestigio della sua carica e su quello, quasi mitico, della sua persona, per ammonire la nazione, libero dai vincoli di una politica a breve termine. In questo contesto, egli formulò quello che sarebbe diventato il locus classicus della geopolitica americana fino alla seconda guerra mondiale:«la nostra vera politica consiste nell’evitare alleanze permanenti con qualsiasi area del mondo esterno…»6. L’Europa ha una serie di interessi primari, che non corrispondono ai nostri, se non in misura risibile. Ciò spiega il suo coinvolgimento in controversie frequenti le cui cause sono essenzialmente estranee ai nostri interessi. Saremmo quindi imprudenti se ci lasciassimo coinvolgere, in nome di legami artificiosi, nelle vicissitudini ordinarie della sua politica o nelle coalizioni e collisioni dettate dalle sue amicizie o dalle sue inimicizie. La nostra situazione di distacco e di distanza ci suggerisce e ci consente di seguire una direzione diversa. Se rimarremo un solo popolo, sotto un governo efficiente, non sarà lontano il momento in cui potremo resistere ai danni materiali procurati da ingerenze esterne; in cui potremo adottare una posizione di neutralità e decidere in ogni momento che questa venga scrupolosamente rispettata; in cui le nazioni belligeranti, nell’impossibilità di avanzare rivendicazioni nei nostri confronti, non rischieranno alla leggera di provocarci; in cui potremo scegliere la pace o la guerra nel rispetto del nostro interesse, guidati dalla giustizia. Perché rinunciare ai vantaggi di una situazione così speciale? Perché abbandonare ciò che ci appartiene per avventurarci in un terreno straniero? Perché, intrecciando il nostro destino con quello di un qualsiasi paese europeo, affidare incautamente la nostra pace e la nostra prosperità ai meccanismi laboriosi dell’ambizione, della rivalità, dell’interesse, degli umori o dei capricci europei?7
Va tuttavia osservato che, sebbene questa sua esortazione si basasse su una lucida analisi geopolitica, le generazioni successive la scambiarono per vangelo, invece di condividerne semplicemente lo spirito. Come osserva Henry Kissinger, «L’America non considerò
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 41
41
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
l’avvertimento di Washington come un giudizio pratico e geopolitico, ma come massima morale»8. Ciò che contava, infatti, non erano tanto gli interessi geopolitici, quanto il desiderio di liberarsi dalla loro influenza corruttrice. Se gli Stati Uniti erano un paese virtuoso come nessun altro, incontaminato dall’immoralità della tradizione politica europea, quale altra scelta restava loro per conservarsi tali se non il rifiuto di quest’ultima? Una posizione, questa, che, in ultima analisi, trascende la politica. Va detto, tuttavia, che il suo monito non mirava a incoraggiare un distacco ascetico permanente dal mondo esterno. Spesso le sue parole di commiato vennero percepite come una sorta di «sermone della montagna» di carattere geopolitico. Niente, invece, potrebbe essere più lontano dalla verità. Lo scopo, infatti, era quello di indicare una direzione sicura, in grado di tutelare il giovane paese dalle sue stesse propensioni peggiori nel momento della massima vulnerabilità. Un po’ come il padre che mette le rotelle alla bicicletta del figlio, ben sapendo che prima o poi andrebbe a sbattere contro la sua auto. È ovvio che, nella sua visione, gli Stati Uniti non sarebbero stati perennemente esenti dalle costrizioni della geopolitica, liberi di realizzare il loro esperimento di governo repubblicano lontani dal resto del mondo. Al di là della pace e della libertà, Washington guardava chiaramente alla grandezza del suo paese. I cittadini d’America, posti nella più invidiabile delle condizioni, come i soli Signori e Padroni di un vasto tratto del continente, in cui trovano posto tutti i climi e le vegetazioni del mondo, e in cui abbonda tutto ciò che è necessario e conveniente alla vita, oggi, grazie a una pace soddisfacente e definitiva, sanno di godere di una Libertà e di una Indipendenza assolute; e d’ora poi, dovranno essere considerati gli Attori di un immenso Teatro, che si direbbe specialmente designato dalla Provvidenza per mettere in scena la grandezza e la felicità dell’uomo9.
La neutralità illuminata avrebbe dovuto essere pertanto la strategia da seguire fino al momento in cui il paese non fosse riuscito ad affermarsi sulla scena internazionale senza correre rischi. Questa sarebbe diventata la versione americana dello «splendido isolamento» della Gran Bretagna. Ecco perché Walter Russell Mead, si riferiva all’America ancora adolescente come alla «Gran Bretagna
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 42
42
della Gran Bretagna», intendendo con ciò che, così come quest’ultima si era tenuta fuori dalle vicende politiche del continente europeo, allo stesso modo l’America, nel corso del XIX secolo aveva mantenuto le distanze da gran parte del mondo esterno (dominato dagli inglesi), pur traendo benefici da questa posizione di distacco. Il trattato di Jay, firmato durante la sua presidenza, fu la manifestazione pratica più importante delle idee che Washington avrebbe abbracciato nel suo Discorso di commiato. E le aspre critiche con cui i diversi schieramenti politici lo accolsero gettano luce sulla natura essenzialmente controversa del suo pensiero, attenuata dal linguaggio elevato con cui lo formulò e dal fatto che si trattava del messaggio di congedo dell’uomo più venerato dell’epoca. Le tensioni tra Stati Uniti e Gran Bretagna erano andate acuendosi dopo il sequestro, da parte degli inglesi, dei mercantili americani diretti verso le Indie occidentali francesi per trarre vantaggio dall’ultima fase del conflitto anglo-francese, che il radicalismo della rivoluzione dell’89 aveva intensificato. La febbre della guerra sembrava aver colto anche gli Stati Uniti, ma Washington era del parere che un conflitto non fosse negli interessi del paese. E, per scongiurarne il rischio, nel 1794 inviò il presidente della Corte Suprema, John Jay, a negoziare un trattato. La Gran Bretagna riconobbe agli esportatori americani la clausola di nazione più favorita e il diritto di imporre tariffe doganali, ammise implicitamente di aver sequestrato i mercantili americani per potenziare la sua flotta nel corso del conflitto con la Francia e chiese agli Stati Uniti di rispettare l’impegno di estinguere i debiti di quelle che ormai erano ex colonie. In cambio, gli inglesi s’impegnarono a pagare un risarcimento per le navi sequestrate dopo il dicembre 1793. Si trattò di fatto di un accordo a carattere decisamente unilaterale. Innanzitutto, il riconoscimento della supremazia militare e politica della Gran Bretagna e gli accordi commerciali che le attribuivano un ruolo di primo piano negli scambi con l’America suggellavano un impegno alla neutralità soltanto apparente, in quanto destinata a favorire Londra nella guerra con la Francia. Il trattato in questione sanciva, inoltre, la rottura dell’alleanza franco-americana che, nata nel 1778, aveva decretato la vittoria dei coloni contro la Gran Bretagna. I suoi oppositori continuarono tuttavia a simpatizzare per la Francia, soprattutto dopo la sua rivoluzione, e a nutrire ostilità verso l’Inghilterra, colpevole di aver ostacolato l’indipendenza della colonie.
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 43
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
43
Ma, come osservava Washington, «La nazione che si abbandona all’odio inveterato o alla tradizionale predilezione verso un altro paese è in qualche misura schiava: della sua animosità o del suo affetto, entrambi sufficienti a distoglierla dal suo dovere e dal suo interesse»10. Ciò era in netto contrasto con quello che Hamilton definiva «l’attaccamento femmile di Jefferson per la Francia» e il suo «risentimento altrettanto femminile per la Gran Bretagna». Per quanti vedevano nella rivoluzione americana (e in quella francese) un evento di portata messianica, la posizione di Washington era nient’altro che un tradimento dei principi fondativi della nazione. Gli oppositori del trattato avrebbero volentieri condiviso il proprio destino con la Francia, non fosse altro per il significato che la rivoluzione francese assumeva ai loro occhi: la continuazione della loro guerra d’Indipendenza, che preannunciava l’inizio di un nuovo ordine mondiale. «Un’orgia di libertà», secondo la definizione di Jefferson, «che ormai inarrestabile dilagherà nel mondo»11. Opporsi alla Francia non significava soltanto perseguire i propri interessi, magari a danno degli altri, ma andare contro il corso della storia. Di fronte a concetti di questa levatura, si capisce come le considerazioni geopolitiche avessero scarsa fortuna. In realtà, il trattato aveva essenzialmente lo scopo di garantire agli Stati Uniti un ruolo tra le grandi potenze europee che tentavano di conquistare una posizione nel Nuovo Mondo. Gli spagnoli, per esempio, che in un primo momento si erano mostrati recalcitranti, nel timore di un’alleanza anglo-americana che avrebbe compromesso la loro posizione, si convinsero a firmare il trattato di Pinckney (1795), che accoglieva la richiesta dell’America di servirsi del Mississippi come canale di esportazione dei suoi prodotti. Gli Stati Uniti di Washington puntarono quindi sugli inglesi come potenza vincente nella lotta europea per l’egemonia, utilizzandoli per assicurarsi vantaggi che andavano oltre le loro possibilità – come dire che quella di saltare sul carro del vincitore è una pratica che ha origini lontane. Alla luce delle aspre critiche di cui fu oggetto il trattato (rivolte soprattutto a Jay più che al venerabile presidente), vale la pena di chiedersi se la scelta di una neutralità senza pregiudizi, invocata da Washington, sarebbe mai stata compiuta se generazioni di americani non l’avessero associata alla sua persona. La tendenza della democrazia ad obbedire in politica ai sentimenti piuttosto che ai ragionamenti, e ad abbandonare un disegno lungamente
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 44
44 maturato per la soddisfazione di una passione momentanea, si fece sentire fortemente in America all’epoca in cui scoppiò la rivoluzione francese. I più semplici lumi della ragione bastavano allora, come oggi, a far comprendere agli americani che il loro interesse non era affatto di impegnarsi nella lotta che insanguinava l’Europa e dalla quale gli Stati Uniti non potevano ricevere alcun danno. Eppure le simpatie del popolo in favore della Francia si dichiararono con tanta violenza che ci vollero il carattere inflessibile di Washington e la sua immensa popolarità per impedire che si dichiarasse guerra all’Inghilterra12.
Verso la fine del XVIII secolo, le tensioni tra Stati Uniti e Francia si acuirono a tal punto da giungere quasi sull’orlo della guerra, anche perché i francesi, venuti a conoscenza del trattato di Jay, avevano deciso di riservare ai mercantili americani «lo stesso trattamento che avevano subito dagli inglesi». Il che voleva dire sequestrare le navi dirette in Inghilterra e saccheggiarne i carichi nelle acque dell’Atlantico e dei Caraibi. John Adams, successore di Washington alla presidenza, preso atto dell’inutilità di dichiarare apertamente guerra, inviò emissari con l’incarico di negoziare una pace separata. Un tentativo, il suo, vanificato dall’instabilità del quadro politico francese e dalla corruzione di Talleyrand, ministro degli Esteri privo di scrupoli, il quale, prima ancora di incontrare gli inviati americani, chiese il versamento di 250.000 dollari. Adams sottopose tutti i documenti relativi all’attenzione del Congresso, cercando però di nascondere i fatti all’opinione pubblica, ben sapendo quale sarebbe stata la sua reazione (lo scandalo prese il nome di «Affare XYZ», dalle lettere utilizzate da Adams per indicare in codice il nome di Talleyrand). I dettagli, tuttavia, trapelarono ugualmente, scatenando la violenta reazione del paese. È difficile immaginare un esempio più calzante di crisi delle democrazie in generale, e degli Stati Uniti in particolare, nelle questioni di politica estera, quale quello di una nazione, che, appena scongiurato il conflitto con un paese (l’Inghilterra), nel giro di due anni compie un’inversione di rotta e decide di muovere guerra al nemico acerrimo di quello stesso paese (la Francia). Adams riuscì tuttavia a reggere alla tempesta, continuando a premere per un riavvio delle trattative, finché il governo francese, preso atto del suo errore, accettò di negoziare un accordo equo, ponendo fine a due anni di ostilità. Ciò non toglie, comunque, che i due partiti nazio-
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 45
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
45
nali condannassero severamente la politica di Adams, che non venne rieletto alla scadenza del suo mandato nel 1800. Tutta la storia della politica estera americana è contrassegnata da innumerevoli dibattiti il cui copione, anche se gli attori in scena si alternano, alla fine è quello scritto dai padri fondatori. Ma il primo, e il più essenziale, dibattito di politica estera, che per certi versi non si è mai interrotto, investiva di fatto altri temi. La questione di fondo – quella rivoluzionaria, per intenderci – non verteva sulle modalità di promuovere al meglio gli interessi della nazione, bensì sul significato della sua fondazione: gli Stati Uniti dovevano agire nel rispetto delle verità politiche tradizionali, rispecchiate da una natura umana essenzialmente immutabile, come affermavano George Washington, John Adams e Alexander Hamilton, o, com’era nella convinzione di Thomas Jefferson, di James Madison e dei loro eredi, la rivoluzione americana aveva sancito non soltanto l’indipendenza dall’Inghilterra, ma dall’intera tradizione politica? Se poi entrambe le parti difendevano l’idea di un governo scarsamente interventista, lo facevano per ragioni completamente diverse. Per Jefferson e i suoi seguaci il regime democratico liberale degli Stati Uniti – il primo di questo genere nella storia dell’uomo – rispecchiava un mutamento decisivo nella natura umana o, meglio, ne liberava l’aspetto essenzialmente pacifico, oscurato fino a quel momento da sistemi di governo sbagliati. Il nuovo pacifismo teorizzato da Jefferson e da Paine sembra talvolta sfociare in una concezione anarchica della politica. Entrambi accettano infatti, implicitamente, la concezione che lega la politica alla guerra, da cui l’apparente tentativo di evitare la politica tout court: quando la distinzione tra governanti e governati è del tutto cancellata, che bisogno c’è di un governo? Ciò che era valido a livello nazionale lo era altrettanto nelle questioni di politica estera: l’aspirazione imperialista dell’ancien régime altro non era che il risultato della medesima propensione in patria. Una volta liberi dalla monarchia, le inclinazioni bellicose degli uomini sarebbero diminuite in proporzione inversa alla libertà. Molto più pessimistica la visione della natura umana di Washington e dei suoi seguaci, convinti che «se gli uomini fossero angeli, non sarebbe necessario alcun governo» e che porre un limite ai poteri di quest’ultimo costituisse il modo migliore per arginare gli istinti umani peggiori. Nel caso degli Stati Uniti, ciò signi-
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 46
46
ficava che, in presenza di un governo debole, la propensione alla guerra non poteva che crescere. Infatti le violenze del genere [determinate dall’uso illegale della forza, come viene detto poco sopra, N.d.T.] sono più spesso dovute alle passioni e agli interessi di una parte che di tutti, piuttosto a quelli di uno o due Stati che a quelli di tutta un’Unione. Non v’è stata una sola federazione, per debole che essa sia; ma vi sono invece molti casi in cui le ostilità con gli indiani sono state provocate dalla condotta incauta di singoli Stati che, poco disposti o impossibilitati a frenare o a punire le offese, hanno inidrettamente causato lo sterminio di molti cittadini innocenti. La vicinanza di territori spagnoli o inglesi, che confinano con alcuni Stati e non con altri, restringe, naturalmente, ai soli confinanti le eventuali ragioni di litigio. Gli Stati confinanti sarebbero pertanto quelli che, nell’impulsività di una subitanea ira o di un rapido risentimento per un’ingiuria o per un’affrettata valutazione di un proprio interesse apparente, potrebbero con maggior facilità, attraverso l’uso diretto della violenza, esser causa di guerra con quelle nazioni [...]13.
Una tesi, questa, che contraddice nettamente quella sostenuta da Jefferson e da Paine, tra gli altri, secondo cui la causa principale della guerra è da ricercarsi nei governi e non negli uomini. Basti notare che qui già si può scorgere, in nuce, la storia futura degli Stati Uniti fino alla guerra civile, senza tralasciare tutte le guerre con gli indiani, l’annessione del Texas, la guerra con il Messico, episodi minori come l’annessione della Florida, grazie alla campagna vittoriosa del generale Jackson, e i conflitti con gli inglesi per la conquista dei territori a nordovest. L’anarchia, ai loro occhi, caratterizzava anche l’attività di politica estera, dove potere e ambizione non si scontravano con vincoli di sorta e una nazione che ambisse a sopravvivere doveva essere pronta a tutelare i propri interessi per evitare di essere annientata, a prescindere dal suo ordinamento interno. Orientamento geopolitico e visione dello Stato erano quindi interdipendenti. Ciò vuol dire che, fin dall’inizio, le scelte di politica estera degli Stati Uniti miravano non tanto a consolidarne o a salvaguardarne la posizione, ma a definirne il ruolo rispetto agli altri interlocutori. Paesi come la Francia o la Gran Bretagna possono definire i rispettivi interessi nazionali primari sulla base delle esigenze del momento. Non così gli Stati Uniti, per i quali il carattere universale
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 47
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
47
della propria fondazione è in contrasto con i tentativi di fare politica sulla base di tornaconti personali, che, se fossero perseguiti, minerebbero i principi stessi che ne hanno accompagnato la nascita. La scelta, quindi, si pone tra agire nel rispetto di un criterio diverso o rischiare di perdere la ragione stessa della propria esistenza. Obbedire alla raison d’état avrebbe significato, in altre parole, violare lo «spirito del 76». Lo aveva capito Jefferson, che con la sua retorica mirava a infondere il senso di una missione superiore alla nuova nazione, ma ancor di più Washington, il quale non ignorava i pericoli insiti in un simile approccio, temendo, giustamente, che il rispetto di principi elevati avrebbe messo a repentaglio il giovane paese in un mondo popolato da nazioni che concepivano i propri interessi in modo più spregiudicato. Associare non solo gli interessi, ma l’importanza degli Stati Uniti, a una fede imperitura nella libertà universale, avrebbe prima o poi comportato il passo successivo di legarsi a quel paese o a quella causa che avessero incarnato quella fede. Per cui, l’iniziale (ed errata) condivisione dei principi filosofici della rivoluzione francese si trasformò in senso del dovere nei confronti dello stato francese. Sul piano geopolitico, ciò significava gettare inutilmente la giovane nazione nel calderone della politica di potere dell’Europa. E rischiare di compromettere la fragile coesione della repubblica, in cui le fazioni filofrancesi s’identificavano, presumibilmente per motivi ideologici, più con una nazione straniera che con i propri concittadini (anche questo è il motivo della rottura tra Thomas Jefferson e John Adams – amici da una vita e grandi protagonisti della generazione dei padri fondatori – il che conferma una volta di più che anche le dichiarazioni di principio devono piegarsi alle ferree ragioni della geopolitica). L’isolamento auspicato nel Discorso di commiato era, più che una strategia per promuovere gli interessi americani all’estero, un tentativo d’impedire che la nazione si lacerasse prima ancora di poter valutare adeguatamente il mosaico della scena internazionale. Come aveva detto Hamilton, «L’influenza dei paesi stranieri è il vero cavallo di Troia di una repubblica». L’educazione di Thomas Jefferson Per quanto rigorosa, la dottrina di uno Stato fondato sugli ideali, formulata da Washington, non ebbe grande presa. E tuttavia, il suo
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 48
48
pensiero, a prescindere dalla venerazione tributata alla sua persona, non poteva essere del tutto ignorato. La condotta politica di Washington fu sempre basata su queste massime. Egli riuscì a mantenere il suo paese in pace, mentre tutto il resto del mondo era in guerra, e stabilì come base di dottrina che l’interesse bene inteso degli americani era di non prendere mai partito nelle lotte interne dell’Europa. Jefferson andò ancora più lontano e introdusse nella politica dell’Unione quest’altra massima: «Gli americani non dovrebbero mai domandare privilegi alle nazioni straniere, per non essere obbligati a loro volta ad accordarne»14.
È sulla base di questi principi che fu possibile formulare un obiettivo comune e un orientamento più o meno coerente da trasmettere alle generazioni future: Washington e Jefferson, infatti, nonostante le infinite divergenze, sembravano auspicare la medesima politica. …mentre Jefferson poteva parlare con genuina convinzione della neutralità americana e della necessità di tenersi fuori dai conflitti europei, dando l’impressione di condividere la visione di Washington, la sua concezione della neutralità era decisamente diversa. Non pensava, ad esempio, che lo scontro in atto tra Inghilterra e Francia per la supremazia in Europa fosse poi così remoto dagli interessi americani nel lungo periodo e, viceversa, vedeva nella rivoluzione francese la continuazione dello spirito del 7615.
È tuttavia indispensabile prendere atto che quella che per Washington è un’indicazione pragmatica, suggerita dal desiderio di preservare gli interessi e la libertà d’azione dell’America, per Jefferson è un precetto morale, dettato dall’aspirazione a mantenerne la purezza, che a sua volta richiede un grado di libertà dagli intrighi nefandi di altre nazioni. E ciò rendeva possibile formulare una politica comune, sia pure in presenza di reciproche incomprensioni. Gli Stati Uniti, in altre parole, si trovarono a perseguire una politica estera realistica, basata sulla difesa degli interessi nazionali, quasi senza accorgersene. Le politiche prudenti ereditate con gratitudine da Washington, e rivisitate in chiave jeffersoniana, furono percepite dalla nazione, non diversamente dallo stesso Jefferson, come qualcosa di diverso da ciò che effettivamente erano. Il che costituì, sotto molti aspetti, un precedente che ancora oggi ha il suo peso. È una singolare coincidenza che Thomas Jefferson, vale a dire
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 49
49
colui che ha forse esercitato la massima influenza sulla natura particolare della politica estera dell’America, sia stato anche il suo primo segretario di Stato. Ma paradossalmente fu sempre lui a ispirarne, più di ogni altro cittadino americano, la tipica propensione al ripiegamento su se stessa. «Contro l’affermazione del primato della politica estera su quella interna, egli ribadiva che gli obiettivi di politica estera non erano che un mezzo per proteggere e promuovere quelli interni, cioè la libertà dell’individuo e il benessere sociale»16. Resta da chiedersi come un uomo che, almeno a giudicare dalle apparenze, si preoccupava ben poco delle questioni d’interesse nazionale sia riuscito a lasciare un segno nella politica estera americana.
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
La ragione principale dell’ascendente esercitato da Jefferson sta nella facilità con cui sapeva evocare il significato dell’esperimento americano in termini di autonomia […] tanto da convincere anche l’agricoltore più umile che lui – l’americano – apparteneva a una forma di civiltà superiore a quella delle raffinate società europee, con le divisioni artificiose tra classi sociali, le restrizioni oppressive della libertà dell’individuo e il peso schiacciante dei debiti e delle tasse17.
L’America non ha mai avuto un Dante o un Cervantes, un unico personaggio che abbia dato un’anima alla nazione e al suo popolo; in grado di esprimere concretamente le miriadi di esperienze astratte che concorrono alla definizione di una cultura viva. Per questo motivo, da più parti si è affermato che una vera cultura non è la prerogativa del Nuovo Mondo. Probabilmente sarebbe invece più corretto affermare che l’America non ha una cultura che si differenzia dalla politica, in quanto la sua cultura è essenzialmente di natura politica. Ciò spiega perché l’uomo che ricopre al meglio il ruolo di poeta-legislatore è Thomas Jefferson, vale a dire uno statista. Frederick Jackson Turner lo definiva «il primo profeta della democrazia americana» e il suo biografo, James Parton, dichiarava che «Se Jefferson sbagliava, è l’America a sbagliare. Se l’America ha ragione, Jefferson aveva ragione». Nessun pericolo, quindi, di sopravvalutare l’importanza dell’uomo per chi voglia capire gli Stati Uniti. Anzi, sotto molti aspetti, la lunga e travagliata carriera politica di Jefferson può servire da parallelo con la più ampia esperienza americana sul fronte della politica estera. Jefferson, forse più di chiunque altro, esemplifica le due tendenze dominanti in questo campo che ancora oggi con-
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 50
50
tinuano a manifestarsi. La prima è il rifiuto di ammettere la separazione degli interessi dagli ideali: «Noi siamo fermamente convinti, ed è in base a tale convinzione che agiamo, che rispetto alle nazioni e ai singoli, i nostri interessi, giustamente calcolati, si riveleranno sempre inseparabili dai nostri doveri morali»18. La seconda è la propensione a discostarsi dalla realtà e a valutare situazioni uniche nei termini di un contesto più ampio e non di rado astratto. Nel caso di Jefferson, era il prisma della lotta per la libertà globale a rimandargli un’immagine ingannevole della realtà. «Per Jefferson, tutte le decisioni specifiche relative alla politica estera americana maturavano all’interno di un sistema di valori sovrastante, quasi cosmico»19. Ma la conquista degli avversari interni, sia sul terreno della politica (nelle elezioni del 1800) sia, ed è ciò che più importa, sul piano filosofico, non significava che la politica dovesse far posto alla poesia, per cui nell’ambito della politica estera cominciò a farsi strada un accomodamento singolare – un compromesso forzato tra l’idealismo di Jefferson e la realtà – che tuttavia non riuscì mai a superare le tensioni di fondo che lo caratterizzavano. La prima prova sarebbe venuta con i corsari barbareschi, insediati nella fascia nordafricana, i quali si diedero a depredare i mercantili americani diretti in Europa e i cui reggenti, i dey di Algeri, di Tunisi e di Tripoli, chiesero un tributo annuale per porre fine agli assalti. È interessante notare come sia Washington che Adams avessero accettato tale richiesta, non poi così diversa da quella avanzata dall’Inghilterra per concedere l’indipendenza. Jefferson, però, la pensava diversamente. Potrebbe sorprendere il fatto che un uomo apparentemente pacifico avrebbe scelto la forza laddove i suoi predecessori più realistici avevano optato per la convivenza pacifica, ma una spiegazione c’è, ed è più che plausibile: l’aspirazione a cambiare il mondo secondo la sua visione. Obbligato a scegliere tra mezzi non proprio edificanti per ottenere il risultato voluto e l’accettazione di una realtà imperfetta, Jefferson (e i suoi eredi) avrebbero quasi sempre optato per la prima delle due possibilità. Un approccio, il suo, meno dogmatico e più interessante di quanto non sembrerebbe al primo sguardo. In questo caso, significava prendere le distanze dalla visione di una repubblica esclusivamente assorbita dai suoi affari e autonoma rispetto al potere centrale, che, per poter disporre di una flotta in grado di contrastare efficacemente i corsari e i loro capi, avrebbe
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 51
51
dovuto consolidare le sue finanze con le tasse (paradossalmente, nei momenti di crisi, Jefferson avrebbe adottato i metodi a suo tempo indicati da Hamilton). Dopo aver inviato una flotta con il compito di assediare i porti della costa nordafricana e di proteggere i mercantili americani in rotta nelle acque del Mediterraneo, Jefferson decise una linea di condotta più ambiziosa, che mirava a sostituire il pascià di Tripoli con il fratello, meglio disposto verso gli Stati Uniti: anche Jefferson e Madison avevano letto il loro Senofonte.
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
Questa fu la prima di molte volte in cui un presidente americano avrebbe ordito ai danni di un governo straniero – un gioco pericoloso, ma difficile da respingere per l’amministrazione Jefferson non meno che per quelle che sarebbero venute dopo. Scriveva Madison: «Anche se l’intervento negli affari interni di altri paesi non è consono ai sentimenti o ai fini generali degli Stati Uniti, non può essere considerato ingiusto, nel corso di una guerra giusta o del raggiungimento di una pace ragionevole, volgere a loro vantaggio l’ostilità e le pretese di altri contro un comune nemico20.
Come dire che il quarto presidente degli Stati Uniti aveva fatto proprio uno dei capisaldi della diplomazia e della guerra, e cioè che «il nemico del mio nemico è mio amico». Quella spedizione, tuttavia, sarebbe fallita e le «guerre barbaresche» si sarebbero protratte fino al 1815, quando, a seguito della guerra del 1812, Madison inviò una flotta forte di 10 unità per distruggere le navi corsare e costringere i reggenti a sollecitare un accordo di pace. Nel proemio della sua Historia, Tucidide illustra come la civiltà ellenica (e quindi la civiltà dell’uomo in quella parte del mondo) ebbe inizio con la creazione di una flotta cretese che permise a Minosse di sconfiggere i pirati che infestavano l’Egeo e di fondare così la sua potenza, ovvero il primo Stato, sul dominio del mare. Anche Hobbes, con il suo Leviathan, rende omaggio a questa idea, paragonando lo stato da lui concepito a un immenso mostro marino. E non è un paradosso da poco il fatto che Thomas Jefferson, che rifiutava la nozione di guerra come origine dello Stato e mirava a creare e mantenere uno Stato troppo debole per fare della guerra l’obiettivo della propria esistenza, abbia potenziato la flotta per perseguire la prima grande politica militare del governo federale americano contro bande di pirati, che infestavano acque non troppo lontane da quelle dove ebbero luogo le guerre di Minosse.
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 52
52
Il presidente americano che più di ogni altro impersonava l’aspirazione profonda dell’America a rompere con gli schemi corrotti del Vecchio Mondo – ovvero il primo presidente americano «progressista» – rimise in vita la politica estera del primo Stato occidentale a 3000 anni di distanza. Come affermava Mark Twain, la storia non si ripete, ma fa la rima. In questo caso, la visione di Jefferson di una repubblica commerciale pacifica, libera il più possibile dalle ingerenze del potere centrale, fu messa in crisi dall’esistenza di agenti esterni, che chiedevano riscatti e tributi ingenti mietendo indiscriminatamente le vite di civili americani sui mari. Certo, non si trattava di una minaccia esistenziale, eppure la necessità di perseguire obiettivi commerciali relativamente limitati, ma necessari alla vita quotidiana dei cittadini americani, imponeva di espandere la politica navale con conseguenti benefici per il paese. Preso atto della situazione, Jefferson conformò le sue politiche, se non la sua visione, alle nuove esigenze. Va detto, però, che la nuova strategia mette sostanzialmente in luce un limite fondamentale della sua visione senza tuttavia contraddirne l’essenza. L’idealismo, infatti, non chiede di negare la realtà delle cose, ma di difendere la parte fondamentale di ciò in cui crediamo, pur nel cimento di un mondo pericoloso. Una visione resa problematica dalle sue contraddizioni interne più che dagli ostacoli esterni. Legato all’immagine di una società prevalentemente agricola come bastione della libertà repubblicana e ostile al capitalismo urbano, Jefferson era ostaggio di una situazione che, di fronte a un aumento innarrestabile della popolazione, lo obbligava ad assicurasi il controllo di altri territori, che permettessero di sostenere lo stile di vita dei proprietari terrieri. Il che implicava una politica di espansione e annessione, con le conseguenti manovre diplomatiche e i conflitti potenziali con altre nazioni aventi mire territoriali antagonistiche rispetto a quelle dell’America, e l’instaurazione di un completo dominio sulle tribù indiane insediate nelle zone che si desiderava conquistare. Convinto fautore dell’isolazionismo […], Jefferson aveva però una visione della società americana legata alla realizzazione dell’espansione territoriale e degli obiettivi commerciali... Erano quindi i repubblicani [i suoi sostenitori] e non i federalisti [i suoi oppositori] a dipendere maggiormente, in virtù della loro visione interna, dalla politica estera e, di conseguenza, dall’esigenza di accettarne il primato. Nella loro de-
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 53
53
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
finizione, la realizzazione del benessere e della felicità degli americani – che veniva fatta coincidere con la continuità stessa della nazione – dipendeva in larga misura dagli scambi esterni21.
A segnare la vita politica non è la tensione tra etica e necessità, ma quella tra visioni contraddittorie del bene, perché non tutto ciò che è bene è compatibile, anche all’interno dello stesso regime. Non c’è dubbio, infatti, che pensare con serietà alle istanze della politica significa prendere atto della necessità del compromesso. L’aspirazione a realizzare obiettivi contrastanti, insita nella natura dell’uomo, mal si concilia con quella di realizzare politiche ispirate alla prudenza. Una verità, questa, confermata dalla crisi marittima della seconda amministrazione Jefferson. La guerra che dilagava in Europa minacciava di far piazza pulita di tutte le pretese di neutralità che il presidente repubblicano cercava di difendere. Ma, mentre Washington basava la sua neutralità su una lucida valutazione degli interessi americani ed era, quindi, favorevole all’Inghilterra, Jefferson cercava in buona fede di prendere le distanze dal conflitto, che, a suo dire, coinvolgeva «il tiranno della terraferma e il tiranno dei mari». Il suo eterno rivale, Alexander Hamilton, provvedeva tuttavia a puntualizzare che «I diritti della neutralità saranno rispettati soltanto se difesi da una potenza adeguata. Una nazione resa disprezzabile dalla sua debolezza perde anche il privelegio della sua neutralità»22. Può darsi che gli Stati Uniti non aspirassero al potere in Europa e fossero, quindi, nella posizione di rivendicare un certo grado di disinteresse, ma quello che è certo è che l’ordine essenzialmente europeo – sostenuto dalla Gran Bretagna – garantiva le basi di quei diritti commerciali a cui ambivano. Il «distacco» supremo prospettato da Washington nel suo Discorso di commiato non si basava, pertanto, su uno stato di natura benevolo tra nazioni, bensì sull’ordine creato dall’uomo. Si capisce quindi che la Gran Bretagna non abbia trovato particolarmente persuasivi gli argomenti di Jefferson a favore di una imparzialità disinteressata, dal momento, tra l’altro, che questa non escludeva gli scambi commerciali con la Francia di Napoleone – scambi che naturalmente andavano a beneficio degli Stati con cui la Gran Bretagna aveva ingaggiato una lotta mortale. Come sosteneva Churchill, «Non potete aspettarvi che io sia neutrale tra il pompiere e il fuoco». La Francia di Napoleone cercava, da un lato, di consolidare
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 54
54
la sua egemonia in Europa e, dall’altro, con i rischi del caso, di rovesciare gli ordini costituiti dei regimi a cui contendeva il controllo territoriale. Mentre gli obiettivi della Gran Bretagna erano essenzialmente difensivi – preservare lo status quo di prima della guerra e l’equilibrio di potere in Europa (e nel Nuovo Mondo) – quelli della Francia erano di gran lunga più radicali e potenzialmente illimitati. In ultima analisi, a essere in gioco era la sopravvivenza della Gran Bretagna in quanto grande potenza e, forse, il suo stesso ordine interno che, per quanto imperfetto, garantiva un certo grado di giustizia e di stabilità a fronte del caos scatenato dalla Francia rivoluzionaria. La Gran Bretagna, dunque, non riconobbe la legittimità della posizione dell’America e decise di assediare le sue navi e sequestrarne le merci destinate alla Francia, obbligando, nel contempo, i marinai di provenienza inglese ad arruolarsi nella sua marina. Una strategia, questa, che, oltre a ostacolare non poco quegli scambi che erano la linfa vitale dell’America, violava gravemente i diritti individuali dei suoi cittadini. Di qui, la reazione violenta di Jefferson che si sarebbe tradotta nella dichiarazione di guerra dei suoi successori. Per Jefferson, i diritti degli americani, che la neutralità doveva contribuire a tutelare, non erano negoziabili. E gli scambi commerciali, che la neutralità era destinata a favorire, erano essenziali per sostenere uno Stato che aspirava al lusso di evitare la bellicosità delle politiche economiche mercantilistiche. E non si trattava solo di «interessi», ma di diritti che per Jefferson (e quindi per gli americani) dovevano essere massimamente difesi. Ciò spiega la complessità della sua posizione. La neutralità (o il non allineamento, come si sarebbe detto negli anni successivi) è la condizione tradizionalmente invocata da paesi emergenti e ancora deboli. Se perseguita con prudenza, può consentire la fase di tregua necessaria al giovane Stato per consolidare il suo potere (o a un vecchio Stato per evitare di essere fagocitato) senza attirare l’attenzione indesiderata o l’ira di Stati più potenti. Va ricordato, tuttavia, che la neutralità è valida solo nella misura in cui l’ordine al quale si dichiara di non voler partecipare è disposto a prenderne atto. Vale a dire che una dichiarazione di neutralità non presuppone il ritorno a una situazione di normalità da parte del paese interessato. Questo, infatti, si trova nella situazione innaturale di dovere, da un lato, valutare i propri interessi e, dall’altro, i benefici che la sua neutralità può comportare per le nazioni
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 55
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
55
che scelgono di riconoscerla. Una condizione di per sé precaria, ma considerata da chi la adotta più sicura delle alternative. Per gli Stati Uniti, d’altra parte, la scelta della neutralità era la conseguenza della loro naturale condizione di isolamento. La partecipazione agli affari internazionali è storicamente interpretata come il risultato dell’imprescindibile necessità imposta dall’infausta ingerenza di potenze esterne. In assenza di minacce simili, gli Stati Uniti tendono generalmente a ripiegare su se stessi, optando per il coinvolgimento soltanto nelle questioni economiche o, di questi tempi, nelle cause umanitarie. Il coinvolgimento diretto degli Stati Uniti negli affari internazionali (attualmente notevole) ha un carattere sostanzialmente reattivo da considerarsi, più che una concessione alle realtà della geopolitica tradizionale, una risposta alla pericolosa aberrazione del sistema internazionale. Una volta affrontato il problema, il mondo potrà far ritorno a una condizione di relativa normalità e gli Stati Uniti potranno tornare a ripiegare su se stessi, com’è loro costume. La differenza consiste nel fatto che la retorica morale di Jefferson non era al servizio degli interessi: questi sono negoziabili e soggetti a compromessi, i diritti no. Per lui, la neutralità non era in funzione degli interessi americani, ma di una estensione nazionale della libertà individuale, la cui violazione non era che un’altra forma di dispotismo. È necessario tuttavia prendere atto non solo del dilemma che Jefferson aveva di fronte, di fatto non così drammatico, ma anche della sincerità delle rivendicazioni che ne erano all’origine. In caso contrario, la vicenda dei sequestri delle navi americane e la guerra del 1812 diventano semplici conflitti di interesse, e anche relativamente secondari, specie per una potenza giovane ed emergente. Il fatto che questo scontro sia sfociato in una dichiarazione di guerra è significativo. L’arruolamento forzato dei marinai americani nella marina britannica era senz’altro un atto arbitrario, che tuttavia non minacciava la libertà d’azione degli Stati Uniti e, tanto meno, la loro esistenza. Non di meno, nel tentativo di rompere lo stallo, il 22 dicembre 1807 il Congresso, su richiesta dello stesso Jefferson, approvava l’Embargo Act, che bloccava le esportazioni di merci americane e vietava a tutte le navi degli Stati Uniti di salpare alla volta dei porti europei. La speranza era che il potere dell’economia avrebbe avuto successo laddove gli strumenti politici erano falliti e quelli militari non
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 56
56
si potevano impiegare. In realtà, nonostante i metodi pacifici utilizzati, Jefferson mirava a imporre la volontà dell’America al sistema europeo, nella convinzione che la necessità delle esportazioni americane sarebbe bastata a piegare gli Stati europei ai suoi voleri. Ma, al di là dell’eccessiva importanza attribuita al commercio americano e, forse, più in generale ai fattori economici complessivi, ciò che balza agli occhi è la profonda insoddisfazione dell’America nei confronti del sistema internazionale e il conseguente desiderio di modificarlo. All’origine di quella che spesso è stata percepita come la tradizione messianica dell’America sul fronte della politica estera – vale a dire il tentativo di riformare le regole del sistema internazionale invece di accettarle – era il timore che la natura del sistema stesso fosse per lo stile di vita americano una minaccia paragonabile a quella rappresentata dagli Stati che ne facevano parte. Tentare di accomodarsi al sistema esistente poteva comportare il rischio di conformarsi eccessivamente agli schemi dell’ancien régime, in quanto una politica di successo presupponeva l’obbedienza ai precetti della ragion di Stato. Questa, a sua volta, privilegiando la politica estera, minacciava le libertà dei cittadini e, ciò che più importa, i metodi del regime che li governava. Di qui, l’aspirazione a realizzare, con la politica o con l’esempio, un ordine mondiale diverso – che consentisse di fare una politica estera in grado di promuovere il modello americano. Come molti anni dopo avrebbe dichiarato Woodrow Wilson, in nome di politiche ben più radicali di quelle vagheggiate dal Jefferson, «perché il mondo sia un luogo sicuro per la democrazia». I tentativi di Jefferson non riuscirono a modificare il comportamento dei suoi antagonisti europei e distrussero la nascente economia americana. I sentimenti che avevano ispirato le sue politiche avrebbero registrato un crescendo sotto il suo successore, James Madison, il quale decise di ottenere con la forza quei risultati che il ricorso alla diplomazia e alle sanzioni non era riuscito a garantire. Al momento di chiedere una dichiarazione di guerra, Madison sottolineò «gli oltraggi e le umiliazioni che avevano colpito il paese». Ecco come Henry Clay, autorevole nazionalista, spiega i motivi che portarono al conflitto: La guerra fu dichiarata perché la Gran Bretagna si era arrogata il diritto di regolamentare il nostro commercio estero, spacciando le sue mire per misure di rappresaglia decise in seno al consiglio – un diritto che l’ha in-
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 57
57
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
dotta a intimare all’impresa americana «puoi spingerti fino a questo punto e non oltre…»23.
Ma se è fuori di dubbio che il libero scambio rientrava negli interessi economici degli Stati Uniti («libertà di navigare vuol dire libertà di commerciare), è altresì chiaro che, in questo caso, gli interessi furono elevati allo status di diritti. Il principio di libertà economica che governava gli affari interni americani adesso doveva essere applicato anche agli affari esteri. La realtà di fondo dell’illegalità del quadro internazionale, specie in un periodo contrassegnato da guerre senza quartiere, era secondaria all’assunzione di regole di condotta supreme per governare uomini e nazioni. Gli Stati Uniti, quindi, si apprestavano alla guerra non tanto per difendere i propri interessi economici o opporsi all’oltraggio dell’arruolamento forzato dei loro marinai, ma per combattere le violazioni di quelli che consideravano diritti neutrali. E poco importa che in acque extraterritoriali i diritti neutrali, tutelati da trattati stipulati in tempo di pace, non possano avere la legittimità o il peso dei diritti interni tutelati dalla Costituzione. A ciò si aggiunga che fare della dichiarazione di guerra una questione di principio (se non di onore) significava escludere qualsiasi valutazione ponderata degli effettivi interessi coinvolti. Una valutazione che, probabilmente, avrebbe richiesto un’analisi dei rapporti di forza, che, a sua volta, avrebbe messo in luce la grande debolezza degli Stati Uniti. «Spesso una certa condiscendenza – come osservava Alexander Hamilton – scongiura il rischio di umiliazioni future». Un’atteggiamento salomonico rispetto al quale il trattato di Jay e la guerra del 1812 si pongono agli antipodi. Gli eventi che seguirono non costituirono una sorpresa per Washington, che commentò: «La nazione, spinta da un sentimento di ostilità e dal rancore, a volte costringe il governo a dichiarare una guerra, in contrasto con le valutazioni politiche»24. E fu precisamente ciò che accadde: a soli vent’anni dalla sua nascita, il paese precipitò in un conflitto con la potenza più forte del mondo che sarebbe culminato nell’incendio del Campidoglio. Si potrebbe cedere alla tentazione di vedere nelle vicende di questo periodo il risultato degli errori commessi da una giovane nazione ancora priva di esperienza, i cui responsabili politici non sanno ancora come governare la nave dello Stato in mezzo ad acque insidiose: in questi casi, gli incidenti sono sempre dietro l’angolo. Ma si an-
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 58
58
drebbe fuori strada. I fondatori degli Stati Uniti sono, al di là di ogni dubbio, la più grande generazione di statisti che la nazione abbia mai prodotto. Furono loro a creare la prima democrazia liberale del mondo, nata nel fuoco di una rivoluzione, e a consegnarla intatta ai successori. A James Madison, che avrebbe guidato il paese nella incauta guerra del 1812, va il merito di aver dato il suo contributo di filosofo della politica ai saggi raccolti nel Federalist. Nessuno di questi uomini ha peccato d’ingenuità o ignorato i problemi del mondo. La direzione seguita, così diversa da quella indicata in molti casi dalla storia, non era frutto dell’ignoranza di quest’ultima (il che vale anche per molti dei loro successori), ma piuttosto di una visione diversa che, per essere realizzata, esigeva un cambio di rotta. Una visione non dettata principalmente dagli interessi, e un modo di pensare che sarebbe diventato una seconda natura per tanti altri uomini politici e che finì con l’essere considerato una concessione quanto mai infausta alla necessità. Alla fiducia nelle nuove possibilità sul fronte della politica estera si accompagnavano le nuove opportunità di politica interna, rese possibili dalla nascita di un nuovo Stato. Se, contrariamente a ogni aspettativa, avrebbero potuto evitare gli eccessi del dispotismo della Russia zarista, l’imperialismo degli Asburgo, la frammentazione dell’Italia e della Germania, e l’orgia di sangue della Francia rivoluzionaria, e godere di una libertà maggiore di quella della Gran Bretagna, era poi così improbabile che la rivoluzione americana e il superamento dell’Europa trovassero coronamento nell’ambito della politica estera? Per Machiavelli, una leadership superiore non poteva che infiacchire il popolo, creando le premesse di un grosso problema politico. Come dire che i grandi successi rendono più facile la vita e più difficile affrontare le difficoltà. Allo stesso modo, il grande successo delle leggi e delle istituzioni interne americane nel creare una società civile rispettabile e osservante del diritto aveva avuto anche l’effetto di proteggere quest’ultima dalle realtà più dure della vita politica, specie una volta assicurato il controllo esclusivo dello spazio continentale. Di qui, la convinzione che la relativa armonia che regola il sistema americano abbia le sue radici nella natura delle cose politiche. Anche perché la pace e la tranquillità che certamente hanno caratterizzato la vita di altre nazioni e di altre città, per non parlare degli imperi, erano senz’altro più precarie. Se la filosofia di Jefferson ha lasciato un segno nelle generazioni
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 59
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
59
che si sono succedute è anche perché la sua visione, più di tutte le altre, era congeniale alla vita che conoscevano. L’asprezza di un Washington o di un Hamilton presupponevano, al contrario, un’esperienza più vasta, e probabilmente meno piacevole, delle cose politiche, fortunatamente negata alla maggioranza degli americani. Quei padri fondatori, in quanto esterni al regime cui diedero vita, conoscevano realtà con cui i loro successori non si sarebbero scontrati. Tutti i grandi statisti che hanno studiato la natura delle relazioni tra le nazioni condividono una nota di pessimismo: è il caso di Federico il Grande, di Winston Churchill, di Charles de Gaulle, e anche di quei primi americani il cui pensiero non si è mai pienamente trasfuso nel credo nazionale: Washington, Adams e Hamilton. Nei grandi uomini, il pessimismo non è un alibi a giustificazione del quietismo o della sconfitta, ma solo una comprensione prudente della natura umana e dei limiti della politica. Ma, soprattutto, rivela un pensiero che affonda nella coscienza storica. Non soltanto conoscenza della storia, ma anche un senso della stessa e una conoscenza del presente e del futuro che essa concorre a formare. Questo pessimismo – e in una certa misura quest’ultima forma di conoscenza – sono anatema per l’America, convinta che questo modo di conoscere la storia equivalga a farne una prigione, a confinare la politica futura entro gli orizzonti passati. Con il rischio di arrestare l’evoluzione della storia umana di cui l’America è l’avanguardia e di costringere gli Stati Uniti a convivere con potenze più vecchie, i cui errori e le cui magagne sono da lungo tempo sotto gli occhi di tutti. Gli Stati Uniti sono nati nella convinzione di avere qualcosa da insegnare al mondo. Eppure, lungo il cammino verso la supremazia, non di rado si sono scoperti a imparare per la prima volta ciò che altre nazioni sapevano da molto tempo. Nondimeno, queste prime lezioni non sono da ascrivere a un’arte di governare ancora incerta, ma alla manifestazione naturale di un modo americano, nuovo e particolare, di percepire la politica. Le generazioni future non li avrebbero considerati né errori da cui trarre una lezione né una base sulla quale edificare, ma il modello americano dell’arte di governare. Questo periodo non riveste soltanto un interesse storico, ma è fondamentale per capire una visione geopolitica che emerge dalle idee più che dalla storia e dalla struttura di un determinato sistema internazionale o dallo studio dei rapporti di forza tra le nazioni.
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 60
60 NOTE 1
Alexis de Tocqueville, Democracy in America, vol. I, cap. XIII, Vintage Books Edition, luglio 1990, testo di Henry Reeve riveduto da Francis Bowen e ulteriormente corretto dal curatore, Phillip Bradley (trad. it., La democrazia in America, Rizzoli, Milano, 1992, a cura di Giorgio Candeloro, p. 235). 2 Washington to John Barrister, 21 aprile 1778, Writings of George Washington, Washington, 1931-1939, vol. VI, pp. 107-108 a cura di John C. Fitzpatrick. 3 Ellis J., Founding Brothers, Alfred A. Knopf, New York, 2001, p. 132. 4 Washington to Edmund Randolph, 31 luglio 1795, Writings of George Washington, op. cit., vol. XXXIV, p. 266. 5 Proclamation of Neutrality, 22 aprile 1793, Writings, cit., p. 840. 6 George Washington’s Farewell Adress, 17 settembre 1796. 7 Ibid. 8 Kissinger H., Diplomacy, Simon & Schuster, New York, 1994, p. 32 (trad. it., L’arte della diplomazia, Sperling & Kupfer, Milano, 2004, p. 13). 9 Lettera circolare del 1783, George Washington, Writings, Library of America, New York, 1997, a cura di John Rhodehamel, pp. 516-517. 10 Washington’s Farewell, cit. 11 Jefferson in una lettera a Tench Coxe, 1 giugno 1795, in The Writings of Thomas Jefferson, New York, 1892-1899, vol. VII, a cura di Paul Leicester Ford. 12 Tocqueville, op. cit. (trad. it. cit., p. 237). 13 Jay J., «The Federalist No. 3: The same subject continued», The Federalist Papers (trad. it., Il Federalista, nr. 3, «Continua lo stesso argomento» [questo titolo del 3° articolo de Il Federalista rimanda al 2° articolo intitolato «Circa i pericoli rapprsentati dall’influenza di potenze straniere ovvero da loro possibili interventi armati», N.d.T.], Nistri Lischi, Pisa, 1955, a cura di Gaspare Ambrosini, pp. 16-17). 14 Tocqueville, op. cit. (trad. it. cit., p. 236). 15 Ellis J., op. cit., p. 142. 16 Tucker R.W., Hendrickson D.C., «Thomas Jefferson and American Foreign Policy», Foreign Affairs, primavera 1990, vol. 69, nr. 2. 17 Ibid. 18 Thomas Jefferson nel suo 2° discorso inaugurale, 1805, The Writings of Thomas Jefferson, cit., vol. VII. 19 Ellis, op. cit., p. 142. 20 Boot M., The Savage Wars of Peace: Small Wars and the Rise of American Power, Basic Books, New York, 2002, p. 23-24. 21 Tucker e Hendrickson, op. cit. 22 Hamilton A., «The Federalist No. 11: The Utility of the Union in Respect to Commercial Relations and a Navy», The Federalist Papers (trad. it. cit., Il Federalista, nr. 11, «Utilità dell’Unione ai fini delle relazioni commerciali e della costituzione di una marina», p. 69). 23 Dal discorso di Henry Clay, del Kentucky, «Speech in the House of Representatives», 8 gennaio 1813. 24 Washington’ Farewell.
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 61
CAPITOLO TERZO
I L CONTINENTE SENZA OSTACOLI
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
La grande strategia di John Quincy Adams La dottrina Monroe sancì il coronamento della formazione geopolitica degli Stati Uniti: per l’allievo volenteroso era giunta l’ora di mettere in pratica le conoscenze acquisite grazie anche alla saggezza di Washington, alle sfortunate esperienze di Adams nei suoi rapporti con la Francia e, soprattutto, alla disastrosa guerra del 1812 e all’incendio del Campidoglio. Il fatto che, una volta promulgata, il popolo americano e i suoi leader l’abbiano prontamente accantonata per oltre mezzo secolo ne testimonia il successo e l’unicità. Con essa ebbe inizio anche un isolazionismo destinato a protrarsi per oltre un secolo. È giusto, tuttavia, precisare che, nonostante l’imprimatur di Monroe, questa dottrina fu di fatto elaborata dal suo successore, osservatore attento e rigoroso della situazione geopolitica americana1. L’influenza da lui esercitata sul suo secolo fu tale che, persino chi lo aveva sconfessato, costruendo la propria carriera su una posizione di distanza – si pensi ai presidenti Jackson e Polk – avrebbe portato le sue politiche alla loro logica conclusione, non diversamente da Jefferson che, volente o nolente, si era trovato ad abbracciare le idee degli oppositori che disprezzava maggiormente. A conferma, una volta di più, dell’impossibilità, almeno negli Stati Uniti, di raggiungere un consenso geopolitico a tavolino. John Quincy Adams, figlio di John Adams, secondo presidente degli Stati Uniti, fu segretario di Stato di James Monroe, al quale sarebbe successo come sesto presidente. Nello svolgimento di questi due incarichi, egli si batté a favore di una politica estera pragmatica, destinata, secondo la teoria già espressa da Washington, a proteggere l’America da ingerenze europee e, nel contempo, a consolidare il potere americano sul continente.
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 62
62
Come lo stesso Adams avrebbe toccato con mano, il modo migliore di assicurare l’indipendenza e la sicurezza degli americani sarebbe stato, nella misura del possibile, evitare innanzitutto le intromissioni esterne. Fu Andrew Jackson, eletto alla presidenza nel 1818, a conquistare le città di St. Marks e di Pensacola e a rivendicarne l’annessione agli Stati Uniti, nel corso di una spedizione da lui guidata contro gli indiani seminole con cui i pionieri avevano avuto scaramucce in Florida – ancora sotto il dominio spagnolo. E l’allora segretario di Stato John Quincy Adams si trovò a negoziare le condizioni indicate dal generale, sostenendo che gli spagnoli non erano nella posizione legittima di avanzare pretese su quel territorio, dal momento che non erano in grado di assicurarne il controllo, uniformandosi, in tal modo, a un precedente classico di geopolitica americana in virtù del quale a decidere gli obiettivi diplomatici sono spesso azioni militari indipendenti. Come nel caso del «destino manifesto», di cui si sarebbe sentito parlare in anni futuri, e che questo incidente aveva anticipato, era la pratica, non la strategia, a mettere in luce, non di rado fortuitamente, la natura degli interessi americani. Questa, allora, la conclusione formulata con coerenza da Adams: «La Spagna deve cedere agli Stati Uniti una provincia… di fatto derelitta, aperta all’occupazione di qualsiasi nemico degli Stati Uniti, civilizzato o selvaggio, e il cui unico scopo concepibile è di essere per questi una fonte di guai»2. Nel 1821, il trattato Adams-Onis sanciva l’annessione della Florida agli Stati Uniti e Jackson divenne il suo primo governatore. Preso atto della loro debolezza dopo l’inconcludente guerra del 1812, gli Stati Uniti si resero conto che incidenti come la controversia sulla Florida erano destinati a ripetersi, in quanto segni evidenti delle sfide alla sicurezza che li minacciavano da più parti. La risposta a queste sfide fu la cosiddetta «dottrina di Monroe», enunciata nel 1823 dal presidente James Monroe in occasione del discorso annuale al Congresso. Qualsiasi tentativo – questo il principio teorizzato dalla dottrina – da parte di altri paesi di esercitare il proprio potere nell’emisfero degli Stati Uniti sarebbe stato considerato alla stregua di una minaccia e affrontato di conseguenza: l’America aveva tacitamente adottato l’antica nozione realistica delle «sfere d’influenza». La sincerità e le relazioni amichevoli esistenti tra gli Stati Uniti e le potenze in questione c’impongono di dichiarare che considereremo pe-
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 63
63 ricoloso per la nostra pace e la nostra sicurezza ogni tentativo di estendere i loro sistemi a qualsiasi area del nostro emisfero. Noi non abbiamo interferito e non interferiremo con le colonie o con i possedimenti di nessun paese europeo, ma, con riferimento ai quei governi che hanno dichiarato e mantenuto la propria indipendenza che noi, con grande rispetto e in virtù di giusti principi, abbiamo riconosciuto, non potremo che considerare qualsiasi intervento europeo, volto a opprimerli o a controllarne altrimenti il destino, come una manifestazione di inimicizia nei confronti degli Stati Uniti3.
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
Preoccupata di assicurare il margine di protezione più ampio possibile, senza tuttavia formulare specifici obiettivi di lungo termine, la dottrina Monroe era, sul piano geostrategico, relativamente elementare. Non tanto una strategia di lungo periodo, ma piuttosto un metodo per scongiurarne la necessità. Negare la possibilità di ingerenze europee nel nuovo emisfero, significava infatti ridurre in modo considerevole il ricorso alla guerra e alla diplomazia, che avevano messo duramente alla prova la repubblica nei suoi primi anni di vita. Con il risultato, tra le altre cose, di consentire l’isolamento degli Stati Uniti rispetto al mondo esterno. E ciò perché, pur non prevedendo esplicitamente un quid pro quo in cambio della non ingerenza europea negli affari americani, la suddetta dottrina dava per scontato il loro disinteresse per gli affari del Vecchio Continente, come si evince chiaramente dalle parole pronunciate da Monroe, nello stesso discorso: «Non abbiamo mai preso parte, né la nostra politica lo prevede, alle guerre delle potenze europee per questioni di loro esclusivo interesse». La storia, tuttavia, non finisce qui: All’inizio, metà del territorio compreso nei confini conosciuti era disabitata e incolta. Da allora, sono stati conquistati nuovi territori, vasti e percorsi da numerosi fiumi, primo tra tutti il Mississippi, la cui navigazione fino all’oceano era della massima importanza per gli Stati originari. In tutto questo spazio, la popolazione è andata sviluppandosi in ogni direzione, rendendo possibile la nascita di un numero di nuovi Stati più o meno uguale a quelli che costituivano il primo nucleo della nostra Unione. Lo sviluppo della popolazione e l’annessione di nuovi Stati hanno sortito il più felice degli effetti per quelli che sono i nostri massimi interessi. Che ciò abbia notevolmente aumentato le nostre risorse e accresciuto la nostra forza e la nostra rispettabilità in quanto potenza è generalmente riconosciuto, ma non è solo in queste sfere, sia pure im-
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 64
64 portanti, che l’effetto benefico si è fatto sentire. È palese, infatti, che, grazie all’allargamento della base del nostro sistema e all’aumento del numero degli stati, i due rami del sistema stesso si sono grandemente rafforzati4.
La promessa di Jefferson, secondo il quale la grandezza avrebbe garantito la felicità, rimase ancor viva. E la dottrina Monroe non faceva che mettere insieme, d’un sol colpo, le virtù anelate dell’isolazionismo e dell’espansionismo. Com’era già accaduto con Washington, anche l’approccio di Adams fu spesso, ed erroneamente, interpretato come una forma di isolazionismo di principio. E, a conferma, si cita una sua famosa dichiarazione secondo la quale l’America «non va all’estero in cerca di mostri da distruggere. Essa si augura libertà e indipendenza per tutti. L’America è il paladino e il vendicatore di se stessa»5. E, tuttavia, ecco quanto osservava nel 1826, anticipando in qualche modo il futuro, a proposito del Discorso di commiato di Washington: Non posso sorvolare sul fatto che il monito di Washington, in quel caso, come tutti i moniti dettati dalla saggezza, si fondava sulle circostanze in cui il nostro paese e il mondo intorno a noi si trovavano nel momento in cui fu pronunciato… [ma] se paragonassimo la nostra situazione e le circostanze di quel tempo con quelle attuali, quali sarebbero, volendo attingere alle parole di allora, i suoi moniti per i concittadini di oggi?
Le lezioni della frontiera L’attuale politica estera americana è un riflesso – forse una distorsione – dell’esperienza americana e della sua lezione: la necessità di espandere il territorio e, quindi, di far arretrare il confine tra civiltà e caos, il cui limite definisce la sicurezza dello Stato. Di qui, il crescente espansionismo degli Stati Uniti come mezzo per garantirsi anche contro la possibilità di una minaccia da parte di un territorio esterno. Ma è lecito chiedersi: dove finisce tutto questo? Come determinare la sicurezza – questione squisitamente soggettiva – e quali misure sono da considerare necessarie per garantirla? Pochi sono i paesi che hanno dimostrato la flessibilità degli Stati Uniti nell’individuare quel confine (con l’ovvia eccezione della Russia),
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 65
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
65
in gran parte delimitato da altre potenze. Obbligati a prendere atto delle circostanze politiche che concorrevano a determinare la loro posizione, a riconoscere gli opposti interessi di altri Stati e a reagire di conseguenza. Le terre incolte (sulle quali erano insediate le tribù indigene più ostili) non erano, tuttavia, un’entità dotata di rilevanza politica, ma esistevano principalmente come un fatto di natura; uno spazio privo di legge che doveva essere bonificato come l’agricoltore bonifica la palude che infesta il suo terreno. La distinzione tra insediamenti e frontiera, città e regioni incolte, è stata un’idée fixe per ampie fasce della società americana nel corso della sua storia. «A distanza di un secolo o poco più, l’organizzazione globale che cominciava ad apparire possibile e necessaria assumeva agli occhi di molti americani non già l’aspetto di un equilibrio di potere tra Stati, bensì di una legge e di un ordine volti a punire i disturbatori; tutela che doveva essere garantita da uno sceriffo e dal suo posse comitatus»6. La debolezza del governo centrale auspicata dai federalisti, si traduceva nell’enorme flessibilità con cui il giovane paese definiva i propri interessi sul continente. La capacità di fare politica – soprattutto quella che all’epoca era la politica estera – da parte di elementi geograficamente periferici consentì agli Stati Uniti di assicurarsi vantaggi che, se concepiti come parte di una grande strategia, sarebbero stati ingiustificabili. A cimentarsi sul terreno della geopolitica erano i soggetti più diversi (generalmente i pionieri), i quali scindevano i propri interessi da quelli dello Stato, anche se questo di fatto beneficiava regolarmente delle loro imprese. Come osserva sir Michael Howard, buona parte dell’idealismo illuminista della giovane repubblica era sostanzialmente confinato nelle regione di Nord est. «Più a ovest e a sud, l’esperienza dei pionieri, la difesa della frontiera e l’estensione territoriale stavano producendo una cultura di guerra che nulla aveva da spartire con il passato feudale e aristocratico e presentava viceversa tutti gli aspetti violenti di una società di frontiera»7. «Jacksoniani» sarebbero stati definiti i rappresentanti di questa cultura da alcuni storici americani che si ispirarono al settimo presidente degli Stati Uniti. Contrapposto [alla tradizione dell’élite] si rileva un elemento populista che percorre tutta la storia americana dall’epoca del Grande risveglio evangelico, guidato da Jonathan Edwards contro le mollezze del diciottesimo secolo, e della rivolta popolare capeggiata da Andrew
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 66
66 Jackson contro John Quincy Adams. Di fatto, la contrapposizione tra populisti e classe dirigente riveste nella politica americana un’importanza più radicale di quella tra sinistra e destra o tra liberali e conservatori8.
Se questo è un giudizio che può apparire esagerato, resta tuttavia innegabile che la tradizione populista americana – «jacksoniana», dal nome del presidente Andrew Jackson – è una delle variabili uniche che concorrono a determinare le scelte di politica estera. Ma, nonostante il suo peso sull’esito politico, essa non riscuote grande considerazione a causa dell’inesistenza di scuole di pensiero a essa collegate e della partecipazione minima all’effettiva formulazione della politica; in altre parole, essa è destinata a essere esclusa per sempre dal Palazzo. Ma, se è vero che accademici e osservatori stranieri tendono ad accantonarla, è vero il contrario per quanto riguarda i leader politici americani. La sua influenza sulle scelte di politica estera è tale che chi non riesce a coglierla è portato a giudicare le scelte in questione deludenti e ottuse. Sono gli osservatori stranieri, in particolare, che, non riuscendo ad afferrarne le caratteristiche, sopravvalutano o, a seconda dei casi, sottovalutano la determinazione americana… Chiunque voglia anticipare il corso della politica americana non può prescindere dalla comprensione dei principi e dei valori della tradizione jacksoniana9.
A rendere unica l’America, infatti, non è la sua tradizione populista, ben radicata e a volte persino bellicosa, ma il ruolo che questa ha avuto nel dar vita alla nazione. Etimologia a parte, sono stati quelli che si sono richiamati a lui, più dello stesso presidente Jackson, a condizionare fortemente la politica estera americana. «Quanti si compiacciono di vedere nella politica estera americana un misto deprecabile di ignoranza, di isolazionismo e di diplomazia aggressiva si riferiscono in genere alla tradizione populista jacksoniana.»10 Ecco ciò che afferma Walter Russell Mead, per il quale questa tradizione assurge a livello di scuola di politica estera: Lenta a mettere a fuoco una questione particolare di politica estera, e ancor più ad assumere l’impegno di perseguire un obiettivo con determinazione e per un lungo periodo di tempo, l’opinione jacksoniana, una volta maturata la decisione, accetta con difficoltà anche maggiore
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 67
67
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
la prospettiva di una inversione di rotta. Soprattutto quando si tratti di soprassedere ai suoi principi cardine e di mettere da parte l’intransigenza per far posto a una linea di moderazione. Per tacere della difficoltà di ottenerne l’appoggio a una politica che rifugge dalle semplificazioni eccessive a favore della complessità. Difficilissimo, per esempio, una volta espressa la propria posizione in merito alla guerra in Vietnam piuttosto che a quella del Golfo, che i suoi esponenti tornassero a farsi sentire in assenza di una vittoria totale. Così com’è molto difficile, una volta individuate la Cina o il Vietnam come nazioni nemiche, costruire un consenso sulla normalizzazione delle relazioni o, peggio ancora, sull’allargamento degli aiuti11.
Un populismo che frappone grossi ostacoli a una politica estera coerente ed efficace, con esiti talora disastrosi, ma che – e questo è il paradosso – funge al contempo da elemento di moderazione della politica americana, contrastando, da un lato, la grande strategia, e, dall’altro, impedendo d’imboccare la via dell’impero e del governo internazionale. Gli americani che appartengono alla classe media, tra i quali questa tradizione raccoglie consensi, sono scarsamente interessati ai grandi progetti e all’esistenza di avamposti USA all’estero. La loro occasionale belligeranza, che li porta talvolta a ingigantire le imprese (si veda la guerra con il Messico), rifiuta, infatti, qualsiasi istituzionalizzazione, che, oltre a distogliere l’attenzione dagli affari interni, comporterebbe il rischio di una graduale erosione della loro sovranità, che hanno cara più di ogni altra cosa. A rendere unica la politica estera americana è la diffidenza dell’anima populista della società nei confronti della classe dirigente che la rappresenta, che non si traduce tuttavia nell’aspirazione a riappropriasi delle funzioni delegate. Questa stessa diffidenza nei confronti del potere – una versione più militante delle idee sposate da Jefferson e da Paine, ampliate e divulgate dalla coscienza popolare – è , infatti, in contrasto con l’ambizione politica. E, tuttavia, il rifiuto di fare politica non esclude la necessità di ottenere il consenso populista quando si tratta di rendere plausibile la minaccia di ricorrere alla forza. Ma, ciò che forse più importa, è il perdurare di queste caratteristiche anche nel secolo successivo, nonostante l’avvento dell’idealismo progressista. Il che probabilmente aiuta a capire perché la stessa nazione, che aveva sposato i «quattordici punti» proposti da Wilson e le «quattro libertà» propugnate da Roosevelt, avrebbe in seguito contrastato l’incursione di Ludendorff al Bois de Belleau e partecipato al
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 68
68
micidiale bombardamento di Tokyo e di Dresda. Uno spirito marziale, il suo, che avrebbe continuato (e continua) a coesistere con l’idealismo che informa la visione americana più ampia. E che funge da anello di congiunzione tra le lezioni di Washington e le esperienze di Adams e il modo in cui il potere americano andava configurandosi sul terreno – fra teoria e realtà. È importante, altresì, prendere atto di una situazione geografica che, oltre a consentire all’America un espansionismo relativamente incontrastato, costituiva il presupposto della sua evoluzione a grande potenza. Anche se colpisce il fatto che questo dato innegabile abbia influito così poco sulla percezione che l’America ha avuto di se stessa dopo avere raggiunto lo status suddetto. La sua nozione di grandezza, infatti, ha sempre ruotato intorno a un fondamento etico che ne giustifica la buona fortuna, nozione che alcuni fanno risalire alla giustezza delle sue istituzioni e alla saggezza dei fondatori, confermando la scarsa propensione degli americani a rendere merito alla geografia per il ruolo che attualmente svolgono negli affari mondiali. A differenza di quanto accadeva in Europa, raramente, a quell’epoca, la geografia veniva collegata alla politica; il controllo del territorio era in gran parte incontestato o lo era solo debolmente da nazioni molto distanti e prive di interessi primari nella regione. I nativi che popolavano il continente erano relativamente pochi e, in ogni caso, rappresentavano una minaccia militare trascurabile e non erano considerati un’entità politica autosufficiente. Diversamente dagli europei, in altre parole, gli americani non avevano mai visto nella geopolitica la combinazione tra geografia e sicurezza nazionale. Se la geografia non è un fattore irrilevante, diversa è la sua percezione a livello elementare. Per gli Stati Uniti non esistono concetti fondamentali come il bisogno della Gran Bretagna di preservare l’integrità territoriale dei Paesi Bassi o l’aspirazione della Francia a far sì che la Germania sia debole e disunita. La dottrina Monroe, che più di altri principi si sarebbe avvicinata a questi assiomi, può essere vista come una reazione a una situazione geopolitica specifica, ma rappresenta anche il tentativo di creare una condizione, diversa da quella esistente entro i confini degli stessi Stati Uniti, che in qualche modo consentisse di garantire la sicurezza e d’interrompere movimenti geopolitici pericolosi. Nello spazio continentale americano non esisteva una società riconosciuta preesistente all’insediamento degli stessi americani. Ciò
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 69
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
69
vuol dire che le città non furono conquistate, ma costruite. Basta, del resto, prendere atto della differenza tra le città americane e quelle del resto del mondo. Le prime, diversamente da quelle che sorgono in altri continenti, non sono costruite a scopo di difesa: sono i terreni più accessibili quelli prescelti per la loro ubicazione, non le montagne o le colline. Il commercio, e non la guerra, è l’obiettivo di fondo. I fattori geografici favoriscono gli scambi – e i problemi di difesa sono secondari. La sicurezza è un fatto scontato. St. Louis ha poco da temere da Kansas City. Alla fine del XIX secolo, stabiliti i confini continentali, il resto del mondo era ormai tracciato. L’America non aveva mai combattuto una guerra importante fuori del suo territorio. Al massimo, i suoi soldati si erano spinti a Città del Messico. E la sua breve tentazione imperiale fu di per se stessa una deviazione dalla norma12. La geografia, insomma – quanto meno quella degli altri paesi – non aveva mai svolto un ruolo importante nell’esperienza americana. L’America era una nazione con un impero incorporato ovvero un impero incorporato in una nazione. Ciò che gli inglesi e le potenze occidentali avevano dovuto cercare spingendosi «a est di Suez», i loro contemporanei americani, nell’impresa di colonizzare la regione, avrebbero potuto trovarlo a ovest del Missouri. Come osserva Kissinger, i primi uomini politici americani consideravano l’espansione territoriale nel continente un affare interno e non una questione di politica estera13. Era una realtà storica particolare a richiedere che Stati-nazione consolidati avessero relazioni di politica estera. Nel caso degli Stati Uniti, fare politica estera significava intrattenere rapporti diplomatici (relativamente limitati) con le potenze europee, in particolare con la Francia, la Gran Bretagna e la Spagna, e, occasionalmente, con i loro rappresentanti in Canada e nella regione meridionale del Nordamerica. I rapporti diplomatici con le grandi potenze investivano le questioni geografiche solo con riferimento alla periferia. In casi come il contrasto con la Gran Bretagna sul Territorio di Nord Ovest, non erano le questioni di sicurezza nazionale a preoccupare le parti, per le quali l’interesse a risolvere la situazione non rivestiva certo un carattere prioritario. E questo perché, anche agli albori della nuova repubblica, quando la situazione era oltremodo precaria, nessuna minaccia esistenziale legata a una posizione territoriale specifica aveva mai gravato sugli Stati Uniti. Anche l’incendio di Washington, all’epoca della guerra con la Gran Bretagna nel 1812, fu più umi-
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 70
70
liante che realmente pericoloso – a conferma che gli inglesi non miravano a distruggere o a ricolonizzare gli Stati Uniti, ma solo a impartire una lezione a chi aveva dichiarato guerra a una potenza egemone globale. Altre nazioni, o quanto meno i loro leader, non ignoravano che una politica estera diversa – sia pure accorta – da parte di paesi terzi avrebbe potuto interferire con le loro fortune, magari in modo disastroso. Un diverso controllo della geografia, nuove alleanze politiche, affiliazioni religiose, tutto contribuiva alla grande precarietà di un sistema in cui il tornaconto personale imponeva di studiare con attenzione altri paesi e altri popoli. Non così negli Stati Uniti, la cui popolazione si considerava immune da questi cambiamenti. Anche l’arruolamento forzato dei marinai o il sequestro delle navi, che li coinvolsero marginalmente nelle guerre napoleoniche, non furono considerati episodi di una guerra più vasta, ma azioni perpetrate specificatamente ai loro danni. Quello che per gli europei era un «grande gioco», agli occhi degli americani era una «grande distrazione». «In breve, la politica estera degli Stati Uniti consisteva nel non avere una politica estera»14. Questo sintomo si sarebbe manifestato in forma attenuata durante e dopo la Guerra Fredda, quando i ruoli si erano invertiti, con l’America nella veste di potenza la cui politica estera ad ampio raggio avrebbe sortito effetti imprevisti sul destino di paesi più piccoli, anche nel Sudest asiatico e in America Latina. L’America disdegna la nozione di equilibrio di potere perché, secondo il pensiero di alcuni, non ha una visione sofisticata della geopolitica o perché persegue un moralismo fuorviante. Ma secondo un’altra interpretazione, più radicale, gli Stati Uniti respingono questo approccio perché lo considerano un segno di debolezza. In un emisfero in cui a spartirsi il controllo, in origine, erano le varie potenze europee, e che in buona parte non era ancora stato rivendicato, non c’era alcuna garanzia che il sistema internazionale europeo non si sarebbe riprodotto nel nuovo continente, dando luogo a una contesa infinita per il riconoscimento dei propri diritti. In tal modo, una parte del Midwest avrebbe corso il rischio di diventare un’altra Alsazia-Lorena, un altro Golfo del Messico o i nuovi Dardanelli. Come osserva Kissinger, «dal momento che l’America non doveva confrontarsi con nessuna potenza, era poco probabile che en-
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 71
71
trasse nell’ottica dell’equilibrio delle forze, neppure se i suoi dirigenti avessero avuto la bizzarra idea di riprodurre le condizioni europee in una popolazione che aveva voltato le spalle all’Europa»15. Solo col senno del poi il dominio continentale da parte di un’unica potenza appare inevitabile, auspice la teoria del «destino manifesto». Nel XIX secolo, viceversa, generazioni di americani consideravano l’equilibrio di potere del tutto incompatibile con i loro interessi, per tacere della grandezza americana. Frutto di un mancato controllo del continente, esso avrebbe comportato la cessione di varie regioni ad altre potenze. Data una opportunità che non si era mai presentata alle nazioni europee, per quale motivo gli americani avrebbero dovuto aspirare a ripetere di propria spontanea volontà una storia infelice?
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
La scelta si poneva, da un lato, tra la convivenza con «un numero infinito di clan e tribù, di nessuna importanza, in guerra perenne tra loro per il possesso di una roccia o di uno stagno, in ossequio al mito congeniale ai padroni e oppressori europei» e, la nascita, dall’altro, di una nazione, che comprendesse tutto il continente nordamericano, destinata da Dio e dalla natura a diventare il paese più popoloso e potente mai nato all’insegna di un’unica compagine sociale16.
Come dire che l’esistenza stessa di un sistema di equilibrio di potere presuppone una certa dose di debolezza da parte degli Stati che lo adottano: nel caso del Nordamerica, sarebbe stato il risultato di un dominio incompleto e della cessione di varie regioni ad altre potenze (presumibilmente europee). Ma perché, in presenza di una opportunità mai data agli europei, gli americani avrebbero dovuto desiderare di ripetere una storia infelice? Per quanto cruda, questa interpretazione getta luce sulla realtà degli equilibri di potere in Europa e sull’aspirazione dell’America a sfuggirne i limiti e a consolidare la sua posizione sfruttando le opportunità senza precedenti offerte da una «situazione di lontananza». Se poi il tutto suona poco convincente, alla luce dell’idealismo che di solito pervade la rivisitazione dell’avventura americana, si deve in parte al fatto che tale aspirazione andava di pari passo con il grande ottimismo che, all’epoca, induceva a credere che l’America potesse raccogliere i frutti dell’espansionismo, assicurandosi una esistenza tranquilla come non mai. Se il potere era l’ovvia ricompensa dell’allargamento dei confini, la libertà era però quella più ambita. Quest’epoca era, per molti versi, la logica conseguenza della «ricerca
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 72
72
della felicità» di Jefferson, anche se quanti si sarebbero lasciati coinvolgere dalla sua visione non ne condividevano certo gli aspetti aristocratici. Di questi, infatti, non c’è traccia nella politica estera americana del XIX secolo che, pure, può essere considerata la versione continentale di quella visione. Dopotutto, non furono i plutocrati delle città, ma gli agricoltori, alla ricerca di nuove terre da coltivare e di sostentamento, a dare impulso allo sviluppo della nazione, il più delle volte seguiti dal governo federale. La stessa teoria del «destino manifesto» non era un modo di razionalizzare il tentativo di acquisire nuove terre, ma una sua spiegazione a posteriori, a beneficio dei discendenti e non dei pionieri (o dei militari) protagonisti di quelle imprese. Una vernice di ineluttabilità applicata all’intera vicenda, per fare dell’espansione la cosa più naturale del mondo, che nulla aveva a che vedere con le fatiche legate alla creazione di un impero. E il tutto non tanto a tutela della coscienza nazionale ma di una visione del mondo, della convinzione che l’esperienza americana è davvero benedetta. Nati su un continente nuovo, con nuove istituzioni politiche, gli Stati Uniti potevano sperare di essere immuni dalle prove terribili con cui altre nazioni dovevano fare i conti. La loro storia può, quindi, essere considerata come quella di un’ascesa senza ostacoli. Qui, però corre l’obbligo di aggiungere che, in confronto alla maggioranza se non alla totalità degli altri paesi, l’America è stata baciata da una fortuna straordinaria e protetta dalle vicissitudini che normalmente assediano gli altri paesi. «I timori legati alla sicurezza hanno frenato l’ottimismo degli altri paesi… mentre in America la relativa assenza di questi timori nel passato ha contribuito, insieme ad altri fattori, a fare dell’ottimismo una filosofia nazionale»17. La genialità della visione di Jefferson sta in una capacità di metamorfosi praticamente illimitata, in virtù della quale una repubblica appena nata si scopre una vocazione universale e la conquista di nuovi territori si traduce in libertà. Non è un caso che la prima grande espansione del territorio americano abbia avuto luogo sotto i suoi auspici. Quando, nel 1800, la Spagna cedette alla Francia la Lousiana, il presidente Jefferson, allarmato, si trovò costretto a considerare sotto una luce diversa il legame tra scambi commerciali e politica estera. Le libertà politiche di cui godevano i suoi concittadini dipendevano infatti dalle libertà economiche e il porto di New Orleans, ormai sotto
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 73
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
73
il controllo francese, era una linea di comunicazione d’importanza vitale verso il mondo esterno. Per scongiurare il rischio di complicazioni di ordine geopolitico – soprattutto con la Gran Bretagna, nemica di un tempo – e per battere la Francia sull’anticipo, Jefferson inviò James Monroe a Parigi con l’incarico di negoziare la vendita di New Orleans. E il 30 aprile 1803 fu siglato un trattato con il quale la Francia accettava di vendere agli Stati Uniti per soli 15 milioni di dollari non solo quella città, ma tutto il territorio della Louisiana (che corrispondeva più o meno all’attuale Midwest). E la convinzione di Napoleone di aver contribuito alla nascita di un potere in grado di contrastare la posizione della Gran Bretagna, cioè dell’odiato nemico, nel Nuovo Mondo, si tradusse per Jefferson, vale a dire per l’idealista visionario, nella possibilità di trarre vantaggio dal deprecato sistema di equilibrio di potere vigente sull’altra sponda dell’oceano. Come Alexander Hamilton aveva predetto, «noi possiamo sperare di diventare in breve tempo l’arbitro dell’Europa in America e di poter piegare ai nostri interessi l’equilibrio fra le potenze europee presenti in questa parte del mondo»18. A questo punto, è giusto sottolineare come, in questo periodo, gli Stati Uniti avessero ripristinato il ricorso a una diplomazia tipica dell’ancien régime, basata essenzialmente sull’estensione del proprio territorio. Una diplomazia che, in parole povere, mirava a creare un impero. «Gli imperi non hanno interesse ad operare all’interno di un sistema internazionale, ma aspirano ad essere il sistema internazionale. Gli imperi non hanno bisogno di un equilibrio di potere. Questa è la politica estera condotta dagli Stati Uniti nelle Americhe…»19. Anche se gli Stati Uniti non hanno mai aspirato a instaurare il proprio dominio su altri paesi, sull’esempio degli inglesi, ciò non toglie che quella che si sarebbe detta la loro politica interna possa essere stata più estera di quanto essi stessi sarebbero stati disposti ad ammettere. «Due, in realtà, sono le versioni della storia del potere americano negli affari internazionali…: c’è quella americana che racconta di una repubblica democratica e di una ininterrotta diffusione dei suoi valori universali; e quella europea, che narra di un impero americano e della costante diffusione delle sue mire imperiali»20.
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 74
74 Secondo la versione europea, le annessioni territoriali realizzate dagli Stati Uniti nel XIX secolo (soprattutto l’acquisto della Louisiana e le annessioni successive alla guerra con il Messico) richiamavano alla mente quella della Prussia nel XVIII secolo (specie in Polonia) e della Russia nel corso dei secoli (ancora in Polonia, ma anche nel Caucaso, nell’Asia centrale e in Siberia). In questa ottica, tra l’«avanzamento ad ovest» degli Stati Uniti e la «spinta ad est» della Germania c’è solo una differenza di direzione (tedeschi e russi hanno anche aggiunto che, se loro hanno sfruttato i popoli conquistati, gli americani li hanno in gran parte sterminati)21.
Non resta che concludere che, nonostante il rifiuto formale delle nozioni di equilibrio di potere e di impero, la politica estera degli Stati Uniti si è spesso barcamenata tra le due, a seconda delle circostanze. Una tendenza che la conquista militare più importante realizzata nel continente conferma al di là di ogni dubbio. Dopo aver ottenuto l’indipendenza dalla Spagna nel 1821, il Messico si trovò a possedere buona parte dei territori occidentali del Nordamerica, inclusi Texas e California, e quella che attualmente è la fascia sudoccidentale degli Stati Uniti. Ma si trovò anche a intralciare l’avanzata dei pionieri che obbedivano ai precetti di quello che in seguito sarebbe stato definito il «destino manifesto». Una teoria, questa, il cui nome si deve a John L. Sullivan, direttore di un quotidiano di New York nel 1845, che definiva formalmente la motivazione inconsapevole degli americani a realizzare la propria libertà con la conquista del continente: la nozione del diritto, in quanto individui, di rivendicare e occupare tutte le terre che erano in grado di conquistare. Il governo messicano consentì ai pionieri di insediarsi nell’area scarsamente popolata a est del Texas. Ma questi premevano per ottenere una rappresentanza politica che, di fatto, avrebbe dovuto garantire i diritti previsti dalle loro istituzioni. L’acuirsi delle tensioni tra pionieri e governo messicano culminò nella presa di potere del generale Santa Anna, che pose fine alle speranze di uno Stato texano autonomo. Il 2 marzo 1836, il Texas dichiarò tuttavia la propria indipendenza scatenando la rappresaglia militare del governo messicano. Le forze texane reagirono e ottennero l’indipendenza grazie al generale Sam Houston, che fu nominato presidente della nuova repubblica. Fu il presidente James K. Polk, ispirandosi alla filosofia di John Quincy Adams, a rendersi contro che la dottrina Monroe non si
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 75
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
75
sarebbe imposta da sé. Anzi, c’è da chiedersi come mai le nazioni europee non siano ricorse a metodi più persuasivi per sfruttare la posizione ancora relativamente incerta degli Stati Uniti nel continente. Comunque sia, questi svilupparono la consapevolezza che i territori disabitati non aspettavano che di essere occupati e che quelli in cui gli insediamenti erano ormai una realtà vivevano nel costante pericolo di essere venduti al miglior offerente tra le potenze esterne che avevano potenziali interessi nel continente. Tant’è che, durante i nove anni intercorsi prima dell’annessione dello stato del Texas all’Unione, sia la Gran Bretagna sia la Francia si dimostrarono disponibili alle richieste di annessione e di protezione avanzate da Houston. Per giustificarne l’annessione, Polk invocò la necessità d’impedire che il Texas diventasse «un alleato o un protettorato di qualche nazione straniera più potente»22. Attuate per la prima volta da Polk, le implicazioni più aggressive della dottrina di Monroe saranno il pretesto per puntare al controllo dell’emisfero, controllo che sarebbe stato raggiunto nel secolo successivo. I texani, che controllavano la regione orientale del Texas fino al fiume Nueces, ambivano ad avanzare fino al Rio Grande, cioè fino ai confini attuali di quello Stato. E il piccolo esercito inviato dagli Stati Uniti, al comando del generale (futuro presidente) Zachary Taylor, nel territorio conteso suscitò le proteste del Messico. Una breve scaramuccia tra soldati messicani e americani lungo il Rio Grande fornì il casus belli per l’inevitabile. Le forze americane vinsero il Messico con facilità e imposero un nuovo governo con cui sottoscrissero il trattato di Guadalupe Hidalgo (1848) che cedeva agli Stati Uniti la California, il Nuovo Messico e il Texas propriamente detto, spogliando il paese di quasi metà del suo territorio. Adesso gli Stati Uniti erano una potenza continentale delimitata da due oceani e calata in un nuovo contesto che li avrebbe costretti a fare politica estera. Potrebbe tuttavia essere utile prendere atto di una certa visione di principio che informava le scelte operate dagli americani nel corso della metà del XIX secolo. E non per difenderne l’operato, ma per cercare di spiegare ciò che altrimenti apparirebbe un divario epocale incolmabile e bizzarro – anche in riferimento a una nazione notoriamente imprevedibile in materia di affari esteri. Un po’ come se Bismarck si fosse trovato invischiato tra l’idealismo illuminista degli inizi del XIX secolo e l’internazionalismo progressista del secolo successivo. Una visione secondo la quale l’annessione dei ter-
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 76
76
ritori di sudovest, lungi dall’essere una guerra di conquista, era di fatto un riconoscimento politico della realtà. Dopotutto, la sovranità legale del Messico sulla regione non si traduceva in un possesso effettivo del territorio. Se gli elementi essenziali del controllo statale sono sovranità, popolazione e territorio, la logica geopolitica prevede che ci si assicuri il primo controllando gli altri due. Il caso vuole che il principio dell’autodeterminazione, su cui furono fondati gli Stati Uniti e in nome del quale fu combattuta la guerra d’indipendenza, sia sostanzialmente sulla stessa linea. Il che non è da sottovalutare perché, anche volendo, sarebbe difficile imbattersi in una guerra con una motivazione geopolitica più esplicita: puntare a conquistare i territori a ovest per espandere i propri confini e stabilire la propria egemonia sul continente contro le eventuali interferenze di altre grandi potenze. Implicitamente, si era preso atto che i trattati e la dottrina Monroe non sarebbero bastati; che il territorio non controllato era esposto alla conquista di quanti fossero stati tanto audaci da provarci. Questa la logica applicata dagli Stati Uniti nei confronti del Messico. Il governo messicano, debole e corrotto, esercitava solo un’autorità teorica (anche se legale) sul territorio di quelli che sarebbero diventati gli Stati Uniti sudoccidentali, in buona parte colonizzato da cittadini americani che avevano dato vita a comunità autonome in California, nel Nuovo Messico e altrove. Se a ciò si aggiunge che l’intenzione non era quella di conquistare il Messico propriamente detto, si capisce come la guerra non venisse equiparata alle imprese imperiali delle potenze europee. La sovranità – ingrediente indispensabile della democrazia – tra l’altro non si fonda unicamente su principi astratti, ma su realtà politiche all’interno di uno spazio determinato. Erano stati gli americani a insediarsi e a creare comunità nel Texas e in altri territori di sudovest, così come erano stati gli americani, e non il Commonwealth britannico, a risiedere nelle colonie originali. Mentre sarebbe irrealistico attribuire motivazioni geopolitiche alla fondazione stessa degli Stati Uniti, i principi esposti in quell’occasione si rivelarono nondimeno congeniali agli interessi americani, in questa come in altre vicende della loro storia. Questo approccio può forse contribuire a spiegare il tragico destino degli indiani d’America. Questi non erano organizzati in comunità politiche, così come le concepivano gli americani, per i quali la società si fondava sulla proprietà di beni, ovvero su una nozione
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 77
77
che assumeva un significato del tutto diverso, ammesso che lo avesse, per tribù seminomadi che costituivano entità separate sulla base di calcoli squisitamente soggettivi. Che la terra sia stata tolta agli indiani è una realtà incontestabile, ma per gli americani si trattava di una terra disabitata, mentre per gli indiani la terra non era loro per il semplice fatto che non pensavano alla terra come a qualcosa che si potesse «possedere». Si capisce allora perché le relazioni stabilite per mezzo di guerre o di trattati non venissero considerate un esercizio di politica estera. I trattati, in genere, equivalevano a vendite di territori, il cui significato gli indiani spesso non riuscivano a cogliere, mentre la serie di guerre contro le diverse tribù non furono di fatto che scaramucce, paragonate alle guerre tra le nazioni di cui gli americani erano a conoscenza. Negli altri paesi, la convergenza di popolazioni stanziali con comunità politiche costituite e lo spazio geografico avevano configurato uno status qualitativamente diverso da quello del territorio continentale nordamericano.
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
La casa divisa La vittoria e le annessioni che l’accompagnarono avrebbero finito con l’acuire le tensioni tra Stati «liberi» e Stati schiavisti. Una politica di espansionismo esige infatti che i suoi aderenti adottino un ethos progressista; non a caso furono gli ateniesi progressisti, e non gli spartani conservatori, a creare un impero. Fin dalla nascita degli Stati Uniti, il Sud aveva difeso il mantenimento della schiavitù, appellandosi alla tradizione e alle necessità di un’economia basata sulla coltura del cotone. Ma, nel tentativo di estendere il regime schiavista ai territori di nuova acquisizione, il Sud fu costretto a esplicitare la volontà di restare fedele al passato. E il paese, che continuava a espandersi, fu obbligato a interrogarsi sulla sua identità. In risposta all’elezione di Abraham Lincoln alla Casa Bianca, un repubblicano fermamente contrario a estendere la schiavitù nei nuovi stati, quelli del Sud si distaccarono dall’Unione e il 7 febbraio 1861 crearono la Confederazione degli Stati d’America23. Sulla crisi morale innescata dal problema della schiavitù – ancorché inevitabile – ebbe un peso determinante la questione concreta del territorio. Il Sud, infatti, era favorevole a mantenere un equilibrio tra stati «liberi» e schiavisti nel territorio di recente an-
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 78
78
nessione, in modo da garantirsi un’espansione a ovest che andasse di pari passo con quella del Nord. I nordisti, da parte loro, erano giunti alla determinazione che, nell’impossibilità di schierarsi a favore dell’abolizione della schiavitù (anche se molti lo stavano facendo), erano quanto meno obbligati a impedirne la diffusione. Questa era la posizione di partenza di Abraham Lincoln, il cui pragmatismo e la cui tempra morale erano indissolubilmente legati. I sudisti si resero conto del rischio di essere ridotti a una condizione subalterna rispetto al resto del paese, nella misura in cui altri Stati liberi sarebbero entrati a far parte dell’Unione. Ma se i dibattiti in materia avrebbero potuto (come di fatto furono per oltre mezzo secolo) essere attribuiti ad astrazioni sull’interpretazione della costituzione, fu l’imprescindibile aspetto geopolitico a garantire che l’abolizione della schiavitù non sarebbe stata graduale, ma improvvisa e rovinosa. Ed ecco svelarsi a chiare lettere il senso del monito di Washington: che una Unione che poteva dissolversi a proprio piacimento non era di fatto una Unione. Lincoln, il suo erede più illustre, lo aveva capito e si accinse all’impresa dolorosa che avrebbe portato ad abolire del tutto la schiavitù con il preciso obiettivo di salvare l’Unione. Egli non visse abbastanza per vedere coronati i suoi sforzi che, oltre a salvare il paese e ad abolire la schiavitù, posero le basi di una nazione unita, in grado per la prima volta nella sua esistenza di portare avanti una politica estera autenticamente nazionale.
NOTE 1 Gaddis, Surprise, Security, and the American Experience, è la fonte più attendibile per un’analisi approfondita della statura di stratega di John Quincy Adams. 2 John Quincy Adams a George W. Ering, 28 novembre 1818, citato in Gaddis, op.cit., p. 17. 3 Messaggio del presidente Monroe al Congresso, 2 dicembre 1823. 4 Ibid. 5 John Quincy Adams, discorso del 4 luglio 1821. 6 Howard M., The Invention of Peace, Yale University Press, 2000, p. 29. 7 Ibid. p. 28. 8 Isaacson W., Thomas E., The Wise Men: Six Friends and the World They Made, Simon & Schuster, New York, 1986, p. 28. 9 Mead W.R., «The Jacksonian Tradition and American Foreign Policy», The National Interest, inverno 1999.
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 79
79 10
Ibid. Ibid. 12 Questo non per negare o giustificare quelle che, in realtà, furono avventure imperiali nel Pacifico, ma per sottolineare che esse non alterarono in modo significativo il carattere del regime o il suo approccio di lungo periodo agli affari esteri. Anzi, le conseguenze storiche sugli stessi americani furono così modeste da apparire inesistenti. Molti americani ignorano che fino alla seconda guerra mondiale avevamo protettorati nelle Filippine. A oggi, gli spagnoli sono di gran lunga più consapevoli della loro esperienza imperiale, buona parte della quale risale a centinaia di anni fa. 13 Kissinger, op. cit., p. 31. 14 Ibid., p. 36. 15 Ibid., p. 20. 16 John Quincy Adams ad Abigail Adams, 30 giugno 1811, citato in Gaddis J.L., op. cit. 17 Woodward C.V., «The Age of Reinterpretation», American Historical Review, 66, ottobre 1960, pp. 2, 6. 18 Hamilton A., «The Federalist n. 11: The Utility of the Union in Respect to Commercial Relations and a Navy», The Federalist Papers. 19 Ibid., p. 21. 20 Kurth J., «The Adolescent Empire: America and the Imperial Idea», The National Interest, estate 1997. 21 Ibid. 22 Discorso inaugurale del presidente James Polk, 4 marzo 1845. 23 Texas, Florida, Arkansas, Louisiana, Alabama, Georgia, South Carolina, North Carolina, Mississippi, Tennessee e Virginia.
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
11
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 80
CAPITOLO QUARTO
ORIZZONTI DI GLORIA
Il miraggio dell’impero Quello che ho sostenuto finora combacia per molti aspetti con quanto è stato scritto sulla storia americana. Gli Stati Uniti avrebbero dunque mostrato una forte coesione sotto l’egida di Washington. Evitarono le mire espansionistiche della geopolitica per concentrarsi esclusivamente sulle questioni del proprio continente (o di quello che sarebbe diventato il loro continente), fino a quando tutti gli orrori delle due guerre mondiali non approdarono sulle loro pacifiche spiagge. C’è una parte di verità in questa ricostruzione, non foss’altro perché riflette in larga misura l’autointerpretazione dell’America. Tuttavia essa è decisamente fuorviante se comparata ad altre interpretazioni storiche che tengono conto di fattori rilevanti anche se meno conosciuti. La verità è che gli Stati Uniti non furono mai letteralmente isolazionisti, alla stregua del Giappone dopo il XVI secolo. L’esistenza del mondo esterno non era negata a priori; piuttosto, per il destino dell’America, si tendeva a sottovalutarne l’importanza geopolitica. Per questo si puntò sul mantenimento dell’apertura dei canali diplomatici ed economici e, cosa più importante, all’invio di forze laddove fosse ritenuto necessario. Basti pensare alle numerose occasioni nelle quali, già a partire dal tardo Ottocento, gli Stati Uniti avviarono contatti diplomatici e spedirono truppe oltre frontiera. Come rileva Max Boots, prima della seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti effettuarono non meno di centottanta sbarchi di truppe all’estero1. «La storia degli Stati Uniti – leggiamo all’inizio dello Small War Manual dei marines – insegna che, malgrado il succedersi di diverse amministrazioni
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 81
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
81
con altrettante politiche estere, il governo federale è intervenuto negli affari interni di altri paesi con notevole regolarità [...]»2. Ciò nondimeno, la sconfitta della pirateria in una regione di vitale importanza commerciale come i Caraibi, l’esplorazione delle isole del Pacifico del sud, il soffocamento dei focolai rivoluzionari nei paesi dell’America centrale e meridionale – nei quali gli Stati Uniti stavano tentando di mantenere una presenza diplomatica ed economica – non rientravano all’interno di un articolato e coerente disegno e tutti questi eventi passarono quasi inosservati agli occhi della cittadinanza americana. Per la maggior parte, questi interventi ebbero una valenza strategica puramente ancillare, non collegabili a interessi economici particolari, ed ebbero un ruolo parziale nella formazione di una coscienza geopolitica o, cosa ancor più importante, di quella della nazione stessa. Gli Stati Uniti valutavano i loro interessi caso per caso, cercando di tutelarli ogni qualvolta temevano che fossero minacciati, senza tuttavia trarre conclusioni geopolitiche da queste situazioni. I valori ritenuti più alti per i propri cittadini, in primo luogo la libertà di commercio, di movimento e la sicurezza, venivano messi inevitabilmente a repentaglio nel confronto con altri popoli e nazioni all’interno di un dato spazio. Quando gli interessi e gli scopi di un gruppo sociale collidono o violano quelli di un altro si arriva prima o poi a un conflitto anche se non necessariamente di ordine militare. E il fatto che ciò sia in qualche misura ineluttabile, e l’armonia non tenda a prevalere nei rapporti fra i vari paesi, veniva compreso solo in modo intermittente dagli statisti americani di quel periodo. Senza con questo voler dire che fossero ingenui: dopotutto, che altro era la dottrina Monroe se non una lucida ricognizione degli interessi e delle esigenze di sicurezza dell’America in quel periodo? Ma gli sviluppi di questa dottrina, specie riguardo ai molti problemi di politica interna delle altre nazioni nell’emisfero occidentale, e alla loro rilevanza per gli Stati Uniti, sarebbero stati elaborati come parte integrante di una strategia politica generale – volta a far fronte e a scongiurare le minacce per gli Stati Uniti – soltanto un secolo dopo la sua formulazione originaria. per almeno un secolo dopo la sua formulazione. Da cui la natura essenzialmente reattiva di molti interventi sparsi in tutto l’emisfero nel corso del XIX secolo.
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 82
82
Un esempio significativo è la mancanza di presidi militari permanenti in quelle nazioni in cui essi avevano sedi diplomatiche e finanziarie. La connotazione chiaramente imperiale di tale politica impedì agli Stati Uniti di perseguirla per proteggere i propri interessi all’estero. E tuttavia essi furono sempre riluttanti a rimuovere completamente la loro presenza, mettendo a rischio i propri interessi nella regione. Ma l’ironia vuole che il desiderio di perseguirli senza giungere alla costruzione di un impero, ovvero di avere la botte piena e la moglie ubriaca, li spinse ad attuare una politica estera nel loro emisfero molto più attiva di quanto la loro potenza non avrebbe diversamente richiesto. Max Boot enumera le tappe essenziali di questa particolare escalation: La spedizione di Panama del 1885 segnò il culmine di un numero di sbarchi militari USA in America Latina, nel XIX secolo, quasi fin troppo numerosi da elencare. Marinai e marines sbarcarono in Argentina nel 1833, nel 1852 e nel 1890; in Perú nel 1835; in Nicaragua nel 1852, 1853, 1854, 1896 e 1899; in Uruguay nel 1855, 1858, 1868; in Messico nel 1870; in Cile nel 1891; a Panama – allora parte della Colombia – nel 1860, 1873, 1885, 1895. Questi sbarchi erano così frequenti perché le ambasciate e le delegazioni degli Stati Uniti non avevano presidi permanenti fino al XX secolo e qualsiasi problema si presentasse, nel secolo precedente, i marines erano pronti a salpare. La situazione era sempre la stessa: scoppiava da qualche parte una rivoluzione, seguita da atti di violenza; i mercanti e i diplomatici americani si sentivano minacciati; sbucavano allora all’orizzonte le navi da guerra degli Stati Uniti; le truppe da sbarco presidiavano le città per molti giorni e, una volta tornata la normalità, ripartivano3.
In effetti gli Stati Uniti adottavano all’estero lo stesso comportamento seguito nelle regioni non contese del loro continente, sempre pronti a intervenire per proteggere i coloni e le attività commerciali dagli indigeni ostili e a esplorare terre sconosciute. Se nessuna grande strategia era necessaria in patria, perché avrebbero dovuto allora perseguirne una al di fuori dei propri confini? Questa tendenza imperialista, nel vero senso del termine, non aveva bisogno di un consenso dell’opinione pubblica – e i cittadini di rado venivano a sapere qualcosa al riguardo – né di alcuna mobilitazione di massa e quindi di alcuna legittimazione. Un semplice esercito di professione poteva impiegare forze minime per compiere missioni
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 83
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
83
e ritirarsi una volta portate a termine. La controinsurrezione nelle Filippine fu il primo intervento a lungo termine intrapreso mettendone pienamente a conoscenza l’opinione pubblica e, nonostante il suo successo, rimase controverso, allora come in seguito. Da qui la fondamentale tensione, che è stata una costante nel corso della sua storia, fra l’America come grande potenza in ascesa, con interessi sempre più vasti, e la repubblica democratica le cui origini, ormai quasi mitiche, si fondavano sulla libertà individuale e mettevano un freno alle tendenze imperialiste. Negli anni dell’espansione continentale, gli interessi del paese corrisposero direttamente alla volontà collettiva dei singoli cittadini. Le terre che questi andavano conquistando per se stessi divenivano parte della nazione e, a volte, come nel caso della guerra con il Messico, con scarso aiuto da parte di quest’ ultima. Ma una volta esaurite le possibilità di espansione nei territori contigui, senza instaurare alcun dominio diretto su popolazioni straniere, i cittadini non avevano ormai più quasi alcun interesse a sostenere i disegni espansionistici della nazione. Se prima della Guerra Civile la politica di acquisizione di nuove terre – sostenuta da ferventi nazionalisti come Clay e Polk – trovava sostegno fra la popolazione, in seguito tutti gli sforzi degli aspiranti imperialisti, come William H. Seward, segretario di Stato durante la presidenza di Lincoln e Andrew Johnson, incontrarono forti ostacoli. Allo scopo di realizzare un impero nel Pacifico e di annettere il Canada, egli acquistò l’Alaska dalla Russia nel 1867: un atto che ebbe profonde conseguenze, ma venne deriso, all’epoca, come la «follia di Seward». Al di fuori dei marines, non c’era un corpo militare equivalente alle forze coloniali francesi o britanniche. Gli americani stessi, per la maggior parte, non accettavano di buon grado l’idea di stabilirsi all’estero sia pure come garanti e portabandiera per conto di un impero, specialmente in un momento in cui molti avevano appena fatto la loro fortuna in America. Ed è singolare il fatto che, mentre il carattere insulare della Gran Bretagna generò una particolare sensibilità per l’esotismo, il cosmopolitismo americano produsse l’effetto opposto. Che cos’era cambiato dunque? Le fiorenti, ancorché instabili, repubbliche che stavano sviluppandosi politicamente ed economicamente nell’emisfero, rafforzarono l’interesse delle potenze europee per questa regione, creando una complessa rete di rapporti che
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 84
84
esigeva un maggior controllo da parte dell’America. E, nel frattempo, la pace che regnava in Europa dalla fine delle guerre napoleoniche generò a sua volta un sistema commerciale internazionale più tranquillo che favorì l’intensificazione dei rapporti col nuovo mondo. Ma il dato più importante è che la potenza americana aveva raggiunto i suoi limiti all’interno del continente. Il cosiddetto «destino manifesto» aveva fatto il suo tempo. Con il lento esaurirsi degli effetti devastanti della Guerra Civile, l’America riprese di nuovo vigore. E, alla fine, due eventi quasi contemporanei contrassegnarono irrevocabilmente il nuovo corso della geopolitica americana. Il primo fu la guerra. L’ingresso dell’America nel club delle grandi potenze coincise con l’umiliazione inferta a uno dei membri più antichi: la Spagna. All’epoca, gli spagnoli attuavano una politica particolarmente spietata nelle loro colonie, specialmente a Cuba, che suscitò profonde reazioni negative da parte di influenti personaggi politici americani, molti dei quali invocarono un intervento armato per correggere questo indesiderabile stato di cose. Il 15 febbraio del 1898, nel corso di negoziati volti a ridurre le tensioni, la corazzata americana Maine, ancorata nel porto dell’Avana, esplose provocando la morte di 2 ufficiali e 258 marinai. Sebbene le cause del disastro fossero poco chiare, le trattative vennero immediatamente interrotte e gli Stati Uniti, pur consapevoli delle conseguenze, approvarono una risoluzione che riconosceva l’indipendenza di Cuba, spingendo ovviamente Madrid a dichiarare subito guerra. Cuba funse così da pretesto per estendere il conflitto a tutti i possedimenti coloniali della Spagna; fu la prima guerra dei due emisferi dell’America. Al termine delle ostilità, nell’agosto del 1898, gli Stati Uniti si erano appropriati di Puerto Rico, di Guam e delle Filippine, oltre ad avere acquisito un controllo effettivo su Cuba. La nazione espansionista era finalmente diventata «imperiale». E questo, insieme all’annessione delle Hawaii, nel giugno dello stesso anno, permise agli Stati Uniti di cominciare a svolgere un ruolo di primo piano nel Pacifico. Ma le nuove conquiste comportarono necessariamente anche una nuova valutazione degli interessi nazionali. Il secondo avvenimento fu l’ascesa travolgente di un nuovo uomo politico, che assunse la massima carica a soli 42 anni, allor-
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 85
85
quando una pallottola assassina falciò la vita del presidente William McKinley. Il caso volle che nel momento in cui l’America raggiungeva una posizione di grande potenza, estendendo i suoi interessi ben oltre i familiari orizzonti, anche se la popolazione conservava un orientamento isolazionista, venisse eletto presidente un uomo capace di sfruttare le circostanze con l’equilibrio necessario. E ciò sia in virtù dell’acuta percezione delle realtà politiche, dimostrata Theodore Roosevelt, che della posizione di relativa parità, acquisita di recente dal suo paese, con altre nazioni, in un primo momento molto debole, ma in seguito sempre più forte.
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
Theodore Roosevelt e l’ascesa del prestigio americano La presidenza di Theodore Roosevelt è stata spesso vista come un’anomalia nella storia americana: una breve fiammata di abile Realpolitik combinata con l’impassibile perseguimento di interessi nazionali. Non vorrei aprire ora un dibattito su questo punto. Ma se è vero che da allora nessun altro presidente ha esplicitamente ricalcato le sue orme come grande stratega, vero è anche che la sua presidenza era stata preceduta da un lungo periodo di fiduciosa espansione e di accorta azione diplomatica. L’americanismo ottimista ed espansionista incarnato da Alexander Hamilton, John Quincy Adams, Henry Clay e Andrew Jackson, fra gli altri, rientrava ora all’interno di un disegno globale. Se in passato l’America aveva cercato di controbilanciare la Gran Bretagna nella regione nordoccidentale dell’America settentrionale, ora tendeva a farlo da un capo all’altro del suo emisfero e oltre. E se gli interessi economici della Spagna, a sudovest, erano stati un tempo fonte di preoccupazione, adesso erano le ambizioni della Germania nel Sud America e in Nord Africa a far suonare il campanello d’allarme. In questa fase espansionista, che durò circa un secolo, l’idealismo moralista era andato di pari passo con il realismo tattico sulla base della convinzione che i principi dell’America sarebbero stati attuati nel migliore dei modi promuovendo i suoi interessi, fino ad allora circoscritti al continente. E, a questo scopo, Roosevelt enunciò chiaramente quel che era stato sempre sottaciuto, anche se messo in pratica, ovvero che la grandezza dell’America poteva essere assicurata solo da politiche funzionali ai suoi interessi.
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 86
86
Fu proprio durante la sua presidenza che gli Stati Uniti divennero per la prima volta una potenza globale, sia pure piccola. Ciò non significa tuttavia che l’America avesse «scoperto» improvvisamente la geopolitica, ma semplicemente che ormai quest’ultima non poteva più essere negata. Sebbene le sue fortune nel XIX secolo fossero state spesso dipinte come il frutto di una predestinazione, anziché il prodotto della forza e dell’inganno, ora questa tesi non poteva più essere sostenuta. Avendo già preteso il continente, l’acquisizione di nuove terre avrebbe significato il dominio puro e semplice su popolazioni straniere (come di fatto era avvenuto nel caso delle Filippine): la realtà del’impero non poteva più essere facilmente negata. È significativo notare che Roosevelt si pone, in un certo senso, al di fuori della tradizione: anziché partire da una posizione di fiducioso isolamento e proiettarsi all’esterno per scoprire quali fossero gli interessi della nazione, egli concepì gli Stati Uniti come un paese operante nel contesto di un più ampio sistema di nazioni, la cui posizione all’interno di esso sarebbe stata definita in base a sagge politiche. Nel frattempo, sebbene il concetto di grandezza nazionale fosse sin dall’inizio parte integrante del suo processo di formazione, il perseguimento di questo obiettivo aveva assunto spesso una connotazione squisitamente insulare. Il continente appariva come una grande tela bianca sulla quale gli americani avrebbero potuto dipingere i loro destini individuali. Molti di essi tuttavia non si consideravano in competizione con altre nazioni, fino al punto di riconoscerne di fatto l’esistenza. La grandezza non veniva ricercata in rapporto ad altri popoli. E ancor oggi gli americani tendono a proclamare con orgoglio la loro superiorità, senza stare a fare troppi confronti. Roosevelt fu l’unico a inserire l’America in un sistema internazionale e a riconoscere che avrebbe potuto dimostrare la sua grandezza attraverso la competizione con altre potenze in lizza per la supremazia, ottenuta talvolta anche a loro spese. Tendeva cioè essenzialmente a proiettarsi in avanti anziché limitarsi a reagire, contrariamente alla propensione prevalente del paese. La sua prima grande prova, uno degli eventi che lo avrebbero portato in seguito a enunciare il famoso «corollario Roosevelt», fu il Venezuela. Questo stato sudamericano non riusciva a ripagare i suoi ingenti debiti con la Germania e la Gran Bretagna. Il Kaiser
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 87
87
inviò allora una flotta nei Caraibi per costringerlo a restituire il dovuto o per ottenere un risarcimento con metodi più brutali, assai comuni all’epoca. Roosevelt, allarmato, dirottò allora le sue navi per contrastare l’imponente dispiegamento di forze del Kaiser nell’emisfero americano. La Germania accettò allora di arrivare a un arbitrato, che però non risolse il problema. Il Venezuela voleva attuare una politica monetaria internazionale indipendente pur essendo paurosamente inadeguato a questo compito. Germania e Gran Bretagna, in quanto paesi creditori, rivendicarono così il diritto di intervenire per recuperare le perdite. Ma le ingerenze delle potenze europee nell’emisfero occidentale, sia pure ufficialmente motivate da scopi finanziari piuttosto che geopolitici, rappresentavano una chiara minaccia alla sicurezza degli interessi nazionali americani. Così, il principio di autodeterminazione dei popoli venne sospeso, nel caso del Venezuela, poiché la sua libertà era considerata meno importante della potenziale perdita di quella degli Stati Uniti.
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
I debiti saranno pagati. Farò tutto il necessario perché ciò avvenga. Bisogna tener conto della dottrina Monroe. Se per un verso non possiamo tollerare la confisca permanente di territori, da parte di una potenza europea, in nessuna delle repubbliche americane, d’altro canto io non posso permettere a queste ultime di nascondersi dietro la dottrina Monroe per sottrarsi ai loro obblighi4.
Tutte le repubbliche che aspirano alla libertà si trovano di fronte a questo dilemma «imperiale», poiché il mantenimento della libertà, e della sicurezza su cui si basa, può richiedere una restrizione di quella degli altri Stati. La natura della repubblica democratica ha conferito a questa politica un carattere essenzialmente moderato e perfino indulgente se comparata a quella di molti altri imperi. Il desiderio della maggior parte degli americani di occuparsi prevalentemente della propria vita privata favorisce la tendenza generale a badare solo al «giardino di casa» e ciò impedisce l’attuazione di una politica estera basata semplicemente sul dominio di altri paesi. La propensione a concentrarsi sugli affari interni porta al frequente disinteresse nei confronti delle questioni internazionali. Nel caso dei rapporti con i paesi europei, questo ha comportato la subordinazione della geopolitica alla politica economica, mentre in quello delle Americhe le cose non furono così semplici. Per quanto
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 88
88
sia forte il desiderio di «prendersi cura del proprio giardino», recintare soltanto non è mai abbastanza; bisogna anche badare ad allargarne il perimetro di protezione, specie se il giardino tende a espandersi: «Se vogliamo dire alle potenze europee ‘giù le mani’ allora prima o poi dovremo essere noi stessi a mantenere l’ordine»5. La dottrina dell’autodeterminazione, abbracciata dagli Stati Uniti, permette in teoria a tutte le nazioni di prestabilire il proprio destino ed essere così libere dal giogo di altre. Ma i destini dei vari paesi spesso sono intrecciati: i comportamenti degli uni hanno conseguenze imprevedibili sulle fortune degli altri. Il dilemma posto da questo principio sta nel fatto che vi sono dei casi in cui può essere necessario, per una nazione che voglia mantenere la propria libertà, ridurre quella delle altre. L’incidente del Venezuela rivela inoltre un aspetto singolare della tattica di Roosevelt. La sua propensione alla segretezza come strumento diplomatico fa di lui un raro statista aristocratico all’interno di una tradizione essenzialmente democratica. La sua educazione e la sua formazione elitaria gli consentirono di avere accesso a una fitta rete di diplomatici in Europa. «I loro rapporti confidenziali e accurati lo tenevano aggiornato sia sugli affari di Stato che sulle indiscrezioni che circolavano in ambienti poco accessibili. Grazie alle loro informazioni riservate, riuscivano a concludere accordi non scritti e a mantenere la riservatezza, senza urtare la suscettibilità delle parti in causa»6. Questo stile negoziale permise una notevole flessibilità e favorì una politica prudente nonostante il protagonismo dei leader chiassosi e prepotenti dell’epoca. Prendiamo per esempio la prova di forza riguardo al Venezuela. Roosevelt comprese che il volubile e pericoloso imperatore Guglielmo II aveva un grande senso di responsabilità e di orgoglio nazionale, per non parlare della sua vanità. Per costringere la Germania a cedere nel caso in questione era d’importanza vitale agire senza farle perdere in alcun modo la faccia di fronte al mondo. Possiamo soltanto immaginare la reazione dei bellicosi jacksoniani se fossero venuti a conoscenza che il Kaiser aveva inviato delle cannoniere nei Caraibi. Quel che non vennero a sapere al riguardo salvò probabilmente la presidenza di Roosevelt proprio come quel che scoprirono invece gli americani condannò la presidenza di John Adams dopo l’affare XYZ. I metodi decisionali sofisticati ed elitari di Roosevelt, insieme ai limiti tecnologici dei media dell’epoca, contribuirono a evitare una
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 89
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
89
guerra e a salvaguardare al tempo stesso gli interessi dell’America nel suo emisfero. Per anni gli storici hanno continuato a discutere sui motivi di quell’incidente, che appare degno di nota proprio perché atipico. La segretezza o, tanto per usare un eufemismo, la sottigliezza ben di rado hanno caratterizzato l’arte di governo di questo paese. In una democrazia che considera l’uguaglianza un articolo di fede e custodisce gelosamente le sue libertà, le manovre sotterranee – comprese quelle compiute presumibilmente in nome del bene comune – sono viste con molto sfavore e sospetto. Non vi è naturalmente miglior garanzia contro l’abuso di potere da parte di una minoranza di quella di una popolazione che esige trasparenza dal suo governo. Ma lo svantaggio è che ciò limita fortemente la libertà d’azione di uno statista nell’unico campo in cui la segretezza può rivelarsi di grande aiuto. E questo spiega perché la diplomazia americana tende a privilegiare i vertici ad alto livello, che spesso trovano solo in se stessi l’unica ragion d’essere. Alla luce delle osservazioni di Tocqueville riguardo alla politica estera di un paese democratico, se ne dovrebbe concludere che Roosevelt agiva in modo poco democratico nella sua qualità di paziente e sottile stratega. Ma proprio questa fu senza dubbio in parte la sua carta vincente. La sua immensa popolarità in patria gli conferì maggior forza nell’affrontare le questioni internazionali, proprio come nel caso del cugino Franklin qualche anno dopo (e diversamente da quello di Richard Nixon, che, avendo invece scarsi consensi, non poté concludere accordi diplomatici segreti negli anni Settanta). Ma assai più importante della segretezza fu la sua singolare visione geopolitica della politica estera americana. Nel 1890 l’ammiraglio Alfred Thayer Mahan pubblicò un libro intitolato The Influence of Sea Power upon History («L’influenza del potere marittimo sulla storia») nel quale analizzava in dettaglio i modi in cui le potenze navali avevano dominato il mondo fin dalla notte dei tempi e prospettava un grande ruolo per l’America in questo campo. Per la prima volta nella sua storia era stata delineata una strategia che contemplava la situazione del paese in un quadro globale, proprio nel momento in cui esso stava per raggiungere la capacità di proiettare la sua potenza su questa scala. L’opera incontrò il favore particolare di Roosevelt quando, fin dal suo esordio in politica, ne avrebbe promosso le idee ponendole poi, come presidente, al centro della sua politica estera.
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 90
90
La prima occasione per metterle in pratica si creò nei Caraibi, che Mahan definiva «un centro d’interesse strategico». Così, quel che un tempo sarebbe stato soltanto un riluttante riconoscimento degli interessi in gioco, basato sul coinvolgimento politico ed economico, divenne invece un criterio di valutazione geopolitico. Ciò lo si vide nella sua determinazione di procurarsi un territorio nell’America centrale per costruire un canale che mettesse in comunicazione i due oceani. Ed è significativo che questa visione geopolitica coincidesse con la crescita dell’ingerenza degli Stati Uniti negli affari interni dei paesi del loro emisfero. Fu stabilito che l’istmo di Panama, paese che allora faceva ancora parte della Colombia, fosse il luogo più adatto all’impresa, ma dopo anni di snervanti negoziati, quest’ultima si tirò indietro. Nel frattempo i panamensi, irrequieti, stavano di nuovo per ribellarsi contro il governo di Bogotá (circa la cinquantesima volta in mezzo secolo). Roosevelt, lasciò intendere – attraverso canali ufficiosi – che, pur se non avrebbe sostenuto attivamente la rivolta, poteva però sospendere temporaneamente qualsiasi intervento previsto solitamente in questi casi dall’America per sedare le sommosse laddove si fossero verificate. L’insurrezione ebbe successo e gli Stati Uniti conquistarono un alleato per la costruzione del canale. Ma, cosa ancor più importante, compresero finalmente che la politica estera non poteva più essere nettamente separata dagli affari interni di altre nazioni. Riconoscendo l’indipendenza di Panama dalla Colombia, gli Stati Uniti sostenevano di fatto il principio di autodeterminazione, ovvero il diritto di un popolo sovrano ad autogovernarsi, lo stesso diritto cioè che aveva legittimato la Rivoluzione Americana. E riconoscevano inoltre un governo con il quale si poteva negoziare in modo proficuo un trattato per la costruzione di un canale così a lungo auspicato, che congiungesse due oceani attraverso l’istmo centramericano. Per ragioni dovute alle circostanze quanto all’ambizione, le possibilità di maggiore espansione latenti nella dottrina Monroe cominciarono a emergere proprio in questa fase e gli Stati Uniti si trovarono nuovamente di fronte al problema fondamentale della loro politica estera, sia pure ora su una scala molto più ampia: ovvero al fatto che il perseguimento degli ideali jeffersoniani – di vita, libertà e felicità – in patria poteva esigere un comportamento spietato all’estero. Questo dilemma fu eluso per tutto il XIX secolo considerando
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 91
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
91
la politica seguita nel continente come qualcosa di diverso da quella estera. Questo fu un periodo chiave per la formazione dell’orientamento geopolitico dell’America. Proprio come John Quincy Adams escogitò un modo per evitare che gli interessi principali della nazione restassero circoscritti entro le acque territoriali, così adesso, con Roosevelt, si cominciava a guardare ben oltre i mari e a penetrare in altri territori. Stava emergendo, in altri termini, una visione più generale della geopolitica. Il nucleo centrale del suo pensiero politico venne esposto in occasione del suo discorso annuale al Congresso del 6 dicembre 1904, riassunto in seguito sotto il nome di «corollario Roosevelt» alla dottrina Monroe. Testualmente: «[...] nell’emisfero occidentale l’adesione degli Stati Uniti alla dottrina Monroe può indurre il nostro paese, suo malgrado, in casi flagranti di gravi atti illeciti o situazioni d’impotenza, all’esercizio di un potere di polizia internazionale»7. E, in un discorso analogo alla Cuban Society, il 20 maggio del 1904, aggiunse, con un empito retorico tipicamente americano: «Resta fermo il fatto che i nostri interessi e quelli dei nostri vicini del sud sono in realtà identici»8. Va osservato a questo riguardo che «che Roosevelt fece precedre la pratica alla teoria»9, proprio come nel caso del «destino manifesto» della dottrina Monroe. Questo è un tema ricorrente nella geopolitica americana, che rivela il carattere piuttosto casuale di molte politiche degli Stati Uniti. Da questo punto di vista, la cosiddetta «dottrina Bush» sulla guerra preventiva è un’anomalia, poiché proclama subito i suoi intenti prima di metterli in pratica. In generale gli statisti americani si sono trovati a dover rispondere alle varie esigenze che nascevano, dando solo a posteriori una definizione alle loro politiche reattive. Anche questo ci permette di comprendere meglio la politica estera di Roosevelt. Il suo concetto di giustizia internazionale non era da intendersi nel senso tradizionale di legalità americano, bensì in quello di un ordine mondiale stabile in cui le nazioni occidentali – e gli Stati Uniti in particolare – avevano una cointeressenza. Egli credeva fermamente in concetti tradizionali della geopolitica come le sfere di influenza e l’equilibrio di forze. Proprio per questo respinse la richiesta d’aiuto della Germania per ridurre la penetrazione coloniale della Francia in Nord Africa, malgrado le ben note
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 92
92
brutalità commesse da quest’ultima nella regione, poiché la più grande minaccia nel lungo periodo era costituita a suo avviso dai tedeschi e non dai francesi. In Asia, ignorò l’occupazione della Corea da parte del Giappone e appoggiò il suo attacco contro la Russia – una potenza secondo lui molto più pericolosa. Da cui la sua offerta, nel 1904, di negoziare un accordo fra russi e giapponesi allo scopo di mediare fra le due potenze per favorire in tal modo gli interessi degli Stati Uniti: «Vorrei che la guerra finisse con un corpo a corpo fra Russia e il Giappone, che si controbilanciano a vicenda, e rimangono entrambi deboli per lo sforzo»10. Nel concludere il trattato di pace russo-giapponese, Roosevelt cercò sempre di ottenere un risultato conforme ai rapporti di forza esistenti già prestabiliti. Poiché Sakhalin è un isola, è impossibile, umanamente parlando, che i russi riescano a riconquistarla dopo il disastro della loro marina militare [...]. Ritengo che in base a qualsiasi considerazione di interesse nazionale, di convenienza militare e di umanità in generale, sia molto saggio e giusto per la Russia giungere a un accordo di pace sostanzialmente conforme a queste linee [...]11.
Il fatto che i confini geopolitici fossero stati modificati, in realtà alterati da una forza illegale era per lui meno importante del mantenimento degli equilibri esistenti fra la sovranità in una data area e la capacità di controllarli. Riguardo all’ascesa del Giappone all’inizio del XX secolo, Roosevelt auspicava una politica di pronto intervento militare attraverso un vasto dispiegamento di forze navali nel Pacifico pur trattando al tempo stesso questo paese come una grande potenza civilizzata, degna di tutto il rispetto derivante dalla sua posizione. Ma ciò richiedeva un attento equilibrio, come egli stesso osservò con preveggenza: «La mia politica è molto semplice, sebbene io non abbia la più pallida idea di come convincere il mio paese a seguirla»12. Comprese che era una questione di sfumature, non esattamente percepibili dal popolo americano. O il Giappone non rappresentava affatto una minaccia – e in questo caso pace e buona volontà avrebbero regnato e il dispiegamento di forze militari sarebbe stato superfluo, o era un paese potenzialmente ostile, e in questo caso sarebbe stato difficile fare appello alla buona volontà.
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 93
93
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
Storicamente gli americani tendono a identificare il potenziale con l’intenzionale, perché concentrano la loro attenzione più sulle motivazioni che sulle posizioni geopolitiche. Per loro, il detto di Tacito «se vuoi la pace, preparati alla guerra» era un paradosso piuttosto che un’ovvietà. E più tardi, le prime avvisaglie della Guerra Fredda avrebbero rappresentato la suprema manifestazione di questo dilemma. Teddy Roosevelt, come molti altri statisti americani, riassunse il curioso, e non del tutto coerente, equilibrio fra moralismo e realismo della tradizione americana. E in parte fu proprio per questa ragione che in tempi recenti sia Henry Kissinger che i suoi avversari politici, i neoconservatori, lo hanno considerato come il loro portabandiera. Il primo per la sua sagace intuizione delle esigenze di una politica di grande potenza e la lucida affermazione degli interessi nazionali degli Stati Uniti; i secondi per il suo moralismo e la sua convinzione che la potenza americana dovesse essere usata come una forza al servizio del bene nel mondo. Va tuttavia osservato che la sua fredda razionalità non fu l’unico contrassegno distintivo del suo orientamento. Come egli stesso sottolineò, «Il primo dovere di una nazione si espleta entro i suoi confini, ma ciò non la esime da altri doveri nel mondo più in generale; e, se si rifiuta di assolverli, perde semplicemente il suo diritto a lottare per un posto fra i popoli che forgiano il destino dell’umanità»13. Il nostro posto nel mondo è e deve essere accanto a quelle nazioni che hanno lasciato tracce indelebili nei secoli [...]. Quelle che non si espandono scompaiono e non resta di loro nessuna memoria nel tempo. L’impero romano si espanse e poi scomparve, ma ha lasciato l’impronta delle sue leggi, della sua lingua, della sua magistrale capacità amministrativa, nel profondo della storia del mondo, profondamente incise nel carattere delle razze che sono venute dopo. Chiedo che questo popolo sia all’altezza delle sue enormi potenzialità14.
L’espansione, pertanto, non è solo un semplice mezzo per garantire la sicurezza e gli interessi di un paese, ma, in ultima istanza, la suprema espressione politica della grandezza e dell’ottimismo nazionali. Le sue scelte lungimiranti furono senz’altro frutto della sua abilità e del suo carattere e, dunque, irripetibili oltre la sua presidenza. Infatti fu solo questione di tempo e la sua visione sarebbe stata su-
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 94
94
perata da quella di un uomo che disprezzava e che avrebbe inaugurato una nuova era nella politica estera americana.
NOTE 1
Boot, The Savage Wars of Peace: Small Wars and the Rise of American Power, Basic Books, New York, 2002, p. XIV. 2 U.S. Marine Corps, Small Wars Manual, U.S. Government Printing Office, Washington, 1940. 3 Boot, op. cit., p. 60. 4 Morris, Edmund Morris’ Theodore Rex, Random House, New York, 2001, p. 201. 5 Boot, op. cit., p. 136. 6 Morris, op. cit., p. 177. 7 President Roosevelt’s Annual Message to Congress, 6 dicembre 1904, Record of American Diplomacy, a cura di Bartlett, p. 539. 8 The Letters of Theodore Roosevelt, Cambridge, Mass., 1951, vol. 4, a cura di Elting E. Morrison, p. 801, citato in Edmund Morris’ Theodore Rex, Random House, New York, 2001, p. 326. 9 Kissinger H., Diplomacy, Simon & Schuster, New York, 1994, p. 39 (trad. it. cit., p. 19). 10 Morris, op. cit., p. 356. 11 Letters, vol. 4, 1307-8, citato in Morris, p. 412. 12 Ibid., vol. 4, 1233-34, citato in Morris, p. 397. 13 Cit. in Beale H.K., Theodore Roosevelt and the Rise of America to World Power, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1956. 14 Theodore Roosevelt, Presidential Addresses and State Papers, New York, 1910, vol. 1, p. 394. Citato in Morris, p. 229.
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 95
CAPITOLO QUINTO
L’ETÀ DELL’IDEALISMO
Non ci lasciamo prendere dall’entusiasmo per la libertà individuale e il libero sviluppo nazionale soltanto entro la nostra sfera d’interessi, ma condividiamo questo sentimento dovunque vi sia un popolo che cerca di percorrere i difficili sentieri dell’indipendenza e del diritto1. WOODROW WILSON
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
La riforma di Woodrow Wilson Proprio quasi nello stesso momento in cui cercava di dare all’America un posto nel mondo che fosse consono alle sue grandi potenzialità (spesso senza una reale conoscenza del popolo di cui era alla guida), Theodore Roosevelt venne eclissato, forse inevitabilmente, dall’ascesa di un leader con una concezione molto diversa della politica. Pochi uomini nella storia americana hanno influenzato così fortemente la direzione che il paese avrebbe seguito. Ma Wilson era a suo modo altrettanto americano di Roosevelt, una sorta di controfigura, anche se certamente nessuno dei due avrebbe trovato affinità fra loro. Mentre Roosevelt aveva una visione essenzialmente geopolitica, permeata da un ottimismo e da un moralismo tipicamente americani, Wilson era animato da uno spirito quasi messianico, venato da una sorprendente dose di realismo. E il suo comportamento obbediva a un principio esattamente opposto a quello di Roosevelt, che esortava ad «abbassare la voce e mostrare i muscoli». Più che le contrapposte tendenze della politica estera del loro paese, essi incarnavano quella incoerente ma vitale dialettica americana fra pragmatismo e moralismo. Nonostante il suo machiavellismo geopolitico, Roosevelt, da buon americano, vedeva il suo
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 96
96
paese come una sorta di arbitro della giustizia e del bene in un mondo violento e propugnava la diffusione di questi principi attraverso la crescita incessante della sua potenza. Ma fu la differenza nella loro applicazione che cambiò il destino dell’America e del mondo. La politica realista di Roosevelt provocò, forse inevitabilmente, una reazione idealistica. Se l’America tendeva a promuovere soprattutto i suoi interessi principali, come poteva allora pretendere di incarnare principi metastorici? Fu proprio Woodrow Wilson che sollecitò una ridefinizione dell’idea di nazione, minando così definitivamente le fondamenta rooseveltiane della fiducia del paese in se stesso che era venuta consolidandosi nel corso di quasi un secolo di espansione. Sebbene Wilson non negasse all’America un ruolo in campo internazionale, era convinto che la grandezza di questo paese si basasse non già sulle sue realizzazioni bensì sulla diffusione dei suoi ideali a beneficio dell’intera umanità. La sua politica rispecchiava pienamente la convinzione, ben riassunta dal teologo americano Reinhold Niebuhr, secondo la quale, «tranne che in alcuni momenti di aberrazione, noi non ci consideriamo i potenziali padroni, ma i tutori dell’umanità nel suo cammino verso la perfezione»2. All’inizio, entrambi i presidenti non sembrarono discostarsi molto dai loro predecessori. Wilson era diventato un maestro nell’arte dell’ipocrisia jeffersoniana ed estese il campo d’applicazione della dottrina Monroe ben oltre i limiti previsti da Theodore Roosevelt. Ma in questo modo realizzò, almeno in parte, il suo disegno. Al pari di Jefferson (e, per ironia della storia, di Roosevelt) considerò gli interessi americani equivalenti al bene comune. Fu proprio lui il primo a concepire l’intervento degli Stati Uniti come uno sprone alla democrazia liberale. Dopo aver constatato, per esempio, la brutale politica di Huerta in Messico, decise di toglierlo di mezzo. «Wilson aveva fatto affidamento su un’occupazione pacifica. Era convinto che i messicani – ovvero ‘l’85% del popolo di quella Repubblica che stava lottando per la libertà’ – sarebbero stati favorevoli a un intervento americano volto a rovesciare il loro dittatore»3. Di fronte a un’altra delle cicliche ondate di sommosse in America Latina, dichiarò fiduciosamente: «Insegnerò alle repubbliche sudamericane come si eleggono uomini onesti!». Un diplomatico inglese che lo udì pronunciare quelle parole, disse in seguito: «Se
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 97
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
97
qualcuno dei nostri vecchi ambasciatori avesse sentito una frase del genere, sarebbe trasecolato»4. Ma Wilson mise in pratica quel che predicava, a cominciare da Haiti, dove impose l’ordine americano a un paese in preda a un caos permanente. Ma fu in seguito allo scoppio della prima guerra mondiale e a un progressivo impegno verso l’Europa che egli elaborò una filosofia destinata a diventare una pietra miliare della politica estera americana. In quel periodo, gli Stati Uniti stavano diventando la prima potenza internazionale. Nessun altro Stato-nazione esistente possedeva la stessa consistenza demografica unita a un alto tasso di sviluppo. La Russia, che era geograficamente più estesa, aveva un’economia arretrata ed era sull’orlo di un cataclisma politico. La Germania, potenza egemone in Europa con l’esercito più potente del mondo, aveva una popolazione pari alla metà di quella dell’America. Ma, nonostante il rafforzamento della flotta da parte di Roosevelt, vennero fatti ben pochi tentativi di convertire il suo potenziale in energia propulsiva. La potenza americana stava raggiungendo il suo apice e, a prescindere dai principi, era sempre più difficile stabilire se ciò che le impediva di esercitare la sua influenza nel mondo fosse soltanto la mancanza di coraggio. Destinati ormai indubitabilmente a diventare una grande potenza, gli Stati Uniti intrattenevano normali rapporti diplomatici ad alto livello con altri paesi di egual peso, dominavano l’emisfero occidentale come mai prima era accaduto, controllavano il loro nuovo impero nel Pacifico e furono costretti a prendere in considerazione l’ipotesi di un coinvolgimento massiccio nella catastrofica guerra che stava distruggendo la civiltà europea. L’intreccio jeffersioniano di interessi e valori stava mostrando la corda. I più ampi orizzonti geopolitici esigevano una visone adeguata che giustificasse la nuova politica americana. Ed ecco che entra in scena Wilson. Quando scoppiò la prima guerra mondiale in Europa nel 1914, Roosevelt consigliò subito un intervento per mettere alla prova la potenza tedesca. Ma Wilson rifiutò un coinvolgimento solo in base a concessioni pragmatiche a uno stato di necessità. Egli concepiva infatti quella guerra (al pari di qualsiasi altra) come una conseguenza negativa, tutt’altro che inevitabile, del capriccio di leader politici non democratici.
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 98
98
La sua ferma convinzione (prima di prendervi parte a sua volta) che i paesi belligeranti fossero moralmente corresponsabili assomiglia per certi aspetti a quella di Jefferson, il quale aveva messo sullo stesso piano Francia e Inghilterra durante le guerre napoleoniche, un secolo prima. E lo stesso vale per la posizione condivisa sia da Wilson che dall’opinione pubblica americana durante il periodo di neutralità nella speranza di difendere i diritti della nazione restando fuori dal conflitto. Perché dunque Wilson non rimase neutrale, come nei primi tre anni del conflitto, durante i quali la carneficina si trasformò in un bagno di sangue sempre più spaventoso? O, detto altrimenti, se era soltanto una questione di principi e non di interessi nazionali, che cosa cambiò in quei tre anni? Di certo, l’affondamento del Lusitania fu un oltraggio e la scoperta del telegramma di Zimmerman, che invitava il Messico ad attaccare gli Stati Uniti per rivendicare i territori perduti nel sudovest, avrebbero indotto Washington a intervenire nel conflitto, perché furono atti equivalenti a una dichiarazione di guerra. E infine, l’attacco indiscriminato sottomarino nell’Atlantico, preannunciato dalla Germania il 31 gennaio 1917, andava ben oltre la semplice restrizione dei diritti di navigazione. Se non fosse stato per l’arroganza teutonica, molto probabilmente il fatto che il dominio sull’Europa da parte di una singola potenza andasse a discapito degli interessi degli Stati Uniti non sarebbe stato compreso dagli americani. Questi ultimi, infatti, pur avendo dimostrato una sorprendente capacità di sopportare i grandi sacrifici richiesti per espandere il loro territorio (e difendere in tal modo la loro libertà), erano ancora recalcitranti a rischiare la pelle e bruciare ricchezze per motivi esplicitamente geopolitici, anche se, a lungo termine, anche questo avrebbe contribuito a preservare la loro libertà. Si poneva dunque un problema di legittimità, del tutto nuovo. Per oltre un secolo la politica estera aveva seguito in larga misura gli umori del popolo, non il contrario. Con la sola grande eccezione di Theodore Roosevelt, il quale ebbe il privilegio di attuare politiche che non richiedevano alcun grande sacrificio al suo popolo. Alla fine, però, molte delle sue idee non vennero mai messe in pratica: «Nemmeno Roosevelt avrebbe potuto gestire la politica di potenza che sosteneva, anche se morì convinto che ne sarebbe stato capace»5.
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 99
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
99
Che Wilson l’avesse compreso o meno, la verità è che nell’era moderna i popoli democratici non potevano venir condotti in guerra come pezzi su una scacchiera. La Realpolitik che richiedeva l’uso della forza, o la sua plausibile minaccia per essere efficace, non sarebbe stata più direttamente applicabile a nazioni democratiche. Il funzionamento di un sistema basato sul consenso dei governati frapporrebbe subito ostacoli alla libertà di manovra di uno statista che volesse comportarsi come un Richelieu o un Bismarck, a meno che questi non possieda la capacità e la propensione a trasformarsi in demagogo per raggiungere i suoi fini, col rischio però di minare in tal modo la democrazia nel lungo periodo. Affinché coloro che dovranno combattere decidano se è il caso o meno di entrare in guerra, è necessaria la percezione di un pericolo immediato o altrimenti occorrono pesanti manipolazioni e intimidazioni da parte dei loro governanti che scardinano inevitabilmente la democrazia. Ma la percezione della minaccia è essenzialmente soggettiva e spesso erronea e gli appelli all’interesse nazionale a lungo termine non fanno presa su un popolo poco avvezzo alla geopolitica. Così la retorica di Wilson dovette far leva sulle tendenze messianiche racchiuse nello spirito jeffersoniano. Come accadde nel conflitto del 1812, l’America entrò in guerra per difendere il proprio diritto alla neutralità. Ma allora ciò non richiese l’invio di truppe all’estero. Se le minacce del Kaiser avessero investito la sfera d’influenza americana anziché i mari aperti, sarebbe bastato il furioso sentimento d’indignazione jacksoniano a spingere gli Stati Uniti in guerra. Ma la visione geopolitica americana non comprendeva ancora uno spazio così vasto come sarebbe accaduto invece più tardi. Le decisioni che vennero prese da Wilson, e in seguito anche da Franklin Delano Roosevelt, rispecchiavano la quintessenza del concetto americano di intervento internazionale in linea di principio piuttosto che di fatto. Le politiche adottate nell’emisfero occidentale durante il XIX secolo non vennero sottoposte a un vaglio altrettanto severo poiché riguardavano essenzialmente una sfera di interessi considerata naturale. Ispirate alla dottrina Monroe, esigevano un coinvolgimento talmente modesto della popolazione da non dover quasi richiedere alcuna giustificazione, sebbene anche questo fosse certamente un fattore limitante. Per molteplici motivi, l’ingerenza negli affari europei venne vista come una questione qualitativamente diversa, che esigeva una
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 100
100
nuova giustificazione. La ragione più ovvia – ovvero la geografia – è tuttavia quella meno interessante. Ciò che più incideva sul calcolo non era tanto la proiezione di forza a così grande distanza, bensì nel cuore del Vecchio Continente, con le sue politiche di potenza pericolose e, in ultima analisi, autodistruttive dal punto di vista americano. Per quanto la politica estera americana avesse, fino a quel punto, servito al meglio gli interessi della nazione, questi non erano mai stati considerati la base delle scelte politiche. Così, nella sua dichiarazione di guerra, Wilson non si limitò a motivare l’intervento con la necessità di punire la Germania o di impedirle di nuocere agli Stati Uniti. Il nostro scopo, adesso come allora, è la difesa dei principi di pace e di giustizia contro le potenze autocrartiche ed egoiste e l’istituzione, fra popoli veramente liberi e che si governano da loro stessi, di quella unità di scopo e di azione che che assicurerà per sempre il rispetto di questi principi. La neutralità non è più a lungo possibile né desiderabile quando la pace nel mondo intero e la libertà dei suoi popoli si trovano in giuoco e quando la minaccia di questa pace e di questa libertà risiede nella esistenza di governi autocratici appoggiantisi sulla forza, che impongono la loro volontà senza tener conto di quella dei popoli. Siamo all’inizio di un’era in cui i governi come gli individui debbono essere resi responsabili dei loro atti6.
L’America non avrebbe partecipato al conflitto perché ormai non poteva più scegliere tranquillamente la neutralità, ma in quanto i principi stessi cui s’ispirava glielo imponevano. Wilson applicò alla politica una massima di John Donne: «Nessun uomo è un’isola, intero in se stesso [...]. Ogni morte di ogni uomo mi diminuisce, perché io partecipo dell’umanità. E così non chiederti per chi suona la campana. Essa suona per te»7. E aggiunse: Noi non abbiamo alcuna vertenza col popolo tedesco e sentiamo per esso simpatia ed amicizia. Non è stato sotto il suo impulso e nemmeno con la sua approvazione che il governo tedesco dichiarò la guerra. Questa guerra tedesca fu decisa come gli antichi conflitti dei tempi passati, quando i popoli non erano mai consultati e la lotta avveniva per gli interessi di una dinastia o di un piccolo gruppo di uomini ambiziosi che trattavano i propri simili come pedine o strumenti8.
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 101
101
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
Noi stavamo in effetti salvando il popolo tedesco dal Kaiser, anche se questa pretesa sarebbe apparsa senza dubbio sorprendente per milioni di tedeschi che chiesero a gran voce la guerra e combatterono con grande senso del dovere per conquistare il dominio dell’Europa. Ma, cosa ancor più significativa, Wilson non cercò semplicemente di ridefinire i criteri di intervento dell’America, bensì di spostare l’asse del sistema internazionale facendone ricadere la responsabilità sui capi delle nazioni non democratiche. Il rovesciamento delle dinastie europee divenne così uno degli obiettivi principali dei vincitori. In precedenza, gli accordi di pace miraravano ad assicurare la stabilità sopra ogni altra cosa. Ma, per ironia della sorte, questo oltranzismo precluse qualsiasi possibilità di compromesso, in quanto esigeva una vittoria totale che comportava una guerra prolungata e una pace incerta. Non si deve tuttavia credere che i principi esposti da Wilson fossero soltanto un alibi per salvarsi la coscienza mentre in realtà si perseguivano gli interessi nazionali. Essi riflettevano, in effetti, un’autentica tensione e, in questo, come ha sostenuto in modo convincente Robert Tucker, «nessun’altra figura pubblica dell’epoca interpretò più fedelmente gli umori della nazione, nessuno seppe dar voce alle sue paure e alle sua speranze, più del presidente»9. Ciò è dimostrato soprattutto dalla completa mancanza di preparazione militare nel momento in cui Wilson chiese finalmente l’approvazione di una formale dichiarazione di guerra nell’aprile del 1917, in confronto agli anni dedicati da Franklin D. Roosevelt a predisporre l’intervento prima di Pearl Harbor. La verità è che il presidente non ha mai capito quanto fosse grave il nostro ritardo. Fin dall’inizio ribadii con forza che il paese doveva essere pronto per qualsiasi eventualità [...] Se ci fossimo impegnati attivamente, con tutte le nostre forze, per costruire una macchina da guerra commisurata alla posizione che occupiamo nel mondo, ora avremmo potuto imporre la pace. Se siamo in guerra con la Germania per un conflitto navale, è perché siamo totalmente impreparati e la Germania pensa che siamo impotenti10.
Come Jefferson, Wilson fu inevitabilmente costretto a usare i mezzi del potere, anche se non ne approvava il principio. Pur condividendo il sentimento comune del popolo americano con la sua tormentosa indecisione se entrare o meno in guerra,
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 102
102
seppe però guardare molto più avanti quando si trattò di decidere la pace. Nei suoi «Quattordici Punti» prefigurò un ordine nuovo basato su una Lega delle Nazioni, in cui gli Stati Uniti avrebbero svolto un ruolo chiave come gendarmi del mondo. In altre parole, era favorevole a un impegno permanente del paese che andava contro ogni tendenza storica del popolo americano, indifferente alle sue nobili motivazioni. Il nuovo modello wilsoniano insisteva sul diritto all’autodeterminazione di tutti i popoli, senza tener conto dell’ordine geopolitico che ne sarebbe derivato. Quest’opzione non era considerata reciprocamente esclusiva rispetto ad altre, bensì come il valore morale primario da cui sarebbero discesi tutti gli altri benefici. Walter Lippmann, che è stato a lungo un preveggente osservatore della politica americana, osservò a proposito di Wilson, dimostrando in questo una straordinaria percezione della psiche americana: «La sua mente è come una luce che offusca i contorni di ciò su cui si posa: c’è molta illuminazione, ma si vede ben poco». Egli ebbe comunque il merito di riconoscere che la politica estera americana non poteva limitarsi semplicemente a spegnere i fuochi, soprattutto dopo che si erano trasformati in conflagrazioni che stavano divorando un intero continente, ma c’era bisogno di agire preventivamente per scongiurare queste catastrofi. Ma nel suo pensiero vi erano alcune contraddizioni interne: stava semplicemente gettando le basi per predisporre un impegno americano nel mondo quando questo veniva richiesto dal momento storico o stava di fatto proclamando un obbligo incessante a intervenire negli affari internazionali? E, nella seconda ipotesi, gli americani avrebbero sostenuto il principio di autodeterminazione nazionale o i diritti individuali in quelle occasioni (frequenti), come nei Balcani, in cui queste due scelte entravano in contrasto? La concezione tragica della politica, che esige una scelta fra opposti inconciliabili, è estranea alla visione americana del mondo. La dottrina della sicurezza collettiva di Wilson rivelò, infine, due difetti fondamentali. Innanzitutto egli non offriva alcuno strumento d’imposizione, credendo che le leggi stesse avrebbero indotto all’obbedienza i popoli democratici. Secondariamente, egli dava per scontato che tutte le nazioni avessero un egual interesse a garantire la sicurezza generale e la pace. Ma, nella realtà, si vide invece che la Francia cercò di indebolire a sufficienza la Germania,
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 103
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
103
dapprima insistendo per il suo smembramento, poi accontentandosi dell’Alsazia-Lorena; l’Italia pretese la sua parte dalla disgregazione dell’impero asburgico; e, all’altro capo del mondo, il Giappone cercò d’impadronirsi dei possedimenti tedeschi in Cina. Ognuno aveva interessi specifici che anteponeva ai sublimi ideali di Wilson. Come scrisse The New Republic nel 1914, «finché costruirete sulle rovine, i vostri passi affonderanno nel vuoto». Alla fine, qualsiasi problema teorico apparve irrisolvibile a causa di un insuperabile ostacolo pratico: i cittadini americani e i loro rappresentanti al Congresso erano poco propensi a sopportare questi fardelli. Pur disdegnando il modello europeo, Wilson aveva assegnato involontariamente alla politica estera un ruolo centrale con i suoi accorati appelli alla giustizia internazionale. A tal punto che la promozione della libertà nel mondo prese il posto della sua difesa all’interno come fine supremo della nazione. Ma, col tempo, le incongruità di fondo della filosofia wilsoniana riemersero in modo ancor più acuto dopo la seconda guerra mondiale (e poi di nuovo alla fine della Guerra Fredda). Woodrow Wilson è stato visto spesso come un profeta che riscatta il suo popolo dagli errori che lo hanno deviato dalla retta via, assegnandogli una nuova missione: un’immagine che appare indubbiamente verosimile alla luce del radicalismo di molti dei suoi principi e dei comportamenti di quegli uomini forti che rivendicarono il possesso di un continente e instaurarono un dominio su un emisfero nel corso del XIX secolo e all’inizio del XX. Anche nel caso di un paese quasi senza storia come gli Stati Uniti, abbracciare una teoria che considera la pace e l’armonia come tendenze intrinseche alla loro natura significherebbe negare il passato di una nazione che è nata da una guerra rivoluzionaria; ha sottratto con la forza al Messico intere province; ha mantenuto la sovranità su gran parte del proprio territorio attraverso lunghi conflitti con le popolazioni indigene; ha ottenuto il più importante successo in tempo di pace – l’acquisto della Louisiana – nel quadro di una guerra più ampia, approfittando delle battaglie di Napoleone contro il resto dell’Europa; ed è stata infine profondamente segnata da una sanguinosa guerra civile. Ma se non è affatto strano che una nazione fondata su nuovi principi abbia prodotto una tendenza di pensiero che la considerava esente da gran parte della storia, è curioso che abbia potuto riesumare questa visione dopo un secolo che sembrava aver definitivamente rinunciato a queste speranze.
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 104
104
La reinterpretazione soggettiva della tradizione, da parte di Wilson, ha dunque introdotto una decisiva differenza nella storia americana. Ma egli non avrebbe potuto modificare da solo l’intero corso della politica estera americana andando del tutto controcorrente. Doveva già esistere qualcosa, in quella tradizione, che la rendeva così ricettiva al suo modo di vedere. In un certo senso, ciò testimonia della forza di quella visione originaria, mediata attraverso l’idealismo di Jefferson. Ma al di là di questo, rivela che le lezioni che l’America trae dalla propria storia con sono così ovvie come potrebbero apparire a prima vista. Si possono istituire infiniti parallelismi con l’Europa (o con qualsiasi altra parte del mondo) da un punto di vista storico. Ma l’America non ritenne mai comparabile la sua situazione con quella di altri paesi. La relativa facilità in cui gli Stati Uniti si sono moltiplicati ha fatto apparire quest’impresa quasi come il frutto della Provvidenza e soprattutto ha evitato loro di dover affrontare i difficili problemi posti solitamente dall’elaborazione di una politica estera. Non era stato necessario cioè trovare un equilibrio fra il proprio concetto di nazione e la loro politica estera, poiché pretendevano di non averne alcuna. Molte lezioni che sembravano così ovvie quando venivano tratte dalle esperienze del Nordamerica nel xix secolo non erano applicabili alla geopolitica internazionale del XX. L’idea che le regole che valevano per la conquista di un territorio senza leggi potessero venire applicate anche nei rapporti fra le nazioni era ripugnante. E fu proprio questa consapevolezza che predispose gli Stati Uniti ad accogliere la visione di Wilson. Ma se questa era una conseguenza tutt’altro che inevitabile, fu nondimeno la logica conclusione di quanto era accaduto in precedenza. Sarebbe tuttavia eccessivo considerare la presidenza Wilson come una rifondazione della tradizione della politica estera americana. Molti dei suoi precetti non sarebbero risultati estranei a Thomas Jefferson e neppure a James Madison. L’inclinazione americana all’idealismo non iniziò, né chiaramente finì, con Wilson. Sarebbe più appropriato affermare che la sua filosofia politica archiviò molte teorie sviluppate durante la formazione dell’America nel corso del XIX secolo e in parte anche quelle originarie, di Washintgton e Hamilton in particolare. Forse questo era necessario affinché il paese conservasse la sua eccezionalità nel momento in cui estese il raggio della sua politica estera ben oltre la sua tradizionale sfera continentale.
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 105
105
Ciò che era rimasto a lungo latente venne portato alla luce quando gli Stati Uniti acquisirono, per la prima volta, la capacità e la potenza necessarie per proiettare la propria forza oltreoceano e far sentire così la loro voce sulla scena mondiale. Da questo punto di vista, Wilson rappresentò un’ulteriore complicazione di quella che già era una contraddittoria tradizione risalente a Jefferson. Più d’ogni altro leader americano, egli è infatti l’erede di quest’ultimo, nel senso che, nell’allargare la sua visione scoprì, al pari del suo predecessore, che i suoi principi potevano non coincidere con i suoi comportamenti. Di fronte a questa nuova forma di idealismo, riemerse così, per reazione, nella politica americana del periodo fra le due guerre, la più antica tendenza, altrettanto idealistica, all’isolazionismo. La delusione per l’impegno internazionale prese il sopravvento e ben pochi insegnamenti vennero tratti dallo scoppio della guerra, salvo che ciò dimostrava, ancora una volta, la bancarotta morale del sistema di Stati europeo: un’idea fissa che già circolava da lungo tempo in America. Ma nessuno sembrava rendersi conto che quelle circostanze potevano ripetersi nel giro di appena una ventina d’anni, in parte come risultato del divario fra l’ordine richiesto dalla pace che Wilson aveva contribuito a imporre e la volonta degli americani di sostenerlo. Ma quando venne il momento d’imbracciare di nuovo le armi, gli americani scoprirono che le idee di Wilson, benché dimostratesi fallimentari a suo tempo, avevano messo profonde radici nella loro psiche e vi sarebbero rimaste a lungo.
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
L’ascesa: l’era di Franklin Delano Roosevelt Il dilemma di Roosevelt era tanto semplice quanto complesso. Rispecchiava, di fatto, quello di Wilson: convincere gli americani, a dispetto di quasi tutti i loro istinti più profondi, della giustezza delle sue convinzioni. Ovverosia che l’America aveva una missione da svolgere nel mondo, e specificamente quella di combattere contro le potenze dell’Asse. Il suo compito fu tuttavia più semplice di quello di Wilson, sia perché era un uomo politico di superiore levatura, sia in quanto aveva una visione meno generica e più concreta delle cose. Pur se condivideva con Wilson un idealismo incoercibile, si
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 106
106
può dire che la vera differenza fra i due stesse non solo nel carattere ma anche nella strategia. Wilson, il profeta, guardava sempre molto più in là del popolo cui cercava di imporre le sue idee, laddove invece Roosevelt, da abile uomo politico, tendeva sempre a rimanere in sintonia con esso. E sebbene fosse costretto, come il suo predecessore, ad affrontare lo stesso conflitto fra interessi e principi, in circostanze non nuove, aveva una più acuta consapevolezza del suo dilemma. Inoltre, anche se non dava molto più peso di Wilson ai fattori «geopolitici», riusciva a comprendere meglio i meccanismi della psicologia americana. La prima guerra mondiale fu pe gli Stati Uniti un’iniziazione alla geopolitica europea. Ma, al contrario delle lezioni precedenti, il sangue versato sui campi di battaglia della Marna e del bosco di Belleau non rafforzò negli americani la consapevolezza delle dure necessità della geopolitica, bensì la loro contrarietà a qualsiasi impegno futuro. Così, paradossalmente, il compito di Roosevelt fu reso ancor più arduo dall’esperienza compiuta dall’America in quegli anni. Ma se i principi wilsoniani da soli non avrebbero indotto il popolo americano all’azione in futuro, esso sarebbe stato comunque costretto a scendere in campo anche senza ricorrere a essi, come Roosevelt aveva ben compreso. Così, le sue esortazioni all’America a rinunciare esplicitamente alla neutralità dopo lo scoppio della guerra fra Germania e Gran Bretagna partirono da una premessa morale e non strategica. Non era la minaccia rappresentata da Hitler per gli interessi nazionali degli americani, bensì per i loro principi, a esigere una risposta. È significativo che il dibattito accesosi fra l’inizio della guerra e l’attacco a Pearl Harbor fu caratterizzato non già da uno scontro fra concezioni strategiche bensì fra visioni diverse del paese. Contro la retorica bellicosa di Roosevelt, il senatore Arthur Vandenberg, paladino dell’isolazionismo, dichiarò apertamente: «Abbiamo dimenticato il Discorso di commiato di Washington per gettarci a capofitto nella politica di potenza e nelle guerre di conquista dell’Europa, dell’Asia e dell’Africa. E abbiamo imboccato una via senza ritorno»11. Per quanto ambigua fosse stata la tattica di Roosevelt, per esempio nel promuovere la famosa «legge affitti e prestiti» (Lend-Lease Act) come strumento per mantenere la neutralità quando in realtà equivaleva di fatto a un’alleanza con la Gran Bretagna, egli usò
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 107
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
107
questi mezzi al servizio di una strategia fondamentalmente wilsoniana e soprattutto americana. Al pari di Wilson, infatti (e diversamente dal suo lontano cugino Theodore), Roosevelt vedeva il conflitto come un’aberrazione, il risultato del comportamento di individui malvagi e di regimi iniqui, anziché come il prodotto del sistema internazionale. Nel suo Discorso sullo Stato dell’Unione del 1914, egli espose la sua famosa «teoria delle quattro libertà», partendo dai diritti fondamentali americani per arrivare alla formulazione di un credo dalle implicazioni quasi cosmiche. «La quarta è la libertà dalla paura – il che [...] significa una riduzione degli armamenti in tutto il mondo in misura tale e in modo così completo che nessuna nazione sarà in grado di compiere un atto di aggressione contro qualsiasi paese vicino – in qualsiasi parte del pianeta»12. La speranza jeffersoniana in un luogo in cui il caos e le sofferenze provocate dagli sconvolgimenti politici cessassero di esistere, si era estesa oltre i confini degli Stati Uniti fino a includere il mondo intero, posto che l’America e altri Stati che la pensavano allo stesso modo avessero contribuito a realizzare il sogno. Alla fine, furono proprio i nemici a risolvere il problema di Roosevelt. Il fatto che per costringere gli Stati Uniti all’intervento ci fosse voluto il proditorio attacco giapponese contro Pearl Harbor e la folle dichiarazione di guerra di Hitler agli Stati Uniti che seguì quattro giorni dopo, sta a indicare quanto fosse radicato l’isolazionismo americano. Ma, a quell’epoca, e qui sta la grandezza di Roosevelt come leader, l’America era psicologicamente preparata, come mai prima in passato, a fare la sua parte nel mondo13. Con una punta di saggezza, Churchill dichiarò: «Si può star certi che gli americani faranno sempre la cosa giusta [...] dopo aver esaurito tutte le loro altre risorse». La decisione di entrare in guerra finì però col sollevare l’ulteriore dilemma di come ristabilire in seguito la pace. Roosevelt aveva in mente una versione più muscolare della dottrina della sicurezza collettiva, che prevedeva una combinazione della potenza dell’America, della Gran Bretagna, dell’URSS e della Cina per garantire la stabilità internazionale, senza però alcun tentativo di dominare territori al di là dei propri confini. [Il sistema] di Roosevelt era inapplicabile perché dalla guerra non era emerso alcun equilibrio delle forze, perché esisteva un profondo di-
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 108
108 vario ideologico fra i vincitori e perché Stalin, liberato dalla minaccia tedesca, non aveva più remore nel perseguire gli interessi politici e ideologici sovietici, anche se il prezzo fosse stato un confronto con gli ex alleati14.
Nel rifiuto di Roosevelt di venire a patti con le realtà geopolitiche emerse a Yalta, e in particolare in quello opposto ai tentativi di Churchill di creare una forza di contrappeso in Grecia, se non in altre parti d’Europa, si sente aleggiare lo spirito di Wilson. E, come sempre, alla base di questa visione del mondo vi è un’idea di armonia. Ma se la natura ha orrore del vuoto, ciò vale anche per gli Stati confinanti. Al pari di Wilson, inoltre, anche Roosevelt non concepiva che altri potessero trarre conclusioni diverse dalle loro situazioni individuali, e che la sicurezza collettiva del dopoguerra potesse fondarsi sui contrapposti interessi delle nazioni, e soprattutto, sulla rocciosa intransigenza sovietica. Come ha scritto Charles Bohlen, uno dei migliori esperti americani di affari sovietici: «Non credo che Roosevelt avesse una chiara percezione dell’abisso che separava il pensiero di un bolscevico da quello di un non bolscevico, e in particolare di un americano. Era convinto infatti che Stalin vedesse il mondo con gli stessi suoi occhi»15. In definitiva, se non fosse stato per l’Unione Sovietica e in particolare per l’indignazione provocata in America dal comportamento profondamente offensivo e minaccioso di Stalin, che mirava a impadronirsi di tutta l’Europa dell’est, il vuoto creatosi dopo la prima guerra mondiale avrebbe potuto perdurare indefinitamente. Gli Stati Uniti avevano sempre peccato d’ingenuità. Roosevelt non aveva alcun un piano postbellico che prevedesse un dispiegamento di forze permanente in Europa. Contro il parere di Churchill, né lui, né i suoi alti generali, Eisenhower e Patton, cercarono di condurre la guerra in modo da precostituire un equilibrio di forze postbellico. Ma questa volta ebbero il vantaggio – se così si può dire – di trovarsi di fronte a un maestro di geopolitica, come Stalin, sebbene né l’Europa né loro stessi potessero essergli grati di tale lezione. Dal vuoto di potere, in genere, non fiorisce la pace, né l’autodeterminazione, bensì il dominio di una potenza rivale, che si affretta a sfruttare l’occasione propizia. Alla fine Stalin avrebbe esagerato e gli americani, riconoscendo che il ritiro delle loro forze non
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 109
109
avrebbe preannunciato il ritorno a un qualche ordine preesistente, avrebbero scelto il minore dei mali assumendo un impegno internazionale a tempo indefinito senza precedenti. Ma ciò richiedeva un cambio della guardia e l’improvvisa ascesa al potere di un nuovo leader.
NOTE
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
1
Wilson W., Annual Message to Congress on the State of the Union, 7 dicembre 1915, in Link (a cura di), Papers of Woodrow Wilson, vol. 35, p. 297. 2 Niebuhr R., The Irony of American History, Charles Scribner’s Sons, 1952. 3 Boot, The Savage Wars of Peace: Small Wars and the Rise of American Power, Basic Books, New York, 2002, p. 151. 4 Citato in ibid., p. 149. 5 Kissinger H., Diplomacy, Simon & Schuster, New York, 1994, p. 51 (trad. it., L’arte della diplomazia, Sperling & Kupfer, Milano, 2004, p. 29). 6 Wilson W., Address to Congress Advising Congress to Declare War, April 2, 1917 (trad. it., Il messaggio del Presidente Wilson al Congresso degli Stati Uniti, Tipografia Moderna, Civitavecchia, 1917). 7 Donne J., Meditation XVII. 8 Wilson, Address to Congress (trad. it. cit.). 9 Tucker R.W., «An Inner Circle of One: Woodrow Wilson and his Advisors», The National Interest, primavera 1998. 10 House E.M., Diary and Papers, Yale University Library, citato in Tucker. 11 Citato in Kissinger, op. cit., p. 389 (trad. it. cit., p. 297). 12 Roosevelt F.D., State of the Union Message to Congress, 6 gennaio 1941. 13 Sia il libro di Gaddis, Surprise, Security, and the American Experience, che, in particolare, il capitolo «America Re-enters the Arena» in Kissinger, Diplomacy (trad. it. cit., «L’America entra in campo», p. 281, passim), forniscono convincenti testimonianze della grandezza di Roosevelt come leader politico e stratega in tempo di guerra. 14 Kissinger, op. cit., p. 397 (trad. it. cit., p. 304). 15 Citato in Isaacson e Thomas, The Wise Men: Six Friends and the World They Made, Simon & Schuster, New York, 1986, pp. 260-61.
01 layout 23-110
4-04-2005
16:10
Pagina 110
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 111
PARTE SECONDA IL RUOLO GLOBALE
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 112
CAPITOLO SESTO
L’ALBA DELLA G UERRA FREDDA
Storici, politologi e osservatori esterni non hanno ancora chiuso il dibattito sulle origini della Guerra Fredda. Alexis de Tocqueville, profondo conoscitore della democrazia americana, l’aveva predetta negli anni successivi al 1830 (sconfessando la possibilità di prevenirla), quando osservava che: Vi sono oggi sulla terra due grandi popoli che, partiti da punti differenti, sembrano avanzare verso un’unica meta: i russi e gli americani. Entrambi si sono ingranditi nell’oscurità: mentre gli sguardi degli uomini erano rivolti altrove, essi si sono posti tutto a un tratto al primo posto delle nazioni, e il mondo ha appreso quasi nello stesso tempo la loro nascita e la loro grandezza [...] Per raggiungere il suo scopo [gli americani] si basano sull’interesse personale e lasciano agire senza dirigerle la forza e la ragione degli individui, solo [i russi] concentrano in qualche modo in un uomo tutto il potere della società. Gli uni hanno per mezzo di azione principale la libertà, gli altri la servitù. Il loro punto di partenza è differente, le loro vie sono diverse; tuttavia entrambi sembrano chiamati da un disegno segreto della Provvidenza a tenere un giorno nelle loro mani i destini della metà del mondo1.
Ma non c’è bisogno di risalire tanto indietro nel tempo per analizzare il ruolo dell’America in questa contrapposizione. Basti dire che gli americani maturarono la consapevolezza di un conflitto con i sovietici solo due anni dopo la fine della seconda guerra mondiale. Per l’America, la Guerra Fredda non fu una condizione geopolitica ineluttabile, in ossequio ai precetti della Realpolitik, bensì il risultato diretto dell’aggressione sovietica. È vero, però, che la durata del conflitto stesso è in parte da ascrivere alla sua rinuncia alla superiorità iniziale, anche quando non aveva più motivo di dubitare delle intenzioni di Mosca. Il conflitto con l’Unione Sovietica era sicuramente inevitabile
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 113
113
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
per ragioni sia geopolitiche, legate alle dimensioni e al raggio d’azione dei due avversari, sia ideologiche, legate, quest’ultime, alla logica della lotta irrinunciabile contro il mondo capitalistico quale principio fondante del regime sovietico. Tuttavia, a determinare la natura di quel conflitto – che si configurò sotto forma di Guerra Fredda – furono sostanzialmente gli Stati Uniti, dapprima ricusando di prenderne atto e, in un secondo tempo, rifiutando di valutarne l’aspetto geopolitico. Non furono quindi visioni geostrategiche contrapposte a determinare la Guerra Fredda, ma piuttosto l’assenza di visione da parte di una delle due nazioni interessate. Gli obiettivi territoriali di Stalin erano chiari e, per raggiungerli, egli era pronto a bluffare e a negoziare; per Franklin Delano Roosevelt, e più tardi per Truman, questi obiettivi non andavano oltre la difesa della pace, che essi ritenevano di poter raggiungere attraverso negoziati all’insegna della correttezza. Durante la fase della sua straordinaria espansione, l’America non era mai stata considerata una minaccia da altre potenze e non aveva motivo di vedere in queste una minaccia potenziale dovuta al solo fatto di esistere. Alla morte improvvisa di Roosevelt, nell’aprile 1945, le truppe americane erano sul suolo tedesco e i marines nel Pacifico si apprestavano a invadere il Giappone, mentre, a loro insaputa, il progetto Manhattan [che prevedeva la costruzione di una bomba atomica] stava per essere realizzato. Nel frattempo, in un susseguirsi sciagurato di eventi, le condizioni concordate da Roosevelt e da Stalin a Yalta, in merito all’assetto politico dell’Europa orientale, non erano ancora state soddisfatte. È in questo quadro che Harry S. Truman assunse la presidenza. Molto diverso dal suo predecessore, in un primo momento si dimostrò restio a prendere le distanze dalla direzione indicata da Roosevelt. Americana, come del resto tutto ciò che riguardava questo nuovo presidente americano fino all’osso, era la sua convinzione di fondo che la maggior parte dei problemi si riducessero a incomprensioni reciproche e che anche le questioni più complesse non fossero realmente così complicate come apparivano, una volta realizzata la reciproca conoscenza. Egli non ignorava, inoltre, la fiducia che Roosevelt riponeva nella diplomazia personale dopo aver incontrato Stalin a Teheran e a Yalta2.
All’apertura dei negoziati di Potsdam con i sovietici, Truman non puntava a difendere i suoi interessi di potenza rivale, ma a par-
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 114
114
tecipare allo sforzo collettivo di ristabilire e mantenere la pace: un obiettivo, il suo, diametralmente opposto a quello di Stalin. Uno scambio fra Truman e Winston Churchill rivela le profonde differenze delle visioni del mondo tra il Vecchio e il Nuovo: CHURCHILL: «È essenziale far capire loro quanto abbiamo da offrire o da rifiutare». TRUMAN: «È mia intenzione aderire alla nostra interpretazione degli accordi di Yalta». Il che, con riferimento alla Germania, avrebbe significato ritirarsi di 150 miglia dall’Elba per posizionarsi più a occidente, in direzione di Eisenbach3.
Fu a Potsdam che Stalin gettò la maschera, ponendo fine all’alleanza del tempo di guerra e non facendo mistero delle sue mire di potere in Europa. L’idea che gli americani avrebbero considerato le sue ambizioni non soltanto una sfida strategica ma un affronto probabilmente non lo aveva neppure sfiorato. Averell Harriman, che a suo tempo era stato inviato presidenziale presso Churchill e Stalin, a proposito di Potsdam aveva osservato che «l’orientamento era di trattare Stalin come un alleato – un alleato difficile, s’intende – nella speranza che si sarebbe comportato come tale»4. È oltremodo significativo che, nel tentativo di definire la sfera sovietica, la preoccupazione dominante dei politici americani avesse sostanzialmente a che fare con la giustizia, vale a dire con la necessità di stabilire quanto era dovuto a Mosca, sia sul piano finanziario sia su quello territoriale, alla luce delle perdite pesantissime subite durante la guerra. Come osserva Harriman, «Il calore dei sentimenti del popolo americano nei confronti di quello russo avrebbe portato a ogni genere di concessioni, dai prestiti cospicui agli accordi politici»5. A mancare, viceversa, e in misura evidente, era una prospettiva fondata sugli interessi americani, anche perché, prima di allora, gli Stati Uniti non avevano mai pensato di essere interessati all’assetto geopolitico dell’Europa. E ciò rendeva particolarmente difficile affrontare la questione in termini di quali territori concedere, a chi e a che prezzo. Il tentativo di costruire un nuovo ordine basato su criteri di giustizia e non di geopolitica avrebbe paralizzato gli Stati Uniti per due anni, prima che George Kennan, giovane funzionario del corpo diplomatico, presentasse la sua soluzione.
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 115
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
115
Figura unica nel pantheon dei geostrateghi americani, George Frost Kennan era umorale, pessimista, dotato di un sano realismo e di una mentalità geopolitica più congeniale, per molti versi, a un europeo del XIX secolo che non a un americano del XX. Quando egli consigliò apertamente, mentre gli incontri di Yalta erano ancora in corso, di accettare una sfera sovietica in Europa e di mantenerne una americana nella regione occidentale, l’amico e sovietologo Chip Bohlen replicò irritato: «I tuoi suggerimenti ‘costruttivi’ sono francamente un po’ ingenui. Ottimi, probabilmente, dal punto di vista teorico, ma del tutto inaccettabili in pratica. Non c’è posto in una democrazia per politiche estere di questo genere»6. Sfidando la fiducia americana nelle possibilità infinite che uomini e nazioni hanno di reinventarsi, egli scrive: «Nel lungo periodo, [i rapporti tra nazioni] sono sempre governati da fattori fondamentali relativamente costanti, legati a condizioni storiche e geografiche»7. Un tentativo, il suo, di valutare con un approccio squisitamente geopolitico il contesto in cui il carattere russo si era formato e i suoi effetti sulla politica passata, presente e futura. Nel febbraio 1946, da Mosca, dove era stato inviato in qualità di funzionario del servizio diplomatico, Kennan spedì quello che sarebbe passato alla storia come il «lungo telegramma» – una riflessione sull’obbligo morale di opporsi al totalitarismo e una valutazione assolutamente realistica degli obiettivi di politica estera di lungo periodo che l’Unione Sovietica aveva ereditato dalla tradizione imperiale russa. Questa, in proposito, l’osservazione illuminante di Dean Acheson: «Il 1946 è stato in buona parte un anno in cui si è preso atto che i potenti del Cremlino ragionavano non tanto diversamente da come George Kennan aveva previsto»8. Prima che le idee espresse nel telegramma venissero accettate come vangelo, l’orientamento degli Stati Uniti nei confronti dell’Unione Sovietica era sempre stato, sostanzialmente, quello di creare un’agenzia internazionale col compito di controllare e bloccare la proliferazione dell’energia atomica; la sicurezza era infatti basata sulla legalità e sul disarmo e non su considerazioni di ordine geopolitico. E ciò mentre gli Stati Uniti erano l’unico paese in possesso di armi nucleari. Non mi risulta, tuttavia, che il tentativo di giungere a un accordo sul controllo delle armi nucleari, nel momento in cui era l’America a detenere il monopolio atomico, possa vantare precedenti storici. Nel frattempo, mentre gli americani stavano ancora cercando
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 116
116
una risposta al problema sovietico, gli eventi in Europa si susseguivano rapidamente. Il consolidamento della sfera d’influenza sovietica si era esteso fino alla Grecia e alla Turchia, i cui governi, debolissimi, rischiavano di essere rovesciati. Quando si trattò di decidere in merito all’opportunità di concedere aiuti a quei due paesi, il generale George Marshall e Dean Acheson, all’epoca rispettivamente segretario e sottosegretario di Stato, giudicarono necessario evitare una menzione specifica degli interessi strategici che cercavano di difendere. Alla base di tale decisione, c’era la consapevolezza, più o meno esplicita, che all’indomani di una guerra disastrosa, preceduta da un secolo e mezzo di relativo isolazionismo, fosse impossibile mobilitare gli americani sulla base di una minaccia strategica secondaria. È vero, infatti, che Grecia e Turchia rappresentavano l’accesso al controllo del Mediterraneo che, a sua volta, avrebbe permesso di penetrare nelle regioni vitali del Medio Oriente e dell’Europa occidentale, ma si trattava pur sempre di una minaccia che non si sarebbe ripercossa né sul Congresso né sui suoi elettori. Per questo motivo, la bozza di discorso, invece di evidenziare le caratteristiche regionali, puntava «sullo scontro mondiale tra libertà e totalitarismo». Quella che avrebbe assunto il nome di «dottrina Truman», enunciata ufficialmente per la prima volta davanti al Congresso il 12 marzo 1947, era partita dall’analisi geopolitica di una situazione specifica per culminare nella chiamata alle armi per la difesa morale della libertà nel mondo. Walter Lippman, che a quel tempo era forse l’intellettuale americano che godeva di maggior rispetto, formulò nei confronti di quella dottrina la critica più ovvia, osservando che dal punto di vista strategico non tracciava distinzioni tra situazioni di maggiore o minore interesse, finendo con l’essere un impegno globale senza limiti di tempo e potenzialmente indiscriminato. «Una politica globale indeterminata, che suona come l’appello a una crociata ideologica, non ha limiti. È impossibile da controllare. Così come sono impossibili da prevedere i suoi effetti»9. Con il tempo, anche i suoi sostenitori se ne sarebbero accorti. Nel 1947, a circa due anni dalla fine della seconda guerra mondiale, mentre l’Unione Sovietica di Stalin non dava segni di voler rinunciare alla posizione ostile assunta in merito all’assetto postbellico ancora da definire, George Kennan pubblicava su Foreign Affairs un articolo che fece piazza pulita dei dubbi circa le intenzioni
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 117
117
dei russi. L’articolo, intitolato «Le origini della condotta sovietica» sarebbe diventato il programma di politica estera americana per i quarant’anni a venire. La sua tesi, illustrata con argomenti convincenti, era che l’ideologia comunista avrebbe istigato i sovietici a una lotta continua con il mondo capitalistico, e gli Stati Uniti in particolare, e la sua risposta a questa minaccia si tradusse in una strategia che avrebbe portato il suo nome. «Date le circostanze, è chiaro che l’ingrediente principale di qualsiasi politica americana nei confronti dell’Unione Sovietica debba essere un contenimento di lungo periodo, prudente, ma fermo e vigilante, nei confronti delle tendenze espansionistiche della Russia». E aggiungeva: «[...] è possibile fronteggiare la pressione sovietica contro le libere istituzioni del mondo occidentale con il ricorso, accorto e sollecito, a una controforza attiva in quei settori geografici e politici in continua evoluzione»10. Il contenimento non era soltanto una versione aggiornata dell’equilibrio di potere tradizionale in Europa, ma un mezzo per fronteggiare da posizioni di forza le strutture interne del comunismo da cui originava il nuovo espansionismo russo. Dal punto di vista americano,
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
[…] il conflitto Stati Uniti-Unione Sovietica non era causato da interessi nazionali contrastanti, ma dalle carenze morali della dirigenza sovietica. Di conseguenza, scopo della diplomazia americana non era tanto ristabilire l’equilibrio delle forze quanto trasformare la società sovietica11.
L’ironia volle che George Kennan, il realista per eccellenza, finisse con l’accettare la natura essenzialmente ideologica di questa contrapposizione, individuando una strategia volta a conquistare non già il primato geopolitico, bensì a dimostrare la superiorità delle istituzioni democratiche e capitalistiche. A essere in gioco è la capacità degli Stati Uniti di dare ai popoli del mondo l’impressione di un paese che sa ciò che vuole, che affronta con successo il problema della sua vita interna e le responsabilità di una potenza mondiale, dotato di una vitalità spirituale in grado di tenere fede ai suoi valori nel confronto con le grandi correnti ideologiche del tempo. A fronte di una impressione siffatta, duratura nel tempo, le mire del comunismo russo sono destinate ad apparire sterili e ingenue, le aspettative e l’entusiasmo dei sostenitori di Mosca non potranno
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 118
118 che svanire e le politiche estere del Cremlino dovranno fare i conti con una tensione crescente12.
Persino un pessimista incallito come lui, nel bel mezzo di un’acuta analisi strategica, non poté resistere a un empito di entusiasmo tipicamente americano, tanto più straordinario alla luce delle riflessioni che lo precedono. Così, la decisione non potrà che ricadere sul paese stesso. La questione delle relazioni sovietico-americane è in sostanza una verifica dell’importanza degli Stati Uniti come nazione tra le nazioni. Per scongiurare la propria distruzione, gli Stati Uniti debbono semplicemente conformarsi alle loro tradizioni migliori e dimostrarsi degni di rimanere una grande nazione. Certo, le qualità nazionali non furono mai sottoposte a un test più imparziale di questo. Alla luce di queste circostanze, anche un attento osservatore delle relazioni russo-americane non avrà da recriminare in merito alla sfida che il Cremlino ha sferrato alla società americana. Al contrario, proverà una certa gratitudine per una Provvidenza che, mettendo il popolo americano di fronte a una sfida implacabile, ha fatto in modo che la sicurezza nazionale venisse a coincidere con la compattezza del paese e l’accettazione delle responsabilità di una leadership morale e politica che la storia gli aveva chiaramente assegnato13.
L’articolo di Kennan ebbe un effetto dirompente sulla diplomazia americana, non tanto per la strategia indicata, quanto, e soprattutto, per la lucida giustificazione del conflitto che stava covando. Originale, ma perfettamente in linea con la posizione americana, questa strategia prevedeva un susseguirsi di conflitti innescati dall’antagonismo dell’Unione Sovietica. Ma, nonostante la netta superiorità militare e strategica dell’America di quegli anni, essa suggeriva, non tanto una politica di prevenzione, quanto piuttosto una posizione sostanzialmente difensiva. Una strategia che, nonostante i suoi limiti, era in perfetta sintonia con gli orientamenti americani in materia di politica estera, in quanto consentiva al paese di porsi non come aggressore ma come oppositore non violento delle aggressioni stesse. A proposito dell’immagine che l’America ha di stessa e della consapevolezza dei suoi principi, è interessante notare che, anche quando proclama la giustezza dei suoi ideali, senta il bisogno di giudicare
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 119
119
col senno di poi le sue scelte di politica estera. Mentre l’adesione ai principi cardine del regime sovietico ne autorizzava i leader a perseguire qualsiasi azione in loro nome, sia all’interno che all’estero, quella stessa adesione costringeva i leader americani a vagliare costantemente le attività che avrebbero potuto minarne la legittimità sia in patria che, in una certa misura, al di fuori di essa.
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
Nessun altro documento aveva mai previsto con altrettanta precisione cosa sarebbe di fatto accaduto dopo l’avvento di Mikhail Gorbaciov. E nei postumi di un tale collasso dell’Unione Sovietica potrebbe sembrare eccessiva puntigliosità far notare quale compito massacrante Kennan aveva affidato ai suoi compatrioti. Egli, infatti, aveva incaricato l’America di opporsi alle pressioni sovietiche per un futuro indefinito e lungo una vasta periferia che abbracciava le culture dell’Asia, del Medio Oriente e dell’Eurasia. Il Cremlino era invece libero di scegliere il punto in cui attaccare, e cioè dove i suoi calcoli avrebbero dimostrato di poter avere il massimo vantaggio. Attraverso crisi successive, l’obiettivo politico statunitense sarebbe stato la conservazione dello status quo e lo sforzo complessivo avrebbe portato al collasso finale del comunismo solo dopo una lunga serie di conflitti apparentemente inconcludenti. Il fatto che un osservatore sofisticato come George Kennan potesse assegnare alla sua società un ruolo così globale, così severo e contemporaneamente così reattivo, rappresentava la massima espressione dell’ottimismo nazionale e dell’impareggiabile senso di fiducia in se stessa dell’America14.
È la natura stessa della forma di governo degli Stati Uniti a esigere che le politiche siano al servizio di una causa giusta, poiché, se le politiche sono ingiuste, lo sono necessariamente anche le istituzioni che le hanno formulate. E, in tal caso, anche il sistema stesso perde la sua ragion d’essere e gli interessi strategici finiscono col diventare irrilevanti. Ecco allora che alle rivendicazioni strategiche si affianca non di rado la difesa di componenti morali. Si veda, in proposito, l’NSC-68, documento ufficiale della strategia americana della Guerra Fredda, nel quale si legge: «Solo con l’affermazione pratica all’estero come all’interno dei nostri valori essenziali potremo conservare la nostra integrità, che è la vera causa del fallimento dei progetti del Cremlino»15. E in questa tradizione s’inseriscono le accuse mosse a Saddam Hussein e al regime del partito Baath nelle fasi precedenti le guerre del Golfo e che da più parti furono giudicate faziose ed ipocrite.
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 120
120
Ma se le scelleratezze del Baath non erano la causa prima della guerra, dovevano quantomeno rientrare nel quadro che la giustificava. Non diversamente dalla dottrina Truman, la strategia del contenimento non individuava con chiarezza le aree d’interesse nazionale nel mondo, dando di fatto per scontato un impegno globale destinato ad arginare la diffusione del comunismo. All’inizio, il teatro di scontro era stato l’Europa, ma, dopo la rivoluzione maoista e la crisi di Suez orchestrata dai sovietici, fu chiara la necessità di adeguare questa strategia suddetta all’estensione del comunismo perseguita dall’Unione Sovietica a livello globale. Fu allora che la politica di contenimento, volta a bloccare l’espansione del comunismo ovunque si verificasse, fu posta al servizio di fini morali prima ancora che geostrategici. Una valutazione geostrategica del conflitto, regione per regione, avrebbe infatti significato rinunciare all’elemento morale di fondo del conflitto stesso. Ma cosa dire di un orientamento che, una volta convertito in politica, avrebbe manifestato (come di fatto avvenne) tutto il suo cinismo potenziale? Che dire del fatto che molti, sacrificati sull’altare del divario tra risorse limitate e infiniti dilemmi possibili, sarebbero stati semplicemente abbandonati al proprio destino, malgrado i loro bisogni non fossero meno impellenti, come il popolo ungherese e cambogiano, tra gli altri, avrebbero scoperto a proprie spese? Nel frattempo, la mobilitazione ideologica sortì l’effetto secondario indesiderato di relegare in secondo piano insidie e possibilità di ordine geopolitico. Le prime avvisaglie si ebbero con l’ascesa al potere delle forze rivoluzionarie di Mao in Cina, nell’autunno 1949. L’opposizione morale al comunismo non fece distinzioni nell’analisi delle forze coinvolte, preferendo optare per una condanna indifferenziata. Da questo punto di vista, la condanna della Cina popolare era perfettamente nel giusto, dal momento che la repressione in quel paese sarebbe stata più feroce di quella nell’Unione Sovietica. Sul piano geopolitico, tuttavia, si trattava di un paese completamente diverso, dove un nazionalismo di vecchia data avrebbe potuto fungere da contraltare potenziale al minaccioso vicino e compagno ideologico. Inutile dire che fu Kennan a rendersi conto per primo di questa possibilità, che, tuttavia, sarebbe stata colta solo vent’anni dopo da Richard Nixon, il presidente della Guerra Fredda con una profonda conoscenza geopolitica.
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 121
121
Delle due l’una: o gli Stati Uniti combattevano per sconfiggere il totalitarismo, nel qual caso la loro era una guerra giusta, così come le misure adottate in suo nome, o, più semplicemente, intendevano perseguire i propri interessi nel mondo, nel qual caso non erano forse migliori degli avversari e avevano comunque questioni più urgenti da affrontare in casa propria. In quest’ottica, l’assegnazione alla Cina maoista di un seggio permanente nel Consiglio di sicurezza dell’ONU avrebbe potuto sortire l’effetto di dividere la coalizione degli avversari dell’America, con il rischio però di minare la componente morale della lotta. D’altra parte, «Una conseguenza della Politica di Contenimento fu che gli Stati Uniti si costrinsero a una diplomazia essenzialmente passiva durante il periodo della loro maggior forza»16. Al primato militare, economico e tecnologico, conquistato alla fine della seconda guerra mondiale, si aggiungevano, infatti, l’alleanza con numerosi paesi e una situazione interna più stabile, per non parlare del monopolio dell’arma atomica. Eppure, Washington si rifiutava di far leva sulla sua superiorità al fine di raggiungere un accordo. Un rifiuto di negoziare, foriero di un ordine mondiale sfavorevole che preoccupava non poco Winston Churchill, come conferma un suo discorso del 9 ottobre 1948 a Llandudno, nel Galles:
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
Il problema è: cosa accadrà quando anche loro avranno la bomba atomica e ne avranno accumulate in grande quantità? [...] Nessuna persona sensata può credere che si disponga di tempo illimitato. Dovremmo arrivare a una conclusione e a un accordo definitivo: non procedere a scatti, con imprudenza e incompetenza, in attesa che succeda qualcosa, a mio avviso, a nostro danno. È molto più probabile che le nazioni occidentali ottengano un accordo durevole finché dispongono dell’arma atomica e prima che l’abbiano anche i russi17.
Le sfere d’influenza e l’equilibrio di potere che caratterizzarono gli anni della Guerra Fredda sono infatti da attribuire al rifiuto degli Stati Uniti di prendere atto di queste fondamentali premesse geostrategiche, negando, da un lato, le rivendicazioni egemoniche avanzate dall’Unione Sovietica sull’Europa orientale e dimostrandosi, dall’altro, indisponibili ad assumersi la difesa dell’Occidente dopo averla avocata a se stessi. Da sempre la Gran Bretagna aveva bloccato i tentativi della Russia di essere presente nel Mediterraneo. Una strategia, questa,
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 122
122
che si sarebbe protratta per un secolo e mezzo, sia pure in assenza di una guerra dichiarata con Mosca. E ciò perché la Gran Bretagna dava semplicemente per scontato che la Russia avesse obiettivi geopolitici in conflitto con i suoi e che li avrebbe perseguiti senza troppi scrupoli. È del resto questo stato di conflitto intrinseco, ma senza guerra, che ha caratterizzato i rapporti tra le nazioni nel corso della storia (fatta eccezione per le guerre dichiarate). Ed è proprio questo a suonare anatema per gli Stati Uniti. Inutile dire che gli obiettivi dell’Unione Sovietica erano più estremi e minacciosi di quanto non lo fossero quelli degli zar che l’avevano preceduta. Ma, una volta crollato il regime sovietico – questo l’assunto della dottrina Truman – (o, più semplicemente, abbandonate le sue mire mondiali, ovverosia la sua raison d’être), le basi del conflitto si sarebbero dissolte. Uno dei motivi per cui i leader americani, soprattutto Ronald Reagan, erano pronto ad affrontare una sfida così ampia, era la certezza di poter tornare, dopo la vittoria, a un’armonia naturale. Quando, in occasione della conferenza di Potsdam, gli obiettivi sovietici apparvero nella loro vera luce, la fiducia di poter risolvere tutti i problemi sedendosi al tavolo delle trattative cedette il passo al rifiuto ostinato, e di principio, a trattare. Secondo il modo di pensare degli americani, i negoziati erano legati alla pace. E il sospetto (plausibile) che il regime sovietico se ne sarebbe servito come pretesto per un futuro conflitto li rendeva indisponibili a sedere al tavolo negoziale. L’NSC-68 stabilisce che un accordo negoziato equivale al reciproco riconoscimento di sfere d’influenza, solo per sconfessare esplicitamente questa opzione. È significativo che le sfere d’influenza e il concetto di equilibrio di potere, in genere, venissero storicamente considerate alla stregua di obiettivi deliberati anziché di situazioni scaturite dalla politica di potenza di due o più stati avversari. L’ipotesi, infatti, era che tradizioni di governo così antiquate sarebbero scomparse in assenza di una loro applicazione consapevole. E, invece, con crescente sgomento degli americani, fu proprio questo sistema a consolidarsi attorno al blocco contrapposto delle due superpotenze. Sul fronte delle relazioni internazionali, le nazioni e i loro capi non hanno generalmente la possibilità di scegliere i propri interlocutori: si dà per scontato l’obbligo di trattare con altri paesi, che se ne approvino o meno gli obiettivi o le tendenze. Non così nel caso
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 123
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
123
dell’America per la quale, a testimonianza della distanza geografica e della convinzione che l’impegno in campo internazionale rappresenti una scelta e non un dato di fatto, nulla vieta d’interrompere i negoziati nel momento in cui l’interlocutore si rivela un nemico. È quanto accadde, non soltanto all’epoca della Guerra Fredda, ma anche nei quattro anni successivi al massacro di piazza Tienanmen, in cui tutti i contatti ad alto livello con la Cina furono interrotti. E non si tratta semplicemente di resistenza morale al totalitarismo, ma di un modo d’intendere la politica. Winston Churchill, che si oppose all’Unione Sovietica con implacabile coerenza fin dall’epoca della rivoluzione bolscevica e che fu il primo a lanciare un monito sui pericoli della Guerra Fredda, era nondimeno pronto a una convivenza, in presenza di condizioni favorevoli. Ai suoi occhi, infatti, il conflitto era parte integrante della geopolitica e sarebbe esistito a prescindere dalla natura problematica del regime sovietico e dalla sua condanna per considerazioni di ordine politico e morale. Negoziando un accordo da una posizione di forza – questo il consiglio di Churchill – l’America avrebbe potuto di fatto contenere la sfera d’influenza dell’Unione Sovietica, salvando dal dispotismo molti paesi. Anche se sarebbe stata costretta comunque a concedergliene una, sia pur più limitata, all’interno della quale avrebbero dovuto riconoscere tacitamente la legittimità delle sue pretese trerritoriali, nonostante i metodi tirannici usati da Mosca per consolidare il proprio potere. Gli Stati Uniti, invece, decisero di negare qualsiasi sfera d’influenza, disconoscendo, per motivi di principio, la legittimità degli interventi sovietici nell’Europa orientale e rinunciando, in pratica, a salvare alcuni dei paesi interessati. Con ciò non intendo dire che Washington abbia scelto di sacrificare alcune regioni dell’Europa orientale sull’altare di un anticomunismo inflessibile. Ma voglio piuttosto evidenziare i costi di una politica – sia pure di successo – fondata essenzialmente su questioni di principio. Fino a quando le concezioni americane non fossero cambiate, la resistenza all’espansionismo sovietico sarebbe stata impossibile; ma quando gli Stati Uniti si fossero resi conto del pericolo, il risultato sarebbe stato il ritonro alle sfere di influenza strenuamente respinte durante la guerra. Alla fine non fu più possibile ignorare la geopolitica [...]18.
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 124
124
L’antisovietismo degli americani sarebbe subentrato a quella che, inizialmente, era una posizione stranamente favorevole ai russi, sulla base di un’astratta benevolenza, residuo dell’alleanza di guerra. Ma la grande ingiustizia del sistema sovietico, di cui facevano le spese i paesi dell’Europa orientale, avrebbe finito col creare negli Stati Uniti sentimenti profondi di antipatia che andavano ben oltre la competizione geostrategica. A ciò si aggiunga che la doppiezza e la belligeranza di Stalin acuirono la sensazione di essere stati ingannati, di essere vittime di una violazione delle regole, per di più da parte dell’alleato di un tempo. Resta da chiedersi perché Stalin, il realista per eccellenza, abbia gestito le cose in modo da indurre gli Stati Uniti a ribaltare la propria posizione. Ma questi, anche se il giudizio può apparire opinabile, furono tutto sommato fortunati ad avere un interlocutore paranoico e bellicoso come lui nel bel mezzo del caos del dopoguerra. Si deve all’importanza unica che la diplomazia americana attribuisce all’interazione personale se le scelte politiche del dittatore sovietico ebbero la precedenza sulle analisi geopolitiche. Partendo dalla premessa che, alla fine, le divergenze geopolitiche e ideologiche avrebbero reso inevitabile un conflitto, e che non furono le scelte di determinati soggetti da entrambi le parti a farlo inutilmente precipitare, si capisce come la condotta di Stalin aprisse gli occhi degli americani sul sostanziale antagonismo tra le due superpotenze. Come disse lo stesso Stalin, «non possiamo prescindere dai risultati della guerra». La persistente solidità delle istituzioni dell’America serve a creare tra i suoi cittadini la convinzione che esse non rappresentano soltanto il fondamento di una società giusta, ma la base di tutti i comportamenti politici, a prescindere dal contesto. Convinzione tanto più forte in quanto inconsapevole. Il comportamento di Stalin, ingiusto oltre che ostile, contribuì ad alimentare la tensione sempre più aspra che doveva seguire. È questo elemento a distinguere la Guerra Fredda da altri conflitti bipolari, come quello tra la Gran Bretagna e la Francia di Napoleone o tra Atene e Sparta. Questo momento nella storia americana rappresenta forse la difesa più strenua dell’orientamento «non geopolitico». Di fronte a un nemico ideologico, le cui ambizioni globali andavano ben oltre quella che poteva essere considerata la ricerca tradizionale del potere o della sicurezza, gli Stati Uniti trassero una forza enorme dalla convinzione che ad alimentare il conflitto fossero questioni di giustizia e non d’interesse.
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 125
125
E nella Guerra Fredda, l’America s’imbatté nel nemico che si era sottratto a Jefferson e a Wilson – alle prese con la complessità dell’impero britannico e della Germania del Kaiser. Finalmente, sulla scena era comparso un vero tiranno, che aspirava al dominio mondiale.
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
La guerra fredda sembrava quasi fatta su misura per i preconcetti americani. Vi era stata una sfida ideologica dominante che rendeva applicabili a tutto il mondo massime universali eccessivamente semplificate, insieme a una chiara minaccia militare la cui provenienza non dava adito a dubbi19.
William Manchester, nella sua biografia di Winston Churchill, sostiene che è grazie alla sua natura bellicosa, che lo portava a riconoscere un nemico incline alla guerra senza quartiere o senza pietà, che il premier inglese aveva percepito la minaccia rappresentata da Hitler molto tempo prima dei suoi contemporanei, che ne valutavano le richieste in termini di costi e benefici razionali20. Allo stesso modo, gli Stati Uniti trovarono il loro nemico ideale nell’Unione Sovietica – in un regime che, tralasciando paralleli di ordine morale, lasciava intendere di non voler né rispettare i principi della geopolitica né considerare i propri interessi in termini di ragioni di stato tradizionali. Più in particolare, gli Stati Uniti erano propensi a credere nel legame tra la natura di un determinato regime e la sua condotta nella sfera internazionale, perché questo era il loro principio fondante. Ciò spiega perché – fatta eccezione per le amministrazioni Nixon e Ford – essi videro nell’Unione Sovietica un nemico essenzialmente ideologico, mettendo in secondo piano le considerazioni di ordine geopolitico. Abbandonata la moderazione della tendenza wilsoniana degli immediati predecessori, la nuova generazione di uomini politici americani si astenne tuttavia dall’abbracciare il realismo di Bismarck. Gli eventi che si succedettero tra le due guerre imposero infatti di rivalutare l’orientamento originario, anche se non i principi che lo governavano. A essere oggetto di dubbi non era il progetto di un ordine mondiale pacifico basato sull’autodeterminazione e sulla sicurezza collettiva, ma la fiducia che fosse possibile preservarlo con documenti e trattati legali non sostenuti dalla forza. Come dimenticare la lezione di quei «dieci anni critici e deludenti», iniziati con il patto Briand-Kellog del 1928 per la rinuncia
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 126
126
alla guerra come strumento di politica (una beffa crudele alla luce degli avvenimenti successivi) e culminati negli accordi di Monaco dieci anni più tardi, che da allora in poi per i politici americani sarebbero diventati sinonimo di viltà e di arrendevolezza? Ma se i costi della mancata difesa di un ordine mondiale costituito erano evidenti, meno chiara era la natura dell’ordine da difendere. In altre parole, gli americani continuavano a essere soprattutto americani, anche se, nei momenti migliori, riuscirono a trasformare la debolezza in forza. Un confronto globale richiede, infatti, sacrifici che una democrazia non può sostenere sulla base dei soli interessi, come avrebbe scoperto Henry Kissinger quando giunse il momento di chiedere aiuti per l’Angola. Né è pensabile che un programma della vastità del piano Marshall avrebbe potuto essere varato soltanto sulla base di una lucida analisi del quadro mondiale. Certo, nessuno poteva avere interesse a che l’Europa precipitasse in un baratro politico ed economico, ma impegnare le risorse di una nazione in una ricostruzione sul cui successo erano leciti non pochi dubbi, era tutt’altra faccenda. Il ponte aereo di Berlino, realizzato per venire in aiuto dei cittadini di un paese che per ben due volte, nell’arco di venti anni, aveva provocato l’entrata in guerra di americani andati a morire sul suolo straniero, si protrasse per un anno e due mesi, con 277.804 voli e la consegna di 2.325.809 tonnellate di generi alimentari e rifornimenti. E, infine, ci fu la guerra coreana. Commentando l’attacco nordcoreano alla Corea del Sud, il presidente Truman affermò: «Questa è la Grecia dell’Estremo Oriente»21. Sarebbe davvero difficile pensare a una dichiarazione meno geopolitica di questa, che mette a confronto nazioni con una storia e una cultura diverse e chiamate a far fronte a minacce differenti. Più semplicemente, il presidente americano intendeva dire che l’appoggio ai governi di Grecia e Turchia, in accordo con la dottrina Truman, valeva anche per la Corea del Sud, un paese che in precedenza non aveva mai attirato gli interessi o l’attenzione dell’America. A essere in gioco, tuttavia, non era l’importanza particolare della Corea del Sud, ma il contenimento dell’aggressione per motivi di principio. Ecco quanto afferma in proposito lo stesso presidente Truman: Mi è tornato alla mente che ogni volta che le democrazie hanno rinunciato ad agire hanno incoraggiato gli aggressori ad andare avanti…
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 127
127
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
Se ai comunisti fosse consentito d’invadere la Repubblica di Corea senza l’opposizione del mondo libero, nessuna nazione piccola avrebbe il coraggio di respingere le minacce e le aggressioni dei paesi comunisti più forti. Permettere che ciò accada senza intervenire, significherebbe una terza guerra mondiale, com’è accaduto per incidenti simili che hanno portato alla seconda guerra mondiale22.
La capacità dell’America di misurarsi con i sovietici sul piano ideologico era in qualche modo paradossale: entrambe le parti si rendevano conto che era in gioco non tanto un conflitto d’interessi quanto il sistema politico. E l’Europa divenne il grande scacchiere su cui si giocava questa strana partita. Una volta calata la cosiddetta «cortina di ferro», non si trattò più di espandersi territorialmente, ma di rafforzare le rispettive posizioni. «Non è più come in passato. Chiunque occupi un territorio impone anche il suo sistema sociale» – questa l’affermazione di Stalin che può essere integrata da quella di John McCloy, alto commissario per la Germania, secondo cui «noi contribuiamo a creare il vuoto in cui i metodi russi riescono a imporsi proprio grazie all’assenza dei nostri»23. Gli Stati Uniti attribuivano grande importanza alla natura dei governi alleati dell’Europa occidentale alla cui ricostruzione avevano contribuito. Soltanto col tempo sarebbe stato chiaro che questa scelta aveva un suo valore strategico; che, a differenza degli altri sistemi politici, le democrazie raramente si combattono, privilegiando la mediazione delle controversie, e che erano la disponibilità al compromesso e il rispetto degli interessi legittimi dei terzi a conferire all’Alleanza occidentale la possibilità di adeguarsi al mutare delle circostanze. Come dire che, dopo due guerre mondiali, il wilsonismo era tornato a trionfare. La Guerra Fredda – non si può non prenderne atto – ha esercitato una vasta influenza sul modo in cui gli Stati Uniti guardano alla natura dei governi stranieri e alla qualità delle loro istituzioni interne. Le politiche dell’Unione Sovietica, incentrate sul sovvertimento dell’ordine interno, richiedevano contromisure necessariamente volte a contrastarle a livello politico. A ciò si deve in parte il ruolo ambiguo che la Guerra Fredda ha avuto nella storia degli Stati Uniti, costretti, da un lato, a tutelare i propri interessi a livello globale e, dall’altro, data l’origine ideologica del conflitto, pronti a negare l’importanza della geopolitica,
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 128
128
pur utilizzandone i criteri. Paradossalmente, ciò significa che la lezione più grande nella formazione geopolitica degli Stati Uniti, quella che li avrebbe ancorati per sempre a un mondo più vasto di quanto fosse mai stato in precedenza, equivaleva più a una conferma delle tesi di partenza che non a un nuovo modo di vedere il mondo. Da più parti si è affermato che le responsabilità della Guerra Fredda risalgono alla strategia adottata dagli Stati Uniti, su iniziativa di Franklin Delano Roosevelt, per costringere i sovietici al ruolo di aggressori e ritagliarsi quello di paladini della morale. E questo al duplice scopo di dimostrare che l’America aveva i requisiti per assumere la leadership dell’ordine postbellico tra le democrazie e per dare agli americani un pretesto di opporsi ai sovietici che andasse oltre le ragioni geopolitiche. Personalmente, tuttavia, ritengo che si tratti di un errore di giudizio, che, tra l’altro, dà per scontato un livello di autoconsapevolezza che non appartiene agli americani: un aspetto determinante della mancanza di percezione geopolitica dell’America è proprio l’incapacità d’immaginare che altri paesi possano agire nel rispetto di precetti diversi. Alla fine, entrambe le potenze seguirono semplicemente le rispettive inclinazioni: in modo tipicamente ottimistico, l’America attribuì all’ex alleato le migliori intenzioni, sperando di raggiungere un accordo pacifico nel rispetto dei trattati firmati a Yalta; e, in modo tipicamente paranoico, l’Unione Sovietica diede per scontate le peggiori intenzioni, nella speranza di creare un perimetro grande quanto possibile attorno ai suoi confini, nel rispetto della sua percezione dei criteri di sicurezza. E nessuna delle due parti poteva immaginare che l’altra non l’avrebbe pensata allo stesso modo. Per evitare la Guerra Fredda, sarebbe stato necessario, in altre parole, che l’Unione Sovietica di Stalin e l’America di Franklin Delano Roosevelt, prima, e di Truman, poi, rinnegassero la propria natura. I sovietici avrebbero dovuto riconoscere ai paesi dell’Est europeo il diritto all’autodeterminazione e credere che, per gli Stati Uniti, i trattati avessero valore di legge e non fossero semplici strumenti al servizio di interessi nazionali. Gli Stati Uniti, da parte loro, avrebbero dovuto partire da una lucida analisi della natura dell’URSS per comprenderne la visione del mondo sostanzialmente antagonista. Dopo di che, avrebbero dovuto rivolgersi all’ ex alleato, verso il quale gli americani nutrivano ancora sentimenti di benevolenza, facendo leva sul monopolio ato-
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 129
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
129
mico per costringerlo a recedere dalle sue rivendicazioni e circoscriverne la sfera d’influenza, all’interno della quale sarebbe stato libero di agire a suo piacimento. Il che avrebbe, tuttavia, significato addossare al popolo americano l’impegno prolungato a difendere una sfera d’interesse ben oltre i suoi confini e del tutto contraria alle sue propensioni, condannandolo a chiedersi quali fossero state le intenzioni originali dei sovietici e se il coinvolgimento globale dell’America fosse da condannare. «Se Roosevelt avesse seguito le linee di Churchill avrebbe migliorato la posizione contrattuale degli Stati Uniti, sacrificandone la capacità di sostenere i confronti della Guerra Fredda che si stavano approssimando»24. Per conoscere le vere intenzioni dell’Unione Sovietica sarebbero stati necessari un conflitto di cinquant’anni e la spietata repressione dei paesi dell’Est europeo ai quali furono negate tutte le libertà politiche. Resta da chiedersi se gli americani avrebbero fatto il loro ingresso sulla scena mondiale e sostenuto gli impegni assunti se la politica sovietica non li avesse costretti in questo senso. Data la natura di fondo dei sistemi politici coinvolti, è molto difficile, anche a posteriori, immaginare che gli eventi avrebbero potuto prendere un altro corso. L’importanza di questa fase nella politica estera americana non è da sottovalutare. La politica nazionale, iniziata all’indomani della guerra d’indipendenza, era ormai una realtà. Ma, ed è ciò che più conta, in quella fase la dicotomia tra principi e interessi raggiunse la sua massima espressione. Se, come sosteneva Francis Scott Fitzgerald, un’intelligenza di prim’ordine è confermata dalla capacità di essere fedele a due idee diametralmente opposte, è fuor di dubbio che quella generazione di statisti avesse tutti i requisiti del caso: furono loro i primi ad affrontare a livello realmente globale le contraddizioni insite nella tradizione americana. Una tradizione che, secondo Henry Kissinger, si caratterizzava per «coerenza e vitalità straordinarie», anche se sarebbe più giusto dire che la vitalità prosperava a spese della coerenza; che una tensione irrisolta tra principio e pratica, tra ciò che è auspicabile e ciò che è possibile, è l’essenza, il nerbo dell’approccio americano. In un certo senso, la sua stessa forza derivava da una certa mancanza di «realismo» geopolitico. Un approccio in cui non c’era posto per la feroce coerenza della Gran Bretagna del XIX secolo o per l’ingegno pronto e sottile di un Bismarck o di un Richelieu. Ma che, nono-
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 130
130
stante tutto, all’epoca della sua manifestazione più piena, produsse una politica di enorme potenza, in grado, nonostante gli errori, di attingere a tutte le riserve disponibili del paese in assenza di una guerra dichiarata: questa la grande eredità della politica di contenimento e dei suoi primi fautori. Senza ricorrere alla demagogia, questi trovarono il modo di far abbracciare ai cittadini di una democrazia imprevedibile una grande strategia di lungo periodo e di sostenerla per oltre quarant’anni – cosa in precedenza ritenuta impossibile anche dai critici più favorevoli. Va da sé che una simile scelta comportava l’abbandono di un approccio esclusivamente geopolitico. Per cui, quando Harriman disse: «È mia ferma convinzione che l’uomo sia destinato a vivere non sotto una dittatura comunista, ma in una società libera [...]. La lotta dell’uomo attraverso i secoli per la conquista della libertà non sarà annullata da questa gente», non era meno sincero di Acheson quando dichiarava che gli stretti della Turchia rivestivano la massima importanza per gli interessi strategici degli Stati Uniti. La guerra del Vietnam avrebbe messo in crisi un equilibrio che, da allora, non è stato più recuperato. Anche in quegli anni, non furono le sconfitte militari o il mutato equilibrio delle forze globali, ma la perdita della fiducia in se stessi a rendere impossibile l’ulteriore proseguimento della guerra. Se sottolineo l’importanza di quel periodo, non è per esaltare gli uomini politici che lo ne furono protagonisti, ma perché sarebbe impossibile comprendere le attuali scelte di politica estera da parte dell’establishment americano senza prendere atto di quanto è andato perduto – e dei tentativi di ricupero da parte di tutti gli interessati – nel momento in cui la cosiddetta fratellanza ha cessato di esistere. Quegli anni celebrarono l’apogeo della tradizione di politica estera americana, i cui responsabili non s’imbatterono all’improvviso nella geopolitica, ma furono i protagonisti di una fase in cui una tradizione – andata affermandosi sin dalla nascita della nuova repubblica attraverso un’espansione continentale contrabbandata per politica interna e l’internazionalismo competitivo di Theodore Roosevelt e di Woodrow Wilson – si consolidò, infine, nel momento in cui gli Stati Uniti furono costretti ad assumere responsabilità che non avevano mai preso in considerazione. Non era la visione strategica a rivestire un’importanza particolare, ma il fatto che questa classe politica avesse ritagliato per gli Stati Uniti un ruolo
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 131
131
globale che poteva essere conciliato con la consapevolezza che il paese aveva di se stesso. L’unità, che coinvolgeva le diverse componenti sociali e politiche, si fondava sulla convinzione comune che il coinvolgimento americano nel mondo fosse legato a una necessità sia morale sia strategica. Coinvolgimento il cui sostegno si fondava in larga parte sulla coesione, e non su una particolare analisi delle forze geopolitiche. E fu proprio questo elemento a rendere tanto più tragici gli eventi che sarebbero seguiti. NOTE
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
1 de
Tocqueville A., Democracy in America, vol. I, cap. XVIII [trad. it, La democrazia in America, Rizzoli, Milano 1992, a cura di Giorgio Candeloro, p. 411]. 2 McCullough D., Truman, Simon & Schuster, New York 1992, p. 409. 3 Ibid., p. 383. 4 Ibid., p. 444. 5 Citato in Isaacson e Thomas, p. 378. 6 Ibid., p. 246. 7 Ibid., p. 167. 8 Ibid., p. 362. 9 Citato in McCullough, p. 549. 10 «X» (Gorge F. Kennan) «The Sources of Soviet Conduct», Foreign Affairs, vol. 25, n. 4, luglio 1947. 11 Kissinger, p. 450. 12 «X» (George F. Kennan). 13 Ibid. 14 Kissinger, pp. 455-56. 15 NSC-68, «United States Objectives and Programs for National Security», 14 aprile 1950. 16 Kissinger, p. 470. 17 Churchill W.S., His Complete Speeches, 1897-1963, ed. Robert Rhodes James, vol. VII, 1943-1949, New York/London Chelsea House in associazione con R.R. Bowker, 1974, p. 7710. 18 Kissinger, p. 241. 19 Ibid., p. 802. 20 Manchester W., The Last Lion: Visions of Glory, 1874-1932, Delta Books, New York 1983, p. 4. 21 Citato in McCullough, p. 785. 22 Ibid., pp. 777-78. 23 Citato in Isaacson e Thomas, p. 306. 24 Kissinger, p. 422.
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 132
CAPITOLO SETTIMO
I L TALLONE DI ACHILLE
La lezione del Vietnam Se gli anni dell’immediato dopoguerra rappresentarono l’apogeo della politica estera americana, oltre che la clamorosa riaffermazione di una tradizione indifferente alle ragioni geografiche dei problemi politici ed economici, la guerra del Vietnam fu l’esatto contrario: una punizione terribile per aver ignorato le realtà geopolitiche e un tragico colpo da cui il paese non si sarebbe mai del tutto ripreso. I lati deboli della strategia di contenimento iniziale, sottolineati da Walter Lippmann e persino dallo stesso George Kennan, emersero appieno in questo drammatico intervento. L’impegno alla difesa globale della libertà assunto dai responsabili politici americani – in gran parte gli stessi che avevano contribuito a guidare la politica estera negli anni della seconda guerra mondiale – non consentiva di lasciare il Vietnam del Sud al suo destino. Una scelta di cui il presidente John F. Kennedy si fece interprete dichiarando, al momento dell’insediamento, «che tutti i paesi, amici o meno, sappiano che siamo disposti a pagare qualsiasi prezzo, a sopportare qualsiasi onere, ad affrontare qualsiasi difficoltà, ad appoggiare gli amici e a opporci ai nemici per assicurare la sopravvivenza e il successo della libertà»1. Al di là dell’obbligo morale, c’era il timore che un non intervento in Vietnam avrebbe minato la fiducia negli alleati dell’America e, peggio ancora, consentito l’espansione comunista nei paesi del sudest asiatico. Da allora, è diventato di moda liquidare la teoria dell’«effetto domino» come un mito inventato dagli irriducibili fautori della Guerra Fredda. Sorvolando, in tal modo, sulla rapida diffusione
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 133
133
del comunismo nell’Europa dell’est, nell’Asia orientale e nell’America Latina, e sulla crescente influenza sovietica in Medio Oriente e in Africa, ben al di là della sfera tradizionale. E non considerando che, complice il disimpegno americano, Vietnam, Laos e Cambogia erano di fatto diventati comunisti, con conseguenze spaventose per la popolazione. Ma – questo il vero interrogativo – era necessario intervenire per bloccare gli effetti domino in generale o sarebbe stato meglio scegliere le battaglie da combattere nell’ambito di una guerra più vasta al comunismo globale?
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
I veri problemi posti dal Vietnam non erano se si poteva bloccare il comunismo in Asia, ma se il 17° parallelo rappresentasse la giusta linea di demarcazione; non cosa sarebbe accaduto in Indocina se fosse caduta la pedina Vietnam del Sud, ma se si potesse stabilire un’altra linea di difesa, per esempio ai confini con Malacca. Questi temi non furono mai accuratamente esaminati in termini di geopolitica [...] la tradizione universalista americana non consentiva di differenziare fra le vittime potenziali in termini di utilità strategica2.
Dal momento che la politica di contenimento e la dottrina Truman non prevedevano la possibilità di scegliere le aree d’impegno, anzi contestavano un’eventualità del genere, un rifiuto, in questo caso, sarebbe sembrato arbitrario. Ma, come George Ball, allora sottosegretario di Stato e unico funzionario importante dell’amministrazione a dubitare dell’utilità del coinvolgimento americano in Vietnam, ammonì con lungimiranza, «Una volta cavalcata la tigre, non è detto che si possa decidere quando scendere»3. Dopo aver dichiarato che la difesa della libertà globale rientrava negli interessi nazionali dell’America, non era poi così semplice cambiare idea e decidere che il Vietnam non era parte di quegli interessi. Non era possibile fare come Bismarck, il quale aveva liquidato i Balcani, affermando che «non valevano la pelle di neppure un granatiere di Pomerania». Certo, non si può non rilevare il paradosso di un’America che, dopo aver evitato di definire i suoi interessi nazionali per gran parte della sua storia, dichiara che il mondo intero rientra nella sfera di questi ultimi. E, anche in questo caso, senza conoscere le mezze misure. Si tratta, tuttavia, di posizioni estreme che hanno, come vedremo, un’origine comune. Nessuna delle due individua ciò che costituisce o meno un interesse, nel senso che, malgrado l’inver-
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 134
134
sione di rotta, l’America continuava a non tener conto della geopolitica. Può anche darsi, però, che, data la fiducia in tutto ciò che la strategia di contenimento rappresentava, i responsabili politici americani non potessero giustificare a se stessi l’abbandono del Vietnam del Sud. Che, comunque, non sarebbe potuto avvenire sulla base della pura opportunità. La guerra del Vietnam, in altre parole, più che mirare a difendere gli interessi geostrategici americani in Indocina, peraltro discutibili, puntava a impedire l’espansione del comunismo, considerata fuori discussione per questioni di principio. E tuttavia l’incapacità di valutare le situazioni che li riguardavano, di vedere per quello che è lo spazio in cui si agisce, si rivelarono un punto debole di particolare gravità, sia al momento di entrare in guerra sia nel corso delle operazioni militari. Lo stesso dicasi della teoria del complotto comunista controllato dal centro, privilegiata rispetto a un’analisi approfondita dell’ambivalenza della Cina nei confronti del regime di Hanoi e delle tensioni tra Pechino e Mosca. E, ancora, non può non colpire il fatto che, quasi fino all’ultimo, invece di inquadrare le operazioni militari nell’ambito del più ampio contesto dell’Indocina, si puntasse quasi esclusivamente sul Vietnam del Sud, nonostante il fatto che la guerra coinvolgesse l’intera regione, dal Vietnam del Nord a quello del Sud e dal Laos alla Cambogia. Alla fine, intervenne il netto rifiuto di comprendere il carattere della società sudvietnamita e del popolo che gli americani avevano cercato di aiutare. La classica aspirazione jeffersoniana a conciliare l’impossibile si manifestò appieno nel desiderio di non scendere a patti con le difficoltà. Dopo aver deciso di opporsi al comunismo nella regione, gli Stati Uniti si trovarono a fare affidamento su un ordine politico gerarchico e ispirato al confucianesimo, tutt’altro che democratico. Una situazione che non giungeva gradita né all’amministrazione Eisenhower né all’amministrazione Kennedy che sarebbe seguita, le quali di fatto sollecitarono l’avvio di riforme democratiche, tentando al contempo di rafforzare la risposta sudvietnamita alle azioni di guerriglia dei vietcong. Inutile ricordare che i tentativi di riforma, intervenuti in una fase di massima debolezza del regime, compromisero gravemente quelli di opporre una difesa. Di fronte a una serie di atti terroristici
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 135
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
135
compiuti dai comunisti nelle principali città, gli americani si sentirono obbligati ad accrescere il livello del loro coinvolgimento, anche se l’autoritarismo del Vietnam del Sud, minato dai tentativi di riforma, era in contrasto con i loro principi. Il nodo gordiano fu infine tagliato dall’amministrazione Kennedy che incoraggiò il rovesciamento di Ngo Dinh Diem. Questa decisione, che si sarebbe inevitabilmente tradotta nella necessità di una maggiore presenza americana sul territorio, fece il gioco dei vietcong, i quali si videro servita la caduta del dittatore anticomunista. In ultima analisi, furono gli Stati Uniti, obbligati ad armare la difesa di una società che avevano contribuito a sovvertire, a pagare i costi più alti per non voler giocare con le carte a disposizione. Quella idea, squisitamente americana, secondo cui la strategia non attiene alla realtà della geografia, della storia, della cultura e della politica, ma è una sorta d’imposizione, è stata in certi casi un incentivo a compiere imprese senza precedenti. Incentivo che, in questo caso specifico, le circostanze concorsero a bloccare, con conseguenze tragiche. L’America, priva di appoggi nella regione, optò per un intervento diretto, imprimendo una svolta alla situazione. Ma, nel tentativo di creare una democrazia liberale dove non era mai esistita e di difenderla dagli attacchi dei guerriglieri che potevano contare sull’aiuto di altre superpotenze, Washington si addossò inutilmente un peso che andava ad aggiungersi a una impresa di per sé estremamente difficile. Né fece mai un serio tentativo di rafforzare l’esercito o la società civile sudvietnamita, in parte nel timore di essere accusata di mire imperialistiche. «Guardando indietro, non può non sorprendere che soldati e civili evitassero questioni della massima importanza [...] come la necessità di assicurarsi il controllo di un esercito vietnamita riformato – questione liquidata da Westmoreland perché in odore di colonialismo»4. Considerare il Vietnam – come oggi è la norma – un’aberrazione agghiacciante nella storia della politica estera americana, significa travisarne notevolmente il significato, anche se una lettura di questo tipo può risultare confortante. All’epoca, avevano ragione i critici più agguerriti nel considerarlo l’emblema di un disegno più vasto. Forse il simbolo di una visione del mondo sbagliata, o di una tracotanza imperialistica fuori controllo, o, ancora, qualcosa di marcio nel cuore stesso dell’edificio americano, mentre la realtà è sempre più complessa.
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 136
136
E ci riconduce a un elemento di continuità che parte dai primi giorni del confronto con l’Unione Sovietica – con la nascita dell’Alleanza Atlantica, l’attuazione del piano Marshall e la realizzazione del ponte aereo di Berlino e, naturalmente, la decisione di andare in Corea – per arrivare direttamente al Vietnam. In altre parole, l’impulso che ha generato il confronto è lo stesso che ha portato l’America in Vietnam. Clark Clifford, uno dei primi esponenti della strategia di contenimento, nella sua funzione di aiutante di campo del presidente Truman e, successivamente, di segretario alla Difesa sotto la presidenza Johnson, dà una sua spiegazione: Come gli altri, anche io credevo in due lezioni: una, che la negligenza ha portato alla seconda guerra mondiale, due, che una opposizione coerente ha scongiurato la terza. Questa era la mia convinzione inconsapevole, se non addirittura cosciente. Così, quando la guerra in Vietnam è diventata una faccenda seria, ho pensato, ci risiamo. Dovevamo opporci5.
In un certo senso, il Vietnam non era che la continuazione di una politica consolidata e, fino a quel momento, di grande successo. Per analogia, quell’interpretazione della realtà che avrebbe potuto tenere l’America fuori dal Vietnam avrebbe anche potuto negarle la capacità e la decisione d’impegnarsi, dopo tanti anni di isolamento, nella difesa e nella ricostruzione del Giappone e dell’Europa occidentale. Soprattutto, le lezioni impartite dalla storia dopo Monaco, sottolineavano la necessità di una opposizione costante su tutti i fronti. Contro la rimilitarizzazione di Hitler e contro l’ingerenza sovietica in Europa e in Asia. All’epoca, le due sfide maggiori riguardavano Berlino e Cuba. Acconsentire a un accordo sulla questione tedesca avrebbe significato rinunciare all’elemento fondamentale dell’Alleanza Atlantica, cioè all’impegno americano nel mondo; accettare la presenza di testate nucleari nell’emisfero occidentale era impensabile. Gli oneri di una politica intrapresa sulla base del principio – non negoziabile – di respingere l’aggressione sono più facili da accettare di quelli legati alla difesa di interessi, i quali possono essere oggetto di compromesso quando i costi non giustificano più i benefici. In questo caso, sarebbe stato logico lasciare che il Vietnam entrasse nell’orbita comunista e tentare di tracciare un confine in un
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 137
137
luogo più favorevole, come la Malesia. O, ancora, abbandonare il Vietnam del Sud al suo destino sin dall’inizio, prima di un intervento militare imponente da parte di Washington. Come altre vicende verificatesi in questa fase della storia americana, il Vietnam avrebbe anche potuto non essere inevitabile, ma sarebbe stato difficile per i responsabili politici di quel tempo conciliare il suo abbandono con l’impulso che li aveva guidati negli anni turbolenti della Guerra Fredda.
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
Gli Stati Uniti erano stati coinvolti innanzitutto per aver applicato letteralmente i principi della positiva politica europea a una regione con condizioni sociopolitiche ed economiche completamente diverse. L’idealismo wilsoniano non consentiva differenziazioni culturali, mentre la teoria della «sicurezza collettiva» postulava che, essendo la sicurezza indivisibile, il tessuto dell’intero ordine mondiale si sarebbe disfatto se fosse stata sfilata una sola trama6.
Le superpotenze – e in particolare le democrazie – sono come le grandi petroliere che hanno un raggio di manovra di parecchie miglia: una inversione di rotta, per loro, non è facile, specie quando si è investito molto per sostenere quella seguita fino a quel momento. E tuttavia, di fronte al numero altissimo di perdite umane, la guerra divenne ingiustificabile anche per chi ne era stato in origine il fautore. Quella che sembrava l’avanzata inarrestabile dei nordvietnamiti raggiunse il punto culminante con l’«offensiva del Tet», nel gennaio del 1968. Questa segnò una grave sconfitta militare per i vietcong, ma, paradossalmente, fu per gli americani un colpo psicologico di gran lunga peggiore. Inorriditi da quanto avevano messo in moto, il ministro della Difesa Robert McNamara e il segretario di Stato Dean Rusk persero il controllo, riducendosi, come avrebbe riferito Daniel Patrick Moynihan, ad affermare, a mo’ di giustificazione, che era il Vietnam «a dare ordini». Fu Clark Clifford, già strenuo fautore della Guerra Fredda, che, nella veste di ministro della Difesa (come successore di McNamara), dopo l’offensiva del Tet si pronunciò contro la guerra, ma non l’opinione pubblica americana, il 70% della quale era favorevole a proseguire i bombardamenti. L’establishment, che impersonava l’es-
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 138
138
senza dell’internazionalismo americano ancora nascente, era irrimediabilmente entrato in crisi. Essere tra i migliori e i più intelligenti significava farsi accusare di incompetenza criminale. E che significato aveva questo per l’America? Se non si poteva sperare che i migliori e i più intelligenti non ci distruggessero, allora eravamo condannati. Il potere americano poteva essere esercitato con un minimo di fiducia? No, era del tutto impossibile gestirlo. La grandezza nazionale era una possibilità, se i migliori tra noi erano stolti? Dopo il Vietnam, per un establishment liberal, privato della fiducia in se stesso e nel suo paese, anche la parola grandezza era diventata indecente7.
Alla fine, non fu l’opinione pubblica, ma l’establishment – vale a dire lo stesso gruppo bipartitico che aveva guidato la nazione verso una visione globale del suo ruolo – a perdersi d’animo di fronte al mälström del Vietnam. L’establishment s’incrina Nel corso di sedici anni, cinquantottomila soldati americani persero la vita in Vietnam. Un numero altissimo di vittime – tanto più alla luce dell’incapacità di raggiungere la vittoria – ma pur sempre di gran lunga inferiore a quello provocato dalle due guerre mondiali, per tacere della carneficina della guerra d’indipendenza. Molto inferiore, sia in termini di numeri che di proporzioni, alle perdite subite dagli inglesi nell’altrettanto inutile guerra dei Boeri e che, a differenza della guerra di Algeria, dove a morire furono anche i civili, si riferisce solo all’esercito. A ciò si aggiunga che, diversamente da quanto accadde alle potenze europee con le due guerre mondiali, gli Stati Uniti, malgrado la guerra del Vietnam, continuarono a essere una superpotenza (anche se perdere una guerra non è mai un fatto positivo in termini di posizione strategica). Anzi, alla luce della loro vittoria finale nella Guerra fredda, quella del Vietnam può anche rappresentare un costo estremamente modesto per la conquista definitiva dell’egemonia globale. Se insisto su questo punto, non è né per sminuire la genuinità del sacrificio compiuto né lo spaventoso tributo di vite umane, bensì per sottolineare l’impossibilità di cogliere fino in fondo il significato del Vietnam sulla base del parametro tradizionale delle perdite e
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 139
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
139
dei profitti: l’America non è entrata in guerra per considerazioni di ordine geopolitico, ma ha valutato costi e benefici sulla base di criteri completamente diversi. Il disastro del Vietnam si deve alla concezione originaria della Guerra Fredda, vissuta, almeno in parte, come un confronto ideologico – la stessa concezione che ha determinato l’impegno dell’America nella difesa dell’Europa. Le sue vittorie – non solo, o almeno non esclusivamente, quelle sul campo di battaglia – non rivestivano soltanto una valenza strategica, ma erano dimostrazioni visibili della superiorità del sistema americano, non soltanto in riferimento a se stesso, ma anche agli alleati attuali e potenziali. Dimostrazioni che consentivano di alimentare quella che McGeorge Bundy, pupillo di Dean Acheson nonché uno dei grandi architetti dell’impegno americano in Vietnam, definiva «[...] la fiducia degli alleati dell’America e la fiducia in se stessa di quest’ultima»8. Corre tuttavia l’obbligo di rilevare che si trattava in buona parte della reazione a una filosofia comunista che prospettava al mondo un ordine molto più giusto e umano rispetto al fascismo e al nazismo, che a suo tempo avevano rivendicato di essere i più forti. E che anche la tradizione messianica della fiducia in se stessi, che risale alla fondazione dell’America, ha fatto la sua parte (con l’aiuto, s’intende, di Woodrow Wilson). Comunque sia, resta il fatto che la perdita del Vietnam non si sarebbe risolta semplicemente in un diverso equilibrio delle forze geopolitiche (tra l’altro di scarso rilievo), che avrebbe costituito una perdita accettabile o controbilanciata da vantaggi in altre aree, ma avrebbe inferto un colpo alla pretesa dell’America di difendere la libertà nel mondo. Allo stesso modo, la crescente ondata di opposizione interna alla guerra non era dovuta a una diversa valutazione geopolitica, ma alla contestazione degli imperativi morali che avevano portato al Vietnam e all’inizio della Guerra Fredda. I limiti del potere dell’America erano intrinsecamente legati a quelli della sua giustizia. Secondo l’espressione di Robert Kagan, «noi non eravamo soltanto l’America grande, ma l’America buona»9. Paradossalmente, la stessa mentalità che aveva portato l’America in Vietnam, le consentì anche di uscirne, e non a causa di costi divenuti eccessivi, nonostante l’impegno morale di cercare di difendere il suo popolo da una tirannia crudele: non bastava che una causa morale finisse con l’apparire incauta, doveva diventare im-
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 140
140
morale al fine di giustificare il disimpegno. Di più, non era soltanto la causa a essere diventata moralmente nociva, ma anche tutto ciò che l’aveva determinata. Così, anche l’eccezionalità americana fu vista sotto una luce perniciosa e cominciò a ripiegare su se stessa. E gli eredi del Vietnam, in particolare gli studenti dell’epoca, attribuirono al mito originario, che risaliva alla fondazione stessa del paese, la causa della sconfitta, convinti, tra l’altro, che esso avrebbe prodotto altri Vietnam, se non si fosse corsi in qualche modo ai ripari. Quando l’America si trovò impantanata in quel paese, i responsabili della politica estera non si limitarono a rinnegare una strategia sbagliata, ma rifiutarono la visione del mondo che l’aveva ispirata – quella stessa visione che aveva permesso l’unità dell’establishment e, più in generale, la presenza americana nel mondo. I responsabili [della politica estera] avrebbero potuto giustificare il disimpegno in Vietnam con l’impossibilità di vincere la guerra o, quanto meno, di vincerla a costi accettabili. Avrebbero potuto dichiarare che la guerra era stata un errore, motivata da buone intenzioni ma gestita malamente. Ma non è così che l’establishment liberal… ha spiegato il suo fallimento. Ha preferito piuttosto disconoscere una intera visione del mondo. Il Vietnam non è diventato una guerra perduta per una causa giusta, ma la metafora di tutto ciò che in America era sbagliato, il simbolo di una fiducia mal riposta nella sua superiorità morale e materiale10.
L’establishment crollò, portandosi dietro anche il fondamento della politica estera americana. «Il consenso alla politica estera si è disintegrato all’epoca del Vietnam, producendo uno dei grandi disastri della nostra storia»11. I leader di quegli anni, infatti, oltre a considerarsi ormai incapaci di continuare la guerra (o di uscirne), non si ritenevano più degni di guidare la nazione nelle sue imprese. Il che, per estensione, significava che gli Stati Uniti non erano più degni di guidare il mondo. Il vecchio isolazionismo, secondo cui l’America era troppo buona per sporcarsi le mani occupandosi del mondo intero, era tornato a riaffacciarsi: l’America era davvero abbastanza buona per proseguire il confronto? Un interrogativo che, naturalmente, non investiva le sue capacità, ma il diritto di continuare a rivendicare la superiorità rispetto all’Unione Sovietica in una guerra come quella
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 141
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
141
del Vietnam. I vecchi assunti di un tempo – secondo i quali l’America poteva scegliere di partecipare alle vicende internazionali, invece di viverne i contraccolpi come un’inevitabilità, erano riaffiorati, prendendosi la rivincita, sia pure sotto nuove spoglie. L’istinto di ritirarsi, come accadde dopo la guerra del 1812, la guerra d’indipendenza e la prima guerra mondiale, era tornato a farsi sentire; questa volta, non perché faccende più importanti la chiamavano a casa, ma perché prima di assumere un ruolo nel mondo doveva mettere ordine al suo interno. Questa la versione geopolitica dell’insegnamento evangelico: «Ipocrita, trai prima dall’occhio tuo la trave, poi avviserai di trarre dall’occhio del tuo fratello il fuscello». Questa volta, tuttavia, il ripiegamento su se stessa – e qui sta la grande differenza con il passato – avveniva in un momento in cui l’America era un pilastro del sistema internazionale. Come la leadership del secondo dopoguerra aveva potuto prendere atto, la sua rinuncia a ricoprire un ruolo nel sistema internazionale aveva concorso a determinare le vicende che avevano portato alla seconda guerra mondiale. È raro che alle nazioni sia dato di decidere quando, e in quali circostanze, intervenire nel teatro del mondo. E l’America, che da anni godeva di un simile privilegio, non poteva ritornare al passato. Ma è proprio ciò che accadde, sia pure entro certi limiti. Il Congresso tagliò tutti gli aiuti, compresi quelli militari, all’Indocina, mettendo Washington nell’impossibilità di sostenere i termini del trattato che alla fine sarebbe stato firmato con il governo di Hanoi, consentendo ai nord vietnamiti d’invadere il territorio sudvietnamita e lasciando che in Cambogia i khmer rossi perpetrassero un genocidio. Ma l’America adesso era coinvolta in una lotta globale e aveva impegni in tutto il mondo. Se il ripiegamento su se stessa non era più un’opzione, ora le toccava cominciare dall’inizio. Da questo momento in poi, non si trattava più di escogitare nuove strategie, ma di trovare nuove motivazioni che in primo luogo ne giustificassero il coinvolgimento. Se un tempo, quando le situazioni si facevano troppo complicate, poteva tirarsi indietro, ora era costretta a fare politica e a cercare, nel contempo, d’individuarne la ragione. La sua idée fixe era sempre stata la continua tensione tra ciò che era auspicabile e ciò che era possibile, tra accettazione e rifiuto del mondo e di un ruolo al suo interno, sin da quando Thomas Jefferson aveva ereditato le politiche di George Washington e le aveva fatte proprie. Da quel momento, fino alla guerra del Vietnam, la storia
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 142
142
della politica estera dell’America sarebbe stata quella di una tradizione che andava consolidandosi nel tentativo di conciliare la fiducia in se stessa con la geopolitica, mentre gli Stati Uniti continuavano a diventare sempre più potenti. Sotto la classe dirigente emersa dopo la seconda guerra mondiale, quella tensione divenne l’elemento catalizzatore di una serie straordinaria d’imprese, originate dalla convinzione che l’America avesse un ruolo da svolgere nel mondo conforme alla sua importanza. Una scelta, questa, maturata in un momento in cui nessun altro paese avrebbe potuto fare altrettanto. Dean Acheson, segretario di Stato di Truman e uno dei responsabili politici più rappresentativi del dopoguerra, nelle sue memorie racconta di essere stato «presente alla creazione» – riferendosi al nuovo ordine che si apprestavano a costruire dalle ceneri della seconda guerra mondiale. In realtà, avrebbe potuto anche riferirsi in modo plausibile alla creazione di un ruolo sostenuto dell’America nel mondo. In un certo senso, la sconfitta del Vietnam e la concomitante radicalizzazione della componente idealistica del pensiero americano portarono all’istituzionalizzazione di questa tensione, con anime diverse che rappresentavano le sfaccettature di un dibattito annoso. Ma la posta in gioco, adesso, era molto più alta e il dibattito più intenso. Le rivendicazioni non riguardavano soltanto la bontà delle rispettive visioni strategiche, ma, implicitamente, anche il diritto di rappresentare l’essenza della nazione. Mentre le vecchie dispute avevano riguardato le prospettive future, le nuove vertevano anche sul passato, dal momento in cui i responsabili politici erano più che consapevoli dei legami esistenti con la tradizione interrotta. Questa aveva certamente peccato d’incoerenza, ma nondimeno era riuscita a contemperare l’idealismo con una certa tutela degli interessi dell’America, la cui ascesa fulminea è la riprova del suo successo, anche in termini di equilibrio interno e di un certo grado di coesione. Viceversa, quella emersa dopo il Vietnam era, e continua a essere, profondamente rissosa. È pressoché impossibile capire le aspre rivalità di oggi, e le politiche cui danno luogo senza prendere atto di questo momento della storia americana. Nel frattempo, mentre la politica estera di Washington toccava il punto più basso, tutto ciò che la nazione aveva respinto per buona parte della sua esistenza riuscì stranamente a prendere corpo.
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 143
143 NOTE 1
Kennedy J.F., Discorso inaugurale, 20 gennaio 1961. Kissinger, pp. 641-42. 3 Citato in Isaacson e Thomas, p. 648. 4 Cohen E., Supreme Command, The Free Press, New York 2002, p. 183. 5 Citato in Isaacson e Thomas, p. 688. 6 Kissinger, p. 698. 7 Kagan R., «How We Unlearned the Art of War», The New Republic, 3 dicembre 2001. 8 Citato in Isaacson e Thomas, p. 654. 9 Kagan. 10 Ibid. 11 Citato in Isaacson e Thomas, pp. 736-37.
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
2
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 144
CAPITOLO OTTAVO
H ENRY KISSINGER E L’EMERGERE DELLA GEOPOLITICA
Dopo avere abbandonato ogni sorta di idealismo, nel momento più critico della Guerra Fredda, gli Stati Uniti imboccarono una nuova strada. Ma, per ironia del destino, adottarono proprio quel tipo di Realpolitik europea che, nel corso della loro storia, si erano affannati a respingere, almeno a parole. Nel 1968 Richard Nixon salì al potere e scelse come suo consigliere per la sicurezza nazionale Henry Kissinger (che più tardi avrebbe ricoperto, simultaneamente, l’incarico di segretario di Stato, svolgendo entrambe le funzioni anche sotto la presidenza di Gerald Ford). S’inaugurò così un breve e controverso periodo in cui la politica estera americana fu contrassegnata da una tendenza ispirata a un realismo di stampo tradizionale. Questo orientamento sminuì l’aspetto morale fondamentale della dottrina del contenimento a favore di una valutazione puntuale, regione per regione, degli interessi geopolitici e del perseguimento di una politica di distensione con l’Unione Sovietica. Eletti inizialmente dietro la promessa di porre fine alla guerra, essi avviarono un’escalation, fortemente criticata, per facilitare il disimpegno delle truppe americane e costringere così i vietnamiti a negoziare. In questo modo, Kissinger riuscì a rendere accettabile, almeno per un breve periodo, la saggezza del principe von Metternich a un paese che, in larga misura, ne aveva sentito parlare soltanto da lui per la prima volta. E adottò una posizione letteralmente estranea allo spirito americano, anche se non nel senso peggiorativo del termine. Si trattava di un pragmatismo per molti aspetti contrario all’idealismo tradizionale di questo paese, in base al quale Ogni statista deve cercare di conciliare ciò che è considerato giusto con ciò che si ritiene poissibile. Ciò che è considerato giusto dipende dalla
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 145
145 struttura interna del suo Stato; ciò che è possibile, dalle sue risorse, dalla sua posizione geografica e dalla sua risolutezza e dalle risorse, dalla risolutezza e dalla struttura interna degli altri Stati1.
Un punto di vista singolare, condiviso dal presidente di cui egli era al servizio. Come dimostra una delle più sorprendenti dichiarazioni fatte da Nixon, degna di nota poiché evidenzia il contrasto fra la tradizionale politica estera americana e l’assunto fondamentale della geopolitica:
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
Il nostro obiettivo è sostenere i nostri interessi nel tempo grazie a una solida politica estera. Più questa sarà basata su una valutazione realistica degli interessi nostri e altrui, più sarà efficace il nostro ruolo nel mondo. Non siamo coinvolti nel mondo perché abbiamo impegni; abbiamo impegni perché siamo coinvolti nel mondo. Saranno i nostri interessi a modellare i nostri impegni e non viceversa2.
Alla luce della storia americana, è chiaro quanto fossero rivoluzionarie le implicazioni di questo modo di vedere e quanto, invece, sarebbero state banali se questa posizione fosse stata assunta da qualsiasi altro paese. Ciò segna una svolta radicale rispetto all’orientamento storico della politica estera degli Stati Uniti, l’unica nazione che possiede una tradizione isolazionista. Va tuttavia precisato che l’isolazionismo è completamente diverso dal neutralismo, poiché quest’ultimo deriva da considerazioni geopolitiche. I paesi che scelgono la neutralità lo fanno in base a una percezione dei loro interessi o per timore di essere coinvolti (se non per entrambe le ragioni). Nel caso degli Stati Uniti, la paura non riguarda la catastrofe materiale, bensì quella morale. Gli americani partono dal presupposto di essere, almeno in modo astratto, avulsi dal mondo e la concezione che hanno del loro rapporto col sistema internazionale rispecchia l’idea dello stato di natura che sta alla base dalla loro fondazione e postula la separazione dell’uomo dalla politica. Così come quest’ultimo è nato libero, indipendente e al di fuori della polis, allo stesso modo gli Stati Uniti sono liberi, indipendenti e separati dal resto del mondo. E parimenti, così come l’attività politica rappresenta per l’uomo una scelta volontaria, lo stesso vale anche per l’intervento degli Stati Uniti nel mondo. In altri termini, il divario filosofico fra il loro orientamento geopolitico e quello del
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 146
146
resto del mondo è paragonabile alla disputa fra Locke e Aristotele, ovvero fra la politica intesa come scelta o, all’opposto, come tendenza intrinseca alla nostra natura. L’interventismo di Nixon non era ispirato da una visione messianica, né dettato da un’incombente minaccia esterna, bensì dalla natura del mondo, ovvero dalla geopolitica. La Guerra Fredda era dunque soltanto uno dei fattori, sia pure quello preponderante, che spingeva gli Stati Uniti ad assumersi delle responsabilità. L’America non era entrata nelle vicende internazionali solo per attuare una politica di contenimento e possibilmente distruggere l’Unione Sovietica, ma ne era coinvolta a priori, in permanenza, e la sfida rappresentata dal comunismo su scala globale costituiva la preoccupazione immediata, predominante nel quadro di un impegno più ampio, di lungo respiro, per la difesa degli interessi americani nel mondo. Questo non fu soltanto un cambiamento di ordine teorico, ma ebbe anche conseguenze pratiche. Come Nixon stesso spiegò in una delle formulazioni forse più concise della sua politica: Considereremo i nostri avversari comunisti innanzitutto e soprattutto come paesi che perseguono i loro interessi così come li interpretano, esattamente come facciamo noi. Li giudicheremo dalle loro azioni e ci attendiamo di venire giudicati dalle nostre. Accordi specifici, e la struttura di pace che contribuiranno a edificare, risulteranno da una commisurazione realistica degli interessi contrastanti3.
L’effetto immediato di questo nuovo indirizzo fu che diversamente dall’applicazione della politica di contenimento, «non riteneva una precondizione ai negoziati la trasformazione della società sovietica»4. La geopolitica avrebbe dunque avuto la meglio sul conflitto ideologico, almeno per il momento. Se questo mitigò in parte la componente morale dell’opposizione verso il regime sovietico, alleggerì anche il fardello di una lotta senza quartiere con la conseguente tentazione di presumere un cambiamento della società che non trovava poi alcun riscontro nei fatti, come solitamente avveniva con l’ascesa di un nuovo leader. Questo fu sempre più o meno il caso a ogni cambio della guardia dopo Stalin: Eisenhower e Kennedy riposero le loro speranze in Krusciov, Johnson fece lo stessa nei confronti di Brezˇnev, e infine Reagan confidò in Gorbaciov per il riscatto dell’Unione Sovietica.
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 147
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
147
Come abbiamo già messo in evidenza, sebbene la Guerra Fredda fosse stata scatenata da Mosca, essa fu largamente condizionata dagli Stati Uniti. La politica di distensione si basava sul consapevole riconoscimento di un ordine mondiale definito e governato dagli Stati Uniti; fu un tentativo di modificare l’assetto mondiale determinatosi in seguito alla lotta contro i sovietici. Ovvero un processo attraverso il quale lo stato di cose venutosi a creare con la Guerra Fredda divenne per la prima volta il centro d’interesse politico preminente. Più che il risultato di uno scontro tra due superpotenze avversarie, la Guerra Fredda venne vista come un conflitto in cui l’America svolgeva il ruolo di una potenza che cercava di mantenere lo status respingendo le continue provocazioni dell’estremismo sovietico: Berlino, la Corea, Suez, Cuba, il Vietnam ecc. Laddove in precedenza i responsabili della politica americana avevano considerato la posizione difensiva degli Stati Uniti come espressione della sua superiorità morale, Kissinger e Nixon la concepirono invece come un mero strumento per dimostrare la superiorità strategica del loro paese. In altre parole, l’America trovava la sua legittimazione nel mondo non soltanto in virtù della giustezza del suo sistema politico, ma anche della fiduciosa convinzione nutrita dalla maggior parte dei paesi esistenti – molti dei quali non davano troppa importanza al conflitto ideologico tra le due superpotenze – che un ordine internazionale garantito dagli americani sarebbe stato più favorevole ai loro interessi e alla stabilità generale di un sistema controllato dai sovietici. Questo fu anche il momento in cui, in seguito alla guerra del Vietnam, e in parte grazie alla tacita spartizione delle sfere di influenza in Europa, il baricentro della Guerra Fredda si spostò dal Vecchio Continente all’area, assai più instabile, dei paesi in via di sviluppo, dando luogo a un moltiplicarsi di eventi riassunti dallo storico americano Walter McDougall, fra i quali una serie di estenuanti missioni diplomatiche al fine di persuadere Anwar Sadat e gli israeliani a ritirarsi dal Sinai; il taglio, deciso dal Congresso, dei fondi destinati alla difesa della Cambogia e la caduta di questo paese nelle mani dei khmer rossi, responsabili del genocidio che seguì; l’offensiva nordvietnamita del 1975 e l’inutile battaglia, in seno al parlamento americano, per fornire aiuti materiali al Sud; l’evacuazione finale di Saigon e il sequestro della Mayaguez [Mayaguez [nave portacontainer americana erroneamente entrata in acque cam-
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 148
148 bogiane nel Golfo di Thailandia il 12 maggio 1975, N.d:T.]; la sconfitta del progetto di autonomia curda e il pericolo di un conflitto che sfociasse in un altro genocidio; i tentativi di chiamare a raccolta gli europei per superare la crisi energetica in corso e prevenire l’ascesa dei partiti eurocomunisti al governo dei diversi paesi membri della Nato. A ciò si aggiunga la decolonizzazione dell’Africa portoghese; l’intervento sovietico e cubano in Angola e il conseguente pericolo di una radicalizzazione dei conflitti e perfino di una guerra razziale nell’Africa; il collasso del Libano, precipitato in una guerra civile e nell’occupazione straniera; la crisi del Canale di Panama e i continui negoziati con l’Unione Sovietica e la Cina5.
Malgrado il trauma della sconfitta in Vietnam e le profonde divergenze nel campo della politica interna di quel periodo, furono raggiunti comunque dei risultati strategici molto apprezzabili. [...] nel corso della prima grande ritirata delle truppe americane della nostra storia, in circostanze molto umilianti [Nixon e Kissinger] migliorarono in effetti la posizione geopolitica degli Stati Uniti nei confronti della Cina, dell’Unione Sovietica e del mondo arabo6.
Questo nuovo orientamento geostrategico, del tutto inedito, favorì l’avvio di negoziati con l’Unione Sovietica, che si conclusero con un accordo storico sul controllo degli armamenti e, dopo la guerra del Kippur, consentì di sottrarre l’Egitto e la Siria all’orbita sovietica. Ma il suo più grande risultato fu indubbiamente il rapprochement con la Cina, ottenuto facendo leva sui suoi contrasti con l’Unione Sovietica in modo da esercitare pressioni su Mosca. Dando maggiore importanza alle differenze geopolitiche rispetto a quelle ideologiche ne sono derivati in effetti benefici innegabili (sebbene anche questo ebbe i suoi costi, come vedremo in seguito). I successi di questa politica, tuttavia, non l’hanno resa necessariamente ben accetta ai suoi beneficiari. Questo fu il caso, soprattutto, della fuoriuscita dal Vietnam che Nixon promise agli elettori, vincendo la corsa alla Casa Bianca. Facendo rientrare questo paese in una visione geopolitica, considerato come una delle tante aree di interesse strategico degli Stati Uniti, Kissinger fu in grado di fornire una qualche giustificazione per il disimpegno. Ma l’America non poteva ritirare a suo piacimento mezzo milione di soldati da un paese in preda al caos. Né poteva semplicemente abbandonare
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 149
149
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
i suoi alleati, che si era impegnata ad aiutare per tanto tempo, riconoscendo in questo modo che, in definitiva, al di là della fredda razionalità, fattori quali la fiducia e l’onore hanno importanza per le nazioni. Per sganciarsi, bisognava condurre davvero gli estremisti vietcong al tavolo della trattativa, il che a sua volta richiedeva misure durissime per indurli a negoziare, come l’intensificazione dei bombardamenti sulle città del Vietnam del Nord, compresa Hanoi, e la disseminazione di mine nei suoi porti. Ma l’iniziativa più controversa di tutte fu l’estensione della guerra alla Cambogia, che era utilizzata come un santuario per le truppe nemiche e per i loro rifornimenti. Ciò avrebbe determinato in seguito le dimissioni dell’assistente di Kissinger, Anthony Lake, ritornato alla ribalta, molti anni dopo, come consigliere per la sicurezza nazionale di Bill Clinton. Un altro esempio è l’idea fissa, di molti pacifisti di allora, che gli Stati Uniti avrebbero dovuto abbandonare il loro atteggiamento monolitico anticomunista per tentare un riavvicinamento con la Cina. Ma essi non compresero o non vollero capire che la continuazione dei bombardamenti sul Vietnam del Nord era proprio una delle carte più importanti che Washington poteva giocare nella partita con Pechino. Come osservò Walter McDougall, solo Nixon poteva avere qualche possibilità di successo [...] poiché era fermamente deciso a contrastare i tentativi di unificazione del Vietnam compiuti da Hanoi e a mantenere il controllo degli Stati Uniti sul sudest asiatico. Avrebbe dovuto essere ormai chiaro che la Cina appoggiava il Vietnam del Nord per motivi ideologici, ma non voleva che i vietnamiti (i quali odiavano la Cina) venissero riunificati sotto un regime sovietico proprio lungo il suo fianco meridionale. Qualsiasi presidente americano che si fosse recato a Pechino per scusarsi, promettendo di abbandonare il Vietnam del Sud al suo destino sarebbe stato messo alla porta. Per essere bündnisfähig – una pregnante espressione tedesca che significa «degni di essere corteggiati come alleati» – gli Stati Uniti dovevano essere strategicamente utili alla Cina, ovvero offrire un contrappeso per bilanciare l’influenza sovietica in Asia dissuadendo al tempo stesso Mosca dall’impiegare le sue armi nucleari7.
Ricorrendo alla forza per ottenere udienza dalla Cina e mantenere rapporti con Pechino la cui continuità dipendeva dalla propensione degli Stati Uniti a contrastare l’Unione Sovietica attraverso i ripetuti tentativi di rovesciare l’equilibrio di forze in Asia,
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 150
150
Nixon si attirò così l’antipatia di chi avrebbe voluto invece migliorare le relazioni con gli altri paesi. E nel trattare col regime forse più criminale del pianeta, dovette necessariamente trascurare il tema dei diritti umani, la cui violazione era stata proprio una delle accuse mosse dai progressisti contro la sua condotta della guerra nel Vietnam. Nel frattempo, coloro i quali erano rimasti convinti che si dovesse continuare a contrastare il comunismo, trovarono sospetta la nuova enfasi posta sulla geopolitica: gli Stati Uniti stavano seguendo semplicemente una politica di grande potenza o combattevano contro il male e la tirannia? Potremmo dire che Kissinger difese la posizione geopolitica dell’America in un momento di estrema debolezza, ma a spese di quella partecipazione emotiva dell’opinione pubblica necessaria a sostenere i costi della conduzione di una politica estera in un mondo pericoloso. Per parafrasare un giudizio di Churchill su Stalin, gli americani volevano i frutti della distensione senza adottare una politica adeguata allo scopo. I progressisti, che per anni avevano assunto posizioni più concilianti verso l’Unione Sovietica, furono soddisfatti dell’allentamento delle tensioni, mentre i conservatori erano contenti che l’America mantenesse le sue posizioni nel mondo. Ma queste politiche avevano anche dei costi. Basandosi su una fredda analisi dei rapporti di forza, che contemplava il ricorso a mezzi coercitivi per giungere a un negoziato, la politica di distensione entrava in contrasto con i valori condivisi dai progressisti. E, dal canto loro, i conservatori ripudiavano la sua natura essenzialmente geopolitica, poiché sminuiva l’importanza della lotta contro i regimi autoritari. Se da un lato apprezzavano i suoi risultati tattici, dall’altro temevano un arretramento strategico complessivo. Da questo punto di vista, il realismo di Kissinger finì per scontentare entrambe le tendenze ispiratrici della politica estera degli Stati Uniti. Vi è in effetti un realismo americano le cui radici risalgono ai padri fondatori, ovvero a un periodo anteriore alla nascita della nazione. A questa scuola di pensiero appartengono George Washington, Alexander Hamilton, John Quincy Adams e, naturalmente, Theodore Roosevelt. Ma si tratta di una tradizione distinta da quella dei cugini europei, che si è sempre basata su un ottimismo tipicamente americano. Pur se spesso incline a venire a patti con l’esistente e a perseguire interessi concreti, non ha mai abbracciato infatti la filosofia che sta alla base del realismo. E ha sempre negato,
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 151
151
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
in generale, l’esistenza di un conflitto permanente fra popoli e nazioni, considerando il perseguimento degli interessi nazionali come un mezzo per avvicinarsi ancor di più alla terra promessa. I suoi seguaci erano molto meno sofisticati dei realisti europei – non vi è infatti alcun Richelieu né alcun Bismarck nel pantheon americano – e la loro dottrina era in genere più che sufficiente per le necessità dell’America, data la sua posizione geografica particolarmente propizia. La nuova tradizione inaugurata da Kissinger si distingueva nettamente da quella precedente. Era molto più cauta, in parte a causa dell’esperienza bruciante della guerra nel Vietnam, ma anche perché derivava da una visione fondamentalmente pessimista dei rapporti fra gli uomini e le nazioni. Non a caso, sia Kissinger che Brzezinski, due dei maggiori esponenti americani di questa tendenza, erano entrambi stranieri, emigrati l’uno dalla Germania, l’altro dalla Polonia. E molti dei più influenti realisti oggi responsabili della politica estera degli Stati Uniti, come Peter Rodman, Brent Scowcroft e William Odom, sono stati in vari periodi loro pupilli. È tuttavia particolarmente significativo che una serie di idee che per secoli hanno ispirato il comportamento di Stati-nazione siano state considerate in America come una scuola di pensiero comunemente definita «realismo», per distinguerla da altre possibili visioni del mondo. Ma il nuovo realismo possedeva anche una componente idealistica peculiare. E la sua analisi si basava in fondo su un particolare tipo di sistema internazionale, diverso da molti altri. Come ha osservato Raymond Aron, i realisti americani hanno preso a riferimento momenti storici della politica europea in cui prevalse un «moderato machiavellismo» – come nel periodo intercorso fra le guerre di religione e la Rivoluzione Francese, o nel secolo a cavallo fra il Congresso di Vienna e la prima guerra mondiale – elevandoli a paradigma normativo delle immutabili esigenze dell’arte di governo. Il loro è stato un lamento conservatore, nostalgico e persino reazionario contro lo scatenamento dei disordini sociali nell’epoca dell’ideologia e della democrazia di massa8.
I realisti cercavano non solo di difendere un ordine particolare, ma anche di istituirne uno. Il loro vero desiderio, tuttavia, era quello di creare un ordine interno armonioso, avendo accettato molte delle difficoltà del mondo esterno. Dopo la dura prova del Vietnam che
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 152
152
aveva dilacerato la società americana trasformando le divergenze sulla strategia in aspri scontri; dopo le ingerenze del Congresso in settori della politica estera tradizionalmente appannaggio dell’esecutivo; e dopo l’influenza senza precedenti esercitata dai mass media sull’opinione pubblica (senza alcuna responsabilità politica), vi era un comprensibile desiderio di un luogo in cui uomini di Stato saggi e ponderati potessero prendere decisioni politiche, al riparo dalle violente passioni della moltitudine. Henry Kissinger viene definito spesso (in modo superficiale) come il fautore di una politica estera profondamente amorale. Ma basterebbe leggere attentamente i suoi molti libri per scoprire che è vero proprio il contrario. La sua dottrina e il suo operato politico hanno sempre mirato a infondere un’educazione favorevole alla pace, il cui pessimismo ammette concessioni su varie questioni di principio, non solo per ottenere vantaggi tattici, ma anche perché il margine di errore fra la stabilità e la catastrofe in un mondo pericoloso è molto sottile. La speranza di un felice e radioso futuro non trova fondamento nella storia del mondo. Anzi, in base a questa logica, ignorare le realtà dolorose è un atto d’irresponsabilità che può rasentare la malvagità. L’obiettivo di un serio uomo di Stato dovrebbe essere quello di riconoscere la fragilità di un ordine pacifico, cercando di mantenerlo a tutti i costi fino ad accettare compromessi morali pur di scongiurare conflitti che minacciano la civiltà come nel caso della Guerra dei Trent’anni o delle due guerre mondiali. È un insegnamento duro ma c’è dell’etica in questo ragionamento. Forse Kissinger non comprese appieno il moralismo tipicamente americano e fu proprio questo il motivo dei suoi più grandi insuccessi come statista, malgrado avesse adottato una politica estera coerente ed efficace, in circostanze estremamente sfavorevoli. [...] la correzione del moralismo progressista dell’epoca della Guerra Fredda, operata da Kissinger, non fu un’impresa senza difficoltà. Pur stupendo il mondo con la sua apertura alla Cina e con la politica di distensione nei confronti dell’Unione Sovietica, mentre continuava a moraleggiare sui guasti provocati dal moralismo americano che ostacolava una politica estera più chiara e razionale, egli si rese conto di non avere il consenso necessario dal popolo americano né dai suoi rappresentanti quando volle far giocare all’America il ruolo della grande potenza, sostenendo ad esempio gli anticomunisti ribelli in Angola o reagendo alla violazione del cessate il fuoco da parte dei nordvietna-
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 153
153 miti. Per la maggioranza degli americani, o i sovietici erano cattivi e la Guerra Fredda continuava, per cui vi restavamo invischiati, nonostante la tregua raggiunta nel Vietnam, oppure era tutto un gioco diplomatico alla Metternich, un freddo calcolo degli equilibri che li lasciava indifferenti all’Angola, e tanto più al Vietnam. Il fatto è che il sistema americano richiede una legittimazione pubblica della politica estera e per questa ragione, il realismo si tramuta in una forma di idealismo. Al pari del moralismo progressista, anch’esso confida nel predominio indisturbato della ragione, ed è perciò tanto più idealista quanto più sembra farsi beffe del moralismo9.
Se Kissinger aveva ragione nel merito riguardo alla situazione degli Stati Uniti in rapporto a quella che Reinhold Niebhur definiva «la questione internazionale», non riuscì mai, tuttavia, a riconciliare la sua visione con la profonda aspirazione degli americani a svolgere un ruolo di guida, al di là della semplice necessità di barcamenarsi in un mondo pieno di insidie. Il riemergere della geopolitica provocò reazioni forse inevitabili da parte delle nuove correnti di pensiero sorte dal crollo del vecchio establishment, ciascuna delle quali comprendeva elementi diversi della tradizione americana e offriva distinte alternative al mero realismo degli anni di Kissinger.
NOTE
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
1
Kissinger H.A., A World Restored: Metternich, Castlereagh and the Problems of Peace 1812-1822, Boston, Houghton Mifflin, Sentry Edition, 1973 (trad. it., Diplomazia della Restaurazione, Garzanti, Milano, 1973, traduzione di Elena Brambilla, p. 9). 2 Nixon R., «First Annual Report to the Congress on United States Foreign Policy for the 1970’s», February 18, 1970, in Nixon Papers, 1970 vol., p. 119 (citato in Kissinger, Arte della diplomazia, trad. it. cit., pp. 553-554). 3 Ibid., p. 179 (cit. in Kissinger, Arte della diplomazia, trad. it. cit., p. 554). 4 Kissinger, Diplomacy, Simon & Shuster, New York, 1994, p. 713 (trad. it., L’arte della diplomazia, Sperling & Kupfer, Milano, 2004, p. 554). 5 McDougall W., «Henry Act III: Review of Henry Kissinger’s ‘Years of Renewal’», The National Interest, estate 1999. 6 Kaplan R.D., «Kissinger, Metternich, and Realism», The Atlantic Monthly, June 1999, Vol. 283, nr. 6, pp. 73-82. 7 McDougall, op. cit. 8 Mahoney D.J., «De Gaulle and the Death of Europe», The National Interest, estate 1997. 9 Baumann F., «Neoconservatism and American Foreign Policy», Conferenza tenuta presso lo Smith College, 9 marzo 2004.
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 154
CAPITOLO NONO
LA RISPOSTA IDEALISTICA
Con lo sgretolamento dell’establishment, che pose fine al consenso bipartisan pluridecennale sulla politica estera, i sopravvissuti cominciarono a riorganizzarsi e ciascun gruppo tornò a far riferimento a diverse correnti di pensiero tradizionali. Ma la differenza più importante fu che, allora, la vecchia dialettica fra idealismo e realismo non operava più all’interno in un’unica tradizione, bensì di due schieramenti politici contrapposti. Il cambiamento forse più significativo ebbe inizio con la radicalizzazione della tendenza idealistica durante la guerra del Vietnam, specialmente fra i giovani. Ma se il vecchio idealismo di stampo isolazionista, che consigliava anch’esso un ritiro, aveva creato ostacoli a una coerente politica estera, il nuovo tendeva invece a rimettere in discussione l’identità stessa degli Stati Uniti, portando alla disintegrazione della coesione interna. E se il primo era nato dal timore che l’America potesse perdere la sua anima lasciandosi coinvolgere dal mondo esterno, il secondo si basava al contrario sulla convinzione che l’avesse già persa, posto che ne avesse mai posseduta una. Come dichiarò Tom Hayden, uno dei principali esponenti della sinistra americana di questo periodo, che fu tra i fondatori del movimento Students for a Democratic Society: «Ci rifiutiamo di essere anticomunisti. Insistiamo che il termine ha perso da tempo il suo contenuto specifico. Serve invece da categoria basilare di pensiero astratto usata in America per giustificare una politica estera non più evoluta dello stupro»1. Fu proprio questa profonda spaccatura che provocò, per reazione, l’avvento dei neoconservatori, risentiti del fatto che la sinistra si era appropriata del linguaggio della moralità per denigrare il proprio paese e, peggio ancora, lo usava per convincere gli Stati
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 155
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
155
Uniti a rinunciare a tutti i loro impegni internazionali per salvarsi l’anima. Molti di loro erano democratici formatisi nella temperie della Guerra Fredda, che si opposero allo spostamento a sinistra del loro partito, convinti che le tendenze pacifiste concilianti di George McGovern – candidato democratico alla presidenza nelle elezioni del 1972 – e dei suoi sostenitori tradissero i principi originari della politica di contenimento. Raggruppatisi intorno al senatore Henry «Scoop» Jackson, formarono una fazione in seno al loro partito (fin quando non confluirono in gran numero in quello repubblicano all’epoca di Reagan) e fu sotto la sua egida che cominciarono a formulare la critica più penetrante della distensione, gettando le basi di una disputa ideologica che continua ancor oggi. Per la maggior parte non erano conservatori, ma semplicemente dei falchi di tendenze liberali che non condividevano le posizioni assunte dallo stesso liberalismo americano subito dopo la guerra del Vietnam. L’altra ala era composta invece dai neoconservatori attuali, ovvero da personaggi con un passato di sinistra, se non addirittura trotzkista. Era essenzialmente un movimento di intellettuali, i cui padri storici, in particolare Irving Kristol e Norman Podhoretz, svoltarono a destra verso gli anni Cinquanta e Sessanta e fecero della critica al progressismo americano del dopoguerra il loro credo. E furono proprio i loro vecchi compagni di strada a etichettarli come «neoconservatori» in quanto avevano tradito la causa della sinistra con il loro anticomunismo. Diversamente dai razionalisti come Kissinger, si erano subito resi conto, in parte perché provenivano dalle sue stesse fila, del problema che la sinistra rappresentava per la politica estera degli Stati Uniti. Minando le basi di qualsiasi geostrategia americana, essa rendeva infatti estremamente difficile la giustificazione della politica e ovviamente anche dei sacrifici necessari al perseguimento degli interessi del paese. Anche se non si trattava, a ben vedere, di un problema strategico bensì ideologico, non soltanto all’estero, ma anche in patria. Fu proprio questo che Kissinger, nonostante la sua acutezza intellettuale, non riuscì a comprendere e gli impedì di ottenere un più largo consenso dei cittadini americani alle sue politiche volte a salvaguardare i loro interessi. Ovviamente, il neoconservatorismo è diventato oggi un termine improprio, poiché si riferisce agli eredi dei suoi antesignani
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 156
156
(che in alcuni casi sono, letteralmente, i loro discendenti, come Bill Kristol, figlio di Irving e direttore della rivista di questa tendenza, The Weekly Standard), i quali, per lo più non sono dei nuovi adepti, ma hanno semplicemente raccolto il testimone. Questo gruppo ha una visione molto più idealistica della potenza americana e della sua influenza nel mondo rispetto alla generazione precedente, poiché la sua esperienza decisiva è stata quella dell’epilogo della Guerra Fredda, non già dei suoi giorni più bui. Il loro punto di partenza è stato la critica della politica della distensione, formulata dal senatore Jackson e dai suoi seguaci, fra i quali il giovane Richard Perle. Essi erano in disaccordo con Kissinger poiché mirava a una coesistenza pacifica con l’Unione Sovietica, anziché alla sua disfatta, e gli attribuirono di fatto, preventivamente, la responsabilità dell’applicazione di tale politica da parte di Carter, che la ereditò. Da questo punto di vista, essi colsero in parte nel segno, poiché la coesistenza favorita dai negoziati avrebbe indotto alla fine a scambiare la temporanea attenuazione delle tensioni per una vera pace. Fu proprio questo orientamento, che va sotto il nome di «funzionalismo», a definire la politica estera dell’era clintoniana, specialmente riguardo ai vari «processi di pace» – in Medio Oriente, nell’Irlanda del Nord, a Cipro ecc. – in cui si pensò che sarebbe stato possibile raggiungere una stabilità duratura mediante graduali intese diplomatiche al vertice anziché attraverso un mutamento dei rapporti di forza esistenti. In effetti, un «processo» di pace genera una propria versione di quest’ultima, che nei fatti però si rivela una stabilità alquanto precaria poiché esiste soltanto all’interno di una realtà ineffabile popolata da diplomatici e capi di Stato abili nel manipolare i mass media. Anche se lo spirito che anima questi incontri al vertice è solitamente sincero, almeno nel caso delle democrazie liberali, che tendono a considerare la pace come uno stato di cose naturale. Perfino la guerra è vista come strumento che porta alla pace dopo di essa, rendendo questo obiettivo l’unica motivazione valida del conflitto, oltre a quella dell’autodifesa. Così, si presume, fin troppo spesso, che la buona fede dimostrata al tavolo delle trattative verrà contraccambiata dagli interlocutori. Alla base di questa idea, vi è la convinzione che la pace sia di fatto la cosa preferibile e che offrendo questa alternativa – attraverso i negoziati – i paesi interessati tenderanno generalmente a non scartarla.
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 157
157
Ma, come sostiene Irving Kristol con un’argomentazione che Kissinger senz’altro condividerebbe:
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
Quando delle entità collettive entrano in urto, la ragione va ricercata solitamente in un contrasto d’interessi. Un tentativo di mediazione può in qualche caso essere utile, purché questo non venga confuso con la risoluzione del conflitto, che è una cosa completamente diversa. Questa infatti tende soprattutto a modificare gli atteggiamenti psicologici prevalenti all’interno di ciascuno dei due campi contrapposti, mentre la mediazione mette l’accento sugli interessi in gioco e cerca di prospettare un accordo che sia minimamente soddisfacente per entrambi i contendenti per poi persuaderli ad accettarlo. Una delle differenze fondamentali fra questi due metodi, è che il primo mira essenzialmente al compromesso, mentre il secondo tende a promuovere una «maggior fiducia e comprensione», nella convinzione che ciò porrà inevitabilmente fine al conflitto creando una pacifica armonia2.
Il «sollievo» – per dirla con Churchill – derivante dalla politica di distensione fu dovuto ai negoziati, che diedero frutti grazie soprattutto a un particolare equilibrio geopolitico che incoraggiò i sovietici a sedere al tavolo delle trattative e a dar prova di moderazione nei loro comportamenti. Ma la loro propensione a ricercare intese non si basava sulla convinzione che la pace fosse obiettivamente desiderabile – come spesso le democrazie liberali (compresa l’America) danno per scontato – bensì in quanto ritenute necessarie o quantomeno funzionali ai loro interessi geopolitici. In questo caso, i negoziati rappresentavano la fine e non l’inizio di una lunga serie di manovre. Per avvicinarsi alla Cina, Nixon intensificò i bombardamenti sul Vietnam del Nord allo scopo di dimostrare che, sebbene le truppe americane stessero ritirandosi, non avrebbero permesso la conquista della regione da parte dei vietcong, invisi a Pechino nonostante la sua solidarietà ideologica. L’apertura alla Cina servì così a sottrarre ai sovietici un importante strumento di pressione, rendendo la trattativa molto più allettante del confronto. Nel frattempo, in Medio Oriente ciò comportò un appoggio a Israele (soprattutto attraverso la vendita di armi) nella guerra del 1973, per creare una situazione di stallo che non fosse troppo schiacciante per i paesi arabi, ma rendesse chiaro comunque che l’appoggio sovietico non li avrebbe aiutati a raggiungere i loro scopi e che, in ultima analisi, qualsiasi cambiamento della situazione geopolitica in questo scacchiere sarebbe stato impossibile senza il con-
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 158
158
senso degli Stati Uniti, ovverosia che l’«America aveva tutte le carte in mano», come ebbe a dire Anwar Sadat. Ciò richiese inoltre una pressione sempre più forte sulla regione del Golfo, esercitata da Nixon mettendo in stato di massima allerta le forze nucleari, in modo da bloccare l’intervento dei sovietici, costringendoli a far affidamento sui loro alleati ridotti all’impotenza: una manovra cui Johnson fu restio a ricorrere durante la guerra arabo-israeliana del 19673. Tutto questo sta a dimostrare che i negoziati SALT 1 (sulla limitazione delle armi strategiche), tanto per fare un esempio, vennero avviati non tanto perché le due superpotenze riconobbero di comune accordo che la riduzione delle forze nucleari fosse altamente desiderabile, ma in quanto i sovietici avevano bisogno di un programma che consentisse loro uno spazio di manovra diplomatico: una necessità creata contrastando le loro mire geopolitiche nel maggior numero possibile di regioni del mondo. Ma il grande successo di molte di queste politiche, che spinsero Mosca alla moderazione, creò la sensazione che si fosse prodotto un cambiamento di mentalità permanente da parte dei leader sovietici, ingenerando proprio quell’errore che la politica della distensione intendeva evitare. In un certo senso, i neoconservatori avevano avuto ragione nel sostenere che quanto più efficace sarebbe stata questa politica, tanto più essa avrebbe messo in ombra il conflitto di fondo fra le due superpotenze a scapito degli interessi americani. È essenzialmente quel che accadde all’epoca di Carter, quando i frutti della distensione vennero visti semplicemente come il prodotto spontaneo di tale politica. Ma ciò equivaleva, per così dire, ad abbellire la propria casa, senza preoccuparsi minimamente delle sue fondamenta. Questa fu dunque la critica dei neoconservatori. Ma qual era la loro soluzione? Se essi ebbero il merito di riconoscere che non si poteva negare il conflitto tra Stati Uniti e Unione Sovietica, era allora inevitabile chiedersi: se il conflitto derivava essenzialmente dalla natura del regime sovietico, cosa sarebbe accaduto dopo il suo crollo? Gli Stati Uniti avevano altri orizzonti al di là della Guerra Fredda? Quali rapporti avrebbero instaurato col resto del mondo quando sarebbe finita? Tutti problemi cui si trovarono di fronte in un volger di tempo più breve di quanto si potesse mai prevedere. Ma prima che le loro idee si traducessero in azioni politiche, un
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 159
159
filone di pensiero molto diverso, ma di analoga matrice, avrebbe visto ben presto la luce.
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
Carter Jimmy Carter cercò di dare una risposta alla Guerra Fredda, ereditata dalla sua presidenza, rifiutando sia l’enfasi posta da Kissinger sull’equilibrio di forze, sia l’anticomunismo che l’aveva contraddistinta in origine. Così, l’isolazionismo trovò un nuovo alfiere nel sostenitore della difesa dei diritti umani nel mondo come elemento distintivo della politica estera americana. E il vecchio ideale della diffusione della democrazia trovò una nuova espressione. Al di là dei suoi nobili intenti, quest’impresa non può essere disgiunta da un’attenta considerazione delle realtà politiche. Presuppone un sostegno a un particolare tipo di regime e induce chi la sostiene a operare distinzioni fra particolari paesi, ovvero a considerarli per quel che in effetti sono, sia pure soltanto al fine di immaginare come potrebbero essere. Nel contesto della Guerra Fredda, l’importanza attribuita alla democrazia polarizzò l’attenzione sulle differenze fra le due superpotenze e quindi sul loro antagonismo fondamentale. Sposando invece la causa dei «diritti umani» Carter separò il suo idealismo dalla geopolitica della Guerra Fredda alla ricerca di un terreno transnazionale e, in ultima analisi, apolitico per lanciare questa campagna. Da questo punto di vista, essa rappresenta la sublimazione finale della visione di Wilson – che a sua volta fu una sublimazione dell’universalismo di Jefferson – avendo spostato il baricentro dalla geopolitica alla politica comparata per finire nella pura astrazione. Carter è stato una delle figure più singolari della storia americana: un populista sinistroide, che ha riscosso il maggior successo dopo William Jennings Bryan. Entrò in corsa per la presidenza come un outsider fuori dai giochi di Washington, conquistando credito come politico antiestablishment, doppiamente estraneo alla cricca che aveva trascinato l’America nell’avventura del Vietnam. Ma, al tempo stesso, in modo sorprendente, cooptò nel suo governo molti uomini, come Anthony Lake e Cyrus Vance, cresciuti alla scuola del vecchio establishment e oggi in cerca di riscatto dopo esser stati segnati dalle loro esperienze. Il netto rifiuto della bellicosità tipica di una superpotenza, unito
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 160
160
al sospetto verso quello che Carter definiva «il timor panico per il comunismo internazionale» e al rigetto d’ogni soluzione di forza concorsero ad alimentare la convinzione che le tradizionali finalità politiche di uno Stato fossero intrinsecamente autodistruttive, per cui dovevano essere sostituite da obiettivi che trascendevano i ristretti interessi di uno Stato-nazione. La débâcle del Vietnam fu la convalida di questa visione del mondo, che, dapprima, venne sostenuta dalla corrente di Henry Wallace in seno al Partito Democratico del dopoguerra. E il fatto che questo orientamento avesse preso corpo sotto gli auspici di due successive amministrazioni democratiche sembrò semplicemente sottolineare la tragica urgenza del loro messaggio. È illuminante inquadrare il punto di vista di Carter sullo sfondo della politica della distensione che egli aveva ereditato dalle amministrazioni di Nixon e Ford, e in particolare sotto quali aspetti si discostava da quello dei suoi artefici originari. In conseguenza [della geopolitica di Nixon] i progressisti si trovarono in un disagevole imbarazzo: i risultati diplomatici che approvavano nella sostanza, come l’allentamento della tensione con l’Unione Sovietica e l’apertura alla Cina, emergevano da principi scomunicati dalla tradizione wilsoniana, come l’interesse nazionale e l’equilibrio delle forze4.
Quello che inizialmente era stato concepito come un mezzo per conseguire uno scopo – la coesistenza come leva per accrescere il peso dell’America all’interno di un ordine bipolare in funzione dei suoi interessi particolari – divenne in seguito un fine in sé, ovvero il raggiungimento di una pace definitiva attraverso di essa, senza compiere alcun tentativo di subordinare la riduzione delle forze militari all’obiettivo di garantire un equilibrio geopolitico. Così, nel giro di pochi mesi dalla firma degli accordi SALT 2 a Vienna nel giugno del 1979, i sovietici invasero l’Afghanistan. Se Carter aveva ragione quando affermava che non tutti gli sviluppi della situazione internazionale erano riconducibili alla Guerra Fredda, come più volte ribadì – e anche Kissinger avrebbe concordato – è altrettanto vero che la maggior parte di essi ebbe un qualche effetto sulla posizione geopolitica degli Stati Uniti e quindi sulla loro capacità di continuare a combattere quella battaglia, come Kissinger avrebbe sostenuto.
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 161
161
Ma anche a Carter, come del resto ai neoconservatori, stava profondamente a cuore l’identità nazionale dell’America. Dal suo punto di vista, questa sarebbe stata rafforzata dimostrando la legittimità delle sue ingerenze negli affari internazionali, essenzialmente attraverso la rinuncia ai suoi interessi particolaristici.
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
Il nostro impegno per la salvaguardia dei diritti umani dev’essere incondizionato [...] La nostra società è stata la prima a definire se stessa in termini di libertà e di valori spirituali. Ed è proprio questa sua autodefinizione, che la contraddistingue da tutte le altre, a imporci un obbligo speciale: quello di adempiere ai nostri doveri morali che, una volta assunti, appaiono invariabilmente conformi ai nostri migliori interessi5.
Ma quella che sembrava una nuova e più decente forma di internazionalismo non era di fatto così diversa dalla tradizione che pretendeva di spazzare via, anche se né gli esponenti dell’amministrazione Carter né i suoi oppositori si sarebbero dati la pena di riconoscerlo. Essa rappresentava, infatti, una sorta di solipsismo, che vedeva gli imperativi geopolitici attraverso le lenti di un’esigenza interna. Il Nicaragua divenne il primo paese in cui sarebbe stata sperimentata la politica di Carter. Il vicesegretario di Stato, Warren Christopher (divenuto in seguito ministro degli Esteri all’epoca di Clinton), annunciò la sospensione degli aiuti al regime di Somoza. A prima vista, sembrò che Washington stesse prendendo le distanze da un dittatore avido e brutale, per adottare una politica estera più umana che non richiedeva (presumibilmente) grandi sacrifici, ma il paese in questione non era d’interesse strategico per gli Stati Uniti. Ma l’esito di questa piccola svolta di secondaria importanza nel quadro dei grandi impegni internazionali dell’America fu la rapida, efficace e del tutto imprevista riorganizzazione dell’opposizione sandinista, che avrebbe guidato con successo una rivoluzione e instaurato un regime estremista con l’obiettivo di esportare il suo modello di tipo leninista nei turbolenti stati confinanti del Salvador e del Guatemala. Questa politica fu una sorta di nuova versione del clamoroso ripudio del corollario Roosevelt alla dottrina Monroe da parte del presidente Herbert Hoover nel 1930. Nei quattro anni dell’amministrazione Carter, l’America Latina fu sconvolta da una cinquan-
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 162
162
tina di rivoluzioni. E il problema che si poneva altro non era, in sostanza, che il riemergere del vecchio dilemma imperiale dell’America: quali erano i limiti morali all’esercizio della sua potenza? Nel frattempo, con una decisione dalle conseguenze ancor più devastanti, nel momento in cui scoppiarono i disordini in Iran, Carter negò l’aiuto necessario allo scià che, pur avendo instaurato un regime autoritario, era un vecchio alleato degli Stati Uniti. Così, quando la rivoluzione del 1979 segnò l’avvento di una repubblica islamica ostile sotto la guida dell’ayatollah Khomeini, l’America cominciò a perdere terreno in Medio Oriente e dovette subire in seguito anche l’umiliazione del sequestro degli ostaggi nella sua ambasciata a Teheran. Posto di fronte alle implicazioni inevitabilmente imperiali di una politica estera su scala globale, Carter scelse deliberatamente la via del rigore morale. Ma l’ironia della storia volle che il nuovo regime si dimostrasse assai più brutale e opprimente di quello dello scià e, data ormai la sua profonda tendenza antiamericana, gli Stati Uniti non potevano più esercitare alcuna influenza per migliorare la situazione dei diritti umani in quel paese. Il problema era allora lo stesso che affligge oggi molti burocrati delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea e il personale di varie organizzazioni non governative, come pure tanti americani. Quando si pongono i diritti umani completamente al di fuori della sfera politica, si instaura una dicotomia artificiale quanto impossibile. Artificiale perché questa sfera è l’unica in cui tali diritti possono essere salvaguardati in modo duraturo (se poi ciò avvenga o meno è un’altra questione); impossibile poiché non è dato compiere scelte contro la politica, specialmente quando si è il leader di una superpotenza. Il risultato è in tal caso la svalutazione degli interessi e degli strumenti politici, come strumenti, sia pure imperfetti, per creare un mondo migliore. E nel momento in cui le grandi speranze, solitamente infondate, in questo futuro radioso, subiscono un tracollo, ne consegue l’inevitabile cinismo che deriva dalle aspettative deluse. Questa deriva fu, per molti aspetti, la triste eredità che Carter lasciò al Partito Democratico. Qualsiasi politica estera o di potenza venne considerata sempre più sospetta. Così, il suo idealismo trovò espressione al di fuori della tradizionale sfera della vita politica: nelle organizzazioni non governative, sussidiarie delle Nazioni Unite, nei media e nel mondo accademico. Nel frattempo, la tendenza neoconservatrice, emersa dalle tensioni della guerra del Vietnam e rinvigorita negli anni della di-
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 163
163
stensione, trasse ulteriore forza dalla reazione alla politica estera di Carter, trovando in seguito il suo campione nel presidente che gli succedette.
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
Reagan Ronald Wilson Reagan (il secondo cognome gli era quanto mai confacente), un ex attore cinematografico di serie B, inaugurò una nuova era della politica estera americana, al tempo stesso rivoluzionaria e reazionaria, dandogli nuovo impulso, grazie al superamento del realismo di Kissinger e del pacifismo di Carter, e cercando di ritornare all’anticomunismo originario, precedente alla guerra del Vietnam, della strategia di contenimento. Da buon americano, egli non concepiva i conflitti geopolitici come dati strutturali, bensì come fenomeni derivanti da scelte politiche e morali sbagliate. La politica estera degli Stati Uniti nel corso del XX secolo rispondeva a un progetto educativo contrapposto a quei regimi che minacciavano l’ideale americano dell’ordine naturale6. E il suo piano per porre fine alla Guerra Fredda avrebbe seguito il solco di questa tradizione. La sua politica del confronto derivava dalla convinzione che il conflitto sottostante da cui era nata la contrapposizione fra Unione Sovietica e America fosse inevitabile, ovvero che il problema consistesse nella natura stessa del regime sovietico e sarebbe stato risolto solo con la sua distruzione. Da qui il carattere peculiare della sua politica estera, che non disdegnava l’impiego di una tattica brutalmente realista (con il finanziamento di gruppi non democratici in Nicaragua e in Afghanistan, fra gli altri, e un massiccio riarmo volto a neutralizzare il dispositivo sovietico) in funzione di un disegno profondamente idealistico: il rifiuto della coesistenza con il comunismo, anche a spese della pace e della stabilità. La sue armi iniziali furono la retorica e l’ideologia, con l’esortazione a non trascurare mai la questione della natura di questo regime. Famosa restò la sua definizione dell’Unione Sovietica come «impero del male». In un senso ironico, Karl Marx aveva ragione. Stiamo assistendo oggi a una grande crisi rivoluzionaria, in cui le esigenze dell’ordine econo-
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 164
164 mico entrano in conflitto con quelle dell’ordine politico. Ma questa non ha luogo nell’Occidente libero, non marxista, bensì nella patria del marxismo-leninismo, l’Unione Sovietica [...]7.
Reagan era molto più deciso a imporre il rispetto dei diritti umani previsto dagli accordi di Helsinki, firmati – è interessante notarlo – all’epoca dell’amministrazione Ford. Ma diversamente da Ford e Kissinger che avevano visto in questo un mezzo per stabilire una serie di norme internazionali a lungo termine derivanti dai principi cari agli americani, e da Carter che cercò di farli valere soprattutto nei paesi che non costituivano una minaccia strategica per gli Stati Uniti, Reagan era pronto a lanciare una campagna indiscriminata, trasformando questa parola d’ordine in una politica specifica. Dopo la repressione di Solidarnos´c´, il movimento nazionale della resistenza sindacale in Polonia, egli reagì con sanzioni molto dure, bloccando la riprogrammazione del debito della Polonia. E affrontò direttamente il problema fondamentale della contrapposizione fra i due blocchi fornendo un crescente sostegno ai dissidenti sovietici, ovvero a una causa che era stata in origine motivo di contrasto fra il gruppo dei democratici schierati col senatore Jackson e l’amministrazione Nixon. Ma non furono solo i regimi comunisti a venir sottoposti a pressioni. Nel 1987, alla giunta militare al potere nella Corea del Sud venne impedito di giustiziare il leader dell’opposizione Kim Dae Jung e le fu imposto di indire libere elezioni, pena la perdita dell’appoggio americano. Anche il dittatore di destra Augusto Pinochet venne costretto a concedere il voto ai cileni e perse il potere in seguito a quelle consultazioni. La Casa Bianca sostenne inoltre la rivoluzione democratica che rovesciò il regime filoamericano di Marcos, grazie soprattutto all’insistenza di Paul Wolfowitz, allora vicesegretario di Stato. E in nessuno di questi casi gli Stati Uniti avevano chiaramente interesse a far cadere governi loro alleati nella lotta contro il comunismo. La verità è che nel comune accento posto sui diritti umani, le opposte fazioni di Reagan e di Carter erano molto più concordi di quanto i partigiani dell’una e dell’altra sarebbero stati mai disposti a riconsocere, proprio come molti neoconservatori e progressisti di oggi. Ma l’amministrazione Reagan adottò un orientamento più pragmatico rispetto a quella di Carter, accettando la distinzione intro-
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 165
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
165
dotta da Jeanne Kirkpatrick fra i regimi non democratici che rappresentavano una minaccia per gli interessi americani e quelli con i quali era invece possibile una coesistenza, se non addirittura una cooperazione8. Dopo la fine della Guerra Fredda, questa distinzione era stata gradualmente abbandonata sia dai democratici che dai repubblicani e sostituita da una più semplicistica fra regimi democratici e non democratici. Reagan non condivideva inoltre la tendenza di Kissinger a considerare la superiorità geopolitica come prioritaria rispetto alla superiorità strategica nucleare, ma era convinto che si potessero raggiungere entrambe simultaneamente. E intuì (correttamente) che la debolezza politica ed economica del sistema sovietico non gli avrebbe permesso di sostenere a lungo il confronto con gli Stati Uniti nella corsa agli armamenti. Per questo motivo, respinse le intese sul controllo degli armamenti, favorendone invece lo sviluppo e il dispiegamento. Il più grande successo della sua politica, l’«opzione zero», concepita da Richard Perle, allora vicesegretario di Stato, è un esempio significativo dell’orientamento neoconservatore. Nell’estate del 1982, in risposta all’istallazione dei missili nucleari sovietici SS-20 nella Germania dell’Est, in grado di raggiungere l’Europa Occidentale (anche se non ancora gli Stati Uniti), la NATO programmò un dispiegamento di forze nucleari di media gittata in Europa, con gli affusolati Pershing II, in grado di raggiungere Mosca e distruggerla in pochi minuti, come pezzo forte del nuovo arsenale. Yuri Andropov reagì allora minacciando l’abbandono d’ogni tavolo di trattativa per la riduzione degli armamenti se questi missili fossero stati installati sul suolo europeo. Ne seguì una protesta di massa contro l’America e la NATO. Il cancelliere tedesco Helmut Schmidt venne costretto a dimettersi per aver approvato questa misura. Gli americani temettero allora una spaccatura all’interno dell’Alleanza Atlantica – strumento fondamentale della loro politica internazionale – come risultato del tentativo di affermare una superiorità nucleare strategica. Paul Nitze, uno degli estensori dell’NSC-68 e in seguito responsabile delle trattative sugli euromissili, bollato in modo sprezzante da Richard Perle come «un incallito risolutore di problemi» (sottintendendo con questo che in alcuni casi bisognava evitare ogni compromesso) cercò disperatamente una via d’uscita, offrendo ai Sovietici un accordo che avrebbe consentito loro di mantenere al-
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 166
166
cuni missili SS-20, anche se l’America non avesse dispiegato i Pershing9. Richard Perle, invece, propose l’«opzione zero», che prevedeva un ritiro di tutti gli SS-20 altrimenti l’America avrebbe istallato tutti i suoi 572 Pershing. Il che equivaleva a escludere ogni ipotesi di negoziato. Ma il punto essenziale non era quello di trovare una posizione intermedia possibile, né di puntare sul disarmo fine a se stesso, bensì di dimostrare sia ai sovietici sia agli europei che gli Stati Uniti erano pronti ad assumersi una responsabilità politica pur di garantire la sicurezza dei loro alleati. Inutile dire che il controdispiegamento non era ispirato da una «teologia» della distensione. Il dramma non riguardava «i circoli di errore probabile» o «le capacità di colpire bersagli pesanti», ma si trattava di un gioco vecchio quanto le disquisizioni di Tucidide sulla guerra del Peloponneso: un semplice test per saggiare la determinazione e la forza [...]10.
Ciò comportava il riconoscimento che i sovietici stavano tentando di giocare politicamente gli Stati Uniti, non semplicemente di sopravanzarli militarmente. Dietro gli astrusi tecnicismi che solitamente appesantivano i negoziati sul controllo degli armamenti, vi erano problemi ben più seri e fondamentali. Si trattava cioè di stabilire se gli Stati Uniti avrebbero potuto mantenere la loro legittimità politica presso i loro alleati, anche se avessero cambiato strategia strada facendo, ovvero se l’autorità dell’America nel mondo era basata soltanto sulla forza o su qualche altra cosa come essa aveva sempre preteso. La politica di Reagan avrebbe portato direttamente ad affrettare il crollo dell’Unione Sovietica – il primo impero che si sia mai estinto per morte naturale – sebbene la spallata finale gliela diede il presidente che venne dopo. Il suo successo fu straordinario e di stampo schiettamente americano. Egli intuì non solo le possibilità geopolitiche di un rinnovato confronto, ma, cosa ancor più importante, data la natura del suo paese, l’occasione di assicurare agli Stati Uniti un certo grado di coesione interna e di rimotivarne l’impegno in campo internazionale, a distanza di così breve tempo dopo la débâcle del Vietnam. Ma questo stesso successo avrebbe creato, contemporaneamente, molti nuovi problemi. Pur se straordinariamente efficace, il suo ap-
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 167
167
proccio ideologico finì per offuscare, agli occhi dei suoi eredi, le questioni geopolitiche affrontate, facendo apparire il suo pensiero eccessivamente schematico. Inoltre, se i benefici morali e strategici derivanti dal sostegno della causa della democrazia liberale ebbero effetti innegabilmente positivi nel galvanizzare gli americani e indebolire i sovietici, in assenza dell’URSS questa politica divenne naturalmente un surrogato di una grande strategia. Così, dopo avere asserito la validità e la superiorità dei regimi democratici, non restava altro da fare che favorire il corso della storia. Ma, soprattutto, nel ricentrare in modo così efficace la coscienza della nazione sulla posta in gioco della Guerra Fredda, le sue politiche ebbero l’effetto di ridurre la funzione dell’America nel mondo a quella di distruggere l’Unione Sovietica, mettendo in ombra i più ampi problemi geopolitici permanenti che avrebbero dovuto affrontare inevitabilmente dopo la vittoria.
NOTE
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
1
Citato in Kissinger, Diplomacy, Simon & Shuster, New York, 1994, p. 668 (trad. it., L’arte della diplomazia, Sperling & Kupfer, Milano, 2004, p. 519). 2 Kristol I., «Conflicts That Can’t Be Resolved», AEI On The Issues, 5 settembre 1997. 3 Per un resoconto avvincente dell’attività diplomatica relativa a questo periodo vedi Kissinger H., Crisis: The Anatomy of Two Major American Foreign Policy Crises, Simon & Schuster, New York, 2003. 4 Kissinger, Diplomacy, p. 743 (trad. it. cit., p. 578). 5 Carter J., Inaugural Address, 20 gennaio 1977. 6 Bloom A., Closing of the American Mind, Simon & Schuster, New York, 1987. 7 Reagan R., Address to Members of the British Parliament, Londra, 8 giugno 1982. 8 Kirkpatrick J., «Dictatorships and Double Standards», Commentary, novembre 1979. 9 Isaacson e Thomas, The Wise Men: Six Friends and the World They Made, Simon & Schuster, New York, 1986, p. 737. 10 Joffe J., «The ‘Amazing and Mysterious’ Life of Ronald Reagan», The National Interest, autunno 2004.
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 168
CAPITOLO DECIMO
L’EGEMONIA
Gli Stati Uniti sono la prima nazione che è diventata la più potente del mondo senza aver mirato a questo scopo1. ANDRÉ MALRAUX L’egemonia è antica quanto l’uomo2. ZBIGNIEW B RZEZINSKI
Sulla scia della presidenza di Ronald Reagan, ma prima del tracollo finale dell’Unione Sovietica, si ebbe uno strano periodo di calma che durò quanto il mandato del suo successore ed ex vice presidente George Bush. In questo breve intervallo, gli Stati Uniti ebbero la possibilità di condurre una politica estera conforme a interessi che, per la prima volta in quasi mezzo secolo, non avevano alcun rapporto con la Guerra Fredda. Ma pur se ormai agonizzante, l’URSS continuava a esistere e questo ritardò la presa di coscienza, da parte degli americani, del cambiamento del mondo che si era verificato. Non solo infatti era mutata la struttura del sistema internazionale, per cui gli Stati Uniti si ritrovavano a essere l’unica superpotenza, ma, cosa ancor più importante dal loro punto di vista, la motivazione originaria della loro politica estera globale stava quasi per venir meno e un suo riesame sembrava ormai imminente. Ma erano già maturi i tempi per una ritirata? In questo interludio, l’America avrebbe proceduto a una valutazione delle situazioni caso per caso, nella consapevolezza dell’inevitabile fine dell’URSS, ma non era ancora pronta a elaborare più ampie strategie finché non fosse sopraggiunto il rigor mortis. Sarebbe difficile sopravvalutare l’importanza della Guerra Fredda come fattore determinante della visione americana del mondo
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 169
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
169
esterno. In un senso del tutto reale, essa è stata – insieme alla seconda guerra mondiale – l’esperienza che ha introdotto gli Stati Uniti su un più vasto teatro. Ed è stato proprio questo conflitto ideologico a definire le linee guida della loro politica estera, laddove invece, curiosamente, il loro approccio, molto più geopolitico, adottato fin verso la metà del XX secolo nei riguardi del loro emisfero, non è stato considerato quasi mai una politica di tipo internazionale. In effetti, l’elemento predominante – se non unico, secondo alcuni – dell’esperienza geopolitica americana sta nel fatto che non venne percepita in larga misura come tale. E nel periodo della Guerra Fredda, la tradizionale visione del mondo degli Stati Uniti ebbe una trionfante affermazione. Le mire espansionistiche iniziali dell’Unione Sovietica risparmiarono agli americani qualsiasi necessità di considerare l’idea che il conflitto geopolitico fosse inerente alla natura degli uomini e delle nazioni, e che il loro impegno nel mondo fosse un fatto, non una scelta. Due delle più importanti iniziative di George Bush senior stanno a indicare la peculiarità della congiuntura venutasi a creare. La prima, l’«Operazione Giusta Causa», venne intrapresa nel dicembre del 1989 per abbattere il regime dittatoriale di Manuel Noriega a Panama, che aveva orchestrato una campagna di propaganda antiamericana per rafforzare la sua precaria posizione. I suoi brutali metodi di governo costituivano un pericolo per le imprese americane che operavano in questo paese e Washington decise che era tempo di sbarazzarsi di lui. Da un lato, questo fu soltanto un classico caso di applicazione della dottrina Monroe, che risaliva a molto prima della sua esplicita articolazione da parte di Theodore Roosevelt. Gli interessi dell’America nel suo emisfero erano minacciati ed era pertanto auspicabile e possibile un ricorso alla forza per cambiare il regime vigente a Panama, così come era già avvenuto di recente a Grenada nel 1983. Dall’altro, ora che la Guerra Fredda era all’epilogo, sorgevano nuovi interrogativi. Quest’iniziativa rappresentava semplicemente un ritorno alla situazione antecedente ovvero a un’attenzione quasi esclusiva per l’emisfero occidentale? O, dal momento in cui gli Stati Uniti avevano interessi globali (e gli strumenti per difenderli), preannunciava altri interventi del genere anche altrove? Molte delle prime imprese rischiose americane vennero giustificate soprattutto per-
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 170
170
ché richiedevano ben poco sforzo, non richiamavano quasi alcuna attenzione da parte dell’opinione pubblica e non sembravano rappresentative di una più grande strategia, almeno finché Teddy Roosevelt non le proponeva come tali. Ma in seguito, la grande svolta della seconda guerra mondiale e tutte le politiche che l’accompagnarono vennero viste alla fine come parte di una risposta inevitabile alla tirannia. Così, anche la difesa degli interessi periferici poté trovare convalida nella necessità di conservare un vantaggio strategico (anche se di rado questa era la ragione addotta) nel più ampio conflitto su scala internazionale. In conclusione, non era più possibile un ritorno alla falsa coscienza prebellica, specialmente fintanto che si perseguivano politiche volte a tutelare i propri interessi. Bush non lasciò intendere che l’invasione di Panama fosse qualcosa di diverso da una semplice risposta a un caso specifico, ovvero privo di implicazioni più ampie (sebbene il ruolo di Noriega come dittatore venne preso a pretesto per giustificarla). Con il muro di Berlino caduto solo da poche settimane, non era ancora evidente che la situazione dell’America fosse cambiata. L’altra grande iniziativa fu la prima guerra del Golfo, che avrebbe riproposto agli Stati Uniti tutte le grandi questioni sollevate dall’invasione di Panama, cadute poi nel dimenticatoio. Quando Saddam Hussein invase il Kuwait nel 1990, questa fu la prima volta dopo cinquant’anni che una crisi nel Medio Oriente poteva essere considerata un fatto circoscritto a quest’area, anziché una delle tante mosse della partita a scacchi fra Stati Uniti e Unione Sovietica. Essa rappresentò il primo vero test per la leadership americana dopo la fine della Guerra Fredda. Con la Russia ormai fuori gioco, emersero due grandi problemi. Il primo fu che i paesi sviluppati si trovarono di fronte a un comune dilemma, ma non fu subito chiaro come intendevano comportarsi: avrebbero reagito d’intesa o lasciando invece che l’America intervenisse per loro conto? E, in questo secondo caso, gli Stati Uniti avrebbero continuato a svolgere un ruolo guida o si sarebbero ritrovati su un piano di parità? Quell’evento fu una cartina di tornasole per saggiare la consistenza dei dibattiti (alquanto monotoni) ancora in corso sulla nuova struttura dell’ordine mondiale: sarebbe stato unipolare o multipolare? La seconda questione era più pressante. Spettava agli Stati Uniti stabilire la natura dei loro interessi e decidere se intervenire in un’a-
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 171
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
171
rea del mondo ben oltre la sfera della dottrina Monroe, di fronte a un aggressore che non rappresentava alcuna minaccia diretta per l’incolumità del paese e a una situazione che non poteva più essere considerata come parte di una lotta inevitabile contro la tirannia. All’inizio, ovviamente, Bush presentò proprio un quadro di questo tipo, paragonando Saddam a Hitler e dichiarando che «questa aggressione è inaccettabile», come se il Kuwait fosse un’altra Cecoslovacchia, mentre il suo segretario di Stato, sempre pragmatico, James Baker, andava ripetendo che la questione era una sola: «lavoro, lavoro e lavoro». La verità era che l’America, come gran parte degli altri paesi, avevano un reale interesse a impedire che un pazzo pericoloso dalle ambizioni smisurate instaurasse il suo predominio su una regione da cui proveniva la maggior parte del petrolio consumato nel mondo (ed è molto strano che una guerra con un consenso quasi universale sia stata combattuta a causa del petrolio, mentre quella successiva, dettata da altre motivazioni, sia stata quasi altrettanto universalmente vilipesa per questa stessa ragione). Ma anche allora, il premier britannico Margaret Thatcher dovette sollecitare Bush a non «mostrarsi troppo esitante». E la confusione all’interno del governo circa gli scopi da raggiungere si tradusse in un messaggio confuso al popolo americano. Inoltre, sul tutto aleggiavano forse due spettri: il Vietnam e l’imperialismo. Il primo venne esorcizzato direttamente mobilitando una forza schiacciante (mezzo milione di soldati) per affrontare un nemico irriducibile. Il secondo, in modo indiretto, prefiggendosi scopi che non andassero oltre il ripristino dello status quo, in modo da consentire il ritiro delle truppe evitando di rimanere invischiati permanentemente senza necessità. Alla luce dei recenti avvenimenti, quella moderazione appare lodevole e ragionevole. Ma è sorprendente che dietro quelle cautele persistesse una profonda riluttanza a perseguire disegni più ambiziosi, date le loro ovvie implicazioni. All’estero, questa linea di condotta ebbe successo, almeno a breve termine. All’invasione seguì il ritiro, la stabilità (relativamente parlando) fu ripristinata e gli alleati vennero tenuti a freno. Ma come sempre, la questione imperiale non poteva essere evitata facilmente. La riluttanza ad arrivare a Baghdad impose uno stanziamento di truppe a tempo indefinito in Arabia Saudita e nello Yemen e consentì inoltre a Saddam di massacrare sciiti e curdi iracheni mentre le forze americane stavano a guardare.
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 172
172
Tutto questo, mal si conciliava con il dichiarato proposito di resistere all’aggressione e difendere il diritto all’autodeterminazione. Il che spiega come mai il successo dell’operazione all’estero non trovò riscontro in patria, dove l’opinione pubblica era stranamente spassionata, ignorando completamente, per la prima volta da lungo tempo, il motivo per cui l’America era scesa in guerra. Questo conflitto avrebbe segnato l’inizio di una fase contraddistinta dal riconoscimento dell’emergere di un nuovo ordine che faceva capo all’America. Tuttavia, quest’ovvia verità non veniva ancora ammessa dagli esponenti dell’amministrazione Bush, troppo lungimiranti per non rendersene conto, ma al tempo stesso impreparati a comportarsi di conseguenza. Va ricordato infatti che il «nuovo ordine mondiale» di Bush non era un tentativo di capitalizzare la supremazia degli Stati Uniti, bensì di sostenere un ordine più o meno bipolare in collaborazione con l’Unione Sovietica, senza la conflittualità dei quattro decenni precedenti. Non tanto per puro idealismo ma per il desiderio di prevenire l’inevitabile il più a lungo possibile, in modo da non dover affrontare troppo presto la catastrofe che segue solitamente la caduta di un impero. Ma questo sforzo venne vanificato dal suo crollo nel dicembre del 1991, costringendo l’America a riesaminare la sua posizione. Vari teorici hanno condiviso la massima della regina Vittoria: «Credo sia molto imprudente rinunciare a quel che si possiede». Ma quasi nessuno è stato concorde su come metterla in pratica, anche perché, data la natura non geografica della supremazia degli Stati Uniti, era difficile stabilire in che cosa consistessero i loro possedimenti. Molti però riconobbero, indubbiamente, che si stava entrando in quella che Charles Krauthammer definì la «fase unipolare»3 (evolutasi in seguito nell’«epoca unipolare») e cercarono di sfruttare questa situazione, come fecero soprattutto gli estensori del famigerato documento del Pentagono, Defense Planning Guidance for Fiscal Year 1994-1999, trapelato sui giornali e poi pubblicamente ritrattato, secondo il quale l’interesse preminente degli Stati Uniti era quello di [...] prevenire l’emergere di un nuovo antagonista, sul territorio dell’ex Unione Sovietica o altrove, che costituisca una minaccia per l’ordine internazionale come quella rappresentata un tempo dal quest’ultima. La considerazione principale che deve sorreggere la nuova strategia regionale difensiva è che bisogna impedire a qualsiasi potenza ostile di
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 173
173 dominare un’area le cui risorse sarebbero sufficienti, se monopolizzate, a instaurare un controllo sul mondo intero.
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
Gli Stati Uniti debbono dimostrare quella capacità di guida necessaria a creare e proteggere un nuovo in grado di convincere i potenziali concorrenti che non hanno bisogno di acquisire più potere né di adottare un comportamento più aggressivo per tutelare i loro interessi. Nei settori che non riguardano la difesa, dobbiamo tenere debito conto degli interessi dei paesi industrialmente più avanzati in modo da non indurli a sfidare la nostra leadership o a rovesciare l’ordine politico ed economico stabilito. E continuare a disporre di mezzi per dissuadere i nostri possibili rivali dall’aspirare a un più ampio ruolo regionale o globale4.
Seguendo analoghe linee guida, anche se da un altro punto di vista e auspicando l’impiego di mezzi diversi, l’ex consigliere per la sicurezza nazionale di Carter, Zbigniew Brzezinski, dichiarò apertamente che la strategia dell’America «per usare una terminologia che riecheggia l’epoca più brutale degli antichi imperi» doveva essere dettata da «tre grandi imperativi: impedire collusioni e mantenere i vassalli in condizioni di dipendenza ai fini della loro sicurezza, garantire la protezione dei tributari costringendoli all’obbedienza e impedire ai barbari di stringere alleanze»5. Queste idee, tuttavia, non andavano alla radice del problema, che era concettuale e non strategico. Dopo essersi proiettati nel mondo con una missione, innanzitutto per dare l’esempio e poi nell’intento di salvarlo, gli Stati Uniti non avevano ora altro scopo se non quello di accrescere e preservare la loro potenza? La risposta fu inevitabilmente che quest’ultima era, per sua stessa natura, una forza al servizio del bene, ma fino a quando gli americani avrebbero continuato a crederci, specialmente quando venivano richiesti gravi sacrifici e le altre nazioni tendevano sempre più a contestare questa pretesa? E in presenza di molte chiare situazioni preoccupanti, ma in assenza di una grande minaccia strategica sovrastante, in base a quali criteri l’America avrebbe deciso se impegnarsi o meno? Nel frattempo, la fine della Guerra Fredda non fece che scatenare una nuova ondata di conflitti fra le varie fazioni in lizza per assumere il controllo della politica estera americana, ma anche delle coscienze, da parte di alcuni. Gli esponenti dell’ala più progressista dell’establishment, che presero le distanze dalla Guerra Fredda durante la crisi del Vietnam ed entrarono a far parte dell’ammini-
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 174
174
strazione Carter e, in qualche caso, anche delle due successive amministrazioni Clinton, sostenevano che il crollo del sistema sovietico fu dovuto soprattutto alla ristrettezza di vedute dei suoi leader oppure semplicemente alle sue deficienze. La sintesi più significativa di questo punto di vista fu la copertina del settimanale Time dedicata a Gorbaciov come «L’uomo del decennio», che conteneva un editoriale del suo direttore di allora, Strobe Talbott, in seguito viceministro della Difesa durante la prima amministrazione Clinton6. Secondo questa dubbia logica, il padre della perestrojka era un sorta di kamikaze, un liberaldemocratico nei panni di un comunista, che minò coraggiosamente il suo regime dall’interno per il bene dell’umanità. Per gli Stati Uniti, ciò implicava essenzialmente che tutti i loro sforzi erano stati inutili fin dall’inizio. Per molti aspetti, questa era una reviviscenza dell’isolazionismo, ma con una forzatura ideologica. Come posizione critica, essa era significativamente priva di una dimensione geopolitica. Si potrebbe discutere, ovviamente, col senno di poi, su quali effetti ebbero determinate politiche e quale fosse il senso di molte scelte compiute. Ma ciò equivarrebbe a misconoscere qualsiasi ruolo svolto dagli Stati Uniti, come se le azioni di una delle due superpotenze non avessero avuto alcun effetto reale – se non forse di tipo negativo – nell’arco di un quarantennio. Sebbene alcuni di quei dibattiti storici apparissero viziati da una pedanteria accademica, per non parlare della meschinità dei loro protagonisti, non furono il risultato di un mero solipsismo, ma ebbero importanti implicazioni per per la politica dei nostri giorni. A seconda di come si interpretava l’epilogo della Guerra Fredda questo determinava la visione di quello che poteva e doveva essere il ruolo dell’America al giorno d’oggi. Ma nonostante la loro vivacità, quelle discussioni assunsero un carattere sempre più astratto e alla prudenza senza lungimiranza che caratterizzò l’epoca di Bush seguirono politiche sempre più amorfe, man mano che l’America si allontanava dalla Guerra Fredda. Gli anni della locusta Dal punto di vista della formazione degli orientamenti delle generazioni che vissero in quei frangenti, l’epoca della Guerra Fredda
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 175
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
175
fu uno strano periodo. Se numerosi pensatori e statisti trassero da quell’esperienza vari insegnamenti elevandoli a verità fondamentali circa i rapporti fra le nazioni, molti altri, in modo conscio o subconscio, furono più inclini a considerarla come una deplorevole aberrazione della politica internazionale. Sotto un certo aspetto, vi è del vero in questo. In base all’esperienza americana, i conflitti che portarono gli Stati Uniti a più stretto contatto col mondo esterno furono l’eccezione, non la regola. E ciò spiega come mai quarantacinque anni di coinvolgimento nelle vicende internazionali e una breve incursione, abortita alla fine della prima guerra mondiale non contarono quanto un secolo e oltre di isolazionismo precedente. Si potrebbe attribuire all’amministrazione Clinton, o al popolo americano in quel periodo, una debole determinazione o una semplice miopia, ma la verità è che gli Stati Uniti ritornarono alla loro posizione naturale, che ritengono propria di tutti gli Stati. Per cui questo non fu il risultato di una scelta consapevole, bensì di una mancanza di determinazione. In effetti, l’elaborazione di una strategia derivata esplicitamente dal ruolo dell’America nel mondo in assenza di una chiara minaccia avrebbe richiesto una consapevole decisione di rompere con la tradizione e cambiare rotta, come avvenne, per esempio, con il rapprochement tra la Francia e la Germania sotto de Gaulle dopo secoli in cui furono perseguite politiche quasi opposte. In un certo senso, la felice congiuntura della nuova supremazia degli Stati Uniti non stava tanto nel fatto che gli americani erano riusciti a salire «fino in cima all’albero della cuccagana» (per riprendere una celebre frase di Disraeli), bensì in quello che nessun’altro aveva avuto quest’occasione. Detto altrimenti, la risposta geopolitica al nuovo stato di cose fu l’assenza di qualsiasi risposta, nella convinzione che non vi fosse alcuna strategia garantita. Ora che gli Stati Uniti erano ormai la potenza predominante, gli eventi catastrofici che li avevano portati ad assumere un ruolo guida sulla scena internazionale avrebbe potuto cessare, consentendo un «ritorno alla normalità», per dirla con le parole del presidente Warren G. Hardy all’inizio degli anni Venti, subito dopo la prima guerra mondiale. Nel 1992, Bill Clinton salì al potere dopo una campagna elettorale che diede scarso rilievo alle questioni di politica estera. Non solo, ma durante i suoi due mandati guidò un partito la cui maggioranza aveva respinto i presupposti su cui questa politica si era basata nel corso della seconda fase della Guerra Fredda, costi-
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 176
176
tuendo un governo composto da elementi che condividevano tale tendenza. Questa fu la prima generazione, segnata dall’esperienza del Vietnam, a esercitare un’influenza considerevole sulle stanze dei bottoni. Dopo l’11 settembre, si era diffusa in Europa la convinzione che quanto era accaduto in quel fatidico giorno, avesse rappresentato una svolta significativa nella storia americana, nel senso che, finalmente, un qualche grado di pessimismo storico si era finalmente manifestato in un popolo senza storia. Ma per coloro che salirono al potere all’inizio degli anni Novanta, questo si era già verificato col Vietnam. Come scrisse Anthony Lake (il consigliere per la sicurezza nazionale di Clinton durante la sua prima amministrazione), in un’opera pubblicata nel 1977 dal prestigioso Council on Foreign Relations: «l’orientamento interventista» della politica estera americana, dopo la seconda guerra mondiale e il Vietnam, venne «giustificato in base a degli ideali», anche se, in ultima analisi, non era molto diverso da quello dell’imperialismo europeo del XIX secolo. Ma in una nota di ottimismo aggiunse che «se il Vietnam ci ha spinto a una maggiore umiltà anziché all’autofustigazione, alla cautela anziché all’indifferenza, allora dovremo approfittarne per trarre qualche lezione dal suo orrore»7. La politica estera dell’America dopo la Guerra Fredda sarebbe stata un tentativo di correggere i suoi difetti di comportamento e soprattutto i presunti errori commessi nel corso di un conflitto il cui esito l’aveva proiettata verso un domino incontrastato del mondo. Qui sorgeva però una contraddizione: gli Stati Uniti dovevano essere una forza al servizio del bene nel mondo, ma per gli uomini di quella generazione la speranza stessa che avrebbero potuto esserlo si tradusse di fatto nell’arroganza del potere e infine nella tragedia. Incapaci di superare quest’ambivalenza, non riuscirono neppure a elaborare una strategia coerente che definisse gli obiettivi dell’America nel mondo. Così Clinton divenne una sorta di Bismarck nei confronti del suo partito, che riuscì a tenere insieme, nonostante le sue contraddizioni interne, grazie a un’infaticabile abilità manovriera. Spostando l’accento della sua politica dalla sfera internazionale a quella interna, evitò uno scontro autodistruttivo con queste incongruenze. In questo modo, nell’arco di una generazione, il Partito Democratico si discostò sempre più dalle realtà essenziali della geopolitica: dapprima attraverso la campagna, carica di valori, condotta da Carter
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 177
177
contro il concetto di interessi nazionali, poi attraverso l’affermazione, priva di principi, che tutto doveva essere funzionale alle esigenze elettorali a breve termine. Clinton è stato spesso criticato per la sua politica estera troppo liberale, specialmente se riconsiderata alla luce degli eventi dell’11 settembre. Alcuni, come Bill Kristol e Robert Kagan in particolare, sostengono che questa tendenza si era manifestata nella sua profonda riluttanza a ricorrere all’uso della forza, preferendo trattare col resto del mondo attraverso consultazioni stile conferenza delle Nazioni Unite. Altri invece hanno affermato che il suo eccessivo liberalismo derivava dalla tendenza ad assegnare la priorità agli scopi umanitari, a scapito degli interessi nazionali. Ma, come ha sottolineato Charles Krauthammer, Clinton non aveva alcuno scrupolo a usare la forza in quanto tale.
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
È sbagliato credere che il liberalismo sia ostile all’esercizio della forza in sé e per sé. Quando furono autorizzati ad usarla, i progressisti scatenarono l’inferno in Serbia, fecero strage di somali e minacciarono di schiacciare Haiti. Il problema nel loro caso non è questo, bensì l’assenza del concetto di interesse nazionale. In linea di principio, non sono avversi infatti al ricorso alla forza, ma hanno difficoltà ad ammetterlo in nome dell’interesse nazionale. Ovvero sono riluttanti a farne un uso secondo loro egoistico, dettato da un ristretto tornaconto, mentre sono favorevoli a impiegarla per fini umanitari quanto più possibile distanti da ogni calcolo di convenienza8.
C’è indubbiamente del vero in queste critiche, specialmente se si tiene conto dei processi di pace avviati da Clinton, a volte con successo (come nel caso dell’Irlanda del Nord) altre invece senza esito (come nel conflitto israelo-palestinese). Quanto poi alle aree in cui gli Stati Uniti sono intervenuti direttamente sul terreno, come in Somalia, ad Haiti e in Bosnia, si può dire che non fossero in gioco interessi nazionali primari. L’apparente contraddizione fra questi due tipi di obiezioni, entrambi validi, rinvia a un problema più ampio. In assenza di una minaccia incombente, e con tutti gli ostacoli interni che si frapponevano all’elaborazione di una strategia geopolitica, gli Stati Uniti hanno spesso ripiegato sulle loro posizioni più tradizionali. L’isolazionismo predominante fra gli americani non era in questo periodo storico una credenza profondamente radicata né una visione del mondo consapevole, quanto piuttosto la naturale tendenza
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 178
178
di un popolo che semplicemente non considera così rilevante ciò che accade al di là dei propri confini. Sarebbe riduttivo dipingere questo periodo come caratterizzato da un conflitto fra isolazionisti e interventisti per influenzare il corso della politica estera americana. Certo, da un lato abbiamo Pat Buchanan che cerca di far rivivere lo spirito riassunto dal vecchio slogan «America first» (prima veniamo noi, poi gli altri), riemerso l’ultima volta alla vigilia della seconda guerra mondiale, dall’altro Madelein Albright, che si chiede a che serve disporre di un esercito se poi non lo si usa. Ma la verità è che entrambe queste tendenze si erano alla fine intersecate e rafforzate a vicenda negli anni Novanta. Dal momento in cui l’immobilismo era ovviamente impossibile per una superpotenza, per surrogarlo si evitò semplicemente di definire gli interessi nazionali. Così l’America si ritrovò a intervenire in varie situazioni, che in qualche caso non rappresentavano alcun pericolo chiaro e imminente per essa né potevano arrecarle alcun beneficio economico o geopolitico. E, durante tutto questo periodo, i parlamentari repubblicani si chiesero, giustamente, quali fossero gli scopi perseguiti, mentre molti commentatori e analisti di tendenza conservatrice schiumavano di rabbia per gli inutili spargimenti di sangue e per gli sprechi finanziari. A prima vista, sembrerebbe assurdo accusare Clinton di isolazionismo, se pensiamo alla vorticosa successione di incontri al vertice convocati dagli Stati Uniti o ai quali essi avevano aderito, ai trattati sottoscritti, alla spola diplomatica in aree che spaziavano dall’Irlanda del Nord alla Bosnia e al Libano. Ma, come tutti ben sanno, un rigoroso isolazionismo è impossibile e neppure nel XIX secolo l’America seguì alla lettera questa tendenza. L’assenza di una strategia ben delineata e il risorgere di vecchie propensioni a chiudersi al mondo esterno non condussero all’inazione. Negli otto anni della presidenza Clinton, gli Stati Uniti inviarono truppe in più di 140 paesi e le mandarono a combattere in Somalia, ad Haiti e in Bosnia, bombardando inoltre il Kossovo con la loro aviazione. Nel contesto degli anni Nocanta, l’isolazionismo poteva essere resuscitato solo attraverso un impegno internazionale fittizio. Per dirla in sintesi, l’America ne avrebbe tradotto in pratica il principio essenziale – secondo il quale per trattare col mondo esterno non occorre una politica estera – assumendo impegni internazionali solo su un piano non politico.
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 179
179
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
L’amministrazione Clinton trasse dalla [teoria della fine della storia] l’idea che se fosse stato assicurato il progresso verso l’autodeterminazione politica e l’integrazione economica, allora gli Stati Uniti avrebbero dovuto, come disse il consigliere per la sicurezza nazionale Anthony Lake, «impegnarsi» soltanto a favorire lo «sviluppo» di questi processi nel resto del mondo. L’egemonia fondata sul consenso, conquistata dall’America durante la Guerra Fredda, sarebbe semplicemente assurta a sistema internazionale dopo di essa9.
La «mano invisibile» di Adam Smith avrebbe svolto il compito più arduo che una volta spettava alla strategia geopolitica. Ma quando l’impegno verso il mondo esterno diventava concreto, sembrava esservi qualche confusione circa le priorità da adottare. Così, il rapporto sulla strategia della sicurezza del 2000, dal titolo altisonante di Una strategia della sicurezza nazionale per un’epoca globale, metteva le questioni ambientali e la lotta contro le malattie infettive sullo stesso piano degli altri temi più tradizionali trattati in questo genere di documenti10. Ma a cosa equivaleva, in pratica, tutto questo? La Somalia era diventata una sorta di esempio paradigmatico dei pericoli di una politica estera sconclusionata, con il suo inutile sacrificio di molte vite di soldati americani in una regione senza alcun rapporto con gli interessi principali degli Stati Uniti. Questa critica tuttavia è insufficiente poiché travisa, in primo luogo, le motivazioni che portarono alla catastrofe, riconducendole a una politica e a una mentalità umanitaristica aggressive. Ma, come rileva Eliot Cohen, il problema non era costituito da un governo iperattivo e al tempo stesso diffidente che lasciò che gli eventi prendessero quella piega. «Rimettendosi a uno zelante alto commissiario – americano – delle Nazioni Unite, né il presidente né il segretario alla Difesa considerarono le truppe stanziate a Mogadiscio come forze che combattevano una guerra di basso profilo, ma pur sempre una guerra, in cui era necessario uno sforzo, da parte delle autorità nazionali, di armonizzare mezzi e fini»11. Gli Stati Uniti, in questo caso, non erano alla guida bensì al traino. Non fu dunque una politica eccessivamente idealistica, ma l’assenza di qualsiasi politica a spingere le forze americane a Mogadiscio. Così è stato anche per tanti altri interventi susseguitisi nel corso di un decennio, e ciò spiega in parte perché in Bosnia l’impegno americano è stato tardivo e inefficace nel far cessare la
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 180
180
carneficina e perché la confusione sui fini, che rispecchiava i problemi cui si trovò di fronte Woodrow Wilson a Versailles, portò a una soluzione fittizia destinata a non durare nel tempo. La moralità dell’intervento umanitario si tradusse così in uno spreco di vite americane. Dopo l’uccisione di diciotto soldati a Mogadiscio, gli Stati Uniti si ritirarono definitivamente dalla Somalia. Questa missione aveva richiesto una rinuncia al principio guida dell’interesse nazionale, ma senza di esso non poteva sussistere alcuna motivazione a tener duro. La principale differenza fra la Somalia e il Kossovo non fu la volontà di riportare una vittoria, bensì il fatto che le forze americane non misero mai piede a terra, ingaggiando battaglia solo dall’alto dei cieli, mentre i serbi scendevano nelle strade per chiedere le dimissioni di Milosˇevic´. Curiosamente, invece, di fronte alla più grande crisi di questo periodo – quella del Ruanda – che avrebbe meritato più d’ogni altra un intervento umanitario, gli Stati Uniti non inviarono truppe e, anzi, evitarono consapevolmente il più possibile qualsiasi coinvolgimento. Come osservò un anonimo funzionario del Dipartimento di Stato dell’epoca, «La nostra politica estera si basa su interessi economici amorali ed è gestita da dilettanti che vogliono farsi paladini di qualche causa – da cui la sua agonia – ma non sono disposti, alla fine, a esercitare alcuna leadership che comporti dei prezzi da pagare»12. Ma, stranamente, l’affermazione del primato degli interessi nazionali aveva effetto, sia pure sempre più come mezzo per evitare l’azione anziché per definirne gli scopi, o per ottenere, come nel caso dei fautori di interventi umanitari, l’attenzione di un’opinione pubblica apatica. Quando la Bosnia era in fiamme – ha osservato Samantha Power – chi tra noi sosteneva che la forza degli Stati Uniti doveva essere impiegata a fin di bene lo faceva in nome dell’interesse dei bosniaci. In quel periodo, avevamo cercato di far rientrare la nostra causa umanitaria nello schema allora predominante, in base ad argomenti poco persuasivi sul rischio che la guerra poteva estendersi alla Grecia e alla Turchia, con effetti destabilizzanti su questi due paesi, se non addirittura far esplodere i Balcani13.
Il cinismo di questa posizione non ha bisogno di commenti. La politica estera di Clinton potrebbe essere paragonata a una partita di calcio fra giovani scolari (che non brillano particolarmente
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 181
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
181
in questo sport, almeno per come viene praticato negli Stati Uniti): un gran subbuglio in cui si spendono molte energie, con ben pochi risultati. L’unico gruppo che propose in quel decennio una linea di condotta coerente fu quello dei neoconservatori, guidati da Bill Kristol e Robert Kagan, che si consideravano gli eredi della politica estera di Reagan14. Più volte invocarono interventi in quelle aree nelle quali Clinton spedì infine le truppe americane, manifestando però puntualmente la loro indignazione di fronte allo scarso impegno e all’insufficiente impiego di forze. Il loro appello si basava sulla superiore potenza degli Stati Uniti, la debolezza di molti dei loro presunti alleati e i pericoli potenziali rappresentati dall’Asia orientale e dal Medio Oriente, nonché sugli imperativi strategici e morali della loro leadership nel mondo. Ma tutto questo tendeva a risolversi, in definitiva, in un interventismo indiscriminato, che anch’esso non era una strategia. Se gli eredi del Vietnam vedevano soltanto limiti, i neoconservatori, per reazione, non ne scorgevano mai alcuno. Né si può dire che una visione del mondo in cui tutto è possibile, pur che vi sia una volontà, tenda a tener conto della geopolitica. Di fatto, accade invece il contrario. Quando l’esercizio della forza non trova ostacoli, non si avverte mai la necessità di saggiare il terreno su cui s’intende muoversi. Ma i neoconservatori colsero una verità essenziale di quel periodo: ovvero il fatto che l’isolazionismo mascherato da isolazionismo era un grosso problema, acuito, anziché ridotto, dalla forza soverchiante dell’America nel mondo. E molti esponenti del Partito Repubblicano non fecero altro che polemizzare contro gli impegni assunti dagli Stati Uniti nel corso degli anni Novanta, rilevando che il paese aveva ben poco da guadagnare, molto da perdere e nessun chiaro interesse nazionale da difendere. Il problema di fondo che non venne mai affrontato adeguatamente era quello di preparare il popolo americano ad assumere il ruolo che competeva ai cittadini di una repubblica la cui potenza era in larga misura responsabile della creazione e dunque del mantenimento dell’ordine internazionale esistente. Ovvero di predisporlo a compiere sacrifici (in termini di consumi petroliferi, crescita economica o sicurezza interna) se intendeva continuare a perseguire una politica estera slegata dalla ricerca di compromessi nel mondo. Gli americani probabilmente non volevano vedere insidiata la loro supremazia in-
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 182
182
ternazionale, ma questo non era sufficiente per impostare una strategia derivante dalla loro posizione di preminenza, o dalla loro propensione ad assumersene le responsabilità. Non vogliamo dire con ciò che la politica estera prevalentemente umanitaria di quel periodo riuscì in questo intento, infondendo nella popolazione la consapevolezza della necessità di un impegno degli Stati Uniti su scala internazionale. Prima o poi, quella che Charles Krauthammer definì una «vacanza dalla storia» sarebbe finita, ponendo gli americani di fronte al mondo così com’è e come è sempre stato e costringendoli a perseguire impassibilmente i loro interessi nazionali in forza della necessità. Questa difficoltà di fatto non è diminuita da quando gli americani sono stati obbligati, a causa di tali interessi, a prestare attenzione ancora una volta al mondo esterno. La popolazione è rimasta curiosamente estranea a esso. L’esercito è composto interamente di volontari, che rappresentano una piccolissima frazione del paese, largamente separata da quest’ultimo sia materialmente che spiritualmente. Persino il presidente Bush che ha parlato, con un linguaggio altrettanto altisonante di John F. Kennedy, della necessità di assumersi responsabilità internazionali, si è rifiutato di trarre le conseguenze pratiche di tutto questo, al punto di ridurre le tasse proprio quando l’America sta ricostruendo il suo apparato militare e di non sfiorare neppure la questione della politica energetica (e il fatto che le considerazioni politiche giochino indubbiamente un ruolo preminente in questa decisione non cambia il problema). Infine, nonostante tutte le critiche rivolte normalmente al Partito Democratico in generale e a Clinton in particolare, i repubblicani avevano ben poco da offrire in alternativa. Molti commentatori rilevarono (sconsolatamente) la vistosa assenza di temi di politica estera nella campagna per le elezioni presidenziali del 2000. Tanto che Henry Kissinger si sentì spinto a intitolare il suo libro più recente Does America Need A Foreign Politicy? («L’America ha bisogno di una politica estera?»). Posta dal massimo esperto americano di geopolitica, questa domanda tradiva una punta di disprezzo per il pubblico. Pur se nel corso degli anni Novanta si fece un gran parlare di «deriva» da parte di entrambi gli schieramenti politici, nel complesso vi furono scarsi segni di un’inversione di tendenza rispetto alla direzione seguita dal paese dopo il crollo dell’Unione Sovietica. Ed è probabile che tutto sarebbe continuato più o meno come prima
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 183
183
nel periodo successivo se non fosse stato per il violento impatto dei due aerei che piombarono sulle Torri Gemelle e sul Pentagono durante una bella mattina d’autunno.
NOTE 1
Citato in Nixon R., Beyond Peace, Random House Value Publishing, 1995.
2 Brzezinski Z., The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives,
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
Basic Books, New York, 1998, p. 3 (trad. it., La grande scacchiera: il mondo e la politica nell’era della supremazia americana, Longanesi, Milano, 1998, traduzione di Mario Baccianini, p. 11). 3 Krauthammer C., «The Unipolar Moment», Foreign Affairs: America and the World, 1990/91. 4 «Excerpts From Pentagon’s Plan: ‘Prevent the Re-Emergence of a New Rival’», The New York Times, marzo 8, 1992. 5 Brzezinski, op. cit., p. 40 (trad. it. cit., p. 57). 6 Talbott S., «Rethinking the Red Menace», Time, 1 gennaio 1990. 7 Lake A. (a cura di), The Legacy of Vietnam, New York University Press, 1976. 8 Krauthammer C., «Self Service», The New Republic, 3 marzo 2003. 9 Gaddis, Surprise, Security, and the American Experience, Harvard University Press, 2004 p. 77. 10 «A National Security Strategy For A Global Age», The White House, dicembre 2000. 11 Cohen, Supreme Command, The Free Press, New York, 2002 p. 201. 12 Citato in Power S., «Bystanders to Genocide», The Atlantic Monthly, settembre 2001. 13 Power S., «Force Full», The New Republic, 3 marzo 2003. 14 Il loro originario cri du coeur si può trovare in Present Dangers: Crisis and Opportunity in American Foreign Policy, Encounter Books, San Francisco, 2000, a cura di Robert Kagan e Bill Kristol.
02 layout 111-184
4-04-2005
16:15
Pagina 184
03 layout 185-232
4-04-2005
16:16
Pagina 185
PARTE TERZA L’AMERICA OGGI
03 layout 185-232
4-04-2005
16:16
Pagina 186
CAPITOLO UNDICESIMO
LA SCENA POLITICA AMERICANA DOPO L’11 SETTEMBRE
E siamo arrivati a oggi. Il lungo excursus storico di questa analisi si deve in parte all’incontestabile supremazia dell’America che non di rado rende difficile capire come questa si veda realmente, quasi che lo status di superpotenza fosse un fattore permanente e non una realtà vecchia di appena 15 anni. E, tuttavia, è il suo passato, non la sua attuale preminenza, a definirne in buona misura le scelte politiche concrete, che raramente derivano da situazioni internazionali specifiche, essendo piuttosto una reazione ai cambiamenti interni e alla sua stessa storia. Come dire che, ancora una volta, siamo in presenza di una tradizione essenzialmente autoreferenziale. Abbiamo visto, infatti, come gli Stati Uniti non siano mai stati costretti a confrontarsi fino in fondo con la geopolitica in quanto strategia. L’espansione dei primi anni fu sostanzialmente estranea alla politica esterna; e la gloriosa guerra d’Indipendenza fu, in ultima analisi, combattuta in difesa di principi filosofici più che di diritti territoriali; mentre i due grandi conflitti del XX secolo che spinsero gli Stati Uniti sulla scena mondiale furono percepiti in termini di opposizione al male e non di tutela di specifici interessi. Ciò che, a questo punto, dovrebbe essere evidente, è la natura sostanzialmente reattiva assunta dalla politica estera americana nel corso di gran parte della sua storia. Dalle due guerre mondiali all’inizio della Guerra Fredda fino all’attuale guerra contro il terrorismo, raramente la politica estera americana ha percepito le minacce strategiche prima che queste si manifestassero pienamente, spesso con conseguenze disastrose. Persino l’attuale strategia della prevenzione è in realtà, paradossalmente, non del tutto preventiva – a prescindere dalle valutazioni sulla bontà della stessa (o sull’opportunità di propagandarla così pubblicamente) – in quanto for-
03 layout 185-232
4-04-2005
16:16
Pagina 187
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
187
mulata solo in risposta agli attacchi più micidiali mai portati a segno sul suolo americano. Ma anche nelle questioni di minore importanza, come la formulazione della dottrina Monroe e la sua riproposizione a opera di Theodore Roosevelt, la strategia ha sistematicamente seguito la pratica a livello tattico. Chi accusa gli Stati Uniti di perseguire una strategia imperiale, dovrebbe guardarsi dal fare congetture scarsamente plausibili, dal momento che un simile obiettivo rappresenterebbe una netta rottura con il passato. È vero, però, che qualcuno potrebbe sostenere, in questo caso a maggior ragione, che le varianti di questa strategia erano già in atto dopo la caduta del muro di Berlino, pur mancando di un elemento catalizzatore che ne giustificasse l’applicazione. Rimane il fatto che, in tutti i grandi conflitti del XX secolo, per quanto vittoriosamente conclusi, Washington, nonostante i moniti di intellettuali e politici autorevoli del nostro paese, fu lenta a reagire a pericoli che, guardando indietro, ci appaiono in tutta la loro evidenza. Gli Stati Uniti entrarono nella prima guerra mondiale solo nel 1918, vale a dire tre anni dopo il suo scoppio, e molto tempo dopo che la sua carneficina era bastata a ridisegnare sia l’Europa sia buona parte dell’Asia. Ed entrarono nella seconda soltanto dopo essere stati attaccati e molto tempo dopo l’avvenuta militarizzazione del Giappone e della Germania che, nel frattempo, si erano assicurati il controllo delle sfere rispettive. E, ancora, presero atto dell’esistenza di un conflitto con l’Unione Sovietica soltanto dopo che a Stalin fu permesso di occupare Berlino e di consolidare la sua spietata dittatura sull’Europa dell’est, e questo nonostante la nostra schiacciante superiorità militare e strategica. Oggi, sono i pericoli legati alle reti terroristiche globali a non essere valutati fino in fondo, nonostante una fatwa* di Osama bin Laden e una serie di attacchi terroristici sferrati, a partire dal 1982, sia in casa sia all’estero, dove a morire sono state centinaia di civili e di soldati. E questo perché, malgrado i fatti testimonino il contrario, gli americani hanno vissuto nella convinzione che le guerre riguardino altri, non loro. Ma il mondo non è più lo stesso – e questo è un fatto – e anche le percezioni americane non sono più quelle che erano – il che è molto più importante – perché il mondo ha cominciato a cambiare con loro. Un cambiamento globale effettivo si era già verificato anni prima della fine della Guerra Fredda. Come afferma lo storico Niall Ferguson, «la vera svolta storica non coincide con l’11/9 ma con il
03 layout 185-232
4-04-2005
16:16
Pagina 188
188
9/11»1. Per gli Stati Uniti il periodo successivo alla caduta del muro di Berlino rappresentò un periodo di pace paragonabile alla «guerra dichiarata ma non combattuta» – a quella strana sospensione dell’azione seguita all’invasione della Polonia e precedente la battaglia d’Inghilterra, all’inizio della seconda guerra mondiale. Ma tanto bastava. E restava la speranza che il sistema consolidatosi attorno alle democrazie negli anni della Guerra Fredda potesse di per sé rappresentare l’ordine internazionale. Soli al vertice del sistema internazionale, senza più nessuno che sfidasse il primato americano, l’istinto innato quello fu di seguire la logica universale dell’assetto del dopoguerra fino alla sua naturale conclusione, esportando atteggiamenti e istituzioni tipici dell’ordine liberale nel resto del pianeta2.
È fuor di dubbio che, prima degli attacchi dell’11 setttembre, non esistessero piani per modificare lo status quo. La conferma viene da un ritratto del presidente in carica durante la sua prima campagna, paradossale, se considerato col senno del poi: Si direbbe che durante un dibattito presidenziale, nel corso del quale ha auspicato un’America più modesta sulla scena mondiale, George W. Bush abbia preso atto dei rischi di una politica estera arrogante – che ha fatto proprio il ritornello secondo cui l’America è una «nazione indispensabile». La squadra del presidente ha altresì inserito come tema centrale di politica estera la necessità di «ascoltare i nostri alleati»3.
L’11 settembre 2001, la pagina degli esteri del New York Times, andata in stampa qualche ora prima degli attentati, riportava due articoli: un breve commento sui colloqui di pace israelo-palestinesi e una nota su un cambiamento di coalizione di partiti nella politica norvegese. Non avendo deliberatamente puntato alla posizione che occupano attualmente, non deve sorprendere che gli Stati Uniti avessero qualche incertezza su come procedere. In assenza di un 11 settembre, è del tutto plausibile che la politica estera americana avrebbe continuato a muoversi coi piedi di piombo come aveva fatto dopo la fine della Guerra Fredda; i continui dibattiti tra scuole di pensiero contrapposte sarebbero rimasti squisitamente teorici ed è improbabile che i vincitori di turno, a seconda degli uomini al potere, avrebbero formulato un orientamento coerente in tempi brevi.
03 layout 185-232
4-04-2005
16:16
Pagina 189
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
189
Ma, quanto meno dalla prospettiva americana, gli attentati hanno cambiato totalmente il quadro. «I confini tra l’esistenza quotidiana e un mondo pericoloso sono stati abbattuti» – scrive John Lewis Gaddis – «così come è scomparsa quella presunzione di sicurezza che fino a questo momento era parte di ciò che significava essere americano. L’11 settembre non rappresenta soltanto una crisi di sicurezza nazionale, ma anche una crisi di identità nazionale»4. Ciò contribuisce a spiegare perché quel che per gli americani è stato un oltraggio supremo, per gran parte del resto mondo è stato in ultima analisi un orrore tra i tanti, da cui non si poteva certo pensare di essere immuni per sempre. A ben vedere, la reazione a quegli attentati lascia intravedere un altro aspetto dello scarso realismo dell’America, ovvero la convinzione che la politica possa servire a parare i colpi della storia, che però è anche l’essenza di gran parte del suo successo dal punto di vista geopolitico: la sicurezza, nel lungo periodo, non è garantita da chi si rassegna all’inevitabilità di minacce all’esistenza stessa del proprio paese, bensì da chi, contrastandole, la configura secondo le proprie esigenze. Così come è difficile capire l’asprezza della Guerra Fredda a meno di non cogliere la sensazione di tradimento e di oltraggio morale patita dall’America nei confronti dell’ex alleato Josip Stalin, della sua politica di potere e del suo Stato di polizia, lo è altrettanto comprendere appieno la reazione apocalittica all’11 settembre, a meno di non prendere atto del grande ottimismo nutrito dagli americani nel corso degli anni Novanta. Un ottimismo che si manifestava secondo due diverse modalità: la prima era la speranza che il mondo avesse finalmente raggiunto un certo stato naturale di equilibrio (l’esatto contrario delle teorie tradizionali della politica di potenza secondo cui l’equilibrio subentra a una condizione caotica naturale) e fosse quindi possibile lasciarselo alle spalle o intervenire essenzialmente su un piano non politico. La seconda era che il primato americano comportasse la possibilità, se non di cambiare il mondo, di migliorarlo sensibilmente in virtù della supremazia degli Stati Uniti. Per i suoi fautori, quella che un tempo era sembrata un’opportunità senza precedenti era ormai diventata un imperativo strategico. Con gli attacchi dell’11 settembre, fu chiaro che ci sarebbe stato un prezzo da pagare per i fallimenti americani. Ma, cosa forse ancor più importante (anche se la maggioranza non se ne rese conto), è che anche i successi avrebbero avuto un prezzo di cui si sarebbe preso atto solo dopo averlo pagato. Il che è ben più difficile da con-
03 layout 185-232
4-04-2005
16:16
Pagina 190
190
cepire per gli americani, anche se forse non avrebbe dovuto sorprendere: la ricompensa per la vittoria nella seconda guerra mondiale e la conquista dello status di superpotenza fu un conflitto protrattosi per oltre cinquant’anni. Ma l’aver vinto quel confitto, conquistando in seguito una posizione di egemonia nel mondo, ha significato, per l’America, essere l’unico bersaglio dell’ira degli scontenti. I mujaheddin che fornirono a Osama bin Laden la sua base iniziale di potere avevano trovato il loro cemento nella guerra contro i sovietici, il cui successo (con l’aiuto degli americani) tornò indubbiamente a vantaggio degli Stati Uniti. Allo stesso modo, anche il successo della prima guerra del Golfo, con la relativa stabilizzazione della regione che produce gran parte del fabbisogno di petrolio mondiale, si concluse con la presenza di soldati americani nella terra santa dell’Arabia Saudita – la prima delle accuse contro gli Stati Uniti elencate nella fatwa di bin Laden. Ancora una volta, l’elemento tragico della geopolitica sfugge alla comprensione americana. Nessuna traccia delle preoccupazioni che assillavano Winston Churchill o David Ben Gurion nei momenti della vittoria, quando pensavano alle battaglie a venire. Come all’epoca dei coloni, anche ora l’innato ottimismo degli americani li spinge a credere che, superate le difficoltà del caso, sia possibile raggiungere la Terra promessa e porre fine ai travagli. Beghe interne A ulteriore conferma della scarsa inclinazione degli americani a pensare in termini geopolitici, basta prendere atto dell’impossibilità di cogliere appieno la natura dei dibattiti di politica estera attualmente in corso se non si considera che ad animarli non è la geopolitica bensì un problema di autodefinizione. E non si tratta di puro egotismo da parte di una superpotenza che può concedersi il lusso di concentrarsi su se stessa, ma del persistere di una tradizione che risale alla sua fondazione. In una nazione dove tutto, o quasi, è fluido, e la libertà è considerata talmente importante da rappresentare sovente non tanto il bene supremo, ma l’unico bene, la sensazione inevitabile è che ci siano ancora molte cose in sospeso, da definire, con conseguenze rilevanti sul piano politico. Sotto molti aspetti, le questioni restano sostanzialmente le stesse: le sfide lanciate tanto tempo fa sono state raccolte da nuovi soggetti.
03 layout 185-232
4-04-2005
16:16
Pagina 191
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
191
I termini delle questioni, ovvviamente, non sono più gli stessi. I politici di oggi si muovono in circostanze molto diverse e sono essi stessi il prodotto di esperienze del tutto nuove. Ma, come a suo tempo osservò Margaret Thatcher, l’America è fondata sulla filosofia e non sulla storia. Un’affermazione, questa, che non viene smentita dal fatto che oggi proprio la sua storia ha concorso a plasmare molte sue percezioni del mondo. Ciò significa che le divergenze sui principi fondamentali sono iscritte nella natura stessa di questo paese. E la sua supremazia non ha fatto che elevare la posta in gioco per quanti stanno ancora cercando di deciderne il futuro. Tutto è cambiato con la svolta operata dal presidente in carica all’indomani dell’11 settembre. Quando, quattro anni fa, George W. Bush s’insediò alla Casa Bianca, promise un ritorno a una politica estera più prudente e conservatrice di quella dell’amministrazione di suo padre, da cui ereditò figure quali Colin Powell e Dick Cheney. Ciononostante, è proprio in questo settore che Bush si è dimostrato uno dei presidenti più liberali – anzi più rivoluzionari – della storia americana, i cui discorsi suonano simili «non soltanto a quelli di Woodrow Wilson, ma a un discepolo contemporaneo di Immanuel Kant, il filosofo dell’illuminismo tedesco»5. Così, la Strategia per la sicurezza nazionale del 2002, con la sua teoria della prevenzione mirata all’Iraq, si è affiancata a un rinnovato interesse per i diritti umani e per la natura interna dei regimi ostili. Ed è stato lo stesso Bush, in un discorso tenuto nel novembre 2003 presso il National Endowment for Democracy, a fornire la più ampia illustrazione dei principi cui s’ispira la sua amministrazione e della svolta successiva agli eventi dell’11 settembre. In quell’occasione, egli proclamò apertamente la volontà di assicurare la giustizia prima della stabilità in Medio Oriente (e quindi nelle aree di crisi del mondo) attraverso la diffusione del liberalismo e della democrazia, non soltanto come strumento retorico ma come strategia effettiva. Ciò ha segnato un evidente ritorno alla dottrina Reagan, con la differenza però che, laddove quest’ultima mirava a perseguire in tal modo un obiettivo specifico – la caduta dell’Unione Sovietica –, la dottrina Bush si prefigge invece lo scopo, molto più ambizioso e potenzialmente inesauribile, di costruire un nuovo ordine mondiale pienamente democratico. Non vi è dubbio che la visione del mondo di Reagan e quella
03 layout 185-232
4-04-2005
16:16
Pagina 192
192
di Bush derivino direttamente da uno dei principi cardine della strategia di contenimento originaria, elaborata in uno dei suoi documenti fondamentali, l’NSC-68, in cui si proclama che «Solo con l’affermazione pratica, sia all’estero che in patria, dei nostri valori essenziali, potremo preservare la nostra integrità, dando scacco in tal modo al disegno del Cremlino»6. Basta sostituire «fondamentalista islamico» a «Cremlino» per constatare un comune orientamento caratteristicamente americano. Quella che in precedenza era stata una politica essenzialmente gradualistica – volta a promuovere una liberalizzazione su scala globale in funzione degli interessi americani – assunse così uno slancio straordinario. E all’interno del paese, le vecchie categorie prevalenti dopo la guerra del Vietnam vennero rovesciate con straordinaria rapidità. Il quadro esistente era in ultima analisi artificiale, in quanto si era venuto a creare dopo la crisi dell’orientamento tradizionale americano in seguito all’esperienza del Vietnam. Alla rinuncia dell’establishment, rafforzata dall’avvento dell’internazionalismo liberale, venne così contrapponendosi una sorta di iperrealismo. Sarebbe difficile non annoverare Dean Acheson, Teddy Roosevelt o John Quincy tra le file dei realisti, ma il loro era un realismo ispirato dall’antica fede nell’eccezionalità dell’America. Per questi uomini, la difesa degli interessi nazionali e dei principi morali era una cosa sola. Ma il richiamo a quei principi venne alla fine strumentalizzato da progressisti esacerbati che si servirono di un linguaggio moralistico per denunciare proprio quello stesso moralismo, colpevole, a loro avviso, di aver portato l’America sulla strada sbagliata. Ciò produsse, per reazione, un realismo distaccato e profondamente pragmatico, che aveva poco in comune con quello più ispirato dei primi statisti americani, pur condividendo con quest’ultimo la difesa costante degli interessi nazionali. Quel realismo prudente, inaugurato da Henry Kissinger, è vivo ancora oggi, ma è privo d’una base politica di sostegno ed è ancora in attesa di esprimere un leader in grado di galvanizzare la nazione. Al polo opposto dello spettro politico, troviamo i wilsoniani originari, reincarnati nei neoconservatori di oggi, i quali non paventano il coinvolgimento nel sistema internazionale in quanto tale, bensì gli effetti dell’esistenza di regimi non democratici al suo interno. In realtà, se la democrazia non è sicura dappertutto, non è sicura in nessun luogo. Ignorare l’esistenza di tirannie o la piaga di
03 layout 185-232
4-04-2005
16:16
Pagina 193
193
democrazie assediate nel resto del mondo, equivale a corrompere gli ideali democratici e a minarne le fondamenta in casa propria. Per preservare la purezza della democrazia, costoro non esiterebbero a gettarsi nel fango della politica internazionale, come dei missionari zelanti disposti a tutto pur di convertire in suore le prostitute. Vi è, infine, il liberalismo moderno, post-Vietnam, erede di Wilson, che disdegna profondamente gli interessi nazionali e per il quale la moralità non risiede più in una nazione giusta, ma al di sopra di essa, nella forma di istituzioni sopranazionali. Fatto proprio dal Partito Democratico negli ultimi trentacinque anni, questo liberalismo ha trovato tuttavia la sua massima espressione politica al di fuori della politica stessa: nei media. E ciò gli assicura una forte influenza nel dibattito corrente, pur continuando a essere distante dalla massa dei cittadini.
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
Opinione pubblica ed élite concordano su numerosi temi di politica estera. E, tuttavia, le differenze tra di loro superano di gran lunga le analogie: l’opinione pubblica è nazionalista, le élite sono transnazionaliste7.
Ciascuno di questi orientamenti rappresenta un’estremizzazione di tendenze latenti, presenti da sempre nella tradizione americana, che, in mancanza di un terreno comune, hanno finito col diventare inconciliabili. E ognuno, in un certo senso, contiene il germe dell’isolazionismo, in quanto, pur riconoscendo l’esistenza del mondo, non lo vede com’è, ma con il prisma della propria interpretazione dell’esperienza americana. L’unico filo che li lega è, in ogni caso, l’importanza secondaria attribuita alle considerazioni geopolitiche. La metamorfosi di un presidente repubblicano in un crociato ha completamente sconvolto la scena. In gran parte essa è dovuta alla rapida ascesa dei neoconservatori dopo l’11 settembre, i soli ad avere un piano qualsivoglia all’indomani degli attacchi: trasformare il Medio Oriente, per troppo tempo culla del terrorismo e del dispotismo – visti come due fenomeni strettamente intrecciati –, in un luogo «sicuro per la democrazia», con la speranza che cessi di rappresentare una minaccia per la vita degli americani. Secondo Peter Berkowitz la politica estera dei neoconservatori tende a «perseguire fini progressisti – la diffusione universale della
03 layout 185-232
4-04-2005
16:16
Pagina 194
194
democrazia liberale – con mezzi non progressisti – l’esercito americano»8. Dopotutto, che altro potrebbe esservi di più progressista, più liberale «dell’unica, grande impresa di ingegneria sociale mai intrapresa dall’America, la rimozione chirurgica di un dittatore nell’altra parte del pianeta e, a un costo superiore ai 100 miliardi di dollari, la creazione di istituzioni democratiche in un territorio straniero che non ha mai conosciuto l’autogoverno?»9. L’ottimismo apparentemente immotivato di molti di questi politici deriva in buona parte da una esperienza formativa nelle amministrazioni Reagan. A quegli anni risale il loro impatto con le politiche che portarono al crollo dell’Unione Sovietica e alla successiva transizione democratica dei paesi dell’Europa dell’Est, contro le previsioni di molti. E, sempre negli anni Ottanta, furono testimoni della sostituzione di regimi autoritari con sistemi democratici nelle Filippine, in Nicaragua, in Cile, nella Corea del Sud e della progressiva democratizzazione di Taiwan sotto la sorveglianza degli Stati Uniti – imprese un tempo ritenute impossibili, tra gli altri, anche dal Dipartimento di Stato. Almeno per il momento, i gruppi neoconservatori hanno formulato una politica in grado di mobilitare gli americani, che, alla valutazione delle minacce – l’imperativo di distruggere regimi che potrebbero fornire armi di distruzione di massa ai terroristi – associa l’idealismo – il progetto di sostituirli con qualcosa di meglio. Molti realisti, tra cui Brent Scowcroft, consigliere per la sicurezza nazionale sotto Bush senior, erano contrari a portare alle estreme conseguenze questo progetto, mentre altri, come Henry Kissinger, avevano espresso un tiepido assenso alla guerra in Iraq. Ma lo scontro più aspro è stato quello tra neoconservatori e liberal post-Vietnam, che si sono dati battaglia sulla definizione dell’idealismo americano. E pensare che i paladini della guerra in Iraq, dai liberal per autoproclamazione, come Christopher Hitchens e Paul Berman, alle teste d’uovo di tendenza più conservatrice, come Bill Kristol e Robert Kagan, avrebbero potuto fare appello all’eredità di Wilson per sostenere la necessità di rovesciare un dittatore spietato e di promuovere la democrazia in quel paese, ma altrettanto avrebbero potuto fare quelli che erano contrari: numerosi esponenti del Partito Democratico, per esempio, e il comitato di redazione del New York Times, convinti che, sfidare la volontà della «comunità internazionale», equivalesse a un uso illegale della forza.
03 layout 185-232
4-04-2005
16:16
Pagina 195
195
Queste profonde tensioni sono state ulteriormente acuite dal prolungarsi dell’occupazione dell’Iraq e dalla rielezione di Bush. Ma, mentre queste curiose controversie interne, rimaste confinate per lo più nel ristretto ambito della capitale, animavano il dibattito sulla politica estera americana, nel tentativo di attrezzarsi ad affrontare il mondo secondo i propri desideri, eventi più grandi si susseguivano rapidamente.
NOTE *
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
Fatwa significa «editto religioso» espresso da giureconsulti autorevoli al fine di interpretare rettamente la rivelazione coranica su questioni non chiare e definite [N.d.T.] 1 Ferguson N., Colossus: The Price of America’s Empire, The Penguin Press, 2003 [11/9 è la data storica del crollo del muro di Berlino, abbattuto il 9 novembre del 1989, N.d.T.]. 2 Rose G., «Imperialism: The Highest State of Capitalism?», The National Interest, n. 71, primavera 2003. 3 Ikenberry G.J., «Getting Hegemony Right», The National Interest, primavera 2001. 4 Gaddis, p. 10. 5 Ash T.G., «Living With America», Newsweek, 22 novembre 2004. 6 NSC-68, «United States, Objectives and Programs for National Security», 14 aprile 1950, Foreign Relations, United States, 1950, vol. 1, p. 240. 7 Huntington S., «Dead souls», The National Interest, primavera 2004. 8 Berkowitz P., «Political Paradoxes», The New York Sun, 29 giugno 2004. 9 Ibid.
03 layout 185-232
4-04-2005
16:16
Pagina 196
CAPITOLO DODICESIMO
L’AMERICA E IL MONDO
Oggi gli Stati Uniti hanno indubbiamente un problema di pubbliche relazioni. Alla base di molti degli ostacoli diplomatici che incontrano, c’è il problema derivante dalla loro presunzione di essere, per dirla con Madeleine Albright, «la nazione indispensabile», unita alla sottaciuta (anche se spesso non così tacita) convinzione che gli interessi dell’America coincidano con quelli del mondo intero. Ma questa retorica moralistica non ha trovato consensi oltreconfine e appare, per certi aspetti, come un’autogiustificazione da parte di chi intende mantenere in realtà la propria supremazia internazionale. Molti infatti, al di fuori degli Stati Uniti, ritengono che ciò nasconda, in modo disonesto, interessi economici di bassa lega; o che, nonostante gli onesti intenti, la sua efficacia sia dubbia. Come aveva acutamente osservato Henry David Thoreau: «Se sapessi che qualcuno viene a casa mia con l’intenzione cosciente di farmi del bene, non mi farei più trovare...». Questa pretesa degli americani non ha fatto di certo molti proseliti alla loro causa. Il problema è inoltre esacerbato dalla tendenza attuale ad equiparare la forza al diritto, laddove invece nel corso di gran parte della storia degli Stati Uniti questi sono stati due termini antitetici, almeno sul piano dei principi. Per quanto ragionevole e necessaria sia la difesa dei loro interessi nazionali, gli americani tendono a considerarli, senza riflettere, omogenei a quelli del resto del mondo. E anche quando ciò fosse il caso (come talvolta è accaduto in passato), si parte comunque dal presupposto che gli altri paesi, almeno in Occidente, la pensino allo stesso modo, ignorando così la storia dell’umanità. Ma perché mai, ora che l’Unione Sovietica non esiste più, il mondo dovrebbe guardare con sollievo anziché con trepidazione alla continua crescita della potenza americana.
03 layout 185-232
4-04-2005
16:16
Pagina 197
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
197
Gli Stati Uniti hanno dunque un problema di credibilità. Si ha un bel dire che pensano al bene dell’umanità quando cercano di combattere il terrorismo, ma ciò non toglie che molti paesi non danno la stessa importanza a questa minaccia. Molti di questi problemi sono spesso visti, in modo semplicistico, come dimostrazione dell’arroganza del potere, quando invece sono semplicemente il risultato della storia della seconda metà del XX secolo. Il mondo attuale è, verosimilmente, una chimera, ovvero il risultato di una lotta per la conquista della supremazia globale durante la quale gli Stati Uniti hanno assunto responsabilità sempre più vaste su scala planetaria. E questo successo ha creato situazioni senza precedenti e forse alla lunga insostenibili. Ma, nel corso di questo lungo conflitto, si era soliti parlare, giustamente, non soltanto di contrapposizione fra russi e americani, bensì anche fra occidentali e sovietici. Così, come gli Stati Uniti ostentavano orgogliosamente il loro sistema di alleanze sotto l’egida della NATO, allo stesso modo i sovietici cercarono di fare altrettanto, dapprima attraverso il Patto di Varsavia, poi, su scala più ampia, attraverso il Terzo Mondo, in qualsiasi paese riuscivano a incoraggiare sommovimenti rivoluzionari. Chi dimentica o ignora le dimensioni di quel conflitto non riesce a cogliere l’importanza della differenza tra i rapporti dell’America e dell’Unione Sovietica con i loro rispettivi alleati. Uno dei vantaggi duraturi in questa lotta fu infatti la crescente disparità fra questi sistemi di «alleanze» e il grado e la natura degli obblighi che comportavano. Ciò non significa che l’Alleanza Atlantica fosse compatta. Gli interessi nazionali tendevano sempre a prevalere. La Gran Bretagna rivendicò il diritto a sviluppare un programma nucleare per proprio conto, al pari della Francia. E gli Stati Uniti denunciarono il comportamento di entrambi questi paesi durante la crisi di Suez, umiliandoli agli occhi del mondo intero. Questi contrasti spinsero infine la Francia a uscire dalla NATO e a perseguire un’autonoma politica di distensione con l’URSS. E, nel frattempo, emersero molti disaccordi sul modo di affrontare la questione dei paesi satelliti di Mosca, soprattutto nella fase precedente la Ostpolitik di Willy Brandt. Ma, alla fine, tutti gli Stati che avevano aderito alla NATO erano uniti da un comune impegno per la difesa delle libertà che stanno
03 layout 185-232
4-04-2005
16:16
Pagina 198
198
alla base delle società democratiche occidentali. E la principale minaccia che gravava su di esse proveniva dall’Unione Sovietica. Così, fu proprio la necessità di far fronte a questo pericolo che le spinse a ricompattarsi sotto la guida degli Stati Uniti. Alla luce del deterioramento dei loro rapporti, che hanno raggiunto il punto storicamente più basso dopo l’11 settembre, sia l’Europa che gli Stati Uniti hanno certamente mitizzato, in qualche misura, il periodo della seconda guerra mondiale e gli anni immediatamente successivi, quando le amministrazioni Roosevelt e Truman e le istituzioni da esse create rappresentarono l’epoca d’oro della solidarietà interatlantica e della diplomazia americana nel mondo. Un’epoca in cui gli alleati venivano consultati, le intese erano cordiali e venne creato un sistema che assegnava un ruolo a ciascun attore. Da questo punto di vista, l’equilibrio emerso nel dopoguerra presentava analogie con quello prevalso dopo il Congresso di Vienna. Il sistema di trattati, alleanze e istituzioni creato sotto quelle due presidenze americane era decisamente un’anomalia rispetto alla tradizione degli Stati Uniti, in quanto comportava un impegno permanente col mondo esterno. Come osservò lo stesso Truman: «Mi rendevo conto che lo spirito di Washington, di Henry Clay e di tutti gli altri santi patroni dell’isolazionismo sarebbe stato invocato contro di me»1. Oggi si tende a rivalutare la saggezza e la lungimiranza di quelle politiche che spinsero gli Satati Uniti ad abbandonare in parte l’indipendenza cui tanto tenevano e a cogestire la loro potenza nel quadro di istituzioni internazionali a beneficio di tutti. Ma nulla potrebbe essere più lontano dal vero. Se così fosse stato, nulla di tutto questo avrebbe potuto accadere, poiché il popolo americano non lo avrebbe mai permesso. Alla fine, fu la semplice esistenza di tali istituzioni a conferire loro autorevolezza. E questo, insieme alla buona volontà degli statisti di entrambe le sponde dell’Atlantico, porta coloro che riesaminano quel periodo a scambiare per cause gli effetti di quelle iniziative. Gli Stati Uniti, infatti, conclusero invariabilmente i loro accordi dimostrando la capacità di conservare la loro libertà d’azione e la loro superiorità sugli alleati. Tant’è vero che nel momento stesso in cui decisero finalmente, senza esitazioni, di assumere un impegno internazionale, il loro predominio nei confronti degli alleati era talmente schiacciante che la diplomazia tradizionale non sembrò
03 layout 185-232
4-04-2005
16:16
Pagina 199
199
svolgere un ruolo significativo. E il loro rapporto, del tutto atipico, con gli alleati durante la Guerra Fredda, divenne la norma. La logica essenziale dell’isolazionismo non venne sconvolta più di tanto né abbandonata come si potrebbe credere. Si potrebbe perciò affermare, onestamente, che il periodo successivo alla seconda guerra mondiale segnò la prima esperienza di un’alleanza duratura in cui prevalse la diplomazia e non si tenne più conto dell’ammonimento di Washington. L’importanza di questa fase deriva in larga misura dal modo in cui l’America concepì i suoi rapporti stabili con i paesi amici, ricercando un difficile equilibrio fra l’assenza di un aperto conflitto e l’impossibilità di armonizzare tutti gli obiettivi. Il periodo in questione illumina infatti non solo i problemi della leadership americana, ma anche quelli di qualsiasi coalizione fra partner ineguali. Alla fine si arrivò a discutere del perché le nazioni collaborano. Secondo il punto di vista americano, tutti i popoli ragionevoli prima o poi arrivano alle stesse conclusioni; gli obiettivi comuni, pertanto, sono dati più o meno per scontati e l’accento viene posto sui meccanismi idonei all’attuazione dell’armonia latente2.
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
La verità dell’osservazione di Churchill secondo la quale «la storia di tutte le alleanze si può riassumere nelle reciproche lagnanze di coloro che ne fanno parte» è stata riconosciuta tardivamente, e forse mai appieno, dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti infatti non hanno mai considerato il rapporto con l’Europa alla stessa stregua di quello stabilito tra la Gran Bretagna e i Paesi Bassi. E nel momento in cui si trattava di stringere alleanze strategiche, occorreva qualcosa di più. I fondatori dell’Alleanza Atlantica [...] capivano che senza i legami atlantici l’America si sarebbe trovata in un mondo di nazioni con le quali non aveva vincoli morali o tradizioni comuni, salvo che nell’emisfero occidentale. In tali circostanze, gli Stati Uniti sarebbero stati costretti a condurre una Realpolitik essenzialmente incompatibile con la tradizione americana3.
L’impegno dell’America nel mondo – in termini espliciti, e non soltanto sottintesi tra le righe della dottrina Monroe – era largamente basato su una rinuncia agli interessi geopolitici dal punto di vista della sua tradizione. Era pertanto necessario che questa svolta
03 layout 185-232
4-04-2005
16:16
Pagina 200
200
venisse vista non come una scelta da parte degli Stati Uniti, ma come un fardello che era stato posto sulle loro spalle. L’America non entrava in lizza nell’arena delle grandi potenze perché aveva improvvisamente deciso di perseguire i propri interessi in quest’ambito, bensì in quanto una grave situazione internazionale esigeva un suo impegno. Ma poteva pretendere legittimamente di intervenire solo proclamando il suo disinteresse. E quando si trattò di venire in soccorso dell’Europa, la sua decisione non fu dettata da una più ampia definizione dei propri interessi strategici, quanto piuttosto dalla convinzione che essa avesse l’obbligo morale di difendere la libertà. Ecco perché la difficoltà attuale dei rapporti interatlantici, pur se probabilmente inevitabile, è per molti una crisi psicologica più che un problema politico. Gli Stati Uniti sono riusciti a evitare molte contraddizioni intrinseche alla loro posizione di superpotenza liberale proclamando, in modo convincente durante la Guerra Fredda, che i loro interessi nazionali coincidevano con quelli dei loro alleati, effettivi e anche potenziali, nonostante le divergenze circostanziali o le incomprensioni, il che equivaleva a includere in teoria il mondo intero (così, durante gli anni di Clinton, la NATO si allargò indiscriminatamente, senza troppo riflettere in quale direzione)4. Ciò aveva una certa plausibilità (più in Europa occidentale che non, per esempio, in America Latina) per il fatto che essi stavano lottando contro la peggior tirannia mai conosciuta nel mondo, con ambizioni di predominio globale per giunta. John Lewis Gaddis definì questo orientamento una strategia volta a evitare il peggio, attraverso la quale gli Stati Uniti mantengono una legittimità internazionale, posto che vi sia sempre qualcosa di peggio da scongiurare5. Ma dopo il crollo del regime che incarnava quel peggio, sono riusciti a evitare ulteriormente di far fronte al loro dilemma geopolitico elevando il concetto di interesse nazionale al livello di pura astrazione durante l’amministrazione Clinton. Così, affermando che l’America era favorevole al liberalismo e alla democrazia e alla lotta contro la povertà nel mondo, ha potuto pretendere che i suoi interessi fossero universali, quando invece erano in effetti particolaristici. Un’affermazione più o meno simile a quella di un politico che di fronte ai suoi potenziali elettori dice di essere favorevole alle famiglie. Ma chi non lo è? Ciò, tuttavia, non impedì l’emergere, in Europa, durante gli anni Novanta, di un’opposizione alla supremazia degli Stati Uniti, che
03 layout 185-232
4-04-2005
16:16
Pagina 201
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
201
il primo ministro francese Hubert Vedrine definì una «iperpotenza». Per tutto quel periodo, il volto pubblico dell’America – almeno nel Vecchio Continente – fu incarnato soprattutto dalla tendenza liberale internazionalista, che aveva più a che vedere con i suoi interlocutori che con il popolo che essi rappresentavano. E questo, unitamente al disinteresse generale degli americani per gli scopi della politica estera, creò l’impressione che il multilateralismo fosse divenuto la tendenza prevalente. Ma così non era. L’unilateralismo è sempre stato infatti l’impulso predominante negli Stati Uniti. Le sue origini risalgono a un periodo in cui l’America non era ancora una potenza mondiale e se ne trova già un’eco negli ammonimenti di George Washington. Il suo principio cardine è quello di riservarsi una libertà d’azione, agendo con gli alleati quand’è possibile e da soli se necessario. O, per dirla con il segretario alla Difesa, Donald Rumsfeld: «È la missione che determina la coalizione». Ma la verità è che, fin dall’inizio della Guerra Fredda, gli americani non hanno preferito «agire da soli». E anche se, per gran parte della loro storia, si sono comportati proprio così, lo hanno fatto in tempi in cui le loro azioni passavano quasi inosservate agli occhi del mondo esterno, in un emisfero largamente periferico rispetto alle preoccupazioni predominanti delle grandi potenze dell’epoca. Molti consigliano oggi agli Stati Uniti di attenersi al principio proclamato nella loro Dichiarazione di indipendenza, manifestando un «rispetto per le opinioni del resto del mondo». Un’esortazione spesso associata all’idea che ciò rispecchi la loro vocazione originaria, dal momento in cui è espressa in uno dei documenti su cui si fondano. Ma la verità è che, per la maggior parte della loro storia, l’umanità si è occupata ben poco degli Stati Uniti. L’isolamento diplomatico dell’America su numerose questioni – dall’embargo contro Cuba alle risoluzioni di condanna di Israele, fino ai trattati per il bando delle mine terrestri – solitamente nell’ambito dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, è visto spesso come una prova della sua arroganza di superpotenza. Quale altra nazione sarebbe altrettanto sicura di sé da mettersi ripetutamente in contrasto con la stragrande maggioranza dell’opinione pubblica internazionale (o quanto meno dei suoi rappresentanti)? Data la rapidità della loro ascesa, non dovrebbe sorprendere se il peso geopolitico degli Stati Uniti non si è ancora tradotto completamente in una consapevolezza psicologica adeguata. Per secoli, ancor prima
03 layout 185-232
4-04-2005
16:16
Pagina 202
202
della loro fondazione, sono state le opinioni interne, non quelle esterne, che hanno contato. Gli americani hanno condiviso per lungo tempo la convinzione di Andrew Jackson secondo il quale «un solo uomo coraggioso forma una maggioranza». E il fatto che quel «solo uomo» spenda per la difesa più di altri venti paesi messi assieme non cambia molto le cose. Dico questo per spiegare in parte perché il comportamento dell’America dopo la Guerra Fredda, e in particolare all’indomani dei fatti dell’11 settembre, non dovrebbe essere visto come una rottura col passato o un abbandono di uno schietto dialogo col mondo esterno, o quanto meno con i suoi alleati, ma come un confronto con una nuova realtà internazionale. Oggi esiste indubbiamente un ordine basato essenzialmente su due concetti americani: il sistema di alleanze fra paesi occidentali ereditato dalla Guerra Fredda e quello di sicurezza internazionale (molto più debole) costituito dalle Nazioni Unite. In un certo senso, gli Stati Uniti si trovano perciò intrappolati in un ordine mondiale che essi stessi hanno contribuito in larga misura a creare e che per molti aspetti è sicuramente funzionale ai loro interessi. Sarebbe difficile immaginare, a rigor di logica, un altro sistema in cui una sola potenza distanzi tutte le altre in termini politici, militari, economici e culturali, senza dover imporre un dominio imperiale diretto. Nessun sistema tuttavia si sostiene da solo. L’abdicazione delle potenze europee e del bordo del Pacifico in materia di difesa, il disordine interno e la povertà prevalente dei paesi del Terzo Mondo, l’incertezza riguardo alla Russia e alla Cina e l’impotenza delle istituzioni internazionali sono tutti fattori che concorrono ad assegnare agli Stati Uniti una responsabilità sproporzionata nel mantenimento della stabilità relativa di quello che – dato il suo squilibrio – dovrebbe essere, in teoria, un mondo molto più caotico. È senz’altro vero che mai prima, nella storia, una sola nazione è stata così importante per garantire un ordine più ampio pur rimanendo parte di esso. La Gran Bretagna, per esempio, fu sempre il fattore decisivo, ma in definitiva uno fra gli altri all’interno del sistema europeo. E Roma non sorreggeva l’ordine, ma lo era essa stessa. È necessario riconoscere il problema che gli Stati Uniti debbono affrontare nel mondo attuale (per non parlare del terrorismo). Detto semplicemente, da quando sono diventati per la prima volta una po-
03 layout 185-232
4-04-2005
16:16
Pagina 203
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
203
tenza globale, il mondo era in larga misura diviso, per quanto riguardava le nazioni che avevano un’importanza decisiva, fra amici e nemici. Pur se dovettero basarsi sugli interessi in molte occasioni, il contrasto o la convergenza fra questi ultimi fu ampiamente sussunto nel quadro più generale della lotta fra tirannia e libertà. La natura dei regimi con cui avevano a che fare svolse un ruolo molto importante nel determinare l’esito del conflitto. E questo fu indubbiamente un punto di forza, in quanto consentì loro di affrontare gli avversari con grande determinazione e di improntare (quasi sempre) i loro rapporti con gli alleasti a un vero senso di solidarietà che andava oltre il mero opportunismo, aiutandoli a superare molte crisi. In precedenza, l’America non si era considerata affatto parte del sistema internazionale (fatta eccezione per l’epoca di Theodore Roosevelt), poiché era rimasta ferma al monito di George Washington e alla dottrina Monroe, nella convinzione che ogni nazione vivesse felicemente entro i propri orizzonti, interagendo con le altre solo su un piano commerciale. In altre parole, solo alla vigilia della guerra contro l’Iraq si è resa conto che un nuovo ordine internazionale comportava necessariamente un riesame dei propri interessi e l’instaurazione di nuovi rapporti con gli altri paesi del mondo e in special modo con gli alleati. Sin dalla fine della Guerra Fredda, gli Stati Uniti hanno dovuto operare in una realtà internazionale fatta di nazioni con interessi contrastanti anziché di amici, con i quali le divergenze si potevano appianare, e di nemici, che andavano invece contenuti o annientati. Ovvero hanno dovuto vedersela con una Russia che non agisce entro la sua sfera in modi necessariamente conformi ai valori americani, ma la cui stabilità, tenuto conto soprattutto dei suoi depositi ancora consistenti di armi di distruzione di massa, è considerata molto importante per Washington; con una Cina autoritaria al suo interno e in ascesa come potenza economica concorrente, ma senza le ambizioni dell’ex Unione Sovietica; e con un’Europa in realtà inesistente, anche se si contrappone regolarmente all’America nel campo della politica estera, pur rimanendo legata a essa attraverso vari trattati e organizzazioni internazionali, prima fra tutte la NATO. Tutti questi problemi pongono gli Stati Uniti in una situazione ambigua sul piano internazionale. E per affrontarli occorre una più accorta diplomazia, ma soprattutto una visione del mondo molto
03 layout 185-232
4-04-2005
16:16
Pagina 204
204
diversa da quella che gli americani hanno sempre avuto. Ovvero più vicina al realismo di Theodore Roosevelt, il quale non vedeva il suo paese circondato da amici e nemici, bensì da nazioni che perseguivano i propri interessi. Trovare una posizione più equlibrata non sarà facile per l’America nel prossimo futuro. E sarebbe stato comunque un problema anche se non fosse scoppiato il terrorismo islamico che ha cambiato tutti i calcoli oltreché la storia recente.
NOTE 1
Truman H., Memoirs, Doubleday, Garden City, New York, 1955. Kissinger, Diplomacy, Simon & Shuster, New York, 1994, p. 616 (trad. it., L’arte della diplomazia, Sperling & Kupfer, Milano, 2004, p. 478). 3 Ibid., p. 819 (trad. it. cit., p. 640). 4 Harries O., «The Dangers of Expansive Realism», The National Interest, Inverno 1997/98. 5 Gaddis, Surprise, Security, and the American Experience, Harvard University Press, 2004, p. 64 2
03 layout 185-232
4-04-2005
16:16
Pagina 205
CAPITOLO TREDICESIMO
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
LA GUERRA SULLA GUERRA
Dopo gli attacchi dell’11 settembre, l’evento globale dominante è stato sicuramente l’invasione dell’Iraq, con i contrasti che la hanno accompagnata e la violenza che ancora oggi caratterizza il dopoguerra in quel paese. La guerra con l’Iraq ha alimentato un antiamericanismo contingente e per molti è stata l’occasione per manifestare opinioni radicate da tempo. Nell’invasione, in altre parole, ciascuno ha visto ciò che voleva, rinunciando sostanzialmente al tentativo di capire che cosa abbia spinto l’America a questo passo. La domanda da porsi, viceversa, era, ed è, perché l’Iraq? La convinzione diffusa in buona parte dell’Italia e dell’Europa, così come in un’ampia fascia della popolazione americana, è che si sia trattato di una guerra per il petrolio e, quindi, di natura economica. Punto e basta. Ma se venalità e avidità fossero tipiche della politica estera dell’America, la sua storia dovrebbe conservarne tracce evidenti. Inoltre, se essa avesse una lunga tradizione alle spalle di abile capacità di manovra dal punto di vista geopolitico, i suoi responsabili politici avrebbero dimostrato probabilmente molta più competenza nel far fronte alla situazione postbellica, se non per il beneficio degli iracheni, almeno per il proprio. E se, d’altra parte, la guerra con l’Iraq segnasse una svolta nella politica estera americana, allora saremmo in presenza di un cambiamento assolutamente rivoluzionario che, con il consenso della maggioranza del popolo americano, avrebbe fatto piazza pulita dei metodi seguiti negli ultimi duecentoventi anni. Un’intera nazione avrebbe sostanzialmente rinnegato la sua tradizione per escogitare politiche volte a saccheggiare le risorse di un altro paese, con costi ingenti in termini di vite umane, di mezzi finanziari (almeno nel breve periodo, in attesa che montagne di soldi e di barili di petrolio incomincino ad affluire a titolo di risarcimento)
03 layout 185-232
4-04-2005
16:16
Pagina 206
206
e di legittimità internazionale – per tacere dei rischi di un aumento del terrorismo contro gli Stati Uniti e i loro alleati. Una visione, questa, che ha in sé qualcosa di squallido e insieme poco convincente: parlare di una ricerca della supremazia degli Stati Uniti nei confronti delle altre grandi potenze – sull’esempio del Kaiser Guglielmo II – suonerebbe di gran lunga più plausibile. È assurdo pensare che l’unica superpotenza rimasta, con una forza militare e una ricchezza che non hanno eguali, si liberi di tutte le sue remore morali e decida, come manifestazione del suo predominio, d’invadere un paese come l’Iraq, rivelando in questa impresa la sua debolezza. Il tutto per scoprire che il prezzo del petrolio continua a essere alto, che si bruciano miliardi di dollari e non ci sono segni di ripresa, mentre, in questo momento, gli americani che hanno perduto la vita sono più di 1000. Nel frattempo, le televisioni di tutto il mondo trasmettono le immagini del caos, della violenza e dell’inettitudine americana, con soddisfazione dei potenziali terroristi (per non parlare di quelli reali) e imbarazzo degli alleati. E di fronte a tutto questo c’è chi è convinto che la posta in gioco fosse mettere le mani sul petrolio iracheno. A questo punto viene spontaneo chiedersi se non sarebbe stato più semplice comprarlo, il petrolio. Si sa che Saddam sarebbe stato disposto a venderlo, sia pure a prezzi maggiorati. Come si sa che i canali ufficiosi erano in grado di stringere accordi con il raìs, come conferma lo scandalo del programma Oil-for-food. Comunque sia, il petrolio poteva essere una motivazione tanto per favorire la guerra quanto per osteggiarla, come di fatto fecero numerose società petrolifere, esercitando pressioni affinché le sanzioni fossero revocate. Quanto alle armi di distruzione di massa, si è trattato di un fattore importante, ma non fondamentale. E la mancata scoperta ha indotto molti a concludere che si trattasse di un pretesto sin dall’inizio, come conferma chiaramente lo slogan scandito da milioni di manifestanti: «Bush mente e la gente muore». Riesce, tuttavia, difficile credere che l’amministrazione abbia mentito deliberatamente sapendo che, all’indomani dell’invasione, la verità sarebbe emersa. In realtà, i servizi segreti americani non erano i soli a credere nell’esistenza di queste armi. A fugare eventuali dubbi in materia, avevano contribuito il colossale fallimento della CIA riguardo all’11 settembre e il fatto che negli anni precedenti la prima guerra del Golfo non c’era stato il minimo sentore che di lì a un anno Saddam
03 layout 185-232
4-04-2005
16:16
Pagina 207
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
207
avrebbe avuto l’arma nucleare. Questa volta la prudenza consigliava di pensare al peggio. C’è poi chi vede nelle scelte operate dall’America la tendenza a uno «scontro di civiltà». Una tesi, a mio parere, decisamente assurda: in una guerra basata sul concetto di «scontro di civiltà» l’esportazione della democrazia non sarebbe certo una tattica vincente, in quanto partirebbe dal presupposto che un’altra civiltà, con una storia e con consuetudini completamente diverse, non può in alcun modo portare a istituzioni democratiche. Lo scontro delle civiltà non è negli interessi degli Stati Uniti, i quali – questa la realtà – hanno difficoltà a prendere atto dell’esistenza delle stesse. È il senso religioso che permea la loro visione del mondo a non consentire questo tipo di distinzioni. E non è la teoria, ma la storia – soprattutto le esperienze maturate all’epoca della Guerra Fredda – a determinare buona parte delle loro scelte attuali. La guerra con l’Iraq rientra a pieno titolo nella tradizione americana, anche se non per le ragioni accennate in precedenza. Oggi, però, alla luce della disastrosa gestione del dopoguerra in quel paese, è difficile parlare con chiarezza dei motivi che hanno portato all’invasione. Una cosa però è certa: la guerra e la gestione attuale sono legate alla percezione che Washington aveva dell’Iraq prima di accingersi all’impresa. Vale a dire che la guerra e i piani di ricostruzione hanno il loro fondamento nell’incapacità di formulare una valutazione geopolitica della regione e che questa incapacità ha generato politiche sbagliate. I fautori della guerra hanno comunque colto una verità particolare attorno alla quale molti, a mio avviso con qualche ipocrisia, si sono timidamente agitati. Mi riferisco al veleno insinuatosi nelle culture di gran parte di quello che oggi si chiama il Grande Medio Oriente, con una definizione tanto vaga quanto inutile. Qui, sull’esempio di quanto accadde in Europa verso la fine del XIX secolo, l’impulso religioso, che aveva guidato tanta parte della storia della regione, impossibilitato a esprimersi altrimenti dall’avvento della filosofa e del materialismo moderni, aveva imboccato la strada delle ideologie politiche, con conseguenze micidiali. In questo caso, la fonte del modernismo era decisamente esterna, proveniva cioè da una civiltà i cui rapporti con il mondo musulmano non erano stati, a dir poco, storicamente tranquilli. Era la stessa fonte di scontri storici; dell’odiato colonialismo che aveva ritracciato antichi confini nazionali; delle aspirazioni socialiste che avevano prodotto regimi
03 layout 185-232
4-04-2005
16:16
Pagina 208
208
dispotici e inefficienti in Egitto, in Siria, nel Libano e in Iraq. Una fonte che aveva portato alla disgregazione del tessuto sociale, senza che ciò comportasse il minimo vantaggio. E adesso, grazie alla tecnologia di quel modernismo, i «martiri» della causa hanno trovato il modo di esprimere tutta la loro rabbia nei confronti dell’Occidente. E per molti, troppi, anche per quelli che non imbracciano le armi, questa guerra è probabilmente diventata il mezzo per affrancare una civiltà sempre più alla deriva in un mondo moderno e distante. «Abbandona questa vita senza senso e avrai la massima ricompensa in cielo. Le porte sono aperte ai nuovi arruolati», recitava un volantino distribuito nelle moschee radicali di Milano. Un problema di cui gli europei non hanno ancora preso atto fino in fondo, con i rischi conseguenti. Così, le abituali manifestazioni di appoggio ai leader che tiranneggiano il loro popolo, la denigrazione reiterata dell’Occidente, in generale, e dell’America e di Israele in particolare, e il conseguente rifiuto di pensare in modo critico a problemi sociali che hanno radici profonde, possono essere tutti ricondotti a un’unica causa che è di ostacolo al progresso. La guerra in Iraq è stata anche in buona parte, e sinceramente, motivata dalla convinzione di poter cambiare le cose e di fare di quel paese un caso esemplare nella regione. Un Iraq libero dal partito Baath, sulla strada di una vera prosperità nazionale invece che di una cleptocrazia arricchita, che garantisca i diritti dei suoi cittadini, confermerebbe le possibilità di una moderna democrazia liberale e incoraggerebbe col tempo il rifiuto di tendenze regionali più distruttive. Resta, però, che, avendo individuato il problema, l’America ne ha visto la soluzione con il prisma della sua esperienza. L’antica fede nei poteri salutari della democrazia, che risale alla fondazione ed è stata rafforzata dai travagli della Guerra Fredda, non ha fatto che raddoppiare alla luce della diffusione dei principi democratici in gran parte del mondo. L’idea che la natura dei regimi sia al centro di tutti i conflitti politici e che la democrazia sia la soluzione ha le sue radici nel pensiero dei padri fondatori. «Come prima fase della terapia, è il governo stesso che deve essere rigenerato. La sua volontà deve essere subordinata a quella della comunità o, meglio, uniformarsi a essa», aveva affermato James Madison1. E di fatto la storia americana può essere in gran parte interpretata come una strenua difesa della democrazia liberale in tutti gli eventi mondiali.
03 layout 185-232
4-04-2005
16:16
Pagina 209
209
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
È vero anche che, a differenza di altri regimi, le democrazie generalmente non si fanno la guerra e risolvono le divergenze pacificamente, se non amichevolmente, indirizzando le ambizioni dei loro cittadini verso obiettivi commerciali e tutelandone i diritti fondamentali. È comunque difficile stabilire la misura in cui l’esperienza dell’America sia attinente ai problemi che si trova di fronte in Medio Oriente. C’è il rischio, infatti, che la terapia proposta, nell’ignoranza della situazione reale, aggravi la malattia. «Non tutti gli anticomunisti sono democratici e non tutti i democratici si oppongono all’imperialismo russo», fu il commento di Henry Kissinger a proposito della lotta per il potere scatenatasi in Russia agli inizi degli anni Novanta, dopo il crollo dell’Unione Sovietica. Una verità sacrosanta anche per i riformatori del Medio Oriente di oggi, nei quali l’amministrazione Bush ha riposto molte delle sue speranze: non tutti gli antiautoritari sono filoamericani o contrari al terrorismo. E qui si pone il più ovvio dei problemi: l’improbabilità, e probabilmente l’impossibilità, che i paesi del Medio Oriente, a cominciare dall’Iraq, diano vita a un sistema democratico, quanto meno in un tempo utile alla soluzione dei problemi in atto. Quanto alla questione della legittimità violata nei forum internazionali, viene da rispondere che la legittimità è scarsamente utile quando si frappone alla tutela dei bisogni di sicurezza percepiti dalla nazione interessata. Sul piano morale, il multilateralismo nulla ha fatto per scongiurare il massacro in atto in Sudan (e ben poco nei Balcani nel corso degli anni Novanta). La verità, anche se più complessa, è che per gli Stati Uniti obiettivi di lungo periodo e legittimità internazionale non si escludono reciprocamente. La speranza di ottenere una legittimazione ex post non era poi così irragionevole. Sarebbe bastato scovare un programma di armi di distruzione di massa di ampie proporzioni all’indomani dell’invasione o realizzare una transizione verso la democrazia in tempi rapidi e a costi contenuti, com’era nelle aspettative dell’amministrazione Bush. Chi ha affermato che l’unilateralismo americano nei confronti dell’Iraq interrompe una lunga tradizione di cooperazione transatlantica non conosce la storia. All’epoca della Guerra Fredda, gli Stati Uniti spinsero ripetutamente gli alleati europei a fare cose che erano riluttanti a fare, non di rado anteponendo i fatti a una successiva approvazione. Ed essendo la loro valutazione più realistica di quella degli europei, la le-
03 layout 185-232
4-04-2005
16:16
Pagina 210
210 gittimazione veniva di fatto accordata retrospettivamente. E, all’epoca, gli Stati Uniti non furono accusati di unilateralismo, ma elogiati per la loro leadership2.
La guerra in Iraq – e, più precisamente, la polemica su di essa – riassume il dilemma geopolitico attuale degli Stati Uniti, ovvero la tensione irriducibile fra il loro universalismo e il loro particolarismo, fra l’America come base dell’ordine internazionale e come Stato-nazione, nel senso che i suoi interessi specifici – o almeno la sua percezione di questi ultimi – inficeranno sempre in qualche misura le sue pretese universalistiche in questi forum internazionali. Ciò si spiega in parte col fatto che organizzazioni internazionali quali le Nazioni Unite, al pari della Chiesa cattolica, hanno una visione universalistica che, in alcuni momenti, entra in conflitto con quella degli Stati Uniti. Ma come ha osservato Joef Joffe, «La pace non fiorisce grazie alle istituzioni, ma sono queste ultime che fioriscono grazie alla pace»3, la quale, a sua volta, si basa sugli equilibri di forza. Di conseguenza, vi è anche un argomento più brutale per motivare l’invasione dell’Iraq. Il proverbio latino, secondo il quale «la fortuna aiuta gli audaci» potrebbe aver fornito una giustificazione convincente. Dopo aver assunto l’iniziativa in Afghanistan, era necessario non perdere slancio, costringendo i nemici sulla difensiva così da smentire sonoramente qualsiasi credenza residua, come quella diffusa da bin Laden, nella debolezza dell’America. Al pari di altre ideologie, la volontà di potenza dell’integralismo islamico non deriva, come molti continuano a sostenere, dalla disperazione, bensì dalla «speranza e dall’onore». E anche quest’impulso ha dovuto essere soffocato. Come diceva Machiavelli: «Gli uomini vanno accarezzati o annientati». Ma è evidente che il machiavellismo mal si attaglia al carattere degli Stati Uniti. In effetti, l’invasione ha oscillato fra questo atteggiamento, improntato allo spirito della campagna Shock e Sgomento, e un estremo idealismo wilsoniano, ispirato dalla convinzione che il rovesciamento di Saddam avrebbe fatto apparire gli americani come liberatori e che la democrazia sarebbe uscita bell’e pronta, come Minerva dalla testa di Giove, senza la necessità di un ulteriore uso della forza. Di questo era profondamente convinto il vicepresidente Dick Cheney, secondo il quale il popolo iracheno desiderava «sbarazzarsi di Saddam» e avrebbe accolto gli americani a braccia
03 layout 185-232
4-04-2005
16:16
Pagina 211
211
aperte una volta abbattuto il tiranno4. Così, in modo abbastanza insolito, gli Stati Uniti fecero tesoro del consiglio di Machiavelli a non seguire la via di mezzo. L’invasione e l’occupazione dell’Iraq forniscono molte altre illustrazioni del rifiuto di scegliere fra principi in contrasto fra loro (gli interessi spesso si possono mettere più facilmente al primo posto) come, per esempio, fra democrazia e stabilità, sovranità e monopolio della violenza contro i ribelli. Gli Stati Uniti avrebbero voluto che Allawi possedesse una reale sovranità, così da sgravarli da ogni fardello imperiale, ma non volevano che egli intaccasse la sua legittimità venendo a patti con Moqtada al Sadr. Ma, come ha osservato George Will,
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
considerando il problema di al Sadr e delle sue milizie, [...] un portavoce dei Marines ha detto: «Continueremo le operazioni nei modi che il primo ministro [Allawi] riterrà opportuni». [Ma nel frattempo] le autorità militari americane «hanno ridimensionato una più ampia proposta di amnistia nazionale annunciata dal Dr. Allawi all’inizio di questa settimana, che ne limita l’applicazione escludendo qualsiasi ribelle che abbia preso parte all’uccisione o al ferimento di militari americani».
Da cui il suo legittimo interrogativo: «Chi esercita in effetti la sovranità? Il primo ministro, che può imporre la sua volontà ai comandanti militari americani? O questi ultimi, che possono limitare la sua autorità?»5. La confusione circa il problema della natura della nuova sovranità irachena ha portato a commettere l’errore forse più grave: la decisione di sciogliere le forze armate nazionali. È proprio qui che l’ambivalenza tipicamente americana riguardo alle dure scelte imposte dalla geopolitica e il relativo ottimismo che tende a considerarle ovviabili hanno dimostrato le loro disastrose conseguenze. Non c’è dubbio che mantenere intatta la struttura di base dell’esercito iracheno avrebbe significato lasciare al potere esponenti di secondo rango del vecchio regime baathista, né che l’intenzione di cancellare il più possibile le tracce lasciate da Saddam fosse genuina. Ma la riluttanza al compromesso nel perseguire obiettivi più ampi e la speranza che, nel vuoto di potere, sarebbero prevalsi i migliori anziché i peggiori istinti, hanno favorito l’emergere di organizzazioni armate ostili che hanno tratto motivi e occasioni per infliggere gravi danni alle truppe americane e alla popolazione irachena.
03 layout 185-232
4-04-2005
16:16
Pagina 212
212
Di certo, la convinzione di poter trasformare rapidamente l’Iraq in una democrazia liberale più o meno stabile è un’ulteriore prova indubitabile, se mai ve ne fosse stato bisogno d’altre, che gli Stati Uniti non tengono conto dei fattori geopolitici nella loro politica estera. A sostegno di tale convinzione, si è spesso rilevato che, dopo tutto, questo cambiamento era stato realizzato con successo in Germania, in Italia e in Giappone. Ma si potrebbe scrivere un intero libro per dimostrare, con mille esempi, che l’Iraq non è paragonabile a questi paesi all’indomani della seconda guerra mondiale. Come ha osservato James Fallows in un’acuta analisi del processo decisionale antecedente l’invasione, Quando gli esponenti dell’amministrazione Bush cercavano di prefigurare quel che avrebbe potuto succedere in Iraq, facevano quasi sempre riferimento ai successi duraturi ottenuti in Giappone e in Germania, o in altri paesi dell’ex blocco sovietico in Europa orientale. (Un consulente civile diretto a Baghdad all’inizio dell’occupazione ricorda che, osservando gli altri passeggeri che viaggiavano a bordo dello stesso aereo militare, quelli che non dormivano o non sfogliavano riviste leggevano libri sulle due ex potenze dell’Asse, non sul mondo arabo. E, secondo lui «Questo non era un buon segno»)6.
Il desiderio di instaurare una democrazia anziché contare sulle autorità esistenti significava inoltre far affidamento su chi già aveva maturato un’esperienza democratica concreta, ovvero sui fuoriusciti, come Ahmed Chalabi, sebbene egli mancasse dall’Iraq da quando Fellini aveva girato Le notti di Cabiria. Questo non significa che gli arabi siano incapaci di dar vita a un sistema democratico. Coloro che escludono subito questa possibilità indulgono a un cinico semplicismo. Non v’è motivo di scartare completamente questa ipotesi, soprattutto alla luce della sorprendente fioritura della democrazia su terreni considerati assai poco fertili per il suo sviluppo. Ma ciò che è possibile non è necessariamente probabile, e gli statisti debbono operare nel campo del fattibile se non vogliono costruire i loro progetti sulla sabbia. L’invasione dell’Iraq, infine, forse più di qualsiasi altro evento nella loro storia, ha esposto gli Stati Uniti all’accusa di comportarsi come una potenza imperiale. Per molti aspetti, la questione imperiale li ha afflitti fin dalle loro origini, quando si distaccarono da uno dei grandi imperi e si proclamarono estranei ai vecchi metodi
03 layout 185-232
4-04-2005
16:16
Pagina 213
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
213
basati sulla pura politica di potenza, imboccando una strada che li avrebbe poi costretti, per coerenza con questo alto principio, a tenersi alla larga da qualsiasi tentazione imperiale. Ma queste, in effetti, sono, in una certa misura, intrinseche alla natura stessa della politica estera. Quando si trascendono i confini della repubblica e si riconosce l’esistenza di interessi al di là dei propri confini, emerge fatalmente il problema dell’imperialismo, se non dell’impero. Quali libertà si è disposti a concedere ad altri a rischio della propria sicurezza e prosperità? Dal momento in cui Jefferson inviò le sue navi nel Mediterraneo, o John Quincy Adams mercanteggiò senza pudore l’acquisizione della Florida dopo che Andrew Jackson l’aveva già rivendicata con la forza, la tentazione imperiale era ormai affiorata. E non è facile distinguere dove finisce l’impero e comincia la geopolitica. Di fatto, le nazioni più propense a lasciarsi guidare da quest’ultima sono quelle più incoercibilmente imperialiste. Ma ancor più evidenti dovrebbero essere gli sforzi compiuti dagli Stati Uniti per non cadere in questa trappola. L’Iraq ne è un esempio eloquente. Quasi tutti gli errori commessi in questo paese sono in effetti il risultato del tentativo di evitare la tendenza imperiale. La sua invasione era stata progettata inizialmente partendo dall’ipotesi che la gioia per il defenestramento di Saddam si sarebbe tradotta in una positiva volontà di cooperazione, in modo che le truppe americane non dovessero rimanere a lungo sul suo territorio. Le soverchie speranze in una rapida instaurazione della democrazia rispecchiavano cioè il desiderio di trovare una strategia d’uscita in tempi brevi. E l’impiego di forze di combattimento leggere e su scala ridotta, che a sua volta ha impedito di prevenire i saccheggi, far funzionare i servizi e pacificare il paese, è stato indotto dal timore di apparire come conquistatori. Ma soprattutto, la più ampia strategia volta a creare un effetto domino positivo di espansione della democrazia nell’intera regione, era l’apoteosi dell’aspettativa antimperiale. Dopo l’11 settembre, venne deciso, molto giustamente, che limitarsi a dar la caccia a bin Laden e ai suoi seguaci sulle montagne dell’Hindukush sarebbe stato insufficiente a prevenire futuri attacchi. Ma ciò avrebbe comportato un lungo impegno, costante, graduale, senza limiti di tempo, per affrontare i problemi del Medio Oriente a vari livelli, con risultati non prevedibili in anticipo. Il carattere rivoluzionario della politica di Bush ha evitato proprio questo, puntando non già a un’in-
03 layout 185-232
4-04-2005
16:16
Pagina 214
214
terminabile espansione dell’influenza americana, bensì a stabilizzare la regione senza un eccessivo dispendio di energie. Per quanto lungo fosse stato il periodo necessario a tal fine – la Guerra Fredda è durata 45 anni – vi sarebbe stata una fine, dopo di che gli americani avrebbero fatto ritorno in patria, una volta garantita la sicurezza del loro paese. Solo gli americani potevano credere che il loro impegno nella prima guerra mondiale fosse inteso a promuovere la democrazia nel mondo. O che il Giappone imperialista e la Germania hitleriana potessero diventare dei paesi liberi, come essi si sforzarono, con successo, di trasformarli. I punti di forza e di debolezza degli Stati Uniti derivano dalla stessa radice e non sono facilmente distinguibili. Con questo non vogliamo dire che gli ideali americani siano per loro natura la causa del disastro; gli errori vengono commessi dai pasticcioni e a essi soltanto ne va attribuita la responsabilità. Ma l’impulso che ha portato a invadere l’Iraq deriva da una tendenza tipicamente americana, non da un desiderio di dominio e di espansione imperiale. In effetti, il problema non era tanto la guerra in sé e per sé, bensì il tentativo, fallito, di inserirla in un più ampio piano d’azione americano. Dopo aver ignorato per troppo tempo i problemi che affliggevano il Medio Oriente, nella speranza che i regimi esistenti assicurassero le forniture di petrolio, cercando di quando in quando di spingere Israele a fare qualche concessione, convinti che ciò avrebbe alleviato le tensioni, gli Stati Uniti sono passati improvvisamente all’estremo opposto senza troppo riflettere. Resta da chiedersi, tuttavia, se Bush intendesse la politica della prevenzione, adottata per preparare l’invasione dell’Iraq, come una strategia generale per l’intera regione o semplicemente come una minaccia per mettere in riga i regimi turbolenti, come quello di Saddam. In questa seconda versione, essa sembrò dare inizialmente buoni risultati, con la rinuncia della Libia al suo programma nucleare e la rinnovata disponibilità della Siria e dell’Iran, nelle prime settimane, a riprendere i negoziati. Ma quell’onda d’urto non poteva durare indefinitamente, e sebbene per Gheddafi fosse ormai troppo tardi, questi ultimi due paesi trovarono invece conveniente rendere la vita ancor più difficile agli americani in Iraq, convinti che, una volta intrappolati, non avrebbero più costituito una grossa minaccia. Ma ancor più arduo è stabilire se la democratizzazione fosse lo
03 layout 185-232
4-04-2005
16:16
Pagina 215
215
scopo ultimo dell’intervento. Riconosciuto che la situazione attuale è indesiderabile, quale grado di instabilità gli Stati Uniti sono disposti a tollerare pur di raggiungere quell’obiettivo? Dean Acheson definì il compito che stava di fronte a lui e agli americani dopo la seconda guerra mondiale come quello di «ricostruire mezzo mondo [...] senza che tutto andasse in pezzi nel corso di quest’opera»7. Sebbene nessuna impresa che l’America si accinga a compiere oggi sia altrettanto grandiosa, quel periodo può servire da lezione per il futuro. Serve a poco trasformare il Medio Oriente, se ciò provoca soltanto disastri. Il perseguimento di quest’obiettivo – sia pur in vista dello sviluppo della democrazia – porterebbe, con tutta probabilità, a un rovesciamento dell’attuale monarchia saudita e del regime del generale Musharraf in Pakistan, con l’avvento al potere di fanatici integralisti islamici: proprio quello che si proponeva bin Laden con la sua strategia iniziale. Essendo passati da un estremo all’altro, gli Stati Uniti devono ora affrontare una lunga fase di riassestamento, sia in Iraq che altrove.
NOTE
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
1
Hunt G.(a cura di), The Writings of James Madison, G.P. Putnam’s Sons, New York, 1906, vol. VI, p. 89. 2 Fukuyama F., «The Neoconservative Moment», The National Interest, estate 2004. 3 Joffe J., «Bismarck or Britain?», International Security, vol. 19 nr. 4, primavera 1995, pp. 94-117. 4 Richard Cheney, osservazioni su Meet the Press, 16 marzo 2003 (la campagna Shock and Awe – un’espressione spesso erroneamente tradotta con «Colpisci e terrorizza» – cui si fa riferimento poche righe sopra, prende il nome dal titolo di un fortunato libro di Harlan k. Ullmann e James P. Wade, Choc and Awe. Achieving Rapid Dominance [«Choc e sgomento. Come ottenere rapidamente il predominio»] pubblicato nel 1996 dalla National Defense University Press. La tesi degli autori, che dichiarano d’ispirarsi al famoso stratega cinese Sun Tzu del V secolo a.C., è questa: «Disarmare l’avversario prima della battaglia è il più grande successo che un comandante possa ottenere». Com’è noto, Choc e Sgomento è stato il nome dell’operazione dei bombardamenti di Baghdad: distruggere psicologicamente il nemico, togliendogli la forza di combattere, N.d. T.]. 5 Will G.F., «Ignoring History in Iraq», The Washington Post, 18 agosto 2004. 6 Fallows J., «Blind Into Baghdad», The Atlantic Monthly, gennaio-febbraio 2004. 7 Acheson D., Present at the Creation, W.W. Norton, New York, 1969.
03 layout 185-232
4-04-2005
16:16
Pagina 216
CAPITOLO QUATTORDICESIMO
E POI?
Mentre scriviamo, l’Iraq è ancora in primo piano e la riconferma di George W. Bush alla presidenza è motivo di preoccupazione per buona parte del mondo. Molti si chiederanno se sarebbe stato possibile imprimere agli eventi una piega diversa. Ma la risposta non è incoraggiante. L’impressione è che il presidente americano abbia respinto con pervicacia il monito di Otto von Bismarck: «Guai al leader i cui argomenti, alla fine di una guerra, non sono plausibili quanto lo furono agli inizi». Ma la verità è che Bush ha vinto perché le differenze con lo sfidante, John Kerry, non erano tali – quanto meno sul fronte della politica estera – da indurre la maggioranza degli americani a cambiare leadership. E qui si apre una speranza, perché, come abbiamo visto, la tradizione americana entra spesso in contrasto con se stessa – non con il mondo esterno: è dai tempi di Jefferson e di Washington che i dibattiti di politica estera investono non solo questioni di strategia, ma di diritto, sempre sullo stesso tema: a chi spetta definire l’America? La politica estera americana si è espressa al meglio negli anni successivi alla seconda guerra mondiale, in presenza di un consenso reale tra i responsabili politici al timone di uno Stato che navigava in acque turbolente. A rinsaldare la tradizione, all’epoca, contribuì la sensazione che l’impegno americano sulla scena mondiale – almeno in quel momento – fosse non soltanto necessario ma giusto. Dopo la crisi seguita alla tragedia del Vietnam, le varie tendenze dell’antica tradizione si riorganizzarono in fazioni, con il compito di definire la nazione, sia che ciò significasse trasformarla in una forza del bene o, più semplicemente, preservarla dagli istinti peggiori. La difficoltà di fare politica dopo l’11 settembre è in buona parte
03 layout 185-232
4-04-2005
16:16
Pagina 217
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
217
dovuta alla frammentazione del gruppo a cui era stato affidato il compito di formularla. E tuttavia, dopo aver preso atto dell’impossibilità di lasciare l’Iraq o di ricostruirlo da cima a fondo, si direbbe che oggi stia maturando un impegno effettivo a perseguire gli interessi americani nel mondo, in grado, probabilmente, di mettere a tacere le dispute interne1. Si tratta, in altre parole, di un recupero della strategia di Nixon: siamo coinvolti, e non per scelta. Soltanto il tempo ci dirà se il nostro impegno comporterà ulteriori sviluppi. Il fatto nuovo che emerge dalla progressione degli eventi riassunti in questo libro sono le circostanze del tutto diverse con cui gli Stati Uniti si sono confrontati dopo la fine della Guerra Fredda. L’11 settembre non ha modificato la struttura dell’ordine internazionale più di quanto fece Pearl Harbour, ma ne ha cambiato la percezione da parte dell’America, cosa che, nel corso della sua storia, ha sempre rivestito un’importanza maggiore rispetto a tutte le situazioni geopolitiche oggettive. Gli attacchi messi a segno a New York e a Washington gettano luce sugli interessi legati alla presenza americana nel mondo: parafrasando Trotsky, si può affermare che, se l’America non è interessata alla geopolitica, quest’ultima continua a essere interessata all’America. Di qui, la reazione tardiva ai cambiamenti geopolitici verificatisi quindici anni or sono, con l’implosione dell’Unione Sovietica. Il presidente Clinton (come del resto l’opposizione repubblicana) cercò di eludere questo problema di fondo, spostando le questioni politiche sul piano economico e conferendo alle responsabilità americane una dimensione globale, con risultati fallimentari. La difficoltà vera consisteva nel dover affrontare il mondo senza saperne il perché. Compito sicuramente più facile per quella generazione di grandi insediata al potere dopo la seconda guerra mondiale: allora, la convinzione della necessità del coinvolgimento americano era basata sull’esistenza della minaccia sovietica e sul concomitante declino della Gran Bretagna e della Francia nel ruolo di grandi potenze. E l’imminenza della sfida allontanava qualsiasi scontro interno sul ruolo dell’America come pilastro del sistema internazionale in confronto alla sua posizione di repubblica insulare, libera di pensare a se stessa senza dover tenere conto delle peripezie della storia del mondo esterno. La specificità del compito, inoltre, legava l’impe-
03 layout 185-232
4-04-2005
16:16
Pagina 218
218
gno americano al contenimento e all’annientamento finale di una superpotenza ideologicamente motivata, ovvero a un obietitvo circoscritto, e non (salvo negli anni di Nixon e di Kissinger) a un ruolo geopolitico permanente. È comprensibile, quindi, come la guerra contro il terrorismo non possa sostituire la funzione svolta a suo tempo dalla Guerra Fredda. Questa è la pura verità, al di là del fatto che, per dirla con il comico Jon Stewart, si tratta «soltanto di un’epressione vuota», poiché la lotta contro il terrorismo è destinata a non finire mai. O, meglio, la sua fine può essere esclusivamente soggettiva, legata alle percezioni del popolo americano e alla leadership di turno. Dalla guerra d’Indipendenza in poi, gli Stati Uniti hanno condotto le guerre con l’intento di perseguire obiettivi ultimi, anche per far sì che il ricorso alle armi non fosse soltanto un altro strumento della politica, secondo la concezione di von Clausewitz. La guerra non è un canale naturale in cui convogliare ambizioni e bisogni di uomini e Stati, ma rappresenta piuttosto la rottura assoluta dei normali rapporti interumani. Ciò significa che deve avere un esito definitivo, quasi a rassicurare gli americani che non potrà mai più accadere, ovvero che si tratta di «una guerra per porre fine a tutte le guerre». Abraham Lincoln non scese a patti con la Confederazione e passò al vaglio numerosi generali, nel timore che fossero privi della risolutezza necessaria per condurre la guerra fino in fondo, ovvero per stroncare la volontà di resistenza degli stati del Sud – e non soltanto per assicurarsi una serie di vittorie sul campo. Woodrow Wilson decise di prendere parte alla prima guerra mondiale allo scopo di rovesciare il Kaiser e gli Absburgo, senza di che non si poteva parlare, secondo lui, di una vittoria definitiva. Dopo l’attacco di Pearl Harbour, l’ammiraglio Yamamoto si lasciò andare a una cupa previsione: «Non la smetteranno più di darci la caccia». Come nel caso della prima, anche in quello della seconda guerra mondiale, la vittoria sarebbe stata assicurata solo con l’annientamento del regime imperiale in Giappone e del nazismo in Europa. Ancor più significativamente, la Guerra Fredda non sarebbe stata risolta instaurando un equilibrio di forze ragionevolmente favorevole, che sarebbe stato probabilmente raggiungibile già molto tempo prima, bensì con la distruzione dell’ideologia marxista-leninista al potere e il crollo del regime.
03 layout 185-232
4-04-2005
16:16
Pagina 219
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
219
Per gli americani, ma non solo per loro, questi sono spesso considerati esempi di altrettante battaglie contro il male, e in ciò vi è di sicuro un elemento di verità. Sarebbe tuttavia più esatto affermare che esse rappresentano l’incrollabile determinazione a garantire un mondo libero dalle minacce, ad assicurare la «libertà dalla paura», nella straordinaria presunzione che un mondo simile sia non soltanto possibile ma naturale. Come per i pionieri, con la loro infaticabile ricerca di nuovi territori dove potersi infine stabilire senza più peregrinazioni, anche oggi è vivo il convincimento di poter chiudere il capitolo della geopolitica per concedere all’America il meritato riposo. È questo convincimento, e non la cieca aspirazione all’impero o alla supremazia, ad alimentare da sempre le imprese americane nel mondo. E se questa interpretazione richiama alla mente gli antichi imperi, se non i moderni, quando Atene e Roma espansero all’esterno le loro periferie per creare una situazione di sicurezza che si avvicinasse all’assoluto, è bene non farsi trarre in inganno. L’aspirazione al dominio era addirittura iscritta nel codice morale di Roma, anche ai tempi della repubblica, che non nutriva certo scrupoli riguardo alla sua presenza nel Mediterraneo e oltre, necessaria per garantire stabilità e prosperità all’impero. Era un codice inflessibile, ma anche innegabilmente realistico, che non si sottraeva alle richieste di sostenere l’ordine costituito. L’impulso americano, viceversa, è l’antitesi dell’aspirazione imperiale, perché guidato dalla convinzione che, una volta raggiunto l’obiettivo, l’America possa far ritorno a casa. Ne consegue che la guerra contro il terrorismo ha lo scopo di annientare tutti coloro che potrebbero nuocerle, com’è accaduto in tutti i grandi conflitti del passato. A rendere difficile la sua posizione è il fatto che lo status quo è al tempo stesso estremamente favorevole ed estremamente pericoloso. Questo spiega perché, soprattutto quanti sono stati testimoni degli attacchi dell’11 settembre, siano propensi ad agire secondo una logica decisamente più rivoluzionaria. Non avendo perseguito deliberatamente un disegno egemonico, l’America non apprezza più di tanto i vantaggi di uno status quo che la vede insediata al vertice, specie quando questa posizione può comportare la perdita di una città. A spingerla sulla scena mondiale non è la ricerca del potere o del petrolio, ma quella della sicurezza, con il rischio, tuttavia, che i suoi standard elevati la rendano controproducente. Ma, nell’im-
03 layout 185-232
4-04-2005
16:16
Pagina 220
220
possibilità di cambiare il mondo per conformarlo ai suoi criteri di sicurezza, nulla le vieta di tentare di assicurarla nella misura del possibile. Una maggior propensione ad accettare le connotazioni imperiali di una strategia globale senza grandi finalità, che non scaturisce da imperativi morali, si sarebbe forse tradotta, paradossalmente, in una politica estera più moderata. Riconoscere l’impossibilità di raddrizzare il mondo di punto in bianco per poi lasciare che segua il suo corso, avrebbe sicuramente significato meno crisi come quella dell’Iraq, anche se avrebbe comportato la necessità di dislocare militari e civili nelle aree in cui l’instabilità minaccia di degenerare in disastri di più ampie proporzioni. Ma questa non sarebbe una situazione poi così nuova. Come ha osservato Robert Kaplan: «In un mondo in cui le grandi invasioni di fanteria stanno diventando politicamente e diplomaticamente proibitive – sia pure in presenza del proliferare di massacri e crimini circoscritti a opera di piccoli gruppi di combattenti che trovano riparo nei deserti, nelle giungle o negli slum dei paesi sottosviluppati – è come se l’esercito americano fosse tornato ai tempi delle guerre contro i pellerossa»2. Il problema di individuare una strategia, quindi, non si pone: l’America, infatti, ha già fatto propria quella appena descritta. Dell’«impero americano» ultimamente si è discusso fino alla nausea, ma non altrettanto delle modalità di gestirlo, che, tuttavia, vanno ugualmente profilandosi. Mentre nei seminari a Washington e a New York, realisti e idealisti discettano sulla «ricostruzione degli Stati» e di altri principi generali, giovani tenenti colonnelli e altri ufficiali intermedi prendono sistematicamente decisioni sul campo sulle questioni più diverse: dall’addestramento dell’esercito colombiano all’individuazione dei capi tribali afghani da appoggiare, dalle esigenze del governo yemenita in materia di guardia costiera e di altre forze speciali alla tutela della sovranità della Mongolia, messa in pericolo dalle infiltrazioni cinesi e russe, e alla trasformazione dell’esercito di Romania in una struttura più piccola che risponda ai criteri di flessibilità della linea di comando occidentale, e via dicendo3.
Anche sotto una seconda amministrazione Bush e oltre, l’Iraq sarà l’eccezione e non la regola. La farsa andata in scena alle Nazioni Unite, con il valido contributo dell’opportunismo franco-tedesco e dell’esecrabile diplomazia americana, non è destinata a ripetersi.
03 layout 185-232
4-04-2005
16:16
Pagina 221
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
221
Una grande strategia, che prometteva molto di più di quanto avrebbe potuto probabilmente realizzare, ha provocato sconcerto in patria e, quel che è peggio, ha dato l’impressione di un’America minacciosa e, allo stesso tempo, debole all’estero. Corre tuttavia l’obbligo di aggiungere che un altro attacco devastante come quello dell’11 settembre, o anche peggiore, modificherebbe completamente la situazione. L’educazione geopolitica dell’America è un processo fragile, che può essere facilmente interrotto da quanti – si veda la grande offensiva contro il Giappone dopo l’attacco di Pearl Harbour – invece di pensare a una strategia di lungo periodo si preoccupano dell’immediato, e ciò in ossequio al principio elementare del «mai più». Sul carattere estemporaneo di molte delle scelte operate dall’America nel corso della sua storia non esistono dubbi. Ma, al di là di una specifica strategia, quella che oggi va maturando è la consapevolezza che la posizione attuale degli Stati Uniti – vale a dire di un paese che nel corso della storia ha operato nella presunzione di un’insita eccezionalità – non ha precedente alcuno e che l’improvvisazione e la gestione delle crisi non sono più sufficienti. Ciò non toglie che anche la politica di contenimento, ovvero la strategia più preventiva e specifica mai formulata da Washington, prevedesse un punto di arrivo. Theodore Roosevelt, che si lasciò fiduciosamente guidare dalle intuizioni geopolitiche e dalla salda difesa degli interessi nazionali, non previde, all’epoca, che gli Stati Uniti sarebbero stati il cardine dell’ordine internazionale. Oggi, viceversa, essi si trovano a contemperare il ruolo di paese che persegue interessi propri con quello di paladino, presumibilmente benevolo, dell’ordine mondiale. Senza poter uscire dalla scena internazionale, come fecero a suo tempo, né prospettare un esito finale gradito a tutti gli interessati. Qualsiasi amministrazione che aspiri ad avviare a soluzione questa contraddizione dovrebbe, tra l’altro, essere in grado di influenzare l’opinione pubblica facendole comprendere quest’esigenza e quale ruolo essa potrebbe svolgere in questo processo. E, considerato che la questione dell’autodefinizione della propria identità nazionale è sempre stata uno degli elementi essenziali per l’elaborazione della politica estera americana, è lecito pensare che gli Stati Uniti debbano prepararsi ad affrontare sfide senza precedenti, evitando però pericolose lacerazioni interne. Un problema, questo, che investe la leadership, dal mo-
03 layout 185-232
4-04-2005
16:16
Pagina 222
222
mento che un vero leader deve anche adempiere a una funzione educativa. Questo è il vero dilemma, di cui la guerra contro il terrorismo non è che un aspetto secondario, nonostante i rischi e i pericoli che comporta. Il mondo, infatti, ha di fronte a sé sfide di tipo nuovo, mentre l’America soltanto ora si appresta a venire a patti con questo stesso mondo che, per riprendere una felice espressione di Henry Kissinger, non può né dominare né abbandonare a se stesso4. Le due alternative – quella di una potenza che a suo tempo garantiva l’ordine, e che sta ancora tentando di definire il suo ruolo, e quella di un mondo che tenta di darsi un ordine – sono entrambe foriere di difficoltà. Ma la loro combinazione sarebbe davvero gravosa. Al punto in cui siamo, quindi, non è tanto necessario puntare su una grande strategia che induca l’America a entrare nella scena mondiale – perché in questa scena è ormai presente come nessuna nazione lo è mai stata – quanto porre le basi di una consapevolezza geopolitica che vada contro la sua storia e la sua tradizione e gli impulsi che la caratterizzano. Un’impresa che richiama quella compiuta dopo la seconda guerra mondiale dai responsabili politici, i quali la investirono di un ruolo globale che tuttavia non inibì i suoi istinti repubblicani. Dal punto di vista della sua storia, questa è una vera e propria rivoluzione. Ma, come disse il romanziere americano Thomas Wolfe, «non potrete mai più fare ritorno a casa». Paradossalmente, è proprio la rinuncia a molti dei suoi impulsi a fungere da sostegno nel difficile compito che il paese ha di fronte, consentendogli di restare «l’ultima migliore speranza» per molti anni ancora a venire. Non è da escludere che questa si riveli la lezione suprema dell’educazione geopolitica dell’America.
NOTE 1
«One Nation after all», The Economist, 11 settembre 2004. Kaplan R., «Indian Country», The Wall Street Journal, 25 settembre 2004. 3 Kaplan R., «Supremacy by Stealth», The Atlantic Monthly, luglio-agosto 2003. 4 Kissinger, Diplomacy, Simon & Shuster, New York, 1994, p. 19 (trad. it., L’arte della diplomazia, Sperling & Kupfer, Milano, 2004, p. 3). 2
03 layout 185-232
4-04-2005
16:16
Pagina 223
CONCLUSIONI
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
LE NOSTRE VIRTÙ E IL NOSTRO DIFETTO
Come si spiega dunque il successo degli Stati Uniti? In questo libro abbiamo cercato di dimostrare in che modo un paese che ha evitato di interpretare il mondo in chiave geopolitica ha elaborato, suo malgrado a volte, una politica estera. Ma questo forse non basta a spiegare perché essa sia stata così efficace. Può essere quindi opportuno riesaminare le due critiche principali mosse all’America, cui abbiamo fatto accenno all’inizio, secondo le quali essa sarebbe in definitiva inetta o corrotta. In un certo senso, entrambe colgono in parte nel segno. Tocqueville sosteneva giustamente che, in qualche misura, lo straordinario successo della politica estera degli Stati Uniti non è il risultato della loro abilità in questo campo, bensì il prodotto delle loro istituzioni che, a mio giudizio, sono riuscite ad arginare o quanto meno a incanalare molte forze politiche (e non politiche) dimostratesi così distruttive in altre situazioni. In un certo senso, l’America è rimasta unita mentre altri paesi si sono disgregati o semplicemente non si sono mai consolidati. La sua supremazia, alla luce della storia del Vecchio Continente, deve non poco a quella che potremmo definire l’abdicazione al trono da parte di molte altre potenze. E si è affermata nonostante l’assenza di una geostrategia. Ma questo non è avvenuto entro un vuoto, bensì in uno spazio specifico. Il suo vantaggio fondamentale, dal punto di vista geopolitico, deriva dalle sue origini. Come aveva osservato George Washington, la sua posizione geografica le aveva consentito uno sviluppo economico e politico senza precedenti. La sua fortuna discende pertanto dal fatto stesso di essere stata colonizzata già circa un secolo e mezzo prima di diventare una nazione. L’altro grande vantaggio è stato il modello federalista di governo, grazie al quale ha potuto assicurare la stabilità delle istituzioni politiche su un’area sempre più vasta. Non basta infatti estendere il
03 layout 185-232
4-04-2005
16:16
Pagina 224
224
proprio dominio territoriale, ma occorre dargli una base che accresca la forza della nazione invece di indebolirla, come la Russia non si è mai resa conto. Le idee formulate da Publius (pseudonimo collettivo di Alexander Hamilton, James Madison e John Jay) in un testo classico come Il federalista, non erano volte a capitalizzare le potenzialità geopolitiche dell’America, bensì ad affrontare il problema dell’istituzione di una libera repubblica su una grande estensione geografica. Ma fu proprio questa particolarità originaria, combinata con l’ubicazione degli Stati Uniti su un’ «ampia parte del continente», ad assicurare la loro fortuna assai più di qualsiasi grande strategia o di qualsiasi politica. Bisogna tuttavia ammettere, come Machiavelli avrebbe riconosciuto, che nella storia americana vi è anche un certo grado di ipocrisia. È stato giustamente osservato che gli Stati Uniti, «predicano l’idealismo ma praticano il realismo»1. Ciò in gran parte è inevitabile. Vi sarà sempre un divario fra le professioni di fede di una nazione e i suoi comportamenti. E la loro distanza ci dà la misura della sua ipocrisia alla prova dei fatti. Ma per quanto innegabile, questa constatazione risponde solo in parte a verità. Bisogna considerare infatti quali alternative coerenti si offrono in linea di principio come sul piano pratico e decidere se siano realmente preferibili. L’applicazione politica – ovvero limitata – dei principi morali si traduce inevitabilmente, da un lato, in un certo grado di ipocrisia e di cinismo o in un completo disastro, dall’altro. Ma ciò significa forse rinunciare del tutto a quei principi? Se l’ipocrisia è l’effetto indesiderato della difficoltà di conciliare i principi con la pratica, le alternative appaiono molto peggiori: o si abbandonano completamente i principi, adottando una politica di potenza amorale e alla lunga autodistruttiva; o li si applica fino in fondo, finendo così con l’esercitare una leadership inefficace o con l’assecondare un interventismo senza limiti. Questi esiti negativi possono essere la conseguenza inevitabile del carattere unico dell’America e della sua supremazia in campo internazionale. Non v’è dubbio che gli Stati Uniti, al pari di qualsiasi altra nazione, abbiano degli interessi pratici e che le politiche derivate dai loro ideali ne abbiano sempre tenuto conto. Ma ben diverso è dire che gli ideali dell’America sono stati concepiti allo scopo di promuovere questi interessi o che non sono mai
03 layout 185-232
4-04-2005
16:16
Pagina 225
225
stati i principi guida del suo orientamento nel campo della geopolitica. In sostanza, la filosofia originaria che prendeva le distanze dalla politica estera pura, detronizzandola e anteponendo a essa gli affari interni, ha plasmato le nostre istituzioni. E queste a loro volta, rafforzando le fondamenta di una società liberaldemocratica, fungono in larga misura da deterrente contro ogni tentazione di assegnare un primato alla politica estera. Così, gli Stati Uniti si sono sempre guardati dal far prevalere considerazioni puramente geopolitiche. Questa è considerata in qualche modo la prova dell’immaturità del popolo americano e della tendenza utopistica della sua classe dirigente. La maggior parte dei realisti non riesce a comprendere pienamente che l’eccezionalità dell’America è soltanto un altro nome dell’universalismo inseparabile dalla sua arte di governo poiché è parte integrante dei suoi principi fondativi e quindi della propria identità nazionale2.
Ovviamente, ciò determina un’incoerenza, rendendo difficile, persino ai critici più benevoli, la comprensione dei suoi comportamenti in campo internazionale.
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
In definitiva, il problema fondamentale della democrazia americana sta nel carattere democratico della sua politica estera. Questo è un fenomeno senza precedenti nella storia dall’epoca dell’antica Atene, la cui politica estera democratica provocò un disastro dopo l’altro [...]. La politica estera americana rimarrà sicuramente, com’è sempre stata, un enigma esasperante per il resto del mondo e per i nostri esperti, inguaribilmente convinti che essa debba essere astrattamente coerente3.
La questione più generale, come abbiamo cercato di dimostrare, è che questi problemi sono insiti nella struttura del sistema politico americano e nell’idea stessa che la nazione ha di sé. Non possono essere semplicemente liquidati come frutto di un errato modo di pensare. Questo non significa, ovviamente, che qualsiasi analisi sbagliata o azione inconsulta debbano essere giustificate o considerate inevitabili, a causa della natura degli Stati Uniti. Ma la stessa mentalità che ha condotto alla guerra nel Vietnam e a commettere un errore dopo l’altro in Iraq, ha generato anche il piano Marshall e il ponte aereo di Berlino, come pure l’impegno ad abbattere le tirannie del XX secolo.
03 layout 185-232
4-04-2005
16:16
Pagina 226
226
Come osserva Machiavelli riguardo al principe: «Se egli riuscisse a cambiare coi tempi, anche la sua fortuna non cambierebbe»4. Resta da chiedersi, tuttavia, qualora gli Stati Uniti non siano capaci di cambiare, se correranno il rischio di essere travolti dalle circostanze. In altri termini, nel caso in cui non riuscissero ad adottare un orientamento più schiettamente geopolitico, che accetti più o meno il mondo qual è senza ritrarsene, finirebbero alla deriva, incapaci di condurre una politica a sostegno dei loro interessi strategici? Non è facile rispondere a questa domanda, soprattutto per un americano. Sarebbe in effetti un’ironia della storia se un paese particolarmente attrezzato per affrontare le grandi sfide non fosse in grado di risolvere problemi più semplici e ordinari. La famosa frase di Charles de Gaulle, secondo il quale «la Francia non sarebbe quel che è senza la sua grandeur », vale anche per l’America. E ciò spiega in parte perché gli attentati dell’11 settembre abbiano prodotto non solo un giustificato risentimento, ma anche la convinzione che agli Stati Uniti veniva assegnato un nuovo grande compito. Da cui la straordinaria forza dell’amministrazione Bush e, più in generale, della reazione del paese. «La tragedia dell’America potrebbe derivare proprio dal fatto che essa è priva di un senso della tragedia.»5 L’idea che «Al di fuori del tempo e dello spazio, nulla è irrefutabile e tutto è possibile»6, ha fornito l’impulso a compiere imprese straordinarie, ma ha prodotto anche grandi catastrofi e potrebbe essere ancora la rovina dell’America. Riusciranno gli Stati Uniti a «diventare» una nazione più attenta alla geopolitica? Per quanto questo sia ineludibile, essi non possono cercare di trasformarsi in qualcosa che non sono mai stati. Il problema è quello di conciliare le dure esigenze della geopolitica con il peculiare carattere di questo paese, in modo da mettere in campo quelle strategie che essa richiede. Ma l’ironia vuole che la sua straordinaria fortuna e la sua supremazia, pur facilitando in teoria questo compito, rendano di fatto il problema più difficile. Sebbene il suo successo sia dovuto in gran parte al fatto che gli statisti americani non abbiano mai cercato di attenuare quei principi quando l’occasione sembrava richiederlo, in misura ancora maggiore deriva dalla sua capacità di tenere fermo a essi, anche di fronte alla dura realtà. Il fatto è che quei principi non offrono alcun consiglio semplice
03 layout 185-232
4-04-2005
16:16
Pagina 227
227
su come procedere, e probabilmente non lo hanno mai offerto. Oggi gli Stati Uniti stanno cercando di immaginare in che modo possono accettare la loro posizione permanente in un mondo da cui non possono ritrarsi né rendere più perfetto. I loro principi debbono guidarli nelle nuove acque mentre il paese impara sempre più a stare coi piedi per terra e non solo a guardare in alto.
NOTE 1
© Edizioni Angelo Guerini e Associati
Selden Z., «What Europe Doesn’t Understand», The Wall Street Journal, 26 maggio 2004. 2 J. Mahoney D.J., «De Gaulle and the Death of Europe», The National Interest, estate 1997. 3 Kristol I., «A Post-Wilsonian Foreign Policy», AEI Online, 2 agosto 1996. 4 Machiavelli N., The Prince, capitolo XXV (ed. it., Il Principe, Rizzoli, Milano, a cura di Piero Melograni, 1991, p. 221). 5 Kurth J., «Inside the Cave: The Banality of IR Studies», The National Interest, autunno 1998. 6 Caracciolo L., «Il sogno di Bush», Limes, 2/2004, «L’Impero Senza Impero».


![Storia universale. Storia degli Stati Uniti [Vol. 25]](https://ebin.pub/img/200x200/storia-universale-storia-degli-stati-uniti-vol-25.jpg)
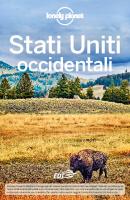

![The Constitution of the United States of America/Costituzione degli Stati Uniti d'America [First ed.]](https://ebin.pub/img/200x200/the-constitution-of-the-united-states-of-america-costituzione-degli-stati-uniti-damerica-firstnbsped.jpg)

![Stati Uniti [2 ed.]
9788815246097, 9788815317711](https://ebin.pub/img/200x200/stati-uniti-2nbsped-9788815246097-9788815317711.jpg)

