Il problema Occidente. Mito, sacrificio, comunità nel pensiero di Jean-Luc Nancy 9788855293839, 9788855294140
Mito, sacrificio, comunità, sono termini che hanno costantemente inquietato il pensiero di Jean-Luc Nancy lungo tutto il
120 79 5MB
Italian Pages 160 [161] Year 2023
Cover
Title
Copyright
La destituzione del senso dato
L’appello al mito
Comunità dell’immanenza, comunità del sacrificio
Sacrificio antico e moderno
Immagini di città
L’esigenza comunista
Sovranità senza soggetto
Democrazia inoperosa
Indice
Passages Collana di Storia della Filosofia
Recommend Papers
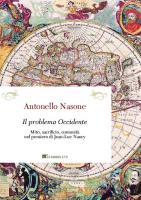
- Author / Uploaded
- Antonello Nasone
File loading please wait...
Citation preview
Antonello Nasone Il problema Occidente Mito, sacrificio, comunità nel pensiero di Jean-Luc Nancy
Passages
Collana diretta da: Umberto Curi e Carmelo Meazza
Passages | 18
Antonello Nasone Il problema Occidente Mito, sacrificio, comunità nel pensiero di Jean-Luc Nancy
© 2023, INSCHIBBOLETH EDIZIONI, Roma Proprietà letteraria riservata di Inschibboleth società cooperativa, via G. Macchi, 94 - 00133 - Roma www.inschibbolethedizioni.com e-mail: [email protected] Passages ISSN: 2282-5282 n. 18 - aprile 2023 ISBN – Edizione cartacea: 978-88-5529-383-9 ISBN – Ebook: 978-88-5529-414-0 Copertina e Grafica: Ufficio grafico Inschibboleth Immagine di copertina: .World map © Sergey Kamshylin – stock.adobe.com
I
Mito
11
La destituzione del senso dato
Anche la storia della luna e dei falò la sapevo. Soltanto, m’ero accorto, che non sapevo più di saperla. (Cesare Pavese, La luna e i falò)
1 Come il torero il narratore di miti compie sempre un passo indietro, dice Kerényi1. Al contrario del filosofo che impone la sua presenza indiscreta, che allunga l’ombra della sua mano e della sua voce nel «dire ciò che “veramente è”», il narratore di miti lascia erompere l’evento fondativo, «si volge verso i tempi primordiali per raccontare che cosa “originalmente era”. Originarietà, per lui, equivale a verità»2. In sorprendente sintonia con questi passi, Nancy dipinge minuziosamente la figura e l’azione del narratore di miti nella suggestiva apertura del secondo capitolo de La comunità inoperosa significativamente intitolato Il mito interrotto: Conosciamo la scena: alcuni uomini sono riuniti e qualcuno racconta. Non si sa ancora se costoro formino un’assemblea, se siano un’orda o una tribù. Ma li chiamiamo ‘fratelli’ per1 K. Kerényi, Introduzione. Origine e fondazione nella mitologia, in C.G. Jung - K. Kerényi, Prolegomeni allo studio scientifico della mitologia, tr. it. di A. Brelich, Bollati Boringhieri, Torino 2018, p. 22. 2 Ibidem.
12 ché sono riuniti e perché sono riuniti e perché ascoltano il medesimo racconto. Non si sa ancora se quello che racconta sia uno di loro o uno straniero. Lo chiamano uno di loro, ma diverso da loro, perché ha il dono, o semplicemente il diritto – a meno che non si tratti del dovere – di raccontare. Non erano riuniti prima del racconto, è la narrazione che li riunisce. Prima, erano separati (questo è almeno quel che il racconto talvolta narra) e se ne stavano gli uni a fianco agli altri, cooperando e affrontandosi senza riconoscersi. Ma un giorno uno di loro si è ritirato, o forse è venuto, come se ritornasse dopo una lunga assenza o da un esilio misterioso. […] Racconta la loro storia o la sua, una storia che tutti conoscono, ma che lui ha solo il dono, il diritto o il dovere di raccontare. È la storia della loro origine: da dove vengano o come provengano dall’Origine stessa […]. Egli parla, recita, a volte canta, mima […]. In questa parola del narratore per la prima volta la loro lingua non serve a nient’altro che a mettere insieme e a esporre il racconto. Non è più la lingua dello scambio tra di loro, ma quella della loro riunione – la lingua sacra di una fondazione e di un giuramento. Il narratore la spartisce loro.3
L’immagine di questa scena, che Nancy riporta ricalcando lo stile e la cadenza tipica della sceneggiatura cinematografica, è l’evocazione di un’origine. Vi troviamo tutti gli ingredienti: il fuoco, le ombre, la voce narrante e gli uomini raccolti in assemblea4. Scena primordiale, il mondo evocato dal narratore 3 J.-L. Nancy, La comunità inoperosa, tr. it. di A. Moscati, Cronopio, Napoli 2003, pp. 95-96. 4 Nel saggio del 1986 Nancy elabora un discorso sul mito riconducendolo all’idea prettamente romantica di inaugurazione di una “nuova mitologia”. Una sorta di volontà di potenza alla ricerca di un’Origine: «In realtà questa formula definisce, al di là del romanticismo e anche al di là della sua forma nietzscheana, tutta una modernità: tutta quella modernità estremamente larga che abbraccia, in un’alleanza strana e contorta, la nostalgia poeticoetnologica di una prima umanità mitante e la volontà di rigenerare la vecchia umanità europea mediante la resurrezione dei sui miti più antichi e la loro ardente messa in scena: intendo evidentemente il mito nazista» (ivi, pp. 99-
13
dell’origine è il mondo raccolto in un senso atemporalmente presente e la cui presenza pretende di sporgere da ogni accelerazione storico-temporale. Il mondo che vibra della presenza degli Dei predispone un’esistenza regolata intorno a un chiaro ordo cosmologico. Il mondo del senso dato – immediato in quanto precede ogni esigenza interrogante – è avvertibile nella presenza di potenze regolate intorno a una struttura gerarchica in cui il divino interagisce con l’umano. È il regime della con-siderazione: un ordine astrale che non prevede erranza, abisso, che non si scioglie in un tempo storico, una comunione essenziale di abitatori presso un’origine. Quando un buco nero ghermirà questo mondo di forze, potenze, presenze, gerarchie, stagioni assemblate in un cosmos – l’ordine immutabile delle certezze affidate alla poesia e al canto –, la narrazione di eventi e figure incorniciati nei versi memorabili di quelli che Vico, mirabilmente, chiamò poeti-teologi5 diventerà piuttosto il lamento di una perdita. Le immagini di una fine annunciata che troviamo nei racconti di carattere mitologico vengono solitamente fissate o su quelle ferree e sanguinarie di un crepuscolo oppure su quelle più compassate e malinconiche di una partenza, di un esilio: l’abbandono degli Dei. Nancy nella figura della costellazione, disegna questo passaggio “traumatico”. Il senso come eterno “dono” delle stelle si è disintegrato, non è più nella purezza immediata dell’integrità. Quell’erranza che caratterizza il movimento di alcuni astri – la percezione della quale, durante le solitudini notturne, si consigliava di non curarsene troppo oppure a impegnarsi, per l’occasione, all’esorcizzazione tramite un sistema di scongiuri –, è
100). L’invenzione del mito in una società che sostanzialmente votata all’assenza di mito è l’indice di una volontà nostalgica di una comunione perduta. 5 Cfr. G.B. Vico, Principi di scienza nuova (1744), in Id., Opere, 2 voll., a cura di A. Battistini, Mondadori, Milano 2001, vol. I, p. 559.
14
ormai aberrazione, dominio di uno sviamento e di una frantumazione siderale: costellazione. Il senso è precipitato in un abisso. La costellazione apparirà non più come un cosmos ordinato ma come un agglomerato di stelle gettato in una qualche voragine siderale, sparso come un pugno di sabbia scagliata a caso, ogni astro col suo moto, ogni astro con la sua particolare orbita. Scrive Nancy: A questo punto – ed è l’evento di tutta quest’epoca – l’evento occidentale per eccellenza – ha fine la considerazione, cioè l’osservazione e l’osservanza dell’ordine siderale.6
Non considerazione ma de-siderazione: destituzione di un rapporto di garanzia col cosmo, con le stelle; uno sguardo de-siderato è lo sguardo del naufrago di un mondo cosmologicamente ordinato. E ancora: Desiderium: la desiderazione comporta il desiderio. Con il motivo del desiderio, la filosofia – fino alla psicanalisi – ha per la maggior parte, e manifestamente, intrapreso il motivo della privazione. Desiderio è la parola che noi usiamo per una perdita infinita del senso.7
Lo svanire di questo senso presente, che compromette le comunità nel suo accoglimento ingenuo, è lo svanire di una vita piena e priva di fughe, priva di tensioni. All’apparire del desiderio fa da controcanto l’avanzare di una mancanza, l’esacerbazione per il ripristino di condizioni di un passato che ora è diventato mito, ovvero nostalgia per una stabilità ormai schizzata verso un movimento aberrante, deviata rispetto a una consuetudine che assicurava ogni movimento circoscritto nei recinti della con-siderazione. Autunno del mito e alba 6 J.-L. Nancy, Il senso del mondo, tr. it., a cura di F. Ferrari, Lanfranchi, Milano 2009, p. 58. 7 Ivi, p. 59.
15
del desiderio: duplice movimento in cui un’apertura inedita è sempre lavorata ai fianchi da una volontà di ripristino di un mondo perduto. Un doppio movimento che per Nancy ha sempre esteso un fascino sinistro su tutta la storia occidentale. Per Nancy, rifuggendo anche da alcuni semplicismi di marca illuministica (l’epoca del rischiaramento del mondo, già avvolto da oscure e impenetrabili nubi, la fioritura di una primavera che succede a un inverno della ragione), la formula miracolo greco è l’insegna di un nuovo paradigma. Scrive a riguardo: La costituzione della metafisica non deriva da un’autocostituzione del “miracolo greco”. Essa è nata da una trasformazione dell’intero ordine dei “legami con l’inaccessibile”. L’Occidente […] si è formato in una metamorfosi del rapporto generale con il mondo, nella quale “l’inaccessibile” assumeva forma e funzione in quanto tale nel pensiero, nel sapere e nella condotta.8
Il mito che si sgretola nella sua enunciazione nostalgica ormai priva di effetto, nella sua trasposizione in racconto, è già precipitato in una sostanziale svalutazione, una riduzione a fabula, chiacchiera, gran parlare. L’implicito visibile che modella l’esistenza è umiliato a finzione, nuovi saperi si costituiscono nella metamorfosi di un mondo nella sua relazione con l’inaccessibile. Nancy chiama «inaccessibile», «incommensurabile», «alogon»9 ciò che sorge da un movimento di esplicitazione verso una “ragione” che prima non era sottoposta a domanda. L’interrogazione angosciosa verso ciò che assume le vesti di incommensurabile modifica il rapporto col mondo, ne cambia il paradigma e la visione, che è ormai quella di uno sguardo verso un cielo che sfugge, verso una costellazione di pianeti erranti (è forse in questo momento che emerge l’angoscia come sentimento esistenzia8 J.-L. Nancy, La dischiusura. Decostruzione del cristianesimo 1, tr. it. di R. Deval e A. Moscati, Cronopio, Napoli 2007, pp. 15-16. 9 Ivi, p. 16.
16
le?). Mancante dell’oriente e interrogante quell’incommensurabile che prima palpitava implicitamente nell’aria tersa e aurea delle potenze presenti, l’uomo è ora gettato in un fondo abissale e fa richiesta di salvazione a quello che si configura come principio. Una storia (nuova) si afferma intorno all’interrogazione sui principi (e dunque, sui fini): la civiltà della filosofia. Che questa rivoluzione abbia avuto luogo in un punto preciso della Storia, che sia stata il culmine di un’onda lunga partita da un lontano passato, la stazione finale – che coincide sostanzialmente con quello che Jaspers chiamò “periodo assiale”, in cui «l’epoca mitica, con la sua quiete ed evidenza, era alla fine»10 – di un processo, come sembrerebbero suggerire alcuni elementi di quella “rivoluzione neolitica” avvenuta qualche millennio prima della nascita di Cristo, che vede l’uomo specializzarsi nella produzione di elaborati, di fini, e in cui è da ricercarsi il primogenitore dell’uomo inteso come produttore, come homo faber (e dunque dello scrigno che contiene quello che più tardi sarà il segreto del capitalismo), è un’ipotesi che lo stesso Nancy sembra avallare11. A ogni modo «la filosofia è lo scotimento, la sospensione e la dissoluzione del presente mitico»12. Il punto di rottura che apre alla “storia nuova” è per Nancy «l’accidente dell’Occidente»13, una sorta di calembour in cui il filosofo francese intende fare i conti col problema del cominciamento, con ciò che svariate interpretazioni hanno riassunto intorno alla famosa formula, già precedentemente richiama-
10 K. Jaspers, Origine e senso della Storia, tr. it. di A. Guadagnin, Mimesis, Milano-Udine 2014, p. 21. 11 J.-L. Nancy, La creazione del mondo o la mondializzazione, tr. it. di D. Tarizzo e M. Bruzzese, Einaudi, Torino 2003, pp. 81-82. 12 Ivi, p. 72. 13 J.-L. Nancy, Essere singolare plurale, tr. it. di D. Tarizzo, Einaudi, Torino 2001, p. 34.
17
ta, di “miracolo greco”. Ha a che fare questo cominciamento con una serie di condizioni che ne hanno determinato la nascita? E se così fosse quale sarebbe il rapporto con la situazione antecedente? […] la filosofia è stata una decostruzione degli edifici di un mondo che si stava allora scuotendo: il mondo mitico-religioso del senso dato e della verità piena e presente. Lo scuotimento di questo mondo è stata la condizione, se non già l’avanzamento, della filosofia, della storia e dell’accidente occidentale: e se volgiamo indietro il nostro sguardo, verso ciò che doveva rendere possibile quest’accidente, ci rendiamo conto di quanto poco esso sia stato “accidentale”, nel senso ordinario della parola.14
Un’alternativa senza compromessi: se il cominciamento è scaturito dalle macerie di una situazione precedente e quest’ultima ne fosse il presupposto, nella peggiore delle ipotesi esso potrebbe essere nient’altro che il punto in cui una ben definita preistoria degrada (il manifesto di tutti i tradizionalismi); se esso fosse sorto in un momento contingente, accidentale, in condizioni di eccezionalità senza un debito filiale con un presupposto, decadrebbe la necessità di questo cominciamento a favore di una sua straordinaria e inedita gratuità. Per Nancy, dunque, la filosofia, nel suo cominciamento, è presa da questo problema: come legittimarsi storicamente sottraendosi alla Storia? Come manifestare e preservare lo statuto del suo sapere senza essere riassorbito in un processo? Se la filosofia sorge in un punto preciso della Storia, quanto del suo statuto è condizionato da una situazione precedente e dal corso progressivo degli eventi? Auto-costituirsi e darsi la propria legge e legittimità rispetto a ogni altro sapere è operare una frattura con la Storia, ma il pensarsi nel fluire di una successione storica significherebbe pregiudicare la libertà stessa della filosofia 14 Ivi, p. 78.
18
e l’assorbimento di essa nei confronti di una processualità, di una Storia orientata e debitrice irreversibile del suo momento fondativo (metafisica). La filosofia, nel volersi auto-costituire libera, con una dignità che essa stessa si è data, per Nancy, ha quindi operato una biforcazione della temporalità: quella della storia, del presente differito, e quella del mito, del presente dato fuori dalla storia. Questo significa principalmente una cosa: che alla filosofia è precluso il gesto con cui poter guardare alla propria fondazione; perché se è vero che è usuale assegnare al mythos la condizione di pre-istoria di una storia cronologicamente strutturata, è pur vero che il suo spazio-tempo, acronico, cade fuori della storia. E così la filosofia, nel segnare una demarcazione tra due statuti fondamentalmente alternativi, il suo e quello del mythos15, manifesta il paradosso di un cominciamento che può unicamente non-fondarsi, non avere uno statuto di fondazione (di cause e fini). Seppur preceduto da una serie di condizioni, l’Occidente sorge in/con uno spazio-tempo altro rispetto a ciò che l’ha preceduto. Così la filosofia come pensiero dell’Occidente. Nella de-siderazione, nel senso in tensione, gettato in un abisso che la verità non riesce, se non a fatica, a far opera di identificazione, esso «non ha senso che nello spazio della filosofia, la quale finisce aprendo il mondo»16. 15 Cfr. J.-L. Nancy, La creazione del mondo, cit., pp. 65-73. 16 Cfr. J.-L. Nancy, Il senso del mondo, cit., p. 67. Nelle pagine iniziali di questo lavoro Nancy opera una chiarificazione dei termini “senso” e “verità”. Nel capitolo esplicativo dichiara un “cambio di registro” nella configurazione di questi termini. Il senso è il movimento transitivo dell’essere, una forza inquieta, vorticosa, che mette in comunicazione l’essere originariamente spartito, mentre la verità è articolata secondo una struttura duplice: «Così, la verità lascia dunque intravedere il senso come la propria differenza interna: l’essere in quanto tale differisce dall’esse, del quale è tuttavia la verità. In questo modo il senso è necessariamente presentato differito dalla verità» (ivi, p. 24).
19
C’è un chiasmo originario che segna inequivocabilmente l’Occidente. All’apertura di un mondo che fa collassare tutto lo spazio-tempo che l’ha preceduto, il mondo della siderazione del senso in tensione, inerisce paradossalmente un movimento che desidera il ripristino della condizione (nelle sue proiezioni comunitarie) mitica. Paradosso, poiché esso ambisce a qualcosa di impossibile, a una condizione irripetibile, alla verità del senso dato: La soppressione del mito è, in effetti, sostanzialmente ambigua: il mito è soppresso in quanto finzione menzoniera ma è segretamente conservato in quanto istanza del già-dato. Il desiderio è l’articolazione di tutto ciò: 1. è del già-dato che si dà mancanza e desiderio; 2. il già-dato è passato sotto la legge dell’inaccessibilità.17
A un mondo dato, presente, succede un mondo da porre, da costruire. Non è un caso che il primitivo pensiero greco muova i suoi primi passi come incessante investigazione sui principi, sulle cause. L’uomo spogliato di un rapporto privilegiato, de-siderato, è spinto all’interrogazione costante sui principi, sulle cause e sui fini della sua esistenza. Da un mondo del senso dato – quello del Mito che non sa di essere mito, configurato in una totalità organicamente ordinata, alla quale era ovviamente alieno uno schema che inducesse a domandare intorno ai principi – si accede alla costante interrogazione sulle cause, si entra nel regime della ricerca del fondamento.
2 Nelle macerie di un mondo abbattuto nelle sue convinzioni profonde («l’ideale eroico […], la successione delle generazioni 17 Ivi, p. 69.
20
umane rinnovantisi le une nelle altre grazie a una circolazione incessante tra morti e vivi: il tempo degli uomini sembrava allora integrarsi nell’organizzazione ciclica del cosmo»18) si schiude definitivamente l’aurora di un Occidente che enunciandosi, sapendosi come Occidente, apre a quella fuga in avanti che provocherà un solco, una frattura col resto delle altre culture coeve. Quali sono le modalità in cui si espone questa frattura? Nell’atteggiamento disincantato verso l’elemento religioso. La decostruzione degli edifici religiosi nella Grecia del supposto “miracolo” si compie definitivamente in uno spazio che, nel suo cammino iniziale, passa per l’ironia senofanea sull’antropomorfismo delle divinità e per il theos di Platone: […] ciò che distingue o addirittura costituisce il “greco” è uno spazio di vita e di pensiero che non è plasmato né segnato dalla presenza divina.19
La costituzione del “greco” (e dunque dell’Occidente), il suo tratto specifico, è, per Nancy, quello di una dimensione fondamentalmente priva di ogni legame salvifico col divino. Il mondo occidentale, ai suoi esordi opera una frattura con ciò che lo precede, in una modalità che Nancy stesso definisce atea. La tesi può sorprendere non solo per ovvie ragioni di carattere storico-religioso, ma per il fatto che proprio l’Occidente, o comunque quello che si è solito chiamare mondo occidentale, reclama tra le sue radici almeno due tra le tre storicamente grandi religioni monoteiste: l’ebraismo e il cristianesimo. Per Nancy il lasciarsi alle spalle il regime del senso dato, il regime del mondo mitico caratterizzato dalla successione verticale di elementi qualitativi, è proprio di un mondo che si avvierà sempre più verso un’interrogazione costante sull’incommen18 J.-P. Vernant, Mito e pensiero presso i Greci. Studi di psicologia storica, tr. it. di M. Romano e B. Bravo, Einaudi, Torino 1978, p. 115. 19 J.-L. Nancy, La dischiusura, cit., p. 25.
21
surabile, su ciò che Anassimandro sottrae alla localizzazione, confinandolo oltre la serie di elementi che abitano uno spazio, ma che ad esso sono legati come origine e destinazione comune, ἀρχή. Se lo spazio occidentale inizia, dunque, nel segno dell’ateismo, ovvero nell’individuazione dell’impostura mitica e nella svalutazione della sua potenza divina, per quale motivo il tratto divino si è declinato come principio? Come è conciliabile una negazione del divino con una affermazione, seppur mutata, rispetto alla potenza mitica, del divino? Quale è la logica che presiede a questo principio? L’affannosa problematizzazione dell’incommensurabile, l’interrogazione sul principio che ha fatto strame del mondo del mito, è già il sintomo che una declinazione teologica si sta preparando. Nella collocazione del principio in un ambito totalmente alieno da quello mondano – un mondano impregnato dell’opposizione sacro-profano, in cui le potenze erano presenze reali stimate secondo successioni gerarchiche20 –, esso risulta certamente il totalmente altro dall’uomo, ma in una forma peculiare rispetto a quella del mondo mitico-pagano, che si esprimeva nel discrimine mortale-immortale. La metamorfosi in cui è coinvolta la nascita dell’Occidente è propria di quel dato, il senso presente frantumato dall’irruzione della questione del principio, del quale i cocci possono essere raccolti e trasfigurati in una rinnovata forma precedentemente sconosciuta – una forma teologica –, come dono fatto da un Dio unico che si presenta come il radicalmente altro dal mondo, e quindi dall’uomo, ma da queste opposte rive in cui Uomo e Dio si ergono e si fronteggiano emerge una logica: […] che si sostituisce alla finzione mitica: la duplice posizione di un’alterità radicale (dio e uomo non sono più insieme nel
20 Cfr. M. Eliade, Il sacro e il profano, tr. it. di E. Fadini, Bollati Boringhieri, Torino 2013.
22 mondo) e di un rapporto del medesimo con l’altro (l’uomo è chiamato verso il dio).21
Nel momento in cui la voce oracolare del divino diventa l’eco sempre più fioca del lamento degli Dei che hanno per sempre lasciato questo mondo, perisce la vitalità di quella religio come nesso essenziale che lega l’umano e il divino. L’interlocuzione con un Dio unico sarà di tutt’altra natura rispetto al culto della pluralità delle divinità, ragion per cui il monoteismo non è tanto una riduzione del politeismo, il suo grado minimo, non la spiritualizzazione delle diverse potenze divine sotto un unico principio. Alle divinità mitiche, alle divinità come presenze tangibili non viene operata una reductio ad unum, non si assiste al raccoglimento di tutta la gloria degli antichi Dei intorno a un’unica figura: La sua differenza con i “politeismi” non dipende dal numero degli dei. La pluralità degli dei corrisponde, infatti, alla loro presenza effettiva […] e la loro presenza effettiva corrisponde a dei rapporti di potenza, di minaccia o di assistenza, che la religione organizza mediante l’insieme dei suoi miti e dei suoi riti. L’unicità del dio indica, invece, il ritrarsi di questo dio fuori della presenza e quindi anche fuori dalla potenza così intesa. Se il Dio d’Israele è un Dio Onnipotente (qualità che lascia in eredità ai suoi successori), non è nel senso di una potenza attiva in un rapporto differenziale di potenze: la sua “omnipotenza” significa che egli è il solo a poterne disporre interamente a suo modo, e può tanto ritrarla quanto ritrarsene, e che è soprattutto il solo a poter stringere alleanza con l’uomo.22
L’azione del principio si sviluppa in un orizzonte definibile come ateo poiché esso è pronunciabile in uno spazio non più
21 J.-L. Nancy, La dischiusura, cit., p. 27. 22 Ivi, p. 51. Cfr. pure S. Micali, La decostruzione ellittica del cristianesimo di Jean-Luc Nancy, in U. Perone (a cura di), Intorno a Jean-Luc Nancy, Rosenberg & Sollier, Torino 2012, pp. 75-80.
23
contrassegnato dalla potenza del religioso, dal vincolo che stringeva umano e divino. Se l’esperienza propriamente religiosa caratterizza le civiltà mitiche, quelle del senso dato, l’espropriazione di questa esperienza si annuncia nel mondo greco con l’apparire della questione dell’ἀρχή: Ogni cosa, in effetti, o è principio o viene da un principio; dell’infinito però non c’è principio, perché così esso avrebbe un limite. Inoltre, esso è ingenerato e incorruttibile, dato che è un principio: infatti è necessario che il generato abbia un termine, e che ogni corruzione abbia una fine. Per questo diciamo che di esso non c’è principio, ma che risulta essere esso stesso principio delle altre cose, e comprenderle tutte e governarle […]. E tale sembra essere il divino: infatti, è esente da morte e da distruzione, come dicono appunto Anassimandro e la maggior parte dei filosofi della natura.23
L’unicità del divino, che emerge dall’investigazione sull’ἀρχή, è, per Nancy, il corpo di pensiero che ha organizzato, in maniera costitutiva la condizione di possibilità dell’Occidente nella modalità dell’ateismo. C’è una duplice lettura che Nancy ci dà dell’ateismo: a) esso è quella forza eversiva di decostruzione dei fondamenti che inventa e accompagna costantemente nel suo cammino l’Occidente, ponendo quest’ultimo pure in una posizione di radicale alterità nei confronti delle altre civiltà; b) nella traduzione teologica dell’inaccessibile come principio, l’ateismo è la facies negativa di una logica, che nella sua positività si identifica con il monoteismo. Se la logica del principio apre al monoteismo, come declinazione teista, e all’ateismo, come suo rovesciamento speculare, essa è in realtà nel suo nucleo più originario un’energia decostruttiva: «il monoteismo non è stato altro che la conferma
23 Arist., Phys., Γ 4, 203b 6, in G. Reale (a cura di), I presocratici, testi raccolti da H. Diels e W. Kranz, Bompiani, Milano 2017, pp. 186-187.
24
teologica dell’ateismo: la riduzione del divino a un principio, all’interno di una logica della dipendenza del mondo»24. Se nella grecità il politeismo della presenza si dissolve nell’ateismo e il divino assume la figura del principio, decisivo, nel completare il quadro dell’Occidente, è l’incontro con l’ebraismo: […] la congiunzione dell’ateismo greco e del monoteismo ebraico, nell’elaborazione di ciò che, sotto il nome di cristianesimo, ha prodotto la grande configurazione dell’onto-(a)teologia.25
Che il cristianesimo nasca come congiunzione tra la grecità e l’ebraismo non è ovviamente una tesi originale. La novità insita nella lettura del cristianesimo fatta da Nancy è la subordinazione dell’evento cristiano alla luce dell’elemento dell’ateismo, ovvero quel campo di reazione entro cui sia il pensiero greco che il monoteismo ebraico – entrambi sorti dal crollo del politeismo delle presenze divine, entrambi ripudianti la potenza del religioso, entrambi coinvolti in una traduzione del divino risoltasi nell’annullamento della personalità intesa come evidenza della figurazione e del nome – sono stati catturati. Il monoteismo, come versione teologica dell’ateismo, è l’espressione di un divino che, nella sua unicità, non è presente né potente come accadeva agli antichi Dei, ma è l’espressione di una volontà in costante relazione con l’uomo, un rapporto che, sia nella manifestazione che nella ritrazione, trova nella figura dell’uomo-Dio, del Cristo, l’apice della verità dell’ateismo, la divinità nel vuoto-di-divinità: Il monoteismo, nel suo principio, demolisce il teismo, cioè la presenza della potenza che aggrega il mondo e ne assicura il senso. Esso rende quindi assolutamente problematico
24 J.-L. Nancy, La dischiusura, cit., p. 32. 25 Ibidem.
25 il nome di “dio” – lo rende non-significante e soprattutto gli toglie ogni potere di assicurazione.26
Il teismo, il volto religioso del monoteismo, pretende di riassorbire il senso costringendolo a punteggiarsi in verità, a esprimersi come presenza assicuratrice e garante. Ma il principio del monoteismo nella sua energia di decostruzione del fondamento (del principio come causa) esaurisce lo spazio per una fede che intende consolarsi nell’assicurazione di una presenza che garantisce. La fede del cristianesimo non è, dunque, una mera credenza religiosa, il suo «camminare nel buio» è una fedeltà a un’assenza di fondamento, è una certezza priva di garanzia. Ragion per cui, per Nancy, l’atteggiamento dell’ateo, che rifiuta fermamente ogni assicurazione consolatrice o redentrice, è paradossalmente più vicino alla fede cristiana che non a quella del credente stesso, poiché il cristianesimo non è altro che il compimento di quell’ateismo da cui è sorto l’Occidente: «Il cristianesimo, quindi, è meno un corpo di dottrina che non un soggetto in rapporto con se stesso, in una ricerca di sé, in un’inquietudine, un’attesa o un desiderio della propria identità»27. Il cristianesimo sarebbe preso da un rapporto problematico, alla stregua di un soggetto, col proprio Sé, in un’animazione perenne che non riesce a risolversi. Quest’inquietudine che fa si che ogni tentativo di rinchiudere un’essenza del cristianesimo (una verità identificante) sia un tentativo destinato a infrangersi, se non a costo di tradire il cristianesimo stesso. Il rapporto col proprio Sé non può che essere infinito: Essendo infinito, da una parte, assume una dimensione temporale (si mette ad avere storia, passato e avvenire come dimensioni del senso e della presenza – o anche: la presenza
26 Ivi, p. 51. 27 Ivi, p. 54.
26 non è semplicemente presente) e, dall’altra, non può in fondo che sfuggire a se stesso.28
3 La singolare identificazione tra Occidente e Cristianesimo che Nancy pone, si fonda su una lettura della genesi del cristianesimo opposta a quell’interpretazione che considera l’evento cristiano come novità radicale rispetto a un contesto preliminare che fa fede sulla nota impostazione paolina29. Il compito del filosofo francese è quello di riavvolgere i fili di una Storia bimillenaria per ricercarne le cause non solo risalendo all’ambiente d’origine, quello ebraico, ma riconsiderando pure quei luoghi che furono solo successivamente toccati dall’apostolato dei seguaci di Gesù. La genesi del cristianesimo sarebbe dunque, secondo questa interpretazione, intimamente connessa a un rivolgimento di enorme portata storica avvenuto due millenni fa che sconvolse l’area mediterranea e al quale non furono estranei importanti movimenti del mondo greco: esso è stato in definitiva, la risultante dei due o tre secoli durante i quali il mondo mediterraneo aveva raggiunto un disincanto completo tanto nei confronti delle religioni religiose quanto nei confronti di quelle civili.30
Il giudeo-greco – una nota espressione di James Joyce che «non denomina altro che il pendant del giudeo-cristianesimo
28 Ibidem. 29 Novità radicale intesa come distruzione e annientamento dell’eredità ebraica e del retaggio greco così come è stato impostato da Paolo in 1Cor 1,19-31. Su questo punto controverso della dottrina paolina ha, com’è noto, insistito Marcione. 30 J.-L. Nancy, La dischiusura, cit., p. 16.
27
[…], da cui partì l’esperienza missionaria del cristianesimo […], per questo motivo non c’è, tendenzialmente, giudeo-cristianesimo che non sia anche giudeo-greco-cristianesimo»31 – è la particolare combinazione che emerge quando l’epoca del disincanto si staglia prepotentemente nell’orizzonte della Storia dell’umanità. Un riferimento assiduo di Nancy in questo senso è il saggio di Marcel Gauchet32 apparso nel 1985, nei confronti del quale ha modo di esplicitare più volte una vicinanza di vedute, soprattutto col capitolo La religione dell’uscita della religione. Nella logica “regressiva” di Gauchet, che capovolge quella tendenza progressista che indica nel raggiungimento del monoteismo l’apice del religioso, l’indebolimento della potenza della religione “originaria” e la caduta delle sue traduzioni politiche nelle spire dissolutrici delle primitive tensioni individualistiche, l’avvenuta «scissione fra le apparenze e il vero»33 pose angoscianti preoccupazioni sia di natura onto-teologica che di natura politica. Se per Gauchet il discorso religioso è imprescindibile rispetto alla matrice politica che lo produce, le forze che emersero in un’area geografica piuttosto omogenea come quella mediterranea – l’individualismo e l’universalismo – furono spinte inarrestabili le cui conseguenze più dirompenti furono il monoteismo ebraico e la filosofia greca. La preoccupazione di un piccolo popolo come gli Ebrei di preservare l’indipendenza nazionale dagli assalti assimilazionisti dei grandi imperi del Vicino Oriente, già proiettati in un’ottica d’integrazione interetnica e universalistica, sortì l’effetto di provocare un intenso campo di reazione in un punto mar-
31 Ivi, p. 60. 32 M. Gauchet, Il disincanto del mondo. Una storia politica della religione, tr. it. di A. Comba, Einaudi, Torino 1992. 33 Ivi, p. 41.
28
ginale dell’indistinta immensità imperiale, il quale fu capace di votarsi a una lotta senza quartiere per la libertà da un servaggio umiliante tramite una polarizzazione senza compromessi col resto del mondo. La necessità di una divinità sola, unica – in cui certamente, come spesso è stato indagato34, sono evidenti i debiti con la “scandalosa” riforma atoniana del faraone Amenhotep IV – e gelosa dell’interlocuzione con quel popolo, dio più potente di tutte le potenze e di tutte le divinità al cui cospetto appaiono ridicole degenerazioni, fu dettata dall’enorme compito storico di una guerra per la sopravvivenza, entro cui il meccanismo di elezione stipulato in alleanza dal Dio unico doveva essere tutt’uno con la non contaminazione nei confronti degli altri popoli. L’antagonismo radicale degli Ebrei, impegnati nella preservazione della propria purezza etnica di fronte al magma dis-identificante degli imperi, rimetteva però in gioco, in modo capovolto, l’istanza universalistica che soggiaceva nell’espressione monoteistica. Come può l’unico Dio, nonostante la concessione in esclusiva del marchio del colloquio privilegiato a un determinato popolo, nella sua unicità, escludere, in quanto divinità, da un progetto globale di salvezza tutti quei popoli da lui creati che un giorno o l’altro lo avrebbero riconosciuto? […] come conciliare la vocazione universale di questo dio, che la sua onnipotenza e unicità destinano con ogni evidenza a tutti gli uomini, con la sua scelta esclusiva d’Israele fra tutte le nazioni? […] Così la logica imperiale, in opposizione alla quale si era formato il monoteismo, risorge in esso allor-
34 A riguardo si veda la nutrita e importantissima produzione di Jan Assmann sul tema: da Mosè l’egizio. Decifrazione di una traccia di memoria, tr. it. di E. Bacchetta, Adelphi, Milano 2000, a La distinzione mosaica ovvero Il prezzo del monoteismo, tr. it. di A. Vigliani, Adelphi, Milano 2011, passando per Potere e salvezza. Teologia politica nell’antico Egitto, in Israele e in Europa, tr. it. di U Gandini, Einaudi. Torino 2002.
29 ché si è ben assestato, come suo orizzonte obbligato: a Dio universale, dominio universale.35
Quegli atroci dilemmi su cui si dimenò il popolo ebraico, messo alle strette nel trovare una conciliazione tra il proprio stato elettivo e il rapporto con le altre nazioni, verso le quali comunque il Dio unico avrebbe steso un giorno o l’altro la sua mano, furono propizi per la nascita di quel caratteristico frutto che tutt’ora connota il giudaismo; il messianismo. È questo lo sfondo su cui si staglia la figura di Gesù di Nazaret. La risposta che quest’ultimo seppe dare agli inquietanti interrogativi posti dal messianismo fu, per Gauchet l’inizio di un processo di compimento dell’universalismo che è proprio del cristianesimo. Lo sfruttamento delle possibilità latenti che giacevano all’interno della fede mosaica non potevano che sfociare nella scandalosa sovversione della proiezione messianico-universalistica operata da Gesù: alla sottomissione che Israele avrebbe preteso dai Gentili nella prospettiva di un’unificazione del mondo, un unico Regno sotto le insegne del messia del Dio unico, Gesù rispose capovolgendo questa impronta bellica nel vangelo dell’amore. L’amore come tensore unificante significava la disattivazione della potenza dell’origine – lasciare la casa del Padre – come strutturazione comunitaria conclusa, in nome di una estraneità alle “cose del mondo”, al dominio sugli enti intramondani. Il ribaltamento dei canoni gerarchici dell’ordine “naturale” operato dalla promessa cristica36, per Gauchet,
35 M. Gauchet, Il disincanto nel mondo, cit., p. 157. A proposito si veda anche il paragrafo La religione come resistenza. La nascita della religione dall’opposizione alla (propria) cultura, in J. Assmann, La memoria culturale. Scrittura, ricordo e identità politica nelle grandi civiltà antiche, tr. it. di F. de Angelis, Einaudi, Torino 1997, pp. 168-171. 36 Gauchet si distanzia dalle tesi nietzschiane de L’Anticristo sulla sostanziale consequenzialità tra la radice giudaica e l’espressione filiale del cristianesimo. La cesura operata da Gesù rispetto al suo ambiente di provenienza,
30
fu l’elemento decisivo grazie al quale la predicazione di Gesù poté suscitare quelle attenzioni di un pubblico sempre crescente, perfino maggiori rispetto al carisma che rifulgeva dalla sua eccezionale figura37 e che determinò l’enorme successo dell’apostolato paolino nel cuore dell’Impero: Gesù si presenta nel punto in cui vi è spazio per concludere il processo di ridefinizione del divino avviato con Mosè: la sua legittimità assoluta consiste nel compiere logicamente l’attualizzazione delle potenzialità spirituali create all’interno della dinamica imperiale e suscettibili di essere cristallizzate unicamente in margine a essa. E Paolo perfeziona questo esito svelando la portata universale dell’annuncio proclamato dal messia; libera il dio unico dell’altro mondo dai suoi legami originari; lo deterge dalla sua emersione in periferia e lo rende idoneo alla reintroduzione al centro del crogiolo acceso dal potere mondiale.38
Naturalmente il trionfo del messaggio cristiano, l’urbanizzazione tenacemente perseguita da Paolo, non avrebbe potuto procedere verso un felice esito se esso avesse evitato il confronto – così come ha sottolineato qualche anno fa in un agile volume Alain Badiou39 – non solo col contesto di provenienza,
ciò che fa di lui un “messia rovesciato” che rompe con la tradizione ebraica, non è tanto l’uomo-Dio, quanto l’accento posto sull’amore. 37 M. Gauchet, Il disincanto del mondo, cit., p. 170. 38 Ivi, p. 172. 39 Cfr. A. Badiou, San Paolo. La fondazione dell’universalismo, tr. it. di F. Ferrari e A. Moscati, Cronopio, Napoli 1999. A tal proposito: «In realtà “ebreo” e “greco” sono disposizioni soggettive. Più precisamente, si tratta di quelle che Paolo considera le due figure intellettuali coerenti del suo mondo e che si possono anche chiamare regimi del discorso. Quando teorizza sugli ebrei e sui greci, Paolo ci propone, in realtà, una topica dei discorsi. […] così Paolo può istituire “il discorso cristiano” solo distinguendone le operazioni da quelle del discorso ebraico e dal discorso greco» (ivi, p. 66).
31
ma pure con quello che era il “discorso” culturale egemone dell’epoca: il pensiero greco. Seppur preso dal fervore missionario che lo contraddistingueva, in cui rimarca l’inconciliabilità tra il Vangelo e l’umana sapienza, come dichiara con toni irriducibili in alcuni passi della Prima lettera ai Corinti, la sfida che l’apostolo delle genti mosse al pensiero filosofico poteva trovare incredibilmente un punto di contatto in quella tensione isonomica del logos greco, in quella che per Vernant era stata la forza decisiva in grado di ridisegnare una nuova immagine del mondo, scaturita dalle ceneri degli ordini impostati sulla differenziazione gerarchica ispirati a una rigida concezione della virilità guerriera40. In questa capacità di fare i conti con ciò che lo ha preceduto, di eccepire con ardore militante gli schemi ideologici sia delle radici dalle quali è sorto sia di quelli debitori dell’orizzonte egemone verso il quale obbligatoriamente incrociò le lame per assecondare lo slancio universalista di un avvenire redentivo dell’intera umanità al quale si era votato, Nancy ha visto la speciale vocazione del cristianesimo a farsi Storia universale. Questa storicizzazione di ogni evento, in cui l’intera umanità è coinvolta mediante l’integrazione del passato e attraverso la proiezione in un futuro come cammino salvifico, fa del cristianesimo l’ideatore dell’impianto propulsivo di un’organizzazione del tempo di quella che sarà la storia occidentale41. Nella pressante preoccupazione di decifrare il passato per cogliere segni e conferme e nell’ansia di indirizzare il medesimo sguardo verso un futuro in cui il cuore è gettato sempre oltre l’o-
40 Cfr. J.-P. Vernant, Le origini del pensiero greco, tr. it. di F. Codino, Feltrinelli, Milano 2007. Sul mutamento storico del concetto di ἀρετή nei principi educativi del mondo greco si veda il classico di W. Jaeger, Paideia. La formazione dell’uomo greco, tr. it. di L. Emery e A. Setti, Bompiani, Milano 2011. 41 Cfr. J.-L. Nancy, La dischiusura, cit., pp. 202-204.
32
stacolo, vi è una particolare forma che impregna la dinamica temporale del cristianesimo: una volontà di (auto) superamento in cui ogni accadimento è la prova-passaggio che invera la bontà della fede in un percorso progressivo42. Se in ogni “religione” il cuore del sacro è consegnato a un passato immemorabile che si riattualizza nel rito, la fede cristiana, al contrario, si attua nella Storia; se ciò che definisce l’esclusività di ogni “religione” è la fedeltà a un originario sottratto al divenire, il cristianesimo ha il dovere di comprendere ciò che gli è estraneo per conseguire un preciso piano salvifico che si dispiega nella Storia. Questa fede è tale solo rivelandosi progressivamente come l’integrazione di ciò che l’ha preceduta e che essa porta più avanti. In questo c’è qualcosa di unico: la fede cristiana è essa stessa l’esperienza della sua storia, l’esperienza di un piano seguito da Dio per l’attuazione della salvezza.43
Il cristianesimo si è affermato dunque (e non potrebbe essere altrimenti, in quanto si fonda su un evento, la presenza divina incarnata, assolutamente non mitica e immemorabile ma collocabile in un punto preciso della Storia) come soggetto storico, il che lo mette su di un piano di incomparabilità rispetto alle altre religioni44, impegnato a perseguire un percorso vettoriale che lui stesso ha disegnato. Un disegno che, per Nancy, nel dogma dell’Incarnazione e nella nuova alleanza con Dio segue un filo teso tra la venuta del Cristo, la presenza, e la sua seconda venuta, la parusia: un piano di salvezza che si inscrive totalmente in un percorso di interlocuzione tra l’umano e il divino e che si dispiega nell’ac-
42 Ivi, p. 198. 43 Ivi, p. 204. 44 Ivi, p. 202.
33
cadere storico ponendolo in modo radicale fuori dall’egida del mito. La storicità che inerisce il cristianesimo, che si comprende come il riassunto delle vicende umane di ogni tempo passato e nella proiezione di esse nel tempo a venire, pretende che nulla del cammino dell’uomo possa esserle estraneo. Ma questo carattere storicistico, che gli deriva dall’incredibile avvenimento di un Dio che si è fatto uomo, dal passaggio del divino nell’umano come rivelazione assolutamente non mitica ma concreta, manifestazione tangibile dell’eterno, fa del cristianesimo l’ultima stazione del divino, il completo disfacimento del religioso come espressione di un sacro che abita una riva irriducibile all’orma umana. Nancy individua, infatti, nell’intimo nucleo del cristianesimo – nel suo essere essenzialmente costituito come soggettività infinitamente aperta, «apertura come ipseità cristiana, distensione di sé, rapporto con sé come uscita indefinita da sé»45, Sé che non si conclude – un dispositivo di decostruzione del religioso, di dissoluzione di ogni orizzonte trascendentale. Questa facoltà decostruttiva del cristianesimo che si esplica nel senso come apertura infinita, fin dalle origini emerge come abbandono, ridislocazione rispetto alle mire tiranniche e indiscrete del fondamento («il cristianesimo è originariamente decostruttore, perché fin da subito si riferisce alla propria origine come a un intervallo, a un battito, a un gioco, a un’apertura dell’origine»46), trovando però un punto d’arresto nel momento di una destinazione finale proclamata al suo apparire: l’annuncio della sua fine. Un crepuscolo rivelato sin dagli inizi è, per Nancy, la «struttura originaria del cristianesimo»47. Nell’apice sfolgorante della parusia del rivelabile che evidenzia l’assenza di un piano ritrat-
45 Ivi, p. 203. 46 Ivi, p. 208. 47 Ibidem.
34
to in cui un Deus absconditus suggerisce e orienta l’apparire, nell’estrema esposizione dell’assoluto priva di velature, sta il mistero di una fine annunciata. Sbaglia chi crede, dice Nancy48, che questo annuncio abbia a che fare con qualcosa di approssimabile alla profezia, alla deliberazione di un auspicio e pure alla promessa. Così come rimane a metà strada chi crede di penetrare il “vero cuore del cristianesimo” nell’integralità evangelica, la purezza di un cristianesimo originario rispetto a una sua adulterazione dogmatica successiva, di cui ancora Nietzsche si nutriva: È invece proprio nello sviluppo dogmatico che bisogna recuperare la vena caratteristica impressa a questo dogma dalla struttura fondamentale dell’annuncio e dell’apertura del senso. Nell’edificio dogmatico cristiano, abbiamo a che fare con una costruzione teologica, cioè anche e innanzitutto con una costruzione o un’elaborazione filosofica.49
È necessario ricordare il punto fermo della riflessione sul cristianesimo proposta da Nancy: l’epocalità del suo sorgere, dalla quale procedere per interpretare il decorso storico successivo. L’evento cristiano non fu un fenomeno improvviso ma la risposta dirompente alle inquietudini che premevano su un’area più vasta rispetto al contesto in cui nacque. Quando Nancy afferma l’impossibilità di scindere il nucleo evangelico, quello kerygmatico, dall’impianto dogmatico che nei secoli è stato edificato a baluardo della fede, non fa che ribadire come il cristianesimo abbia lavorato, fin dalle sue origini, con concetti filosofici. Pensare a un cristianesimo fuori da ogni approccio filosofico, che salvaguardi la presunta purezza di un nocciolo evangelico e ricalchi la nota sentenza paolina, è dunque fuorviante, poiché la filosofia è parte di quello sconvolgimento sto-
48 Ivi, p. 209. 49 Ivi, p. 210.
35
rico che avvenne in un’area mediterranea ormai emancipata dall’alone mitico: cristianesimo e filosofia sono epocalmente prossimi. I dogmi, dunque, non sono contraffazioni postume del dettato evangelico quanto lo sviluppo di quest’ultimo in un linguaggio che è coevo al cristianesimo stesso. Lo stesso cuore del cristianesimo, l’Incarnazione, non sarebbe contemplabile senza la categoria di sostanza, ousia, da cui prende avvio e dalla quale tende ad andare oltre i concetti ontologici che la predispongono50. L’intelligenza teologica, sembra dirci Nancy, può superare la concettualità del logos greco a partire sempre dallo stesso sapere filosofico. Proprio per questo, il cristiano, il giudeo-greco, l’uomo occidentale erede dell’abbraccio tra i custodi del monoteismo e gli scopritori del principio, è colui che più di tutti in questo mondo sperimenta quella “morte di Dio” che altro non è che la progressiva disintegrazione di quell’eredità, di quella principialità, che si è insinuata nell’altezza e nella profondità come attributi del divino. Per Nancy, infatti, l’esito nichilistico del cristianesimo è da ricercarsi nell’essenza auto-decostruttiva come frutto dell’alleanza critica tra l’unicità del Dio e il tema del Principio51, tra monoteismo ebraico e logos greco. L’avventura metafisica che inaugura questa concordia discordante è riassumibile nella figura del cosmotheoros. L’osservatore del mondo, compare quando un mondo posto si fa largo nella scena della storia, scolorando le luminescenze del mondo del mito come mondo del senso dato, dal cui tramonto il tema della creazione viene cooptato al trono dal “tema del principio”: Un mondo “visto”, un mondo rappresentato, è un mondo sospeso allo sguardo di un soggetto-del-mondo. Un soggettodel-mondo (che è poi anche un soggetto-della-storia) non
50 Ivi, pp. 210-211. 51 Ivi, p. 35.
36 può però essere lui stesso nel mondo. Anche in mancanza di una rappresentazione religiosa, un soggetto simile, implicito o esplicito, non può fare altro che ribadire e perpetuare la funzione di un Dio creatore, ordinatore e destinatore (o addirittura destinatario) del mondo.52
Se l’esito nichilistico del cristianesimo, la “morte di Dio”, è da addebitare alla perversa azione del Principio nei confronti del tema della creazione, l’uscita dal nichilismo potrà avvenire solo quando la nozione di creazione saprà sottrarsi una volta per tutte dalla logica “produttiva” provocata da questa insolita combinazione. Insistere sull’intollerabilità del Principio verso la creatio ex-nihilo significa dunque tracciare una via, un modo per uscire dal grigiore del nichilismo. Se il connubio tra logica del Principio e l’evento iniziale della creazione ha scaraventato l’Occidente nell’epoca del nichilismo, quale via potrà tracciare il sapere filosofico per uscire da questa gabbia senza sbarre e salvare così la struttura originaria del cristianesimo: l’annuncio? Per prima cosa la nozione di creazione, per Nancy, dovrà emanciparsi dalla costrizione del circuito della “produzione”, della “fabbricazione”: «La creatio ex nihilo, quando è distinta da ogni forma di produzione o di fabbricazione, corrisponde essenzialmente al duplice motivo dell’assenza di una necessità e dell’esistenza contingente del dato»53. Il motivo della creazione instaura un rapporto che la logica del Principio non può accogliere, poiché quest’ultimo rimane fedele al rapporto consequenziale di causa-effetto, un rapporto d’identità, l’alterità e contingenza tra creatore e creatura gli è insostenibile. L’espropriazione del tema della creazione dal consueto significato di produzione per mezzo di un agente esterno ripropone in 52 J.-L. Nancy, La creazione del mondo, cit., p. 18. 53 J.-L. Nancy, La dischiusura, cit., pp. 36-37.
37
diversa modalità la figura del creatore confinandolo all’interno del mondo. La questione del mondo è, secondo Nancy, il luogo nel quale l’onto-teologia va a infrangersi. L’identificazione dell’essere come totalità degli enti, la perfetta immanenza dell’umanismo, l’esito dell’ipoteca del Principio sulla creazione ha di fatto esiliato ogni figura di cosmotheoros. Una visione del mondo, una visione esterna verso il mondo, presuppone l’esistenza di un principio e di una fine, entro la quale il mondo è sottomesso. Il mondo attuale ha esaurito le possibilità delle “visioni del mondo”. Il mondo non-visto è il mondo così com’è: un mondo che da oggetto di una visione, diventa a sua volta soggetto, si sottrae a ogni ipotesi di creazione esterna, di fabbricazione da parte di un Altro, di un esterno a esso: È finito il tempo in cui ancora potevamo concepire e rappresentarci un cosmotheoros, un osservatore del mondo. Ed è finito poiché il mondo non si lascia più rappresentare. Una rappresentazione, una visione del mondo, implica che si assegni un principio ed una fine al mondo. Tanto che si potrebbe addirittura dire che una visione del mondo coincide, in effetti, con la fine di quel mondo, assorbito e dissolto da questa visione. […] Il Dio dell’onto-teologia, per l’esattezza, si spoglia man mano di tutti gli attributi divini di un’esistenza indipendente, per assumere soltanto quelli dell’esistenza di un mondo totalmente immanente, intrappolato nell’anfibologia di un’esistenza necessaria e al tempo stesso contingente.54
La creazione dal nulla inscritta nel mondo significa che nel mondo non c’è una ragione fondativa che orienta verso fini determinati. Se non c’è nulla al-di-fuori-del-mondo e se il mondo non ha un senso immanente – non è sostanza, fondamento, quanto esso stesso questo nulla, nulla di ragione – il mondo non sarà neanche il campo d’azione dei fini dell’uomo, bensì, 54 J.-L. Nancy, La creazione del mondo, cit., p. 22.
38
il fuori del mondo, lo spazio aperto, sarà all’interno del mondo stesso, una «provenienza senza produzione (né derivazione, né provvidenza, né progetto: una provenienza sprovvista di pro, di prototipo e di promotore…)»55. Nancy rievoca, a proposito, un aspetto dell’etimo del termine “creazione” estraneo alle ambizioni della logica produttiva, rilevando un punto decisivo nel verbo “crescere”56, prendersi cura di una nascita, di una crescita. Prendersi cura dell’aperto. Se lo scostamento della creazione dalla produzione costituisce uno dei punti nodali della decostruzione del cristianesimo, come è possibile l’annuncio della presenza di un Dio che non appare? Se il Dio-vivente è «l’Aperto come tale, l’Aperto dell’annuncio, del progetto, della storia e della fede che, mediante il Dio-vivente, si rivela al cuore del cristianesimo»57, e se «Solo l’apertura è divina, ma il divino non è altro che l’apertura»58, tutto questo imporrà una fedeltà al mondo, all’apertura che lo trattiene dal ripiegarsi e dallo sprofondarsi in un’identità esclusiva e occlusiva, una consegna a quell’oltreil-mondo che è nient’altro che il mondo stesso in eccesso, eccedente la costrizione di ogni immagine.
55 Ivi, p. 18. 56 Ivi, p. 35. 57 J.-L. Nancy, La dischiusura, cit., p. 217. La questione cristologica sembra in realtà elusa in queste pagine di Nancy. Come nota Carmelo Meazza: «Quando Nancy, sempre nel saggio La dischiusura cerca un passaggio fuori dalla Cristologia, in realtà si pregiudica ogni lavoro speculativo sulla questione trinitaria. […] In realtà senza quella umanizzazione di un dio e divinizzazione di un uomo, senza l’esperienza di un dio che risorge come tranoi, esposto nel tra-noi della resurrezione, il pensiero trinitario non avrebbe potuto consumare un Dio come altezza o come profondità. Lo spirito è il nome per questa esposizione tra-noi» (C. Meazza, La comunità s-velata. Questioni per Jean-Luc Nancy, Guida, Napoli 2010, pp. 122-123). 58 J.-L. Nancy, La creazione del mondo, cit., p. 61.
39
Il cristiano rimane destinatario, custode dinamico di un annuncio della fine, di un appello in cui è possibile la visione dell’Aperto. Un aperto/appello che sollecita a ripensare la nozione di limite; un limite che non definisce l’identità di un’esistenza singolare, un limite che non contrae un’esistenza singolare verso un ripiegamento interiore, un limite che non costringe un’esistenza singolare entro le rassicuranti garanzie del religioso59.
59 J.-L. Nancy, La dischiusura, cit., p. 217.
41
L’appello al mito
Über der Menschen Weitverbreitete Stämme Herrschte vor Zeiten Ein eisernes Schicksal Mit stummer Gewalt. Eine dunkle, schwere Binde lag um ihre bange Seele. Unendlich war die Erde. Der Götter Aufenthalt Und ihre Heymath. (Novalis, Hymnen an die Nacht)
1 L’immagine di una vita intensa che aveva impregnato l’esistenza degli Antichi funse, per una vivace schiera di spiriti tedeschi del XVIII secolo, da antidoto all’arida superficialità che Herder aveva riscontrato nel suo incontro con i maîtres-à-penser razionalisti durante il suo soggiorno nella capitale francese. Lo struggimento per un mondo perduto e l’anelito alla sua restaurazione è chiaramente individuabile in alcuni passi di August Wilhelm Schlegel: […] la nostr’anima esiliata sulla terra sospira la sua patria, quali possono mai essere i suoi accenti, se non quelli della melanconia? E però la poesia degli Antichi era quella del godimento, la nostra è quella del desiderio; l’una si stabiliva nel
42 presente, l’altra si libra fra la ricordanza del passato e il presentimento dell’avvenire.1
Lo struggimento di Schlegel non ha nulla a che fare con la melanconia barocca che sorge al ticchettio dei primi orologi meccanici «con que’ colpi onde ’l metal rimbomba/ affretta il corso al secolo fugace / e perché s’apra, ognor picchia alla tomba», bensì esso è come la scintilla che invoca una volontà quasi militante per dar battaglia, come Hamann2 aveva predicato, al secolo che deteneva nelle sue fauci il cuore palpitante. Liberare questo cuore, riabilitarlo nelle sue funzioni vitali grazie al calore che sfugge alle generalizzazioni illuministe: ma come conciliare l’auspicato ritorno della potenza del mito con l’epoca della civiltà della filosofia? Per Nancy la possibilità di un ritorno a quella “patria” a cui fa cenno Schlegel, o meglio, ciò che costituisce questa esigenza dei romantici, è il pensiero del ritorno all’origine che ha animato una particolare metodologia ermeneutica3.
1 A.W. Schlegel, Corso di letteratura drammatica, tr. it. e note di G. Gherardini, Società tipografica de’ classici italiani, Milano 1841, vol. I, pp. 29-30. 2 Sull’importanza della figura di Johann Georg Hamann in qualità di precursore del Romanticismo e strenuo oppositore dell’Illuminismo, soprannominato “Der Magus in Norden”, concittadino di Kant, si tenga presente il giudizio di Isaiah Berlin: «il rappresentante più poetico, teologicamente più profondo e più interessante di questa violenta rivolta» (I. Berlin, Le radici del Romanticismo, tr. it. di G. Ferrara degli Uberti, Adelphi, Milano 2012, p. 88). Sempre di I. Berlin, Il mago del Nord. J. G. Hamann e le origini dell’irrazionalismo moderno, tr. it. di N. Gardini, Adelphi, Milano 1997, e il testo di P. Klossowski, Il mago del Nord. Johann Georg Hamann, tr. it. di A. Marroni, Mimesis, Milano 2001. Non si può non citare la monumentale monografia di Angelo Pupi, Johann Georg Hamann, pubblicata in sette volumi dal 1988 al 2020 per i tipi di Vita e Pensiero. 3 Cfr. J.-L. Nancy, La partizione delle voci. Verso una comunità senza fondamenti, tr. it. di A. Folin, Il Poligrafo, Padova 1993, pp. 19-25.
43
Il programma di una “nuova mitologia” che ispirò il famoso Più antico programma di sistema dell’idealismo tedesco, attribuito ai romantici di Jena, è lo scenario d’apertura di un consistente volume, scritto da Nancy nel 1978 a quattro mani col deuteragonista Philippe Lacoue-Labarthe, dal titolo L’absolu littéraire4. Un lavoro questo che, come specificato nell’introduzione, non vuole essere una mera ricostruzione storica di una corrente letteraria, non «une entreprise d’archivistes… une histoire monumentale ou antiquaire»5, ma un compito di decifrazione della produzione teorica romantica per riportare alla luce «l’équivoque massive que recouvre à lui seul le terme “romantisme”»6. Equivoco di un movimento letterario in cui, per la prima volta, l’ispirazione poetica sorgeva in totale commistione con la riflessione filosofica («la question de l’art comme question de la philosophie»7). Ed è appunto da essa che prenderà le mosse, alla ricerca delle possibilità che soprattutto la terza Critica kantiana poteva offrire ai suoi esponenti di punta8. Questo flusso di vitalità intellettuali che gravitava su Jena, punto d’approdo del pensiero che da Königsberg era transitato per Tubinga, si poneva come obiettivo il superamento, anzi il rovesciamento, di Kant, attraverso la rivoluzionaria conversione del soggetto kantiano (cioè del soggetto morale della seconda Critica) nell’ideale di un soggetto assolutamente libero e quindi cosciente di sé: «le primat est affirmé, dans
4 P. Lacoue-Labarthe - J.-L. Nancy, L’absolu littéraire. Théorie de la littérature du romantisme allemand, Seuil, Paris 1978. 5 Ivi, p. 10. 6 Ibidem. 7 Ivi, p. 43. 8 Ivi, p. 46.
44
l’ombre ou le sillage de Fichte, du Moi absolu comme Selbstbewusstsein»9. Ciò che accomunava i rigogliosi fermenti di tutta l’avanguardia post-kantiana, idealismo speculativo compreso, è ciò che Nancy chiama volonté du Système, ovvero l’auto-riconoscimento dell’Idea come forma propria del soggetto10, ma ciò che, a sua volta, distingue il romanticismo dall’idealismo, ciò che si segnala come il carattere decisivo del romanticismo rispetto all’idealismo di cui comunque è debitore (soprattutto nei confronti di Fichte, emblematica è appunto la seguente frase presente nelle prime battute del testo: «La prima idea è naturalmente la rappresentazione di me stesso come un essere assolutamente libero [absolut freien Wesen]. Con l’essere libero, autocosciente, sorge al contempo un intero mondo dal nulla – l’unica creazione dal nulla vera e pensabile»11), emerge
9 Ivi, p. 48. Sull’indiscutibile debito fichtiano si veda W. Benjamin, Il concetto di critica nel romanticismo tedesco, in Id., Opere complete. I. Scritti 1906-1922, ed. it. a cura di E. Ganni, Einaudi, Torino 2008, pp. 353-451, in particolare la prima parte che ha per titolo La riflessione: «Il pensiero che riflette nell’autocoscienza, è il dato di fatto fondamentale da cui muovono le considerazioni gnoseologiche di Friedrich Schlegel e anche, in gran parte, quelle di Novalis. […] La riflessione è la struttura più frequente nel pensiero dei primi romantici; far riferimento a pezze d’appoggio a sostegno di quest’affermazione significa far riferimento ai loro frammenti. Imitazione, maniera e stile, tre forme tutte applicabili al pensiero romantico, si trovano già coniate nel concetto di riflessione. Ora questo è imitazione di Fichte (come soprattutto nel primo Novalis), ora maniera (ad esempio, quando Schlegel rivolge al suo pubblico l’esortazione a “comprendere il comprendere”), ma, innanzitutto, la riflessione è quello stile del pensiero nel quale i primi romantici esprimono, non arbitrariamente, ma con necessità, i loro più profondi punti di vista» (ivi, p. 360). 10 P. Lacoue-Labarthe - J.-L. Nancy, L’absolu littéraire, cit., p. 47. 11 Il più antico programma di sistema dell’idealismo tedesco, tr. it., ETS, Pisa 2009, p. 21. Questa edizione in lingua italiana, introdotta, tradotta e commentata da Leonardo Amoroso, pone come possibili autori Hegel, Schel-
45
nella seguente proposizione del Programma: «la filosofia dello spirito è una filosofia estetica»12. Questo enunciato adempie a quella volontà a cui si è fatto cenno in precedenza, designando évidemment la philosophie (entendez désormais le Système) du Sujet lui-même, dans son idéalité ou, ce qui revient au même, son absoluité: c’est-à-dire au fond ce qu’on pourrait appeler, de manière assez stricte, le Système-sujet. Et c’est donc en ce lieu précis, nous venons de le voir, que le romantisme s’articule à l’idéalisme spéculatif.13
Esattamente come l’idealismo, il romanticismo concepisce il soggetto non secondo le categorie della classica sostanza, bensì in termini dinamici, di vitale totalità organica. Tuttavia, l’idea che anima questo Soggetto, l’idealità che fa vibrare le corde profonde di questa totalità organica – il Programma è abbastanza esplicito nel dichiararlo –, è la Bellezza, Idea somma, la sola capace di unificare Verità e Bene14. La speculazione, dunque, dovrà porsi all’altezza dell’ispirazione poetica, riflessione filosofica e operare estetico dovranno essere convertibili. Il sublime prodotto di questa concordia sarà l’opera d’arte: Parce que l’idée de la beauté, autrement dit, est l’idéalité même de l’Idée, l’Esthétique spéculative où culmine le Système-sujet se renverse aussi nécessairement en spéculation esthétique, c’est-à-dire s’oblige à une présentation ou une exposition elle-même esthétique. La philosophie doit s’accomplir en œuvre d’art; l’art est l’organon spéculatif par excellence.15
ling e Hölderlin, in una forma supposta: Hegel (?), Schelling (?), Hölderlin (?). 12 P. Lacoue-Labarthe - J.-L. Nancy, L’absolu littéraire, cit., p. 23. 13 Ivi, p. 49. 14 Il più antico programma, cit., p. 23. 15 P. Lacoue-Labarthe - J.-L. Nancy, L’absolu littéraire, cit., p. 50.
46
Se la filosofia dovrà completarsi, compiersi, realizzarsi come poesia, poiché solo la poesia sopravvivrà al sorgere della nuova era, il nuovo propugnato dal Più antico programma del movimento che sorse in Germania nel XVIII secolo come critica violenta all’Illuminismo – e dunque al proprio tempo, accusato di saper compilare solo tabelle ed elenchi – potrà schiudersi quando la poesia ritornerà al suo ruolo pedagogico. La poesia potrà assurgere allora alla dignità superiore16 («sa dignité originaire»17, scrivono Nancy e Lacoue-Labarthe) solo quando essa sarà capace di essere «ciò che era all’inizio, maestra dell’umanità; infatti non ci saranno più né filosofia né storia, l’arte poetica soltanto sopravvivrà a tutte le altre arti e scienze»18. Nelle righe del Programma traspare infatti la consapevolezza dell’astratta inconsistenza del cristianesimo clericale, della fine della fede dei preti quale sistema di valori a scopo educativo. Tutti argomenti su cui il giovane Hegel impegnò i suoi primi scritti e che ci danno una valida panoramica di un ambiente intellettuale che recriminava contro un cristianesimo ridotto ormai ad arida dottrina, mutato ormai in uno sterile culto di un Dio lontano e inconoscibile: «Questa religione può essere sublime, e terribilmente sublime, ma non bellamente umana; e così la beatitudine in cui l’io ha tutto come opposto, tutto sotto i piedi, è un fenomeno del nostro tempo che infondo equivale a quello di dipendere da un’essenza assolutamente estranea che non può divenire uomo»19. Così Hegel nel Frammento di sistema del 1800.
16 Il più antico programma, cit., p. 25. 17 P. Lacoue-Labarthe - J.-L. Nancy, L’absolu littéraire, cit., p. 51. 18 Il più antico programma, cit., p. 25. 19 G.W.F. Hegel, Frammento di sistema del 1800, in Id., Scritti teologici giovanili, tr. it. di N. Vaccaro e E. Mirri, Guida, Napoli 1989, p. 503.
47
Gli interpreti di punta del movimento romantico furono, dunque, tra i primi ad avvertire il depauperamento dello spazio del “religioso” nel mondo occidentale e a cercare un rimedio che andasse oltre la critica corrosiva mossa alla religione dagli ambienti illuministi, per ripristinare, su basi nuove, quel “religioso” che les philosophes intendevano in tutti i modi mettere tra parentesi. Affinché l’anelito romantico avesse potuto godere dello schiudersi di una nuova era, era necessario però riannodare i fili spezzati con quel remoto passato in cui la religione sensibile era di casa. Per raggiungere questo fine era necessario ritornare all’inizio, all’origine. All’epoca dei poeti teologi così ben descritti dal misconosciuto Vico nella Scienza nuova: La sapienza degli antichi fu quella de’ poeti teologi, i quali senza contrasto furono i primi sappienti del gentilesimo […] e le origini delle cose tutte debbono per natura esser rozze: dobbiamo per tutto ciò dare incominciamento alla sapienza poetica da una rozza lor metafisica […]. Ma essi poeti teologi, non potendo far uso dell’intendimento, con uno più sublime lavoro tutto contrario, diedero sensi e passioni […]. Quindi le mitologie devon esser state i propri parlari delle favole (ché tanto suona tal voce).20
Come conciliare questo cammino a ritroso verso l’origine con l’avanzare del prosaico, col tempo scandito dalla fine della fede “ecclesiale” del cristianesimo sequestrata e umiliata nei recinti della sola ragione (illuminista e kantiana) che iniziava ad allungare un’ombra che inquietava gli spiriti romantici più avvertiti? Quest’opera di salvezza, per i fautori del Programma, si sarebbe potuta realizzare solo attraverso un doppio movimento: la filosofia avrebbe dovuto subire un lavacro nelle acque della mitologia per risciacquare la sua infeconda astrattezza
20 G.B. Vico, Principi di scienza nuova, cit., pp. 472-485.
48
nell’ardore della poesia, la mitologia avrebbe dovuto raffinare la sua esuberanza nei percorsi razionali offerti dalla filosofia21. La creazione di questa particolare religione sensibile sarebbe dovuta passare per il superamento dell’elitarismo filosofico e per l’educazione dei semplici, affinché fosse realizzato lo scopo massimo: «un eguale sviluppo di tutte le forze, sia del singolo sia di tutti gli individui»22. Nell’insistenza con cui viene affermato l’impegno pedagogico nei confronti delle masse e, di conseguenza, l’accento posto sulla nozione di popolo – in cui è anche possibile, almeno in parte, rilevare alcuni sussulti che si acquieteranno nella tematica del Volksgeist che Hegel svilupperà nelle prime prove della Filosofia dello Spirito a Jena23 –, non sarebbe errato intravedere rilevanti tracce del magistero di Herder, quantome-
21 Il più antico programma, cit., pp. 23-25. 22 Ibidem. 23 «Solo in quanto opera di un popolo, il linguaggio è l’esistenza ideale dello spirito, in cui quest’ultimo si esprime, [esprime cioè] ciò che esso è (secondo) la sua essenza e nel suo essere; il linguaggio è un universale, un che di riconosciuto in sé, di riecheggiante allo stesso modo nella coscienza di tutti; ogni coscienza parlante diviene in esso immediatamente un’altra coscienza. Altrettanto secondo il suo contenuto il linguaggio soltanto in un popolo diventa il vero linguaggio, l’espressione di ciò che ognuno intende. […] soltanto in un popolo esiste – già posto come tolto, già presente come coscienza ideale, universale – quello che la memoria e il divenire-linguaggio rendono […] ideale» (G.W.F. Hegel, Filosofia dello spirito jenese, tr. it. di G. Cantillo, Laterza, Roma-Bari 1984, p. 55). Sul Volksgeist dei romantici vale la pena riportare il seguente giudizio di Carl Schmitt: «Che i popoli abbiano ciascuno un proprio carattere particolare, un Volksgeist, non era affatto un’affermazione nuova: l’avevano già fatta Voltaire, Montesquieu, Vico e Bossuet, ed il concetto, in sé, non era estraneo né a Malebranche, né a Cartesio, né a Bodin. L’elemento veramente nuovo sta nell’attribuzione al popolo di una realtà oggettiva, mentre lo sviluppo storico – che produce il Volksgeist – diviene una forza creatrice sovrumana» (C. Schmitt, Romanticismo politico, tr. it., a cura di C. Galli, Giuffrè, Milano 1981, p. 102).
49
no di quell’Herder che già dal breve saggio Über den Fleiss in mehreren gelehrten Sprachen del 1764 proclamava che la piena comprensione di una lingua è esclusiva di chi è partecipe del suo vissuto24. Da qui ad affermare che la capacità di ascolto della voce degli Antichi, la comprensione di tutto il loro bagaglio mitico e delle loro espressioni di rigogliosa immaginazione, sarebbe stata preclusa a chi fosse stato estraneo al loro linguaggio, è un passo. Se la mitologia è l’espressione più genuina della sapienza poetica enunciata in una determinata lingua, solo il gruppo umano che si sente erede diretto della lingua che l’ha espressa, in quanto parlante, può comprenderla. In questo passaggio che conclude il Programma, nella proclamata osmosi tra filosofia e mitologia in nome di un nuovo culto di cui il popolo è il destinatario, Nancy e Lacoue-Labarthe vi hanno visto i primi vagiti di quella individualità collettiva, il soggetto-popolo, che si affermerà nel XIX secolo: mais il faut encore que, par l’échange du mythologique et du philosophique, le Idées puissent redevenir accessibles au peuple. C’est que l’effectivité-efficacité de la philosophie suppose l’humanité-sujet elle-même pensée comme peuple (comme lieu privilégie du mythologique, lui-même conçu comme la possibilité d’une exemplarité et d’une figurabilité, d’une force formatrice, à même une langue déterminée), par
24 J.G. Herder, Über den Fleiss in mehreren gelehrten Sprachen, in Id., Sämmtliche Werke, Weidmannsche Buchhandlung, Berlin 1877, pp. 1-7. Riportiamo a mò di esempio questo passo: «Hat also eine jede Sprache ihren bestimmten Nationalcharakter, so scheint uns die Natur bloß zu unsrer Muttersprache eine Verbindlichkeit aufzulegen, da diese vielleicht unseren Charakter angemessener ist, und unsre Denkungsart ausfüllet. Fremden Nationen werde ich vielleicht ihre Sprache nachlallen können, ohne bis auf den Kern ihrer Eigenheit zu dringen. Gestorbne Sprachen werde ich vielleicht den Worten nach aus ihren Denkmälern mit vielem Schweisse erlernen, aber ihr Geist verschwand mir» (ivi, p. 2).
50 où le Sujet lui-même, dans son propre savoir et sa certitude de soi, la conscience de soi comme telle puisse enfin advenir.25
Lo sforzo degli autori del Programma ebbe come punto di partenza quello di ridicolizzare la figura dell’intellettuale illuminista, l’altezzoso che dalla torre d’avorio del suo sapere dispensa ricette e pretende di educare il popolo opponendo a quest’ultimo una distanza invalicabile in modo da tenerlo in condizione di subalternità. Ripudiare la boria del philosophe e farsi organico al popolo, solo in questo modo è possibile quella «eguaglianza degli spiriti»26 che sarà alla base della nuova società e alla quale gli autori del Programma anelavano. Se il vincolo che unisce filosofia e mitologia dovrà obbligatoriamente pianificare lo schema di un’educazione estetica che abbia come fine un popolo autocosciente, il compito del filosofo sarà quello di incanalare la mitologia sotto forme razionali, utilizzare dunque le categorie della filosofia affinché le “immagini parlanti”, i miti, siano il permanente orizzonte educativo in cui il popolo riconoscerà se stesso. Solo così sarà possibile eliminare il “diaframma culturale” che oppone filosofo e popolo. Ciò che schiude alla partecipazione del popolo, ciò mediante cui è possibile una nuova configurazione comunitaria («Allora regnerà eterna unità fra noi»27) – in fondo una rinnovata immagine del popolo, un popolo che deve essere “formato esteticamente” –, è, dunque, la mitologia, della quale il popolo è l’indubitabile depositario, il luogo privilegiato che custodisce il linguaggio narrante ed evocativo. Nancy e Lacoue-Labarthe hanno scorto nelle teorie romantiche di Jena una riattualizzazione di un certo platonismo, più precisamente: «l’ultime répétition de l’eidétique occidenta-
25 P. Lacoue-Labarthe - J.-L. Nancy, L’absolu littéraire, cit., p. 52. 26 Il più antico programma, cit., p. 27. 27 Ibidem.
51
le dans l’élément de la sujectivité»28. Un platonismo filtrato e riletto dalle categorie moderne del soggetto dopo la riforma kantiana, dove la potenza estetica che ha innervato il sapere di un filosofo ormai più prossimo al poeta, secondo gli estensori del Programma, non è pura contemplazione dell’idea di Bellezza – l’idea suprema, quella che compendia tutte le altre –, ma dovrà compiersi realizzandosi nell’opera d’arte: «Ora io sono convinto che l’atto supremo della ragione, quella col quale essa abbraccia tutte le idee, è un atto estetico»29. Nell’opera d’arte, nell’elaborazione artistica riluce l’essereidea della Bellezza, non come oggetto indipendente in-sé, ma come creazione di un soggetto, espressione della sua volontà, compimento della speculazione estetica: Une telle éidesthétique – si l’on nous pardonne ce “concept-valise” – est de fait ce qui trace, dans le paysage de l’idéalisme en général, l’horizon propre du romantisme. L’horizon philosophique du romantisme.30
In questa immanentizzazione estetica dell’Idea platonica vagliata dalle trame del soggetto moderno operata dai romantici, ciò che si può definire come il “bagaglio della mitologia”, il complesso delle narrazioni mitologiche, diventa decisivo in vista del processo di figurabilità. Se il filosofo deve possedere un potere estetico altrettanto potere estetico quanto il poeta, significa che il filosofo deve eguagliare il potenziale evocativo che è proprio della poesia. Filosofia poetante: in altre parole, poiché l’idea di bellezza è l’idealità stessa dell’Idea, l’Estetica speculativa in cui culmina il Sistema-soggetto deve necessariamente capovolgersi in speculazione estetica; la filosofia deve presentarsi, esporsi, realizzarsi in un’opera d’arte. L’arte 28 P. Lacoue-Labarthe - J.-L. Nancy, L’absolu littéraire, cit., p. 52. 29 Il più antico programma, cit., p. 23. 30 P. Lacoue-Labarthe - J.-L. Nancy, L’absolu littéraire, cit., p. 52.
52
è il dispositivo speculativo per eccellenza. Allo stesso modo il filosofo-pedagogo deve saper rendere accessibili le figure simboliche necessarie per la formazione del popolo. La raffigurazione (Darstellung) dell’immagine mitica evocata – il rendere estetico il mito – è necessaria all’edificazione di un popolo determinato. È la bildende Kraft come ästhetische Kraft: la potenza formativa è potenza estetica. L’impellente necessità dei pensatori romantici di dare uno statuto educativo al popolo, mentre rivelava la consapevolezza tutta moderna del suo essere immersa nei vortici di un accento “nostalgico” – ciò che contraddistingue il senso fuggente che caratterizza ogni desiderio –, attivava uno speciale movimento del desiderio che aspirava a ripristinare la verità del senso dato, della presenza come garanzia dell’essente, l’auspicio di un rinnovato incontro tra il desiderato e il dato (ciò che Nancy chiama onto-teo-erotologia31), che avrebbe riempito la mancanza, l’esaurimento del senso, in una modalità che ha visto l’inaugurazione dell’ermeneutica moderna. La volontà desiderante del soggetto di riacquistare quella immediatezza del senso, nel suo indirizzarsi a ciò che è irrimediabilmente perduto, alla decifrazione del suo mistero, proprio così annulla le distanze attraverso il suo sguardo interpretativo. La riconquista mediata dell’origine, provocata dal circolo ermeneutico di cui notoriamente Schleiermacher32 fu uno degli scopritori, rende dunque l’interprete non un estraneo bensì uno stretto partecipante, un adepto a quel senso che è stato riesumato dal suo sepolcro: Nel suo atto di nascita, l’ermeneutica moderna è l’operazione – mediatizzata da una storia e come storia – del rilevamento o della riappropriazione di un soggetto, di un soggetto
31 J.-L. Nancy, Il senso del mondo, cit., pp. 68-69. 32 J.-L. Nancy, La partizione delle voci, cit., p. 23.
53 del senso e del senso di un soggetto. Utilizzando i due grandi versanti tradizionali dell’interpretazione cristiana (che sono a loro volta ripresi, trasformati e rilevati nell’ermeneutica moderna), potremmo dire: nell’interpretazione allegorica del senso dà sempre il soggetto, e l’interpretazione grammaticale del soggetto dà sempre il senso […]. Il circolo ermeneutico è il processo di questa doppia interpretazione, la cui condizione è dunque costituita dalla presupposizione del senso, o da quella del soggetto, a seconda del versante o del momento che si intenda privilegiare. La credenza ermeneutica in generale non è nient’altro che questa presupposizione, che può assumere alternativamente – o, del resto, simultaneamente – la figura filosofica della coppia del senso e del soggetto, la figura religiosa del dono della rivelazione nel simbolo, la figura estetica dell’opera originale e della sua tradizione.33
Caduto l’oblio sull’essere che si dava come foresta di simboli, la quale invitava alla decifrazione mediante corpi ermetici, nella modernità l’elemento di rilievo dell’interpretazione soggettiva è l’adesione a un senso non-evidente e non-dimostrabile, una pre-comprensione che suscita l’operatività di strumenti critici in grado di concludere il processo ermeneutico. Questo tentativo di riappropriazione del mito è pur sempre una tecnica moderna di evocazione razionale: un soggetto, posto a una distanza incolmabile da un passato immemorabile – quel passato immemorabile in cui la potenza del mito orientava le esistenze –, nel suo tentativo di catturarlo e riportarlo in vita nella sua presunta genuinità, mira a renderlo disponibile sotto forma di immagini simboliche, al fine di assolvere a un ben determinato utilizzo, ovvero portare a compimento il processo di identificazione di un soggetto-popolo. La chiave che consente l’accesso alla porta del mito è fornita dal moderno sapere estetico, l’autocoscienza di un popolo determinato si esprime come opera d’arte. 33 Ivi, pp. 24-25.
54
2 Nancy e Lacoue-Labarthe attribuiscono ai cenacoli intellettuali di Jena, dai quali scaturirono il movimento romantico prima e, successivamente, l’idealismo speculativo tedesco, l’aver scoperto: «l’esistenza di due facce nella cultura greca: una Grecia della misura e della chiarezza […], della città, della luce; e una Grecia sotterranea, notturna, oscura, vale a dire la Grecia arcaica e selvaggia dei rituali unanimisti, dei sacrifici cruenti e delle ebbrezze collettive, del culto dei morti e della madre-terra – in breve una Grecia mistica»34. Una polarità su cui, a sua volta, Nietzsche imprimerà un sigillo indelebile introducendo le categorie di apollineo e dionisiaco, le due sponde bagnate dallo stesso mare greco, delle quali una, quella mistica, si distanzia notevolmente dalle classiche pagine winckelmanniane che esaltano il luminoso e delicato sentimento della pura bellezza connaturato allo spirito greco, profonda ragione, secondo Winckelmann, della sua superiorità rispetto agli altri popoli. Una Grecia ctonia e notturna, scarsamente presa in considerazione dai cultori di estetica, che trova l’occasione di suscitare l’interesse di Nancy e Lacoue-Labarthe nel tentativo di delimitare quel nebuloso nucleo mitico da cui il nazismo avrebbe tratto utili materiali per l’edificazione del suo apparato ideologico. L’inclinazione dei tedeschi per questa componente, che per compiti di semplificazione chiameremo dionisiaca, della civiltà greca, secondo Nancy e Lacoue-Labarthe, si spiegherebbe con la febbrile ricerca di un’alternativa a quella Grecia che, nelle sue sfolgoranti vesti solari-olimpiche, funse costantemente da musa ispiratrice nei processi di identificazione dei popoli che abitano i litorali del Mediterraneo e che storicamente hanno
34 P. Lacoue-Labarthe - J.-L. Nancy, Il mito nazi, tr. it. di C. Angelino, Il melangolo, Genova 1992, p. 40.
55
maggiore dimestichezza e vicinanza con il mondo classico, in particolar modo Italia e Francia35. Lo sguardo sempre più interessato che lo spirito tedesco di fine Settecento – impegnato nell’elaborazione di categorie proprie che supportassero l’agognata riunificazione delle frammentate terre germaniche in un’unica compagine statale come sigillo dell’indipendenza nazionale – rivolse all’altra Grecia, fu la risposta dettata da una perdurante condizione di sentita inferiorità culturale nei confronti dei popoli confinanti, verso cui porre solidi argini per evitare ogni tentativo di assimilazione che li riducesse a essere membri del medesimo ambito parentale, una risposta che li indusse a pensare meccanismi di differenziazione nei quali riconoscersi come piena individualità. Una dinamica che, come abbiamo visto in precedenza, aveva investito diversi settori culturali della Germania del XVIII secolo e in cui il magistero di Herder, il discepolo dell’allucinato anti-illuminista Hamann, avrebbe fatalmente intersecato i momenti di tensione politici dell’epoca, culminati nella strenua lotta contro l’egemonia napoleonica nel suolo germanico. Alla più volte sottolineata, da Nancy e Lacoue-Labarthe, importanza che i cenacoli jenesi ebbero nel processo di identificazione dei tedeschi con l’auspicare l’avvento di una nuova “religione sensibile”, fa da contraltare un assoluto silenzio, da parte dei due filosofi francesi, sul ruolo decisivo che nell’investigazione del mito rivestì nel medesimo periodo una robusta schiera di esponenti romantici che operarono nella cittadella universitaria di Heidelberg36. Una lettura completa del movimento romantico tedesco non può infatti prescindere dall’e-
35 Ivi, p. 41. 36 Sul cosiddetto “romanticismo di Heidelberg” si veda l’utilissimo volume di G. Moretti, Heidelberg romantica. Romanticismo tedesco e nichilismo europeo, Morcelliana, Brescia 2013.
56
videnziare la presenza al suo interno di un polo alternativo ai cenacoli di Jena, in grado di elaborare un indirizzo originale rispetto alla sede che fu la patria degli Schlegel, di Hegel, di Hölderlin, di tutti coloro che vengono indicati come gli estensori del Più antico programma. Uno dei più convinti assertori dell’esistenza del polo di Heidelberg, probabilmente il primo che traccio i lineamenti di questa particolare articolazione del movimento romantico tedesco, fu un pensatore votatosi negli anni Trenta del secolo scorso alla causa del nazionalsocialismo: Alfred Baeumler37. Così come nel voluminoso L’absolu littéraire non si fa il minimo cenno all’esistenza di una “scuola romantica di Heidelberg” accanto a quella di Jena, il nome di Baeumler – figura di un certo rilievo del mondo accademico tedesco negli anni tra le due guerre mondiali, del quale non possono essere taciuti gli studi sulla dialettica storia-mito38 e l’interpretazione di Nietzsche che spalancò l’opera dell’autore de La nascita della tragedia all’uso politico nazista39 – è totalmente ignorato da Nancy e Lacoue-Labarthe40 nel denso libello sul mito nazi. 37 Per un profilo di Baeumler si veda G. Moretti, Alfred Baeumler, in «Filosofia oggi», n. 3, 1987, pp. 393-407. 38 Il testo di riferimento è Vom Winckelmann zu Bachofen del 1926, parte centrale di una lunga introduzione a un testo antologico di Bachofen, Der Mythus von Orient und Occident. La traduzione italiana di Giampiero Moretti è contenuta nel volume curato dallo stesso Moretti: A. Baeumler - F. Creuzer - J.J. Bachofen, Dal simbolo al mito, Spirali, Milano 1983, vol. I, pp. 85-190. 39 Cfr. A. Baeumler, Nietzsche filosofo e politico, tr. it. di A. Terzuolo, Edizioni di Ar, Padova 2007. Sulle implicazioni politiche di marca nazista del pensiero di Nietzsche si veda G. Penzo, Il superamento di Zarathustra. Nietzsche e il nazionalsocialismo, Armando, Roma 1987. 40 P. Lacoue-Labarthe accenna a Baeumler nel saggio Lo spirito del nazionalsocialismo e il suo destino, in F. Fistetti (a cura di), La Germania segreta di Heidegger, Dedalo, Bari 2001, pp. 11-22, uno scritto dove i rapporti tra
57
Baeumler, i cui scritti attirarono l’interesse di Heidegger e col quale ci furono scambi continui saldati da un rapporto di stima reciproca41, si fece latore, nella krisis del primo dopoguerra, di una rilettura del movimento romantico tedesco alla luce dell’opera di Bachofen. Attraverso gli studi sul “mondo delle madri” dello svizzero, Baeumler individuò una linea alternativa rispetto a Jena in cui la posta in gioco fu la cruciale tematica del mito. La genuinità della ricezione del mito e, dunque, il suo rapporto critico con la storia, è il punto di divaricazione tra le due scuole. Baeumler, infatti, sulla scorta di Bachofen, vide nella strutturazione comunitaria dell’epoca mi-
Heidegger e il nazismo sono letti dal filosofo francese in chiave filosofica: «Heidegger […] non è qui considerato come un pensatore nazista (lo fu anche seppur per breve tempo), ma come il pensatore del nazionalsocialismo, cosa che egli ha al tempo stesso confessato e dissimulato. La proposizione “Heidegger è il pensatore del nazionalsocialismo” significa che Heidegger ha cercato di pensare – e in questo caso è stato probabilmente il solo – l’impensato del nazionalsocialismo» (ivi, p. 11). Sulle affinità tra Baeumler e Heidegger durante il periodo nazista, Lacoue-Labarthe esprime questo giudizio liquidatorio: «il pensiero di Heidegger è almeno più sottile e scaltro di quello del romanticismo generalizzato. Egli lascia ai “pensatori” del Partito (Bertram, Krieck, Baeumler) la cura di opporre ingenuamente il mythos e il logos; e a Rosenberg di definire in risposta al nichilismo e al declino spengleriano, “il mito del XX secolo”» (ivi, pp. 17-18). Dense pagine sul rapporto Baeumler-Heidegger sono quelle del saggio – successivo a quello di Lacoue-Labarthe – di F. Fistetti, Heidegger e la rivoluzione nazionalsocialista, ivi, pp. 23-104. 41 Lettera di M. Heidegger ad Alfred Baeumler del 19 agosto 1932, in «Margini. Letture e riletture», XLIV, 2003, p. 5. A proposito del lavoro di Baeumler su Nietzsche, Heidegger scrive: «L’accostamento fra grecità e “antichità classica” mi sembra particolarmente riuscito – valuto altresì positivamente l’intero Suo volumetto Reclam – giacché vi compare l’opera “oggettiva” di Nietzsche. Quando Lei, però, vuol interpretare non certo la “psicologia” di Nietzsche, ma ciò che viene chiamato l’”esistenziale”, non posso scorgervi quello che oggi è il maggior pericolo; giacché l’esistenziale in filosofia ha diritto e valenza solo là dove esso venga concretato dall’opera e sia al contempo l’opera-manufatto nel suo senso proprio originario» (ibidem).
58
tica il trionfo del matriarcato, antecedente quindi all’instaurazione di quelle società “olimpiche” sorte dalla frattura traumatica che aveva deposto l’epoca mitica inaugurando quella storica. Il nodo della questione è, dunque, sempre l’interpretazione delle società arcaiche operata da Winckelmann in chiave estetica, e quindi quella grecità “solare” tanto esaltata, che Baeumler leggeva come i primi germogli del pensiero razionale in Occidente: «Winckelmann ha in effetti reciso alla radice la “pianta” dell’arte greca. Egli l’ha considerata solo finché visse alla luce; la radice, conficcata nell’oscuro e materno suolo del mito, non la vide»42. La scuola di Jena, in fondo, secondo la critica baeumleriana, non fece che ricalcare i sentieri già percorsi da Winckelmann – Baeumler non risparmia giudizi salaci sull’ascendenza winckelmanniana degli Jenesi: «Finché fu un ammiratore dei Greci, Friedrich Schlegel rimase l’allievo di Winckelmann»43, e ancora: «F. Schlegel non ebbe alcun senso del mito. Il suo libro è divenuto significativo per l’approccio scientifico con il linguaggio e la letteratura indiane; esso non ha alcun ruolo nella storia della coscienza mitologica del Romanticismo»44 –, mancando l’obiettivo di rievocazione genuina del mito proprio perché ingombra di categorie estetiche, di sapere soggettivo, le quali sarebbero state poi le responsabili dello schiudersi ai loro occhi di una visuale del rapporto tra storia e mito dettata da una temporalità a carattere “progressista”. È questa di Jena una concezione del mondo mitico tutta interna alle categorie storiche, mitologia, ovvero creazione della più infantile e sfrenata fantasia, che può risolversi unicamente come strumento dell’istanza soggettiva, il mito come oggetto manipolabile nelle mani del soggetto estetico. 42 A. Baeumler, Da Winckelmann a Bachofen, in A. Baeumler - F. Creuzer J.J. Bachofen, Dal simbolo al mito, cit., p. 94. 43 Ibidem. 44 Ivi, p. 97.
59
Al contrario a Heidelberg, in virtù di un’indagine storica maturata grazie a un più spiccato retroterra religioso, l’investigazione sul mito subì una torsione particolare dove una minore preparazione filosofica venne compensata dalle ricerche sulla natura del simbolo, sui costumi e i canti aviti. Nel tracciare un percorso che da Görres porta a Bachofen, passando per Creuzer e i fratelli Grimm, Baeumler stende un filo unitario che sta alla base della produzione saggistica degli studiosi elencati, concernente un’attenzione particolare per l’Oriente, visto come contenitore di esuberanza vitale contrapposto a un Occidente appesantito da una ragione dimostrativa, impegnata a esorcizzare tutto ciò che potesse esondare dalle proprie maglie. Un Oriente che sarebbe rimasto immune da quella deriva razionalista che si affermò a un certo punto in Occidente, mostrando per questo maggiore fedeltà a quel mondo dominato dell’elemento materno descritto da Bachofen. La fascinazione per l’Oriente è dunque un argomento che Baeumler utilizza per dare corpo alla sua tesi (corroborata da alcuni passi di Schelling – il quale fu, però, estraneo alle discussioni che animavano i circoli di Heidelberg –, della sua Filosofia della mitologia, passi che nel complesso dell’opera appaiono alcune forzature interpretative)45, per la quale l’epoca mitica non sa45 Cfr. F.W.J. Schelling, Filosofia della mitologia, tr. it. di L. Procesi, Mursia, Milano 1999. Utilissimo nel rilevare le contraddizioni della lettura schellinghiana di Baeumler è il contributo di Giampiero Moretti: «Ed è invece proprio dall’ottava lezione dell’Introduzione alla Filosofia della mitologia, e dalla decima, che Baeumler deriva il principio della separazione fra tempo storico e tempo preistorico, facendone subito la linea portante di questo Da Winckelmann a Bachofen. Quel che però Baeumler non dice è, in primo luogo, che per Schelling il problema mitologico è un problema teologico, e precisamente di teologia cristiana, da vedersi nel suo rapporto con la Rivelazione; in secondo luogo, che il principio di un tempo preistorico occorre a Schelling per dimostrare che il politeismo non ha un inizio storico preciso (il contrario è invece per la Rivelazione cristiana). […] Ancora deve essere osservato che per Schelling è necessario che esista già un’umanità provvista
60
rebbe l’inevitabile preludio all’epoca storica, come vorrebbero tutti coloro che subiscono l’attrazione della significatività delle immagini simboliche ma le riducono a oggetto di apprezzamento estetico, bensì la civiltà mitica e la temporalità che la sorregge sarebbero incommensurabili allo spazio-tempo storico. Per Baeumler la ricezione del mito, se non si procede verso una demarcazione netta tra esso e la storia, rischia inevitabilmente di essere passato in rassegna dall’investigazione razionale e, dunque, di perdere il suo aspetto più genuino per essere costretto entro recinti di liquidazione fantastica come quella grecità, così limpidamente esemplificata da Winckelmann, buona come oggetto di godimento estetico; operare dunque la separazione tra storia e mito, liberare quest’ultimo dal filtraggio delle categorie razionali, consentirebbe di riportare all’attenzione quelle forme d’espressione irrazionali che ancora sopravvivono in determinati ambiti del folklore popolare, e che ancora pulsano di energia mitica, affinché si ripristini quella stabilità genealogica che affonda le radici nel territorio materno. Se Alfred Baeumler (un Baeumler, ricordiamolo, ancora lontano dall’approdare nei lidi nietzschiani e operare quella nefasta interpretazione politica della Wille zur Macht) è una figura estranea al Nancy che esplora il “mito nazi” – il quale ne avrebbe guadagnato assai nel capire per quale concatenazione di autori l’evocazione della potenza del Boden ebbe origine dalla scoperta e dal recupero dell’altra Grecia, quella ctonia e notturna –, non si può ritenere però totalmente fuorviante la sua circumnavigazione intorno al periplo dell’ideologia nazista. Nancy e Lacoue-Labarthe introducono infatti un personaggio, certamente intellettualmente e filosoficamente meno dotato di Baeumler, ma non per questo, tirando le somme, meno impor-
di coscienza affinché possa darsi qualcosa come la mitologia» (G. Moretti, Introduzione, in A. Baeumler, Da Winckelmann a Bachofen, ivi, pp. 30-31).
61
tante rispetto al commentatore di Bachofen. Un personaggio che risponde al nome di Alfred Rosenberg. In un possibile confronto fra i due, in cui è necessario sempre segnalare l’adesione di entrambi al nazionalsocialismo – precisando però che mentre Rosenberg fu tra i fondatori del Partito Nazista (e fu membro di quel brodo di coltura dal quale si formò il partito, la Società Thule del commediografo antisemita Dietrich Eckart) e successivamente s’impegnò a sistematizzare l’ideologia nazista nel suo Der Mythus des 20. Jahrhunderts, Baeumler aveva da tempo una solida carriera accademica prima di aderire al nazismo trionfante al potere –, Baeumler sembra più un raffinato (e nostalgico) cultore di quelle forze primigenie che effondono i miti e che gli possono permettere di stilare, attraverso una ripresa delle intuizioni romantiche, una nuova pedagogia politica per il popolo tedesco dopo il disastro bellico, mentre Rosenberg – e questo mostra tutta la validità della lettura di Nancy e Lacoue-Labarthe –, più che confidare nella “Germania segreta”, dà un taglio decisivo ai fini di questa costruzione ideologica, in cui gli apporti moderni si rivelano fondamentali e senza i quali sarebbe impossibile capire il nazionalsocialismo. Questa lettura del fenomeno evita loro quella semplicistica tendenza che vuole una condanna in toto della cultura tedesca nelle vesti di indiscutibile matrice del nazismo: Fra una tradizione di pensiero e l’ideologia che successivamente, sempre in modo abusivo, pretende di derivarne, c’è un abisso. Il nazismo non si ritrova né in Kant, né in Fichte, né in Hölderlin o in Nietzsche (tutti pensatori chiamati in causa con insistenza dal nazismo) – neppure, al limite, si trova nel musicista Wagner […]. Si deve condannare solo il pensiero che si mette consapevolmente al servizio di un’ideologia, e si pone al riparo o cerca di approfittare della sua forza: Heidegger durante i primi dieci mesi del nazismo.46 46 P. Lacoue-Labarthe - J.-L. Nancy, Il mito nazi, cit., p. 32.
62
Questa precisazione è utile per capire come la delimitazione di un’ideologia preveda la constatazione che le sue frontiere funzionano come la carta assorbente nei confronti di una tradizione di pensiero: per darsi una fisionomia esse devono succhiarne la linfa vitale distendendola nei loro corrugamenti. Un’ideologia priva di una tradizione di pensiero alla quale riferirsi è come un terreno arido e infecondo, rinsecchitosi troppo presto al sole della Storia. Rosenberg, consapevole di ciò, da buon ideologo moderno impegnato nel fornire una legittimazione teorica all’azione del suo partito, nella sua opera principale confeziona una serie di precursori del nazismo all’interno della filiera del pensiero tedesco degli ultimi secoli. E la logica con la quale compila queste liste è ascrivibile a geometrie riferibili alla metafisica del soggetto. La costruzione di un mito (impresa moderna) del nazionalsocialismo, ci suggerisce Nancy, è in tutto e per tutto un’operazione di consolidamento del soggetto nazista, in cui diventa obbligatorio impadronirsi dei mezzi di identificazione: tradizioni, miti, ballate, tutto ciò che concerne riflessioni etnologiche e patrimoni folkloristici saranno utili strumenti per l’edificazione di un soggetto che opera nella Storia. Ma in quest’affastellarsi di miti che incitavano le corde sentimentali degli esponenti romantici, Rosenberg vede nient’altro che la forza straordinaria che emanano immagini simboliche capaci di una forte carica mimetica47, figure parlanti in grado di orientare e condizionare la credenza delle masse. Siamo certamente nei pressi di quella che Kerényi chiamò “tecnicizzazione del mito”, entro cui innestare gli studi d’avanguardia sulla psicologia delle folle di Le Bon. Per quanto i miti abbiano esercitato un’incredibile funzione mimetica, per quanto i toni del Führer possano aver penetrato i recessi dell’animo tedesco risuscitando dal suo in-
47 Ivi, pp. 34-44.
63
conscio collettivo l’archetipo del dio-sciamano Odino, affinché gli strumenti di persuasione del mito nazista da offrire alle masse potessero aver successo, il soggetto nazista per riconoscer-si (per ammantare di senso il suo stare-insieme) dovette passare per la cruna della logica dimostrativa moderna e darsi una legge, la cui indubitabilità rispondeva alla capacità di mettere in relazione i fenomeni osservati. Tutto l’immaginario mitico propagandato dal nazismo passa dunque in subordine rispetto alla legge che lo ordina, che è di matrice scientista di stampo darwiniano: la legge della razza. Tutta l’opera di Rosenberg, depurata degli elementi culturali (che si rivelano essere, in fin dei conti, degli orpelli), si può leggere quindi come un compendio di teorie positiviste, in cui si esalta un unico elemento, un elemento che, in tutti i suoi risvolti di carattere biologico, ha la sua genesi nella scienza moderna: la razza. Non la lingua48 dove, nella molteplicità dei segni e delle immagini, risuona la differenza dei popoli, come scriveva entusiasticamente Herder, ma è la razza che dà voce all’anima – «Seele aber bedeutet Rasse von innen gesehen. Und umgekehrt ist Rasse die Aussenseite einer Seele»49 –, i focolari da cui s’innalzavano i canti delle saghe germaniche per chi era venuto alla terra si trasformano nelle cattedrali di luce che riuniscono quella massa compatta nel tormentato desiderio di coesione assoluta50, l’essere finito costretto in una totalità immanente, «Soggetto assoluto, che crea se stesso, un soggetto che non si fregia soltanto di un potere conoscitivo (come in Cartesio), o
48 «[…] la razza, il popolo dipende dal sangue, e non dalla lingua. Questa affermazione è ripetuta ad ogni piè sospinto da Rosenberg e da Hitler» (ivi, p. 51). 49 A. Rosenberg, Der Mythus des 20. Jahrhunderts, Hoheneichen-Verlag, München 1939, p. 2. 50 Cfr. M. Abensour, Della compattezza. Architetture e totalitarismi, tr. it. di G. Raccis, Jaca Book, Milano 2012, p. 59.
64
spirituale (Eckhart), o speculativo (Hegel), ma che riunirebbe o trascenderebbe tutte queste determinazioni in una posizione immediatamente e assolutamente “naturale”: nel sangue e nella razza. La razza ariana è, in questa prospettiva, il Soggetto»51. L’ossessione claustrofobica tutta scientista della lotta per l’esistenza, nel piano di competizione vitale in cui le razze si combattono alla stregua delle altre specie animali, ghermisce l’immemorabile del mito pervertendone e manipolandone i significati in figure sempre disponibili che annunciano il sogno di volontà di potenza della razza.
3 La primogenitura e la successiva appropriazione che i romantici rivendicarono su quell’aspetto della grecità scarsamente esplorato e non requisito, come quello “classico”, da altri popoli, che doveva dare fondamento alle aspirazioni per un progetto di rinnovata edificazione mitica in vista della realizzazione del programma di educazione estetica per il popolo, non si sarebbe limitata alla pura e semplice imitazione degli Antichi ma, nella raffigurazione del mito, nell’evocazione della sua voce, l’apice di questo processo avrebbe portato a una sorta di partecipazione mistica in cui tutte le generazioni di un popolo determinato si sarebbero fuse in un’unità atemporale52, sciolte dalla costrizione di un divenire considerato nella sua inesorabilità.
51 P. Lacoue-Labarthe - J.-L. Nancy, Il mito nazi, cit., p. 54. 52 «Il singolo sta inevitabilmente nel flusso; lo stesso fluire scorre in ogni singolo dalle lontananze del tempo, e reclama ascolto per il proprio scrosciare. I morti vogliono essere presenti se i vivi prendono decisioni. Essi non sono morti una volta per tutte e scomparsi dalla terra: gli antenati sono,
65
Proprio per questo l’opera d’arte non fu per costoro qualcosa che doveva rispondere a criteri estetici astratti, a criteri del bello indipendenti dall’epoca in cui era stata realizzata; essa era una porta aperta che avrebbe messo in comunicazione mondi affini, ricongiungendoli. Un’opera d’arte, secondo queste indicazioni, non poteva mai essere avulsa dal contesto da cui era sorta, dalle radici dalle quali era germogliata. Su questa nozione di affinità – sulla supposta omogeneità espressiva che stringerebbe in un legame temporale le generazioni del passato con quelle del presente – si possono scorgere quei precedenti su cui molti autori, nell’800 e nel ’900, insisteranno in modo particolare. In realtà questo ponte steso tra Moderni e Antichi è, per Nancy, il più valido certificato dell’illusione di chi si dimena nella costruzione di affascinanti apparecchi acustici i cui echi non sono le voci catturate da remoto bensì lo strazio della propria voce che rimbalza sulla parete: un effetto auto-acustico. Per quanto il desiderio sospinga l’anima anelante a credere di attraversare un ponte gettato nella noncuranza per i secoli trascorsi, la realtà è quella di un fossato invalicabile che divide due sponde la cui opposizione invita a detergere gli occhi trasognati e a guardare lucidamente il mito una volta dissoltosi l’alone mistico che lo circonfonde. Fronteggiare da una sponda opposta il mito è riconoscerlo per quello che è: un mito, una finzione. Certamente non sappiamo che ne è stato e che ne è della verità mitica degli uomini che vivono in seno a ciò che chiamiamo “i miti”. Ma sappiamo che noi – la nostra comunità, ammesso che sia tale, la nostra umanità moderna e post-moderna – non abbiamo rapporti col mito di cui parliamo, anche quando lo compiamo o vogliamo compierlo. In un certo senso del mito ci restano soltanto il suo compimento o la sua volontà. Noi e continuano ad agire e a consigliare nella “comunità” dei discendenti» (A. Baeumler, Da Winckelmann a Bachofen, cit., p. 117).
66 non siamo né nella vita, né nell’invenzione, né nella parola mitica. Non appena parliamo di “mito”, di “mitologia”, significhiamo forse più questa negazione che non l’affermazione di qualcosa. È per questo che la nostra scena e il nostro discorso del mito, tutto il nostro pensiero mitologico sono un mito: parlare del mito è stato parlare della sua assenza. La parola “mito” indica anche l’assenza di quel che nomina.53
Per Nancy, il Romanticismo, proprio nel suo frenetico investimento mitico, rivelava essere il punto di estremo chiarore in cui la consapevolezza di aver a che fare con una finzione sollecitava l’artista a dipingere quelle brume per dare profondità all’ispirazione letteraria. La strenua volontà dei romantici di sopprimere lo iato che separa Antichi e Moderni, di oltrepassare il fiume Lete che divide le due sponde attraverso il proferimento della parola magica “mito”, proprio in quel momento, nell’istante in cui veniva proferita, essa segnalava al mondo di allora, alla contemporaneità, l’inesauribile potenza di qualcosa di sconosciuto, il quale, allo stesso tempo, poteva essere ben compreso come finzione dalle mille risorse. La costruzione del mito nazionalsocialista, Lacoue-Labarthe e Nancy lo sottolineano nel loro saggio54, si basò su pilastri che andavano oltre i tanto celebrati fenomeni esteriori, al di là delle famose processioni di paramenti medievali così in voga durante gli anni del Terzo Reich. Anche per Rosenberg gli “antichi dei sono fuggiti per sempre”, non si tratta certo di ripristinare il culto dei vari Odhinn, Thor e Freyr, quanto di indurre i tedeschi a sognare le loro divinità arcaiche e far emergere i loro rimossi archetipici così da continuare a suggestionare e a sollecitare i loro istinti. Gli Dei che il cristianesimo si illudeva di aver sconfitto una volta per tutte e che riaffioravano nei
53 J.-L. Nancy, La comunità inoperosa, cit., p. 112. 54 P. Lacoue-Labarthe - J.-L. Nancy, Il mito nazi, cit., pp. 46-47.
67
pertugi del subliminale potevano essere sorgente di significato, rivestiti di nuova vitalità come punto di riferimento mimetico, solo agli occhi affascinati che bramavano l’avvento di una nuova aurora. In questo senso la rievocazione mitica operò nelle vesti di stimolazione onirica, manipolazione del mito nei grovigli del sub-conscio, in un’epoca in cui gli studi sulla psiche e sul subliminale riscuotevano enorme successo in tutta Europa e nell’area germanica in particolare. Il mito fu dunque l’ingrediente necessario al nazionalsocialismo affinché una coscienza, risvegliatasi dallo sprofondamento nel sogno mitico, potesse procedere a plasmare l’opera, l’edificio a compimento della Weltanschauung verso cui guadagnare la sua libertà. L’ambiguità di fondo del Romanticismo che Lacoue-Labarthe e Nancy rilevarono nei tentativi dei suoi esponenti di svincolarsi dalle spire del Cogito cartesiano e dal suo dispotismo che soffocava il secolo fu la sostanziale eterogenesi dei fini che costoro si erano proposti. Le fiammanti insofferenze contro il cupo razionalismo non fecero altro che rifornire di inedito carburante la fiamma del Soggetto moderno. All’origine di questo capovolgimento degli effetti sperati c’è l’indagine, tutta moderna dei romantici, sull’essenza della poesia; non sulla poesia come oggetto, come componimento, ma sulla sua radice etimologica greca: poiesis, produzione. L’epoca romantica inaugurava quel tratto caratteristico della tarda modernità in cui la creazione poetica diventa imprescindibile dalla sua riflessione. Nell’auspicare un approccio genuino e sgombro di implicazioni razionali all’ispirazione poetica, il romanticismo si inerpicava, al contrario, in una disperata ricerca per afferrarne il mistero: l’opera come fattore conoscitivo, l’opera che produce in sé la verità della poiesis, l’opera che produce da se la propria verità: auto-poiesis: Et s’il est vrai (Hegel l’établira bientôt, tout contre le romantisme) que l’auto-production forme l’instance ultime et la clôture de l’absolu spéculatif, il faut reconnaitre dans le pensée
68 romantique non seulement l’absolu de la littérature, mais la littérature en tant que l’absolu. Le romantisme c’est l’inauguration de l’absolu littéraire.55
L’assoluto letterario, il dispositivo con il quale i romantici credettero di combattere l’arido soggettivismo, catalizzò tutte quelle forze che, secondo Lacoue-Labarthe e Nancy, confluirono in modo decisivo per la radicalizzazione del pensiero della totalità e del Soggetto56. Inconsapevolmente i romantici diedero quindi un contributo significativo affinché i secoli successivi si consegnassero senza colpo ferire al dominio della “teoria”, all’autorità indiscutibile del soggetto prospettico, a cui fornirono un formidabile armamentario. L’impegno romantico nel voler orientare la ragione verso la stella polare della Bellezza, sfrondandola di tutti i motivi razionalisti che la imprigionavano, non può essere letto in tutta la sua complessità disgiungendolo, secondo Lacoue-Labarthe e Nancy57, dalla stretta connessione con quella “logica produttiva” che inizia ad affermarsi nell’ambito letterario della tarda modernità. L’affermazione progressiva del letterato come professione, del lavoro intellettuale che ha come fine il prodotto di una poiesis. L’opera diventa la finestra da cui l’autore può guardare il mondo. Ecco perché tutte quelle “immagini del mondo”, i Weltbildern, di cui grondano le pareti degli edifici fumanti del XIX e del XX secolo, testimoniano la terribile capacità di preveggenza dello scritto heideggeriano edito nelle Holzwege58. La data di composizione è il 1938, un anno prima della guerra
55 P. Lacoue-Labarthe - J.-L. Nancy, L’absolu littéraire, cit., p. 21. 56 Ivi, p. 26. 57 Ivi, p. 51. 58 Cfr. M. Heidegger, L’epoca delle immagini del mondo, in Id., Holzwege. Sentieri erranti nella selva, tr. it. di V. Cicero, Bompiani, Milano 2002, pp. 90-136.
69
mondiale scatenata dal Terzo Reich, ma esattamente cinque anni dalla funesta ascesa al potere di Hitler e dalla famosa prolusione L’affermazione dell’università tedesca – discorso d’insediamento alla carica di rettore dell’Università di Friburgo, prova inconfutabile dell’adesione di Heidegger al regime nazionalsocialista. Uno scritto questo, che lo stesso Nancy adduce come prova per scagionare il pensatore di Messkirch, non tanto da un’accusa che mostra tracce di colpevolezza indelebili, quanto da quella, ben più infamante, formulata dal suo deuteragonista Lacoue-Labarthe di aver «cercato di pensare […] l’impensato del nazionalsocialismo»59. Secondo Nancy: La Weltanschauung nazista intendeva colmare l’assenza di un cosmotheoros. Ed è per questo che Heidegger nel 1938, ribellandosi al nazismo, annunciò la fine dei Weltbildern – delle immagini del mondo o dei quadri del mondo.60
Questa sorta di richiesta di assoluzione avanzata da Nancy, formulata nel 2002, ha subito ovviamente un ripensamento alla luce del rinvenimento in tempi recenti dei controversi Quaderni neri61. Una tematica, quella dei rapporti tra Heidegger e il nazismo che, grazie a questo ritrovamento, ha ripreso vigore dopo anni. Ciò dà maggiore rilievo allo scritto preso in esame da Nancy in cui Heidegger concepisce l’Età Moderna come fase epigonale della Metafisica in virtù del concorso di due 59 P. Lacoue-Labarthe, Lo spirito del nazionalsocialismo, cit., p. 11. 60 J.-L. Nancy, La creazione del mondo, cit., p. 22. 61 Cfr. soprattutto M. Heidegger, Quaderni neri 1942-1948. Note I-V, tr. it. di A. Iadicicco, Bompiani, Milano 2018. La pubblicazione di questi taccuini (la prima serie avvenne nel marzo del 2014) ha provocato sin da subito una notevole discussione, a cui è seguita una copiosa letteratura. Tra i volumi sull’argomento si segnalano: A. Fabris (a cura di), Metafisica e antisemitismo. I Quaderni neri di Heidegger tra filosofia e politica, ETS, Pisa 2014; D. Di Cesare (a cura di), I Quaderni neri di Heidegger, Mimesis, MilanoUdine 2016; F.-W. Von Hermann - F. Alfieri, Martin Heidegger. La verità sui Quaderni neri, Morcelliana, Brescia 2016.
70
processi: il mondo che diviene immagine e l’uomo che diviene subjectum62. L’epoca del soggettivismo, epoca nel quale l’uomo riduce l’essente a fenomeno di rappresentazione, costantemente a propria disposizione è per Heidegger un capitolo della storia dell’Essere, che si caratterizza come un pensiero che riduce il mondo a immagine: la Weltbilde, intesa in senso essenziale: significa perciò non una immagine raffigurante il mondo, ma il mondo concepito come immagine. L’essente nella sua interezza viene ora visto in modo tale che esso è essente solo e unicamente in quanto è posto dall’uomo pro-ponente e dis-ponente, rappresentante e producente. La dove si giunge all’immagine del mondo, si compie una decisione essenziale riguardo all’essente nella sua interezza. L’essere dell’essente viene cercato e trovato nella rappresentatezza dell’essente.63
Quando il mondo inizia a diventare oggetto di visione da parte di uno sguardo privilegiato, a esser considerato come mero luogo dell’agire dell’uomo, proprio in quel momento la differenza ontologica viene espropriata della sua capacità di tenere la polarità tra “essere” ed “ente”. La metafisica ha già iniziato la sua presa sulla verità originaria. Se il destino (Verhängnis) dell’Occidente, da pensare entro la storia dell’essere (seinsgeschichtlich), è la metafisica, questa destinalità apparirà al Nancy del 2014, al lettore dei Quaderni neri, quasi alla stregua di un’immagine del mondo64, frutto di una visione “onto-storica” che inibì Heidegger dal prendere atto che l’antisemitismo non era un aspetto secondario della
62 Cfr. M. Heidegger, L’epoca delle immagini del mondo, cit., p. 112. 63 Ivi, p. 108. 64 J.-L. Nancy, Nota 2014, in J. Derrida - H.-G. Gadamer - P. Lacoue- Labarthe, Il caso Heidegger. Una filosofia nazista?, tr. it., a cura di S. Facioni, Mimesis, Milano-Udine 2015, pp. 9-11.
71
Storia occidentale. Questa negazione affondava le sue profonde motivazioni nella fedeltà del pensatore di Messkirch a una Storia che avendo la grecità come origine, tutto ciò che straripava da essa era ridotta a pericolosa dissonanza65. Ciò che compare un anno dopo in Banalità di Heidegger è un ulteriore chiarimento riguardo questa destinalità dell’Occidente. Se il greco è stato il tipo, la figura dell’inizio, dell’apertura, della possibilità di “essere”, di lasciar essere “l’essere dell’ente”, vi sarà pure una figura della fine: «un tipo di umanità che si decida a dimenticare l’”essere”, la nullità di ciò che la metafisica ha preso per un ente supremo e generale»66. L’Occidente è destinato (lo dice il nome stesso) al tramonto, all’oblio dell’essere e alla metafisica, vi è dunque un vettore interno che conduce l’origine a esprimere quell’erosione della svelatezza, dell’ἀλήϑεια, e c’è una tipo, una figura che incarna il tramonto – Nancy stesso si chiede se questa figura sia interna a questa Storia oppure sopraggiunge come elemento che accelera la fase di occultamento67. Questa figura è incarnata dal popolo ebraico: La figura ebraica modella il tipo della necessità devastatrice: il colossale, il calcolo, la razionalità affaccendata a indifferenziare il mondo e a sfondarlo letteralmente: a sottrargli, cioè, ogni sorta di suolo. La Bodenlosigkeit – l’assenza di suolo – è un tratto distintivo dell’ebraismo.68
Gli ebrei, dunque, sono il popolo errante per eccellenza, il popolo che meglio esprime l’epoca della globalizzazione sradicante, dell’indebolimento dei sistemi centrati. Affinché questa 65 Ivi, p. 11. 66 J.-L. Nancy, Banalità di Heidegger, tr. it. di A. Moscati, Cronopio, Napoli 2016, p. 21. 67 Ivi, p. 22. 68 Ivi, pp. 23-24.
72
fase declinante abbia fine e avvenga un nuovo inizio è necessario «farla finita con ciò che fomenta la macchinazione della fine: l’Occidente, la metafisica dell’ente, il senza-storia, il senza-suolo e il senza-popolo»69. Un nuovo inizio sarà possibile, per Heidegger, nel momento in cui l’Occidente saprà congedarsi dai suoi esiti, quando la destinalità cesserà di essere Occidente, quando il popolo ebraico si congederà da se stesso, quando anche il popolo del senza-popolo (l’interprete del senza-suolo) distruggerà il senza-popolo che lo costituisce. La distruzione dell’attore principale dell’apogeo dell’Occidente (del culmine del dispiegamento della metafisica) sarà il risultato di una lotta rispettivamente esterna e interna allo stesso senza-popolo: col nemico mortale – il nazionalsocialismo che fonda la sua ragione sulla razza – e attraverso le determinazioni scaturite dal senza-popolo, le espressioni fiorite intorno alla metafisica del mondialismo deterritorializzante: bolscevismo e capitalismo70. Da quest’esplicito antigiudaismo che Nancy rinviene nelle pagine dei Quaderni neri, il filosofo francese scopre due matrici, una più manifesta ricavabile all’interno del pensiero di Heidegger, l’altra come oscuro recesso che Heidegger ha cercato spesso di occultare. Per Nancy, la fedeltà di Heidegger alla questione dell’inizio, al pensiero aurorale che ha origine nella decisione del popolo greco di determinarsi a partire dall’essere e che s’incammina storicamente nella destinazione metafisica dell’oblio dell’essere, aveva di fatto condotto il filosofo tedesco a relegare il problema giudaico all’interno di una Storia dell’essere (Seyn) che non può che metabolizzarlo come caso limitato all’epoca del crepuscolo. Figura del tramonto circoscritta alla fase ulti69 Ivi, p. 34. 70 Ivi, p. 54.
73
ma. L’orrore della Shoah può benissimo essere rubricato come episodio storico-destinale71. Ma nella questione del nuovo inizio che interseca il problema giudaico vi è, per Nancy, un’eredità dalla quale Heidegger ha cercato spesso di sottrarsi, quella cristiana: Heidegger ha voluto pensare un altro inizio che fosse contemporaneamente a immagine e al posto dell’altro inizio che il cristianesimo ha voluto costituire.72
La legittimazione di una nuova era rispetto al contesto dalla quale si è originata ha attraversato gli ambienti cristiani sin dalle fasi immediatamente successive alla morte di Gesù. Sostenitore di una nuova epocalità il cui elemento centrale, il perno su cui ruotare, era l’evento cristico come indiscutibile faglia di una storia umana irrimediabilmente spezzata in due dalla venuta del Dio-vivente – la “nuova alleanza”, la predicazione di Paolo e il tentativo di Marcione di operare un taglio netto col predecessore ebraico –, il cristianesimo sin dalle sue origini si è inquietato, secondo Nancy, della irriducibilità della presenza ebraica, la quale ricordava costantemente al cristiano l’esistenza di un primogenito73. L’antisemitismo di Heidegger si sarebbe nutrito di questo retroterra, sviluppandosi poi in una direzione che sembrerebbe un topos classico della cultura occidentale: il vivere angosciosamente l’epoca del disincanto. Questo “odio di sé” – l’odio dell’occidentale verso l’Occidente terra del tramonto e della Tecnica, padre della logica calcolante e della globalizzazione mercantile – che agita Heidegger, la sua fedeltà inossidabile per l’inizio greco della storia dell’esse71 Ivi, pp. 55-56. 72 Ivi, p. 60. 73 Ivi, pp. 37-42.
74
re, che, allo stesso tempo, gli fa misconoscere la radice cristiana dell’Occidente e individuare nell’apporto ebraico il male necessario; ebbene, tutto questo, è, per Nancy, il grande limite di Heidegger, il tradimento delle premesse di Sein und Zeit, la grande sconfitta di colui che aveva aperto nuovi percorsi verso i quali quasi tutto il pensiero successivo è debitore. Dopo aver imboccato questo sentiero, Heidegger, la dorsale filosofica del XX secolo, si precluse definitivamente, per Nancy, la possibilità di trascrivere in spartito gli echi ancora udibili dell’analitica dell’essere-per-la-morte degli anni Venti. L’evocazione della «grazia a partire dal termine greco charis»74, rintracciabile in un’angusta fenditura dei Quaderni neri, grazia che non necessità di domanda o ricerca, di tensione interrogante e lavoro filosofico, ma di una breccia in cui poter passare, di un varco oltre la tessitura ontologica, fu immediatamente suturata dal filosofo tedesco con la ripetuta e caparbia invocazione dell’essere inassimilabile all’essere (Seyn)75.
74 Ivi, p. 52. 75 Ivi, p. 53. Sul rapporto Nancy-Heidegger sono rischiaranti le seguenti considerazioni di Carmelo Meazza: «Nancy non è interessato a seguire Heidegger e i suoi epigoni nel progressivo spostamento dell’ontologia fondamentale verso un pensiero dell’evento. Il suo interesse si concentra innanzi tutto verso il Dasein di Essere e Tempo, “l’ultima filosofia prima”, come viene definita in Essere singolare plurale. Il compito che egli si pone non è quello di una ripetizione e neppure di un’intensificazione. Nella ripetizione vi sarebbe in agguato quel rovesciamento della Destruktion che ha profondamente compromesso la politica di Heidegger con il crimine nazista. Il programma di Nancy è invece quello di una riscrittura; in qualche modo il pensiero dell’Ereignis deve reimpiantarsi nel cuore dell’analitica esistenziale. Si tratta dunque di ripensare il luogo del Dasein cogliendo e lasciando maturare quanto Heidegger avrebbe troppo in fretta abbandonato. La convinzione di Nancy, su cui l’interprete deve vigilare, è che l’esserecon sarebbe dallo stesso Heidegger definito con chiarezza come “essenziale alla costituzione del Dasein stesso» (C. Meazza, La comunità s-velata, cit., pp. 26-27).
II
Sacrificio
77
Comunità dell’immanenza, comunità del sacrificio
Interim ex fatalibus libris sacrificia aliquot estraordinaria facta; inter quae Gallus et Galla, Graecus et Graeca in foro bovario sub terram vivi demissi sunt in locum saxo consaeptum, iam ante hostiis humanis, minime Romano sacro imbutum. (Tito Livio, Ab Urbe condita, XXII, 57, 6)
Nello spazio moderno d’Occidente in cui la potenza tradizionale del religioso è andata progressivamente assottigliandosi, la parola “mito” ha dato vita a due atteggiamenti contrapposti: il primo è la presa di coscienza di aver a che fare con una finzione, da cui l’esclamazione disincantata «il mito è un mito»1; il secondo è l’accento “nostalgico” che contraddistingue il senso fuggente che caratterizza il desiderio di una parola forte come quella mitica in qualità di surrogato di un legame religioso ormai sotto il maglio dell’inarrestabile mondanizzazione: «la finzione è una fondazione»2. Nell’epoca moderna, in cui il discrimine con ciò che la precedette fu la comparsa di un’indomabile volontà di rappresentazione del mondo («non è che si sia passati da una immagine medioevale del mondo a una moderna: a contrassegnare l’essenza dell’età moderna, piuttosto, è in generale il divenire-immagine del mondo»3), 1 J.-L. Nancy, La comunità inoperosa, cit., p. 119. 2 Ibidem. 3 M. Heidegger, L’epoca, cit., p. 109..
78
l’evocata tensione religiosa e mistica di un mito mai spento divenne l’alleato decisivo che una determinata visione cercava nella sua brama di delineare il mondo secondo un’immagine ben definita. Senza questa complicità ciò che avrebbe assunto poi le vesti dell’ideologia, sarebbe presto capitolata sotto i colpi dell’intellettualismo astratto oppure avrebbe trovato rifugio nelle calde concavità dell’interiorità, per farsi folle visione privata del mondo. L’ideologia, infatti, senza la componente mitica, non sarebbe tale ma fatta a strame dalle sottigliezze analitiche dell’intelletto, o ancora, essa non riuscirebbe ad andare oltre la mentalità calcolante che sottende ogni progetto, nel suo portarsi dietro tutto quel caravanserraglio di minuzie tattiche per assolvere alle fatiche che la pesante quotidianità impone. Per citare Sorel, una rivoluzione radicale non potrà mai avvenire senza i tormenti dell’infinito4. In questo afflato religioso che tutte le ideologie detengono nel proprio petto, Nancy vi ha visto la radice di quello che è stato il disastro novecentesco: «l’immanentismo»5. Una nozione con cui il filosofo francese identifica il mondo come totalità degli enti finiti compattati in una forma comunionale priva di finestre, una sorta di serie storica di esistenze accatastate in vista della fabbricazione di un’opera, il cui autismo, il cupo autarchismo sbandierato come autosufficienza, è la dimostrazione esemplare di un totale ripiegamento nell’immanenza. Anche il comunismo condividerebbe – perfino con i suoi mortali oppositori schierati sotto gli stendardi del capitalismo – il medesimo asse che la modernità ha elaborato: il pensiero dell’umanismo, pensiero che configura l’uomo moderno, l’uomo sor4 Cfr. G. Sorel, Considerazioni sulla violenza, tr. it. di A. Sarno, Laterza, Bari 1970, p. 78. 5 J.-L. Nancy, La comunità inoperosa, cit., p. 22.
79
to nell’epoca dell’esaurimento di ogni afflato di trascendenza religiosa. Eppure, lo stesso Nancy non può far a meno di evidenziare una sorta di resto irriducibile che il comunismo si porterebbe appresso. Ecco, dunque, una duplice considerazione: il fallimento del comunismo è da attribuirsi al pensiero che lo fonda; all’interno di questo indubitabile fallimento il comunismo ha ancora una voce che non è coinvolta in esso. Dunque: il fondamento del comunismo, la causa del suo fallimento, sarebbe da ricercarsi ne «l’uomo definito come produttore (ma si potrebbe dire semplicemente l’uomo definito), e fondamentalmente come produttore della sua propria essenza nella forma del suo lavoro e delle sue opere»6. Una lettura del fallimento storico del comunismo che non attribuisce le deviazioni, le applicazioni pratiche, al pervertimento di una idea che si manterrebbe sempre all’altezza di un ideale incorrotto, ma che individua la responsabilità a carico del pensiero che ne è alla base. Non esiste, per Nancy, una limpida teoria comunista di fronte a una realizzazione storica imputabile di apostasia. La base stessa del comunismo troverebbe nella complicità con l’umanismo la causa più profonda della sua catastrofe. L’insostenibilità di un presunto tradimento andrebbe dunque verificata nel rovesciamento delle sue premesse: se il comunismo “nelle migliori intenzioni” – nel suo “resto irriducibile”, nella sua esigenza profonda – aspirerebbe a una comunità di uomini liberati dalle catene dello sfruttamento, proprio il fulcro, la base sulla quale dovrebbe svilupparsi questo movimento, ovvero l’uomo dell’umanismo, «l’uomo assolutamente considerato come l’essere immanente per eccellenza»7, l’individuo, sigillerebbe ogni possibilità affinché questo possa avvenire. 6 Ivi, p. 20. 7 Ivi, p. 22.
80
L’ostinato presupposto di tutti i comunismi, l’individuo, costituisce il maggior ostacolo per un pensiero della comunità. L’epoca della modernità proprio sull’individuo ha partorito l’architrave decisiva grazie a cui ha edificato la propria struttura. Questo punto avrebbe nella realizzazione integrale della propria essenza la sua risorsa più intima. E questa realizzazione coinciderebbe, secondo Nancy, con la totalità immanente degli enti. Nel compimento dell’individuo, nella realizzazione della sua essenza, e nella sua proiezione comunitaria, si assisterebbe al crudo sviluppo di una soggettività che al fine della sua opera farebbe precipitare tutto l’essere nel grigiore claustrale di un’immanenza senza uscite. A questa riduzione dell’essere a totalità degli enti, questo totalitarismo, che Nancy, abbiamo visto, preferisce indicare col termine «immanentismo», il comunismo vi aderirebbe alla perfezione. Nell’attraversare l’odissea novecentesca di un pensatore eccentrico come Georges Bataille, colui che tentò di esperire in prima persona i versi di una scrittura alimentata delle più rovinose tentazioni comunitarie e degli esiti più estremi della soggettività moderna, Nancy vi ha trovato un ritmo per musicare alcuni spartiti (secondo un’accordatura heideggeriana) quali tessere di mosaico per comporre la sua proposta dell’essere-in-comune8. La consapevolezza del fallimento del quale era causa un irresistibile anelito per il ripristino dell’intimità della comunione, l’ambizione di un novello calore per esorcizzare la fitta nebbia di un disincanto come alito dell’individualismo moderno che ammorbava in maniera soffocante l’epoca post-medievale, portò Bataille alla conclusione che la vita della comunità era assicurata dalla morte, che il sacrificio è la necessaria liturgia della comunità. Se tutte le comunità
8 Bataille è «colui che si è spinto più lontano nell’esperienza cruciale del destino moderno della comunità» (ivi, p. 44).
81
che si dissolvono nel gorgo dell’immanentismo sono tracciabili come opera di morte, per Nancy è proprio il tema della morte il crocevia entro il quale è possibile ripensare la comunità. Ora la comunità dell’immanenza umana, dell’uomo divenuto uguale a se stesso o a Dio, alla natura e alle sue proprie opere, è una comunità di morte – o di morti. L’uomo compiuto dell’umanesimo, individualista o comunista, è l’uomo morto. La morte, cioè, non è in essa l’eccesso irriducibile della finitezza, ma il compimento infinito di una vita immanente; è la morte stessa resa all’immanenza.9
L’individuo definito, e dunque compiuto e concluso in un’identità, è la sostanza nella sua totalità autistica, il soggetto moderno autosufficiente che nella sua esigenza di immortalità ha preteso la trasformazione della morte come carburante in vista di questo fine. Questa comunità si rivela, per Nancy, nient’altro che essere una comunità di morti, un essere immanente e definito in un significato, che preclude la comunicazione tra i suoi membri, poiché presi da una coercizione che ne rivela pure il destino. Come espressione della “metafisica del soggetto”, secondo Nancy, la comunità come comunione, la comunità dell’intimità, sarebbe possibile solo nella fusione degli individui in nome di un significato, di un fondamento a cui appellarsi, un fondamento che assorbirebbe la morte dei singoli come sua esclusiva proprietà sublimata in gloria imperitura, elaborazione retorica di raffinati e celebrativi martirologi, proiettata verso la perpetuazione di un’esistenza futura a garanzia della propria potenza. La vitalità di questa comunità dipenderebbe dunque dalla resa operativa della morte, essa dovrà essere sublimata e ammantata di un senso “trascendente”, affinché non emerga il suo sen9 Ivi, pp. 39-40.
82
so più proprio: la cessazione dell’esistenza. L’operatività della morte è il risultato dell’estorsione della cessazione dell’esistenza al fine dichiarato di fare di essa un veicolo di riconoscimento della comunità – la mia morte è quello dell’altro –, proiettata in un grande Altro, che non sarebbe altro che la comunità divorante le morti dei componenti come sua verità. Il dramma che risolve tutte le soggettività politiche nella loro apparizione, il dramma del pervertimento di una dimensione comunitaria che giustifica la militanza e l’appartenenza, fino agli estremi della vita, la morte, come rinnovata verità della propria immortalità. La prova di questa comunità, l’operazione suprema che richiede questa comunità, è il dono della morte come sacrificio. Il sacrificio è la prova estrema che misura la fedeltà a un significato, operazione interessata che traccia le frontiere sovrane di questo disegno, proiettando la finitezza dell’esistenza, la verità dell’esistenza, nella suggestione della luce di un sole nero che rischiara un’illusoria immortalità. La morte deve convertirsi in operazione sacrificale per stringere la comunità intorno a una presunta verità immortale.
83
Sacrificio antico e moderno
Et longs corbillards, sans tambours ni musique Défilent lentement dans mon âme; l’Espoir Vaincu, pleure, et l’Angoisse atroce, despotique Sur mon crane incline plante son Drapeau noir. (Charles Baudelaire, Spleen)
1 Nell’istante in cui l’evento fondativo trapassa nel racconto che immunizza la ierofania dal disincanto, sorgono i riti che ne devono preservare il potere di evocazione. La narrazione mitica, il canto delle origini deve ripetere ogni volta quell’alterazione qualitativa che ha strappato un gruppo umano dalla piatta omogeneità, dall’indifferenziato: la parola mitica è comunitaria per essenza. Non c’è mito privato, così come non c’è lingua strettamente idiomatica. Il mito sorge soltanto da una comunità e per essa: mito e comunità si generano reciprocamente, infinitamente e immediatamente. Niente è più comune, più assolutamente comune del mito. […] Né dialogo, né monologo, il mito è la parola unica di molti che così si riconoscono, trovando nel mito la loro comunicazione e comunione.1
Una comunione è salda quanto più il potere evocativo della parola mitica è garantito dalla liturgia, dall’insieme di riti che costantemente deve riattualizzare l’evento originario. E non c’è evento fondativo senza che esso venga sancito da un sacrificio. 1 J.-L. Nancy, La comunità inoperosa, cit., p. 109.
84
Da Freud a Girard, passando per Burkert fino ad Agamben, il pensiero del Novecento ha dato al sacrificio il ruolo di garante dell’accadimento primordiale, del taglio risoluto che apre alla possibilità della comunità e che istituisce, subito dopo, la memoria dell’evento. Spesso come peso di una colpa originaria. Così come per il mito, a cui è strettamente correlato, per Nancy, anche lo spettro ambiguo e indistinto del sacrificio che aleggia nell’epoca contemporanea è l’eco di una perdita, il lamento dell’intimità comunitaria nell’epoca del disincanto. L’ossessione tutta novecentesca per la scoperta del segreto del sacrificio è, in fondo, un brancolare nel buio all’ardente ricerca di fuochi fatui con le lenti scure dell’epoca attuale. Per Nancy, infatti, il sacrificio come noi lo conosciamo o ce lo immaginiamo è nient’altro che un’elaborazione occidentale2, un’elaborazione tarda che ci impedisce l’accesso a ciò che fu il sacrificio originario. La nostra comprensione della parola sacrificio è mutuata da categorie tipiche di una civiltà che ha espulso il sacrificio cruento, di una civiltà che considera intollerabile l’esercizio e la pratica sacrificale, almeno così come esse emergono dalle testimonianze dell’antichità. Ciò che noi comprendiamo con la parola “sacrificio” è qualcosa di incomparabile con il significato più proprio di ciò che illuminava quelle pratiche divenute intollerabili alla nostra sensibilità. Ciò che significava propriamente ci è a noi ignoto. Questa ferma presa di posizione di Nancy deve essere vista alla luce dell’enorme fascino che questo lemma ha esercitato durante il secolo scorso. Alla radice di tutto ciò, Nancy vi ha visto l’enorme impressione di una vasta platea della cultura europea per gli studi etno-antropologici, che riportavano all’attenzione pratiche e 2 J.-L. Nancy, L’insacrificabile, in Id., Un pensiero finito, tr. it., a cura di L. Bonesio, Marcos y Marcos, Padova 1992, p. 217.
85
condotte che la civiltà occidentale aveva ormai definitivamente sepolto nei cimiteri dell’oblio. Uno dei folli che venne sedotto dalla nozione di sacrificio riportata alla ribalta appartiene alla cerchia dei numi ispiratori di Nancy: Bataille non volle soltanto pensare il sacrificio, volle pensare secondo il sacrificio, e volle il sacrificio stesso, in atto, e a dir poco non smise di presentare il proprio pensiero come un sacrificio necessario del pensiero.3
Impegnato nella lettura del mondo azteco, Georges Bataille – uno dei più significativi riferimenti filosofici di Nancy, il quale, nonostante quest’ultimo non abbia mai pubblicato una monografia su di esso, rimase una straordinaria fonte di suggestioni – ebbe la fortuna di incontrare il mirabile esempio di una società riportata alla ribalta dai vari reportages etno-antropologici che dava al sacrificio particolare significatività. La nozione di dépense4, frutto di queste indagini, rendeva conto dell’esistenza di un eccesso, di un grumo irriducibile al processo di produzione-conservazione che imponeva una forma di consumo di beni sottratta a ogni prospettiva utilitaristica. Bataille si rese conto dell’esistenza di alcuni comportamenti, che si sublimano in relazioni sociali – la totalità delle relazioni nelle società arcaiche – che strutturano un insieme, dettate da forme, persino da obblighi, che non rientrano nei dispositivi economici in vista di un fine. Non rientrano nell’ordine dei valori di uso, di scambio, di produzione in vista del continuo reinvestimento secondo la legge dell’utile, bensì in un ordine, totalmente opposto a questa legge, in cui i rapporti comunitari si reggono su una scala di valori a carattere simbolico che ca3 Ivi, p. 219. 4 Cfr. G. Bataille, La parte maledetta, tr. it. di F. Serna, Bollati Boringhieri, Torino 1992, pp. 3-22.
86
povolge il sistema di misurazione basato secondo uno schema ispirato al vantaggio economico. All’ordine della dépense è ascrivibile la nozione di sacrificio, che: «non è altro, nel senso etimologico della parola, che la produzione di cose sacre. Fin dall’inizio, appare come le cose sacre siano costituite da un’operazione di perdita»5. I riti d’immolazione degli aztechi restituivano, agli occhi di Bataille, un senso di intimità tra sacrificante e sacrificato, grazie al quale il sacrificio era di fatto espressione evocativa del sacro e la sua pratica del tutto opposta all’operazione utilitaristica. Pratica sovrana del sacrificio incompatibile alla produzione signorile-servile che si dispiega nella logica di soggetto e oggetto6. Grazie alle categorie hegeliane della dialettica del riconoscimento, Bataille dava alla nozione di sacrificio un’interpretazione originale, introducendo, per contrasto, la tematica del lavoro e identificandola come responsabile della degradazione nel profano di una vita immersa nella profondità del desiderio e nel suo libero scatenarsi7. La frattura col mondo sacro, con l’intimità comunitaria spezzata dal lavoro, impose all’uomo un modo per ripristinare quell’intimità che il mondo reale nella sua grigia cosalità quotidiana aveva deposto: «Nei suoi strani miti, nei suoi riti crudeli, l’uomo è fin dall’inizio alla ricerca dell’intimità perduta»8. La violenza senza calcolo del rito sacrificale inondava di calore un legame comunitario sempre in bilico nel perdersi nella rete dell’ordine reale delle cose carica d’incertezza, in quella forma di angoscia per il domani dalla quale l’istante della festa
5 Ivi, p. 7. 6 Ivi, p. 66. 7 Ivi, p. 68. 8 Ibidem.
87
strappava l’essere sociale. La distruzione realizzata dal sacrificio consumava tutto nell’atto rituale, non dava resti o risultati poiché nella sua insignificanza – nella crudeltà senza spiegazione con cui veniva immolata la vita sacra della vittima – sfuggiva all’operazione in vista di un fine. In quell’ordine reale che Bataille bollò come il dominio del profano, Nancy vide il palcoscenico in cui il rito sacrificale non si annullava ma mutava dalla sua atroce e assurda insignificanza nel regno dei significati su cui l’Occidente edificherà i suoi templi.
2 Come sfruttare l’energia distruttiva del sacrificio affinché essa non vada perduta? Qual è il vettore che può immagazzinare e distribuire una tale dirompenza affinché essa non consumi tutto il suo potenziale nel rito? Come bloccare questa sovrabbondante “perdita” e indirizzarla affinché venga conservata e reimmessa nel ciclo produttivo? Bataille si convinse che la terribile violenza scatenata dal sacrificio, l’orrido supplizio a cui venivano sottoposti i prescelti avesse talmente plasmato la sensibilità occidentale, che il solo proferire la parola “sacrificio” avesse il potere immediato di rievocare una zona particolarmente sensibile della coscienza moderna, all’interno della quale baluginano confusamente sanguinolente visioni d’orrore9. Per Nancy, ciò che ci fa espellere un tale orrore dal nostro quotidiano, non è stato causato da un mero mutamento di sensibilità, da una più spiccata tendenza alla dolcezza dei rapporti, ma da una conversione dello stesso sacrificio
9 Ivi, pp. 70-71.
88
alle categorie dell’ontoteologia. Una conversione tale che, senza ombra di smentita, non può che far emergere come la nostra verità occidentale sia impregnata di sacrificio e lo stesso pensiero che non tollera tale orrore ne sia profondamente costituito. Come è possibile che una tale parola, che si preferisce esorcizzare dal nostro vocabolario, abbia avuto un ruolo fondamentale nell’edificazione della ragione occidentale? Come è possibile che la razionalità occidentale abbia un rapporto originario – e ne sia tuttora impregnata –, con un elemento così oscuro? Per Nancy, il nuovo sacrificio, il sacrificio occidentale, si distacca radicalmente dal sacrificio antico; di quest’ultimo noi individui dell’odierno Occidente sappiamo ciò che la nostra razionalità ci offre nelle scialbe vesti di una minima possibilità d’interpretazione. La crudeltà dei sacrifici umani così come appare dalle le pagine di antichi libri o di trattati di etnologia o antropologia culturale è una dimensione che sfugge agli strumenti della nostra razionalità. Ciò che ci fa inorridire, ciò che ci fa rifiutare determinate pratiche è probabilmente un luogo, un recesso, nel quale qualcosa di arcaico è stato metabolizzato: […] l’intera umanità, o poco ci manca, ha praticato qualcosa che chiamiamo “il sacrificio”. Ma l’Occidente riposa su un’altra fondazione, nella quale il sacrificio è sorpassato, sormontato, sublimato o superato in un modo singolare.10
Per Nancy, infatti, il sacrificio occidentale è qualcosa di profondamente diverso da quel tipo di sacrificio che lui stesso definisce “antico”. Eppure, esso manifesta le stigmate di una remota parentela con quest’ultimo. Nancy col formulare questo rapporto come di «rottura mimetica»11 stabilisce una sorta di differenza rilevante che presenta però elementi di continui tà. Con questa formula Nancy rende chiaramente come l’a10 J.-L. Nancy, L’insacrificabile, cit., p. 214. 11 Ivi, p. 221.
89
spetto cruento che caratterizzava il “sacrificio antico” sia stato bandito dai canoni occidentali, ma, allo stesso tempo, afferma che un’eredità del momento sacrificale, depurata dagli aspetti sanguinosi, si è conservata. Nancy dice chiaramente che l’Occidente, fin dal suo levarsi, si è reso responsabile dell’arresto del “sacrificio antico”, della sua interruzione (la sua crudeltà è, per l’appunto, intollerabile), ma allo stesso tempo, lo stesso Occidente ha lasciato filtrare qualcosa: Qual è la natura del rapporto iniziale dell’Occidente con il sacrificio? O meglio, e per essere più precisi, in base a quale rapporto con i sacrifici del resto dell’umanità (o con le rappresentazioni di questi sacrifici) l’Occidente elabora, se così si può dire, il suo proprio «sacrificio» (l’unico, probabilmente, se bisogna insistervi, a rispondere al nome di «sacrificio»)?12
Se l’Occidente si fonda sull’interruzione del sacrificio antico, su una rottura con un passato crudele, in che modo ha proposto una sua versione del sacrificio? In che modo è stata superata l’insignificanza del sacrificio antico, in che modo questa insignificanza è stata riabilitata come piena comprensibilità facendosi fondatrice della verità occidentale? A due episodi cruciali della storia occidentale, a due avvenimenti fondanti, Nancy invita a guardare: la morte di Socrate e quella di Gesù. L’ingiusta condanna da loro subita e la fine tragica a cui andarono incontro sono unanimemente riconosciute secondo i canoni occidentali come esempio di sacrificio. Un sacrificio che, nella sua unicità, nel suo atto unico (nel darsi il veleno e nell’essere crocifisso), esprime un significato universale. La fine dell’esistenza, la morte, assurge a un significato più ampio; ciò che è finita, la carne, e ciò che esibisce la fine, la morte, subiscono un processo di liberazione, di trasfigurazione, di spiritualizzazione. Non è questa la festa crudele in cui
12 Ivi, p. 220.
90
un’orgia di supplizianti si accanisce sulle vittime in un consumo senza resti. Quello di Socrate e del Cristo è un “autosacrificio”: un atto voluto, cercato, per una verità che per trasfigurarsi, per esser vera, deve passare nel cono d’ombra della morte. L’insignificanza del sacrificio antico, la distruzione di energia che dona senza riserve calore all’intimità descritta da Bataille, per Nancy viene sospesa. Tutto il meccanismo di questo sacrificio si ritira di fronte al nuovo sacrificio, alla grandiosità del sacrificio socratico e di quello di Gesù. Questo sacrificio universale sacrifica a sua volta il sacrificio stesso, il sacrificio inteso come pratica esteriore di distruzione di un finito, di una consumazione senza che del sacrificato possa esser capitalizzato alcunché. Il superamento del sacrificio, il “sacrificio del sacrificio” come trasfigurazione è il passaggio necessario al negativo, e dunque la morte pensata come l’ostile negatività che rammenta la finitezza dell’essere, nella modalità di una pratica imitativa tesa a rompere ogni particolarità. Se nel “sacrificio antico” la consumazione della finitezza si risolveva e si placava all’interno del sacrificio stesso, nel sacrificio occidentale la negatività viene assorbita: Si potrebbe chiamare questa mimesis “traspropriazione” [transappropriation], appropriazione, tramite la trasgressione del finito, della verità infinita di questo finito stesso. In un certo senso non c’è più sacrificio: c’è processo. In un altro senso, questo processo ha valore solo per il momento del negativo, in cui il finito deve essere annientato, e questo momento rimane quello di una trasgressione, malgrado tutto della legge che è la legge della presenza a sé. Ora questa trasgressione avviene nel dolore, se non nell’orrore. Per Hegel, per esempio, è la faccia oscura, sanguinosa, ma ineluttabile, della storia. Ma in questo modo lo Spirito realizza la sua infinita presenza a sé, e la legge è restaurata e glorificata.13 13 Ivi, pp. 229-230.
91
Il vero sacrificio, nel mostrare la sua irriducibile distanza dal sacrificio antico, riprende da quest’ultimo, come “necessaria” eredità, il gesto, mimesis, da proiettare in una nuova “configurazione economica”. Il sacrificio occidentale ha come obiettivo quello di superare, dialettizzare e trasfigurare i momenti finiti. La verità, per sapersi vera e infinita, esige il sacrificio. L’universalità pretende la soppressione della particolarità. Il termine che Nancy utilizza, trans-appropriation, indica alla perfezione questa legge. Questa nuova logica sacrificale espelle l’antica economia di distruzione-dépense e attiva un’economia di stampo processuale: Il sacrificio come auto-sacrificio, sacrificio universale, verità e superamento dialettico del sacrificio, è l’istituzione stessa dell’economia assoluta della soggettività assoluta, che di fatto non può che mimare il passaggio attraverso la negatività, da cui, simmetricamente, non può che riappropriarsi e traspropriarsi all’infinito.14
La logica sacrificale prevede uno sguardo che per inverarsi, per verificarsi, deve trasgredire, annientare il negativo della finitezza e così riappropriarsi, riconciliarsi con se stesso. Se il sacrificio antico si definisce come pratica esteriore all’interno del recinto della partecipazione collettiva, un rito dettato dalle convenzioni in auge in una determinata comunità, il sacrificio occidentale ha piuttosto a che fare con il sapere, con la theoria15.
14 Ivi, p. 236. 15 «Ciò che era pratica rituale, culto esteriore, diventa pratica teorica. Il sacrificio moderno-filosofico accade per l’infinito dello spirito attraverso lo spirito, rinunciando in modo acetico alle pompe del culto. Questo rende comprensibile l’espressione apparentemente astrusa che Nancy adopera per illustrare il tratto di sostanziale continuità che tiene insieme il sacrificio antico e lo spirito moderno: il secondo rappresenta propriamente “il sacrificio del sacrificio”, la trasfigurazione della trasfigurazione. […] La trasfigurazione
92
3 Nel 1980, presso il Centre d’études et de recherches interdisciplinaires en théologie di Strasburgo, durante una conferenza dal titolo “Potere e Verità”16, Nancy ebbe modo di interrogarsi sull’identità del liberatore che compare nei celebri passi del mito della caverna nella Politeia di Platone. Al verso 515 C, dopo la descrizione della caverna e della condizione in cui versano i prigionieri, Platone fa irrompere sulla statica, ripetitiva e penosa quotidianità dei prigionieri un elemento di rottura. È l’episodio in cui avviene la liberazione di uno dei prigionieri, il quale viene sciolto delle catene, strappato alla condizione precedente e forzato a uscire dalla caverna. Sul liberatore, su colui che strappa uno dei prigionieri dalle catene e lo costringe alla “visione della realtà”, su colui che sconvolge il sistema di verità nel quale sono immersi i prigionieri e dà inizio a tutto il movimento del mito, lo stesso Platone non dice nulla, lascia sospeso questo passo fondamentale, che resta «sempre un po’ nell’ombra»17 e che sovente passa troppo velocemente nell’economia del racconto. Platone, dunque, non dà un’identità al liberatore, costui si dilegua senza lasciare traccia alcuna se non quest’ombra. L’avvenimento decisivo della liberazione, l’apertura di una faglia nel continuum narrativo è opera di qualcuno che, pur sacrificale non solo trasfigura, ma viene trasfigurata essa stessa, cioè non accade più attraverso figure, riti, storie, racconti, bensì attraverso il concetto» (T. Tuppini, Jean-Luc Nancy. Le forme della comunicazione, Carocci, Roma 2012, pp. 182-183). Sul sacrificio occidentale si veda pure il capitolo Condivisione, in D. Calabrò, Dis-piegamenti. Soggetto, corpo e comunità in JeanLuc Nancy con un’intervista al filosofo, Mimesis, Milano 2006, pp. 101-121. 16 Il testo è stato pubblicato come saggio nel volume di J.-L. Nancy, L’imperativo categorico, tr. it. di F.F. Palese, Controluce, Nardò 2007, col titolo La verità imperativa, pp. 97-122. 17 Ivi, p. 109.
93
restando implicito e indeterminato, è già in possesso della capacità di distinguere i vari piani della realtà, quella della caverna e quella esteriore alla caverna, che si manifestano nella narrazione. È qualcuno dunque già educato al sapere e alla conoscenza, uno che viene da una realtà esterna e ne conosce le situazioni e le condizioni, che discende fino alle estremità della caverna e strappa violentemente uno degli uomini costretto alla detenzione. Decifrando l’intera sequenza in cui si svolge il mito, l’inizio, la liberazione del prigioniero da parte dell’anonimo che sopraggiunge, sembrerebbe coincidere con la fine, con l’intervento decisivo di un liberatore, con la variante, rispetto all’inizio, della sua uccisione. Il mito sembra avere una struttura circolare, l’epilogo sembra ripetere la situazione iniziale, fino, però, alla tragica morte del liberatore per mano degli ex-compagni di prigionia. Il liberatore che presiede l’inizio della scena del mito, pur nell’indeterminatezza dei suoi tratti, sarebbe l’archetipo di quel liberatore che compare nelle fasi finali, a cui viene sottratto il tragico destino dell’ultimo liberatore. Chi sarebbe questo liberatore, che con circospezione compie quell’atto di affrancamento che il prigioniero prenderà a modello per la sua azione durante la parte finale del mito? Il prigioniero liberato sembra ricalcare i tratti, ripetere i gesti, del primo liberatore. In un passo del commento di Heidegger al mito della caverna, testo che Nancy utilizza come punto di riferimento nella sua analisi del “regime di potere occidentale”, un passo che Heidegger recupera dal Platone del Sofista, troviamo una descrizione che sembra rendere giustizia all’identità del liberatore, colui che è uscito dalla caverna e ha contemplato le idee, è il filosofo, «colui al quale sta a cuore scorgere l’essere
94
dell’ente»18. Filosofo è colui che, a differenza degli abitatori della caverna che vivono, in condizione di schiavitù, nella verità della realtà della caverna, ha contemplato il mondo delle idee ed è quindi libero. Se ne può dedurre dunque che, in questo quadro, “libertà” è affrancamento da una visione della realtà errata e fuorviante, dall’ignoranza del mondo delle idee. Solo chi riesce a contemplare il mondo delle idee è libero e può liberare, solo chi è in possesso di questa visione ideale ha la forza per costringere i prigionieri a raggiungerlo nel mondo “libero” della visione delle idee. Solo la luce che permette la visione delle idee rende liberi. La libertà è dunque rapportarsi a questa luce, vincolarsi in modo da prendere possesso della visione. Vincolarsi a questa verità, alla verità ideale, è rendersi liberi e “acquistare potere” grazie a essa. O meglio prendere potere attraverso di essa19. La brevissima inchiesta sul liberatore del mito platonico della caverna consente a Nancy, sulla scorta di Heidegger, di ribadire l’essenza della verità che ha segnato il concetto di sapere occidentale, e di porre all’attenzione il binomio sapere-potere che necessita del passaggio catartico della morte violenta (l’uccisione del filosofo) per essere verità. Il tentativo di Nancy di decostruire il “sistema di potere” occidentale che si fonda sulla verità, l’unica possibile di questa Storia, scaturita dal rivolgimento onto-teologico, non passa per l’edificazione di un’alternativa che proclama con ardore la sua ribellione allo statuto imperiale di una verità al solo scopo di sostituirsi a essa, quanto nell’attraversare questa verità sovrana per strappare ad essa quel nucleo immune dalla tentazione del circuito di potere. Il deciso rifiuto di Nancy di abbandonarsi a 18 M. Heidegger, L’essenza della verità, tr. it., a cura di F. Volpi, Adelphi, Milano 1997, p. 108. 19 Ivi, p. 85.
95
semplicistiche forme contestative è dettato dalla consapevolezza che a questa verità non si sfugge: «la verità occidentale non è dunque «la sola di cui disponiamo»: essa è la verità stessa, nel suo unico luogo»20. La missione decostruttiva di Nancy ha come scopo quella di minare la struttura sulla quale si fonda lo statuto imperiale dell’Occidente, nell’impegno inderogabile di strappare ciò che rimane immune dalla fascinazione del potere di questa verità. L’Occidente stesso è questa verità, nel debito che ha contratto con la verità ideale di Platone. Il particolare privilegio che il greco accorda alla visione dell’ente-manifesto, presupposto imprescindibile, criterio necessario della verità, preliminare dell’incontro tra il dato e la conoscenza è il perno della verità dell’Occidente e il presupposto stesso dell’identità occidentale. Ma per Nancy la verità derivata da questo peculiare statuto della visione21, la verità della theoria, è sottoposta sin dalle origini alle armi insidiose dello scetticismo, alla skepsis. Lo “sguardo dell’occhio scettico” «costituisce in realtà il risvolto di qualsiasi posizione filosofica della verità e dunque di qualsiasi enunciato del vero sul vero»22. Per Nancy dunque la verità, in tutte le manifestazioni della storia occidentale, si è determinata in una continua contesa alla quale è stata obbligata dall’argomentazione scettica. D’altronde parlano chiaro alcuni passi del Teeteto, dove Platone si impone rispondendo al relativismo scettico di Protagora: «Lo 20 J.-L. Nancy, L’imperativo categorico, cit., p. 102. 21 Il verbo vedere in greco è οράο. Heidegger scrive: «Sappiamo che Platone, come in generale i Greci, concepisce il conoscere come un vedere, ϑεωρείν (composto di ϑεα e οράν). E invero l’autentico conoscere l’ente nel suo essere viene simboleggiato appunto dal vedere sensibile, dal vedere con gli occhi» (M. Heidegger, L’essenza della verità, cit., p. 132). 22 J.-L. Nancy, L’imperativo categorico, cit., p. 101.
96
scetticismo nel senso più forte, o la skepsis, è dunque inerente, conflittualmente inerente, alla determinazione teorica della verità. Ne conferma la presupposizione e ne distrugge la posizione»23. Le continue sollecitazioni della skepsis in più di due millenni di storia occidentale orienterebbero la verità teoretica. La quiete di quest’ultima vacillerebbe in quanto sarebbe costantemente impegnata a respingere e a riposizionarsi facendo appello a tutte le sue forze di fronte a un argomento decisivo: l’im- possibilità di enunciare una verità, il non poter dire il vero sul vero, la destituzione di ogni affermazione riguardo la verità. Questo estenuante inseguimento tra theoria e skepsis è il circuito dal quale emergono tutti i passaggi che contraddistinguono la curva del giorno dell’Occidente e Nancy, nello spazio di poche pagine, ne riporta alcuni avvenimenti cruciali ai quali è bene dedicare qualche riga. L’idea che l’Occidente ha manifestato della verità, e che ha avuto nel motto adaequatio rei et intellectus una formidabile sintesi, celebra la verità come corrispondenza tra la conoscenza e la cosa. Ma è proprio la problematica inerente a questa assegnazione preliminare, questo presupposto che si vuole alla base dell’incontro tra la conoscenza e la cosa, che fa saltare l’ingenuità di un certo “realismo”. Difatti il suo crepuscolo si manifesta quando la forza argomentativa della skepsis colpisce con straordinaria intensità: i primi vagiti della civiltà post-medioevale. Quando si manifestano i primi reclami, le prime recriminazioni nei riguardi di una “demoniaca” sospensione del dato reale, nel movimento digradante di una veritas essendi mutata in veritas cognoscendi, il passo cruciale verso gli esiti estremi
23 Ivi, p. 102.
97
della verità occidentale è già stato compiuto. L’argomentazione scettica sarebbe dunque decisiva nel determinare l’apogeo della theoria, l’essenza teorica della verità. Nel passaggio alla veritas cognoscendi di Cartesio, di una realtà sospesa di tutto ciò che non è ego sum-res cogitans, e al Kant che sottomette la realtà fenomenica alle condizioni e ai limiti dell’esperienza possibile a priori si manifesta l’azione di una skepsis che si “converte in theoria”, che si propone come verità prospettando l’accantonamento della verità come corrispondenza, che Cartesio ha definitivamente espropriato e che Kant ha umiliato a definizione nominale. Ma questo non è il limite ultimo. L’apogeo, il pieno dispiegamento della forza della theoria, che mette in catene la skepsis, si avrà con Hegel, che radicalizza tutti i termini: «Hegel può, contro Kant, anche riabilitare la verità come adeguazione, corrispondenza: questa adeguazione è quello dell’autopresentazione della cosa»24. Da una veritas essendi, la verità come corrispondenza che si basava sulla conoscenza della cosa fondata su un’assegnazione preliminare dell’essere, sgretolatasi nella modernità col passaggio verso una veritas cognoscendi, che contempla la perdita della verità come corrispondenza e il divenire “verificazione” (costruibilità dell’oggetto, dimostrabilità del giudizio e verificabilità dell’enunciato), la verità occidentale si installa definitivamente con Hegel, recuperando la verità come corrispondenza, rovesciandola in autocostituzione. Autocostituzione come verificazione dell’essere-manifesto: l’essere-visto, l’essere-manifesto è nella presa di uno sguardo che ha già catturato “idealmente” una presenza e portata al rango di rappresentazione.
24 Ivi, p. 107.
98
Il compimento della metafisica occidentale nella verità come rappresentazione sarebbe il frutto del definitivo trionfo della theoria sulla skepsis, quest’ultima ridotta al rango servile. La verità come corrispondenza sottoposta all’appello della verificazione, si costituisce come verificazione di se stessa nel presupposto dell’evidenza dell’essere-manifesto: l’idea-lismo, l’eidetico, l’essere-presente come essere-evidente si rivela dunque come quel processo attraverso cui qualcosa si presenta e si ri-presenta, e così si accorda a sé. In un tale processo ogni cosa è in primo luogo se stessa in quanto essa è quel sé a cui si rapporta la sua (ri)presentazione. Ogni cosa presuppone questo sé e la Cosa si presuppone come il Sè. […] L’essenza della verità come autoverificazione è il dispiegamento e la radicalizzazione della corrispondenza, della rettitudine adeguata allo sguardo: questa presupponeva «che io conosca l’oggetto», quella esibisce la presupposizione come sua stessa verità, nell’assoluta presupposizione del Sé.25
Il viaggio platonico che ha inizio nella verità eidetica, nello stabilire il primato della comprensione dell’ente alla visione, e quindi dell’ente nella sua presenza, nella sua manifestazione, ha il suo compimento nell’essente che si rivela all’interno della logica del riconoscimento, nella dialettica. La veritas essendi è dunque quella del concetto, entro il quale si presenta la cosa, e l’adaequatio prende la forma compiuta del rapporto soggetto-oggetto. In Nancy questo compimento mostra il definitivo trionfo del soggetto teorico, del “soggetto-verità”, del dominio della conoscenza sulla cosa, intesa come identità, concetto, sottoposta a verifica (e ad auto-verifica), a controllo, alla padronanza del soggetto. La dimostrazione che la verità occidentale nel rivelarsi come potestà, pone nel medesimo piano, come un legame indissolubile, il discorso politico e quello teorico: 25 Ivi, p. 108.
99 A questo punto, eccola la verità che fa potere, che è potere. In qualunque senso si voglia intendere «potere». Perché, come vorrei cercare di mostrare, la Verità – questa verità che è la Verità – esibisce al meglio la struttura nuda di ciò che riunirebbe le due figure antinomiche di tutte le interrogazioni della filosofia politica: il potere come forza o potenza bruta e il potere come autorità legittima. La Verità-Soggetto è ciò che si legittima dalla sua propria potenza di presentare sé e di verificare sé, ed essa è ciò che ha la forza di legittimarsi, di farsi vero […]. La Verità è la presupposizione del Potere stesso, almeno se il potere è pensato come la legittimità di una forza e se questa legittimità presuppone in ultima istanza (monarchica, democratica o come si vorrà) la sua autolegittimazione.26
4 Abbiamo visto precedentemente i tratti che accomunano i due liberatori: la proprietà del sapere per il tramite della visione della realtà delle idee e l’uso della forza nella liberazione dei prigionieri. Ma abbiamo pure notato che i comportamenti dei due liberatori, i movimenti all’interno della scena del mito, subiscono una variazione di fondamentale importanza nella sequenza finale che vede l’uccisione del secondo liberatore. Quest’ultimo, sciolto dalle catene, è il prigioniero liberato che volge verso il suo luogo d’origine, ritorna all’interno della caverna, per adempiere alla missione di liberare il resto dei compagni incatenati, i quali sordi alle sue proposte lo catturano e lo uccidono. La chiusura di questo circolo si delinea dunque in modo tragico e per Nancy, proprio questo sanguinoso episodio, è il punto nel quale la violenza che aleggia in tutto il racconto, da quella del primo liberatore che costringe con successo il prigionie26 Ivi, p. 109.
100
ro all’uscita dalla caverna, a quella di quest’ultimo, il nuovo liberatore, che si adopera nel persuadere i suoi ex-compagni, trova una sua compiuta giustificazione: questo omicidio è il garante della violenza iniziale. Ciò che Platone vuole stabilire come il martirologio della filosofia è in realtà il circolo della presupposizione violenta della verità e della presupposizione (o prelegittimazione) del potere nel vero.27
Il giorno dell’Occidente si compie, si invera in una sorta di sacrificio finale nel quale probabilmente si avrà l’indizio fondamentale sull’identità del primo liberatore. La proprietà del sapere predispone, invita, all’uso della forza. La contemplazione della realtà, della vera realtà, il raggiungimento del sapere, la conoscenza, presuppone una violenza necessaria affinché la quieta passività del quotidiano, così come nel mito appare la scena della caverna, venga scossa. La verità occidentale che presuppone l’evidenza, lo sguardo verso l’ente-manifesto, cela nell’intimo una “struttura di potere”, che al fondo della visione dell’idea, del vedere ideale, è circoscritta, è caratterizzata come un mirare nella giusta direzione: Tutto il teorico è sospeso a questo: al suo colpo di mano, al suo colpo di Stato, che è e fa la sua veri-ficazione. L’orthotés in vista dell’idea, vale a dire la pre-visione della visione implica una ortopedia che la istituisce: un’educazione, un addestramento alla giusta direzione, al buon orientamento teorico – l’orientamento occidentale – e questa correzione istitutrice richiede la forza e il potere dell’istitutore. La struttura della Verità è la circolarità o l’antecedenza reciproca e infinita del teorico e del politico.28
La connessione originaria che legherebbe il teorico e il politico è che questa visione della presenza sarebbe già da sem27 Ivi, p. 110. 28 Ivi, p. 111.
101
pre accompagnata da una volontà di imposizione. Lo sguardo dell’Occidente, la verità occidentale, la presa del reale da parte della conoscenza come volontà di significazione velerebbe una pretesa di disposizione che legittima il proprio atto. La violenza è necessaria in questo schema di potere. Non c’è compimento, non c’è alba di un nuovo circolo senza questo sacrificio che è garanzia di riuscita e verifica della propria legittimità. Senza il sacrificio capiremmo poco dell’identità del primo liberatore. Nancy, a un certo punto, spende su di lui queste parole eloquenti: è proprio con il Soggetto che si comincia, con un Soggetto morto-vivente che torna prima di essere partito e che si manifesta – come per il più imprevedibile ma anche il più prevedibile colpo di scena (è in ogni caso il colpo della pre-veggenza) – in una pura violenza, nella brutalità di una liberazione forzata.29
Il primo liberatore è morto anch’esso, o meglio, si è appropriato della morte, della finitezza e superandola ha subito un processo di trasfigurazione. Il circolo della verità dell’Occidente, della filosofia, deve passare necessariamente per il sacrificio per verificarsi; il liberatore affinché il suo sapere non sia vano, affinché il suo sapere possa elevarsi a verità, deve passare attraverso il suo morire.
5 In un college di Cambridge fa bella figura una coppa attica risalente all’epoca della guerra peloponnesiaca30. Sono raffigurati un giovane seduto che scrive su una tavoletta, concen29 Ibidem. 30 La descrizione della scena è di Roberto Calasso nel suo La letteratura e gli dèi, Adelphi, Milano 2001, pp. 158-159.
102
trato, assorto, nella scrittura; una testa mozzata con lo sguardo rivolto verso il giovane, Apollo in piedi che con la mano sinistra tiene un ramo d’alloro e con il braccio destra indica il giovane. Per Calasso: «è la scena primordiale della letteratura, composta dei suoi elementi irriducibili […] Il loro aspetto non è molto diverso: tutti e tre giovani, dalla capigliatura folta e serpentina»31. La testa mozzata si frappone tra lo scrivente e il Dio; lo scrivente chino sulla tavoletta non vede né il Dio e né la testa mozzata. Il suo raccoglimento interiore è proprio dell’ispirato, di colui che pascola i pensieri battendo sentieri che si rischiarano al passaggio. Ma l’immagine sembra dire che, senza sacrificio, senza quella testa recisa, il dono divino non è possibile. Talete il sapiente, colui che la storiografia filosofica considera come il primo indagatore del Principio, racconta Diogene Laerzio, dopo una scoperta di carattere geometrico, immolò un bove32. Non agli Dei, non alla comunità, ma al sacrificio per la conoscenza, per il sapere la nascente filosofia che il sacrificio aveva rinnegato spalancava le porte.
31 Ivi, p. 158. 32 J.-L. Nancy, L’insacrificabile, cit., pp. 213-216.
III
Comunità
105
Immagini di città
Paris change! Mais rien dans ma mélancolie n’a bougé! Palais neufs, échafaudages, blocs, vieux faubourgs, tout pour moi devient allégorie, et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs. (C. Baudelaire, Le Cygne)
1 Se c’è un luogo fisico nel quale l’Occidente si inaugura è la città. La città come sito in cui stabilirsi, chiedere riparo e garanzia dopo una fuga, un luogo in cui poter ricominciare una nuova vita e cancellare un passato che opprime dopo tante peregrinazioni, è un topos che nella storia occidentale, nell’immaginario che l’ha contraddistinta, richiama profondamente il concetto di libertà come autonomia dai vincoli. La Mileto nella fu Asia Minore, città commerciale costiera resistente all’Impero persiano, patria dei primi investigatori del Principio, sembra riconoscersi su una duplice frattura: il distacco fisico dalla madrepatria e la contrapposizione politica con l’Impero Persiano. Esilio, desiderio d’avventura, ricerca di una condizione appagante, fuga dalle costrizioni gerarchiche compongono il complesso fascio della condizione spirituale di un colono che nella vastità del mare prospiciente scorge quella visione della Totalità come effetto di una perdita di familiarità con la stessa Totalità. Allo stesso tempo è colto da un moto d’orrore nell’incontro con gli immensi ordinamenti asiatici: «le descrizioni greche
106
dell’Asia esprimono sempre il senso dell’illimite: illimitate terre, illimitati eserciti, illimitato potere del Re – oppure il senso del confuso, dell’informe, di ciò che, insomma, non ha ancora ‘incontrato’ la potenza del limitante»1, un orrore di fronte a un qualcosa che esonda dal regime del Μέτρῷ, χρῷ, dalla possibilità di una misurazione. Questo sentimento di sbigottimento di fronte all’illimitato non sarebbe altro che il contraccolpo di una ragione nascente che ha fatto di una misura, una proporzione che esprime l’equilibrio di forze contrarie, la condizione d’umanità. La filosofia, il pensiero d’Occidente nasce nelle città commerciali costiere dell’Asia Minore, in fuga dalla “restrizione” comunitaria della madrepatria, in polemica con l’ombra imperiale: la filosofia comincia con e nella co-esistenza «concittadina» in quanto tale.2
Il nesso tra città e filosofia è dunque originario. Ma da un rapporto che si vuole originario sono scaturite, secondo Nancy, alcune interpretazioni che individuano questo nesso come un rapporto di subalternità che coinvolgerebbe a parti inverse città e filosofia: La tradizione ci ha dato diverse versioni del rapporto che ci sarebbe stato (o che avrebbe dovuto esserci, o che dovrebbe esserci) tra la filosofia e la città, ma di solito lo si vede come un rapporto di sudditanza. La filosofia, intesa quale articolazione del logos, sarebbe suddita della città, intesa quale spazio di questa articolazione; mentre la città, intesa quale insieme dei logikoi, sarebbe suddita della filosofia, intesa quale produzione del loro logos comune. L’essenza stessa del logos, o il suo senso, risiederebbe in questa reciprocità: il logos sarebbe
1 M. Cacciari, Geofilosofia dell’Europa, Adelphi, Milano 1994, p. 19. 2 J.-L. Nancy, Essere singolare plurale, cit., p. 46.
107 il fondamento comune della comunità e la comunità stessa come fondamento dell’essere.3
Questo rapporto di reciprocità descritto da Nancy – il quale parla esplicitamente di sudditanza –, e che stringe in un nesso originario città e filosofia, è la genesi dell’apertura politica dell’Occidente4. In queste fasi iniziali, da cui muoverà i primi passi la nozione formulata successivamente da Aristotele di zoon politikon, la spinta alla costruzione di un inedito concetto di umanità grazie alla filosofia, all’edificazione di un discorso nel quale l’ambito politico è il luogo di emancipazione dell’individuo dall’areté eroica, la città rappresenterà il campo di contesa su cui si confronteranno le varie proposte filosofiche. Vernant5 ha insistito su questo aspetto, sullo spazio urbano dell’agorà, come fondativo di una condotta cittadina che nell’espressione del pensiero privo di precauzioni gerarchiche ha represso il regolamento di conti privato come giustificazione della vendetta. Se prendiamo per valida questa connessione originaria tra filosofia e politica che nel contesto urbano trova lo spazio espositivo per eccellenza, formulata da Nancy, dobbiamo necessariamente evidenziare come il legame che ha stretto questi due saperi sorti dal collasso delle architetture mitico-religiose, ha subito sin da subito una divaricazione immettendosi su un doppio binario: da un lato, la dinamica incessante della questione della physis disegnava un progressivo spazio ontologico omogeneo privo di fratture ierofaniche, di picchi qualitativi, dall’altro, la tensione polemica insita nella filosofia si canalizzava nella pretesa di ciascuna theoria di comprendere
3 Ivi, p. 34. 4 Cfr. C. Meier, La nascita della categoria del politico in Grecia, tr. it. di C. De Pascale, il Mulino, Bologna 1988. 5 J.-P. Vernant, Le origini del pensiero greco, cit., pp. 54-82.
108
la Totalità. Il piano politico sarebbe dunque teso tra due polarità, a un’estremità l’apertura del logos che si traduce nella promozione dell’istanza egualitaria, all’altra la pretesa del pensiero di conquistare l’ambito sociale affinché esso soddisfi nella pratica la sua potenza. Nancy in quest’ultima polarità ispirata alla filosofia eraclitea vi ha decifrato una costante del pensiero che nel radicamento a un fondamento, nel continuo richiamo a un’origine, occlude l’apertura all’essere-comune. In questa volontà di conquista, con la città trasformata nientemeno che in un campo di battaglia tra Weltanschauungen, tra visioni del mondo, nel confronto tra ideologie (a cui, secondo Nancy, si ridurrebbe la filosofia), vi ha ravvisato l’inizio del connubio tra filosofia e politica, l’inizio di una speciale confidenza in cui l’individuazione di una specifica causa lavora per la realizzazione di fini determinati: Il risultato è che, altrettanto regolarmente la dis-posizione viene rovesciata in esclusione, e ogni politica filosofica è una politica dell’esclusività e della correlativa esclusione – di una classe, di un ordine, di una «comunità» qualsiasi, e infine, sempre, di un «popolo» nel senso «piatto» del termine.6
Per Nancy una causa che opera nell’interesse proprio, secondo le finalità che si è preposta è la cartina di tornasole di una filosofia politica escludente. Il suo costante riferirsi alle origini predispone a una visione predatoria e totalizzante del mondo, una metafisica nella quale la causa di un soggetto (un singolo, un gruppo, un popolo) si dovrà compiere, si dovrà realizzare secondo un’economia di tipo sacrificale. Il sacrificio, in questo caso, sarà sempre la procedura essenziale di ogni filosofia politica. Politica della causa, politica che costringe il senso a inverarsi, a compiersi. 6 Ivi, p. 36.
109
Nelle premesse e nell’economia della filosofia politica veicolata secondo questi criteri, c’è, secondo Nancy, quell’aporia profonda che, come abbiamo segnalato, scorre in un binario parallelo. Essa insidia la filosofia politica della causa, trovando nella connessione che lega i termini della città e della filosofia, una presa per decostruire questo paradigma. La disarticolazione del rapporto tra città e filosofia come sudditanza che regolerebbe lo spazio pubblico nella veste di scenario della contesa filosofica, dell’operazione di conquista e di realizzazione dei vari logikoi, che ambiscono alla verità della propria causa, per Nancy, troverà un elemento di resistenza nell’istanza egualitaria e simmetrica che sorge dall’essere- comune e che precederebbe la volontà di potenza del pensiero. Se le città commerciali elleniche nell’Asia Minore, solitamente identificate come il luogo di nascita della filosofia, sono il risultato di una dislocazione al di fuori dei confini della comunità d’origine, in esse è possibile verificare l’avvento di una nuova comunità che decostruisce la comunità fondata sullo spazio concluso o sulla trascendenza come misura gerarchica. Se la filosofia comincia con la città, e, allo stesso tempo, rappresenta un nuovo sito di condivisione sulle ceneri dello sconquasso mitico, essa sarà dunque: la «comunità» senza un’origine comune.7
Se la filosofia è costantemente inquietata dalla ricerca dell’origine, la città non farà che portare in superficie quell’aporia fondamentale che si insinua nella visione della sudditanza dello spazio pubblico: l’esibizione del Mit-sein come dis-posizione (come dispersione e disparità) di una comunità d’essenza, che si presenta come fondata sull’interiorità e sulla trascendenza. Per Nancy, il senso essenziale della polis:
7 Ivi, p. 35.
110 non intesa come somma combinatoria di tutte le attività e le funzioni umane, ma come il luogo della comparizione, ovvero dell’essere-in-comune. […] L’essere-in-comune non ha rappresentazioni; esso rappresenta piuttosto l’assenza della rappresentazione.8
La città non sarebbe altro che l’esposizione di questo esserein-comune irrapresentabile, Mit-sein, e l’energheia della filosofia avrebbe nella decostruzione dell’essere come verità, di un essere che si vuole come identità conclusa, il suo oriente. La filosofia come pensiero del Mit-sein che costantemente rifiuta di subordinarsi a una supposta identità. L’essere coincide con se stesso nella misura in cui questa identità è già scartata. Uno scarto impossibile da contemplare per la filosofia politica della causa presa dal compimento di un principio che non può che configurarsi come identità assoluta.
2 Se la città è un tema che fa da sfondo ad alcune delle pagine più interessanti dei più grandi scrittori del XIX e del XX secolo, il pensatore che potremmo definire come l’investigatore più acuto della città moderna, colui che ha ritratto con sublime lucidità sfondi e figure della metropoli contemporanea nella sua fase aurorale è sicuramente Walter Benjamin. La Parigi del XIX secolo, che Benjamin guarda con gli occhi di Baudelaire, è la città nella quale il capitalismo si afferma come nuovo modo di produzione seriale. In un contesto labirintico quale appare la città moderna, con i suoi viali, i suoi vicoli, le famose gallerie al coperto parigine – i celebri passages –, la
8 D. Calabrò, Dis-piegamenti, cit., p. 104.
111
merce seriale pallidamente si trasfigura e l’intenzione allegorica ne spezza la connessione al valore determinato che il capitale gli ha consegnato. La merce è senza valore, fuori da ogni valutazione d’uso e di scambio, nuda, esposta. L’incarnazione più evidente di questa speculazione, di questa espropriazione dell’essenza direbbe Nancy («la merce cerca di guardarsi in faccia», scrive il pensatore berlinese), è dunque, per Benjamin, da ricercarsi nella figura della prostituta. Nella grande città, nel mercato per eccellenza della produzione industriale, la prostituzione diventa un articolo di consumo di massa. Ma nell’affermazione che Benjamin fa della prostituzione come inaugurante una comunione mistica con la massa, Nancy direbbe (rilevando comunque in questo l’esatta intenzione di Benjamin a riguardo) che c’è poco di mitico e di mistico in questa forma comunionale. Il rapporto della massa con la prostituta non fa intimità, non fa esperienza, è una comunità dispersa negli innumerevoli labirinti nei quali si inabissa la città. La città, come la prostituta, non ha un’essenza se non nell’esposizione costante della propria merce in superficie. Questo sfondo, dice Benjamin, è una superficie senza un secondo piano, un “senza fondo” come può esserlo solamente la strada, piuttosto che le secrete stanze di un bordello. La città è la spaziatura delle singolarità in atto. Il “sempre nuovo” della merce, che altera continuamente i valori di uso e di scambio (pensare un sistema di cambi fissi in una città è praticamente qualcosa che tocca il limite dell’assurdità), inibisce l’esperienza9: in Baudelaire, riporta Benjamin citando Leiris, la parola familier è piena di mistero e inquietudine.
9 Sull’incapacità dell’uomo contemporaneo di fare esperienza, si veda G. Agamben, Infanzia e storia. Distruzione dell’esperienza e origine della storia, Einaudi, Torino 2001.
112
La città non consente una privatizzazione dell’esistenza, un ripiegamento nell’interiorità, una vita intima. La vita è scaraventata nella pubblica piazza. L’esempio più acuto è la descrizione che Benjamin fa della città di Napoli. Quella Napoli che quasi mezzo secolo appariva ancora «l’ultima metropoli plebea, l’ultimo grande villaggio»10. L’occasione per presenziare a un convegno di filosofia aveva portato Benjamin a violare involontariamente la sacralità dell’evento, a essere risucchiato nelle spire di un luogo dove non era possibile uno spazio privato. La descrizione dei luoghi, delle chiese che perdono ogni aura di religiosità, dei volti miseramente variopinti e perfino dei dolori degli storpi e dei mendicanti che gioiscono dello sgomento dei trasognati passanti alla loro vista non era lo sfondo che custodiva lo spazio interiore degli abitanti, quanto il fondale di un teatro nel quale ogni abitante dava luogo alla sua esibizione: Balcone, ingresso, finestra, passo carraio, scala e tetto fanno contemporaneamente da palco e da scena. Anche la più misera delle esistenze è sovrana nella sua oscura consapevolezza di essere parte.11
Nancy direbbe che questa esistenza teatrale, che caratterizza il popolo napoletano, questa esistenza perennemente in atto, non dà alla città la definizione di una identità compiuta che sussume tutte le singole esistenze. Al contrario, la consapevolezza di ciascuna singolarità di essere parte è esserlo nella misura di una irriducibilità a qualunque senso “superiore” che ne totalizzi le possibilità. La parte è sovrana in quanto non relegabile, originariamente spartita, continuamente in atto, esposta: 10 P.P. Pasolini, Lettere Luterane (1975), in Id., Saggi sulla politica e sulla società, Mondadori, Milano 2001, p. 553. 11 W. Benjamin, Napoli, in Id., Opere complete. II. Scritti 1923-1927, ed. it. a cura di E. Ganni, Einaudi, Torino 2001, p. 40.
113 «Con» è la spartizione dello spazio-tempo, è un allo-stessotempo-nello-stesso-luogo in quanto esso stesso, in se stesso, scartato. È un principio di identità istantaneamente demoltiplicato: l’essere è allo stesso tempo nello stesso luogo, nella spaziatura di una pluralità indefinita di singolarità.12
Vicoli sudici, cantine che fungono insieme da alloggio per la notte e da deposito merci, commercianti che vendono a prezzo fisso mozziconi di sigarette raccolti dopo la chiusura del caffè, schiamazzi festivi infrasettimanali che evidenziano quanto un granello di domenica ravvivi ogni giorno della settimana, parrocchie che soddisfano la propria ambizione nel superare la parrocchia vicina con un’esibizione di vivacità luminosa sono la superficie nella quale l’esibizione, la platealità svilisce ai minimi termini la familiarità e l’intimità domestica: «così la casa non è tanto il rifugio in cui gli uomini si ritirano, quanto l’inesauribile serbatoio da cui escono a fiotti»13. Le azioni e i comportamenti privati non trovano occasione per farsi essenziali, non riescono a capitalizzarsi come immagini interiori, poiché continuamente inondati da flussi di vita comunitaria; ogni questione privata diventa una questione collettiva: «la vita privata del napoletano è lo sbocco bizzarro di una vita pubblica spinta all’eccesso»14. C’è, per Benjamin, una legge (se è lecito chiamarla così) che, più che regolare, spiega questo aggrovigliarsi di esistenze: è la porosità15. Questa interconnessione particolare che Benjamin rileva dal l’osservazione del materiale edilizio sul quale è fabbricata la città di Napoli e la peculiare esistenza che affiora dal popolo 12 J.-L. Nancy. Essere singolare plurale, cit., p. 50. 13 W. Benjamin, Napoli, cit., p. 44. 14 Ivi, p. 40. 15 Ivi, p. 41.
114
napoletano, è il medesimo che lo portò a identificare la Parigi, capitale del secolo XIX, con i famosi passages. La porosità assicura la comunicazione, la friabilità del definitivo e il continuo riassemblaggio del materiale. Essa consente: «aperture, varchi, accessi, porte – in una forma urbis che non si sviluppa mai per programmi, per a priori, dove nulla procede, o avanza, o si fa strada secondo linee rette, per interruzioni e rotture»16. La città non si sviluppa secondo direzioni pre-ordinate, pianificazioni che si risolverebbero in compiutezza; la porosità è passaggio, fluidifica una serie di legami e di nodi che rifuggono dalla definitività. La città non può che compendiare: una politica del legame come tale, piuttosto che del suo scioglimento in uno spazio o in una sostanza.17
Il legame politico come nodo che prevede costantemente il suo scioglimento, pone le parti che ambiscono al potere, costantemente sotto la scure di una loro possibile consunzione. Una politica della autosufficienza – anche un partito rigido di quadri –, in un contesto cittadino sarà sempre a rischio18. 16 L. Saviani, Poros. Idee di Napoli, in Id. (a cura di), Poros. Idee di Napoli e variazioni sul tema del Mediterraneo, Marcovalerio, Torino 2002, p. 73. 17 J.-L. Nancy, Il senso del mondo, cit., p. 142. 18 Le decomposizioni delle grandi Narrazioni nella tarda modernità di fine Novecento – il partito, lo Stato-nazione, le istituzioni e tradizioni storiche – sono alcuni dei passaggi centrali de La condizione post-moderna di JeanFrançois Lyotard. Il rapporto tra azione politica e contesto metropolitano è stato oggetto di interessanti elucubrazioni provenienti dall’area politica dell’estrema sinistra italiana, nelle quali ci fu un tentativo di distacco da una certa ipoteca del leninismo, della progettualità politica in favore di uno spontaneismo da ritrovare nell’elemento del “partito in atto”, una sorta di «processo di partito come base di una dialettica ricostruttiva che non è in nessun caso di prefigurazione» (A. Negri, La Forma-Stato. Per la critica della costituzione materiale, Feltrinelli, Milano 1977, p. 237). La volontà dei movimenti di inserirsi nelle trasformazioni dei contesti metropolitani è stata sintetizzata da Franco Berardi Bifo: «Ma che senso può avere il lenini-
115
Questa insofferenza per la rappresentazione definitiva del suo spazio vitale, che sembra caratterizzare la città – la Storia ci ha, in effetti, fornito molteplici esempi: dalla Parigi di Robespierre, passando per la Ginevra di Calvino –, sarebbe dunque da attribuirsi, alla tragedia e all’orrore verificatesi nel momento in cui una politica esclusiva tenta di costringerla. L’immagine della città, questa Stadtbild, si sarebbe sedimentata dalle visioni di innumerevoli figure (dal legislatore al profeta al capo di partito) che hanno cercato di obbligarla alle diverse forme d’identificazione; per Nancy in essa riposa la violenza verso il con dell’essere, la costrizione, la forzatura verso l’unità, verso una figurazione dell’essere che mette in subordine la sua originarietà spartita. Prendere partito in città, direbbe Nancy, è un esercizio di potere (malgrado esso, malgrado l’esercizio obbligatorio) che deve fuggire dalla tentazione di una riduzione della parte a soggettività politica, a un soggetto che sarebbe costantemente spinto a ridurre la spaziatura a sé, al proprio interesse.
3 Per Nancy, non è più il tempo in cui una città possa segnare un’epoca, come la Roma antica o la Parigi benjaminiana capitale del XIX. L’urbe ha dilatato i suoi confini abbracciando tutto l’orbe, il mondo. Questa osmosi, questa confusione tra urbe e orbe, questo accavallarsi di città, villaggi, masse, popolazioni, edifici, questa conurbazione, Nancy la definisce, con
smo nella metropoli? Che senso può mai avere l’idea di un partito di quadri quando il lavoro mentale diviene un continuum superindividuale che connette e globalizza innumerevoli cervelli?» (F. Berardi Bifo, La nefasta utopia di Potere operaio, Castelvecchi, Roma 1998, p. 69).
116
un termine che, richiamando una certa vischiosità, ne esalta l’illimitato abuso dell’agglomerazione, come glomus: L’agglomerazione erode e sciupa quel che sembrava un globo e che si riduce ormai al suo sosia, a un glomus. In questo glomus si assiste simultaneamente alla crescita indefinita della tecnoscienza, alla crescita correlativa ed esponenziale della popolazione, all’aggravamento delle ineguaglianze di ogni tipo – economico, biologico, culturale – e allo smarrimento di quelle certezze, di quelle immagini, di quelle identità che una volta componevano il nostro mondo e la nostra umanità.19
La descrizione che Nancy fa del mondo contemporaneo è simile alla descrizione che ciascuno può fare di una bolgia, di un quadro a tinte forti come nelle peggiori fantasie oniriche di Bosch. Al capolinea di ogni filosofia della Storia, al termine di ogni immagine del mondo, con l’interconnessione globale di tutti gli abitanti del pianeta, il Mondo appare questo immenso campionario di orrori. Che cosa intende Nancy per agglomerazione? Prendendo alla lettera il termine, potremmo dire che esso è un movimento di coagulazione causato da un principio attivo che fa precipitare il mondo in una massa informe e omogenea, pronta a essere “lavorata”. Qual è questo principio attivo? Se la città, come spesso si è detto è contemporanea della filosofia, ne condivide i medesimi inizi, essa, presa da un orizzonte di misurazioni, svilupperà progressivamente, nei secoli, a regolamentare i vari tipi di scambio, sociali ed economici, su proporzioni non più determinate da valori eroici. Secondo Nancy, l’Occidente intrattiene, fin dai suoi esordi, uno stretto rapporto col capitale e col principio-guida dell’equiva-
19 J.-L. Nancy, La creazione del mondo, cit., p. 6.
117
lenza generale, ovvero la riduzione di tutto a oggetto di valore misurabile. Nancy segue sostanzialmente le direttive di ciò che Marx intendeva come “prestazione storica” del capitale ma nell’interpretazione che ne dà Nancy, essa suonerebbe seguendo questo spartito: il capitale è il destino dell’Occidente in una biforcazione in cui alle estremità si trovano il dominio e l’apertura; occidentale in quanto preso dalla forza eversiva della decostruzione tipica dell’Occidente, come dominio perché estorce il senza-valore dell’apertura verso l’appropriazione, l’accumulazione e lo sfruttamento. Il capitale è certamente forza che espropria i fondamenti nelle sue garanzie, verso i connotati del sacro, ma lo fa in vista di un’appropriazione esclusiva del valore secondo il metro che le porta in dono l’equivalenza generale: tutto è misurabile, tutto è mercificabile: È la lotta dell’Occidente contro se stesso, o del capitale contro se stesso. È la lotta tra due infiniti, l’infinito dell’estorsione e l’infinito dell’esposizione.20
L’Occidente ha dunque una struttura bifida. Il capitale porta agli estremi la connessione tra gli abitanti di un mondo – la comunicazione, l’esser-comune che precede ogni istanza riconoscitiva –, espropria il mondo di qualsiasi concezione che vorrebbe ridurlo a immagine da un osservatorio privilegiato e fa emergere la sostanziale assenza di causa, di ragione fondativa. Il capitale compie la sostanza nichilistica dell’Occidente. Ma proprio in questo punto il capitale subisce un arresto: se il capitale non riesce a riassorbire integralmente nella merce questa risonanza senza ragione, ciò significa che il capitale non si basa soltanto sulla merce: qualcosa precede il capitale,
20 Ivi, p. 38.
118 e questo qualcosa è la ricchezza come sfarzo, la ricchezza che non produce nuova ricchezza ma produce il suo stesso splendore, la sua stessa opulenza, come irradiazione di un senso da cui il mondo è sempre già avvolto.21
C’è una ricchezza che precede il capitale e che sfugge nel rapporto con quest’ultimo alla mercificazione. L’eccesso della ricchezza, la possibilità che essa possa configurarsi è qualcosa che è ostile all’accumulazione, all’azione del capitale. Anzi, la volontà di sottomettere quest’eccesso, di capitalizzare questo incommensurabile conduce a quel “cattivo infinito”, all’infinito dell’estorsione che sfocia inevitabilmente nella disperazione di un immanentismo assoluto. La faglia che questo eccesso apre nella carne del capitale è la possibilità di uno sfarzo, una magnificenza, una grandezza non misurabile. È il capitale che si confronta con il senza-ragione del mondo: l’irruzione non definibile di un evento come l’infinito in atto.
21 Ivi, p. 29.
119
L’esigenza comunista
My ravnye. Tovarišči v rabočej masse. Proletarii tela i ducha. Liš’ vmeste vselennuju my razukrasim i maršami pustim uchat’. Otgorodimsja ot bur’ slovesnych molom. K delu! Rabota živa i nova. (V. Majakovskij, Poet rabočij)
1 La forza eversiva dell’ateismo, nello scardinamento degli edifici religiosi, ha pensato presuntuosamente che l’espulsione di quello che definiva “orizzonte religioso” fosse sufficiente per l’apertura di quello spazio laico posto come fondamento di una rinnovata dimensione della politica. È stata la motivazione che ha caratterizzato alcune fasi della storia occidentale e che ha segnato quell’epoca che conosciamo come Modernità. Quando Nancy parla delle religioni civili come in un rapporto di successione e di supplenza nei confronti delle religioni precedenti, non fa che sottolineare come la causa del loro fallimento sia da ricercarsi nell’aver sostanzialmente ricalcato il ruolo svolto da queste ultime. Le religioni civili hanno in tutto e per tutto assunto come loro schema quello dell’economia sacrificale. E termini come “lotta di classe” e “liberazione dell’umanità” in senso marxiano, sa-
120
rebbero nient’altro che esempi classificabili all’interno di una logica di tipo salvifico. È questo l’impasse entro il quale si sarebbe arenato tanto Marx quanto, soprattutto, molti dei suoi interpreti successivi. Non è un caso che le parole comunismo e socialismo hanno con prepotenza negli ultimi due secoli rappresentato perentoriamente la possibilità di religione civile e non è un caso che l’emblema della perdita della comunità nell’era moderna sia stato incarnato dalla parola comunismo. Si è detto in precedenza che, per Nancy, voler distillare il comunismo per ritrovarne un senso – nella versione originaria di Karl Marx –, depurato dalle sue perversioni storiche, da una certa distorsione avvenuta nelle applicazioni pratiche che si sono avvicendate nel corso della Storia, è un esercizio ingenuo1. Anche concentrare tutto sulla protesta dello stesso Marx contro le cosiddette “totalità fagocitanti” come lo Stato politico hegeliano nell’intento di preservare quella declinazione della comunità che è la società civile è un’errata interpretazione di molti suoi esegeti che non tiene conto della antropologia filosofica di Marx: l’uomo definito come produttore (ma si potrebbe dire l’uomo definito), e fondamentalmente come produttore della sua propria essenza nella forma del suo lavoro e delle sue opere.2
Il perno sul quale poggerebbe il progetto comunista di liberazione è nient’altro che l’homo faber, ovvero l’uomo come produttore della sua essenza, della sua libertà, che realizza la comunità umana come opera propria, attraverso la forma del lavoro. Le argomentazioni che scaturiscono dalla sfrenata ricerca di un presunto “tradimento” sul quale verrebbero giustificati tutti i modelli che si pongono come lettura radicalmente
1 J.-L. Nancy, La comunità inoperosa, cit., pp. 19-20. 2 Ivi, p. 20.
121
alternativa alle forme di comunismo realizzato, di “comunismo reale”, cadrebbero, dunque, su questo pilastro individuato da Nancy. L’uomo dell’umanesimo, l’essere immanente che attraverso il lavoro realizza la sua essenza, è un presupposto che, in una prospettiva teleologica, conduce al compimento di una comunità immanente di individui. Il programma umanistico definisce tutto il pensiero della modernità occidentale fissandolo su un idealtipo, l’individuo emancipato, il metro da cui ogni impresa politica, ogni raggruppamento umano istituito in un ordinamento, non può sfuggire. Un metro che deve la sua nascita all’investimento che una te(le)ologia laica fece su uno spazio lasciato vuoto dal progressivo esaurirsi del senso collettivo dell’esistenza: Egli è un’altra, simmetrica, figura dell’immanenza: il per sé assolutamente distaccato, preso come origine e come certezza.3
L’affermazione dell’individuo nell’epoca contemporanea ha aperto la perdurante faglia del problema della comunità. L’auto determinazione dell’individualità, la pretesa dell’individuo– la sua etimologia è abbastanza esplicita – di “bastare a se stesso” e dunque di essere esso stesso la propria origine e la propria certezza, è, per Nancy, l’allucinazione che offusca l’intera modernità occidentale. Più questa pretesa, sostanziata da una straordinaria volontà di autosufficienza, insiste nel suo ruolo autarchico, più l’ombra sotto cui si vuole celare il problema di un mondo – tutto ciò che è esterno all’individuo – inizia a dissolversi. L’individualismo, il pensiero dell’unicità dell’individuo, deve obliare, per affermarsi, l’irriducibilità di un mondo che si sottrae alla sua visione. La costruzione dell’individualità (entro cui dovremmo includere le “grandi individualità” del Politico moderno, come gli Stati) ha il suo punto d’avvio in un pensiero in
3 Ivi, p. 23.
122
cui le risorse dell’interiorità sono il sufficiente carburante che predispone una visione dell’esterno, dal quale è necessariamente chiuso, privo di rapporto, quand’anche il “valore” di questa chiusura derivi dal confine, che lo determina. È il motivo per cui nella metafisica del soggetto moderno (del per-sé assoluto) la comunità non compare. Sapersi soli essendo soli, questa è l’assurdità di una logica dell’Assoluto autosufficiente che si pensa senza rapporto. Ma più un soggetto-Assoluto si pensa senza rapporto più il pensiero della comunità ritorna prepotentemente a scalfirlo: il rapporto-con-l’Altro (la “comunità”) è la costante minaccia di un Assoluto autarchico che si pensa senza Mondo. Questa problematica Nancy la affronta riportando le note critiche che, ne L’esperienza interiore, Bataille mosse al Sapere Assoluto hegeliano (nella nota “mimesi” del Sapere Assoluto, terza stazione della “nuova teologia mistica” batailliana4). Bataille, secondo Nancy, capì che l’ascesa graduale della coscienza al divenire-Tutto come raggiungimento dell’Assoluto, la necessità della conoscenza del Tutto come auspicato raggiungimento dell’estrema libertà, era la raffigurazione di una immanentizzazione assoluta, la totalità dell’essere intesa come totalità degli enti. Che la Destruktion heideggeriana aveva privato di ogni credibilità. Bataille aveva infranto questa logica circolare, operando una lacerazione nel tessuto della logica hegeliana con il concetto di estasi, dell’essere estatico, aperto, in-relazione che conduce all’impossibilità dell’immanenza assoluta. Pensare la necessità dell’esistenza di ciò che si sa, ovvero pensare che ci si guadagni la piena libertà nella conoscenza di tutto ciò che c’è da sapere, è il folle disegno che ha sollecitato Bataille a definire l’estasi come impossibilità dell’immanen-
4 Cfr. G. Bataille, L’esperienza interiore, tr. it. di C Morena, Dedalo, Bari 1978, pp. 173-174. Il testo è ripreso da Nancy in La comunità inoperosa, cit., pp. 26-27.
123
za assoluta. Il comunismo marxiano impostato sull’homo faber non potrà che seguire il destino della metafisica dell’individuo, del soggetto moderno, col quale condivide il pensiero che la libertà si guadagni con la conoscenza del Tutto. Ambedue sono: solidali nel diniego dell’estasi. E la questione della comunità è ormai inseparabile, per noi, dalla questione dell’estasi: come si comincia a capire, infatti, essa è inseparabile da una questione dell’essere considerato come una cosa diversa dall’assolutezza della totalità degli enti.5
Allo scacco del pensiero del Sapere Assoluto, all’impossibilità dell’assolutezza dell’Assoluto o all’impossibilità assoluta dell’immanenza compiuta, dice Bataille, solo il silenzio dell’estasi è in grado di rispondere. Un’esigenza che sollecita l’abbandono dell’immanenza e dell’umanesimo, l’esigenza di una comunità irriducibile alla necessità dell’opera, irriducibile al ciclo riproduttivo della sua essenza.
2 Il comunismo è, per Nancy, il nome che definisce il desiderio di comunità, che, in fondo, è consegnato sempre a un afflato di nostalgia, al sentimento di una coscienza retrospettiva che sembra accompagnare l’Occidente fin dal principio. In Marx se vi è una virtù nel capitalismo, è quella di essere un movimento che porta alla connessione globale, che esige la comunicazione tra gli uomini, preparatore di quel momento culminante, il rovesciamento violento, che porterà all’avvento della società comunista. Il capitale avrebbe nella sua forza motrice la capacità e la volontà di porre in comunicazione gli essenti. La necessità del capitale è quella di condurre a una moltiplicazione delle 5 J.-L. Nancy, La comunità inoperosa, cit., p. 28.
124
relazioni tra gli individui. Lo sguardo del comunista scorgerà, in un punto ben preciso di questo movimento, il senso reale delle cose come connessione dei rapporti tra le diverse esistenze, scoprendo la verità del valore, il senso del valore come produzione di rapporti tra individui. Il valore (della merce) si misurerà nella connessione, nello scambio tra gli essenti: Di conseguenza la «rivoluzione comunista» non è altro che la presa di coscienza di questa connessione mondiale e la relativa liberazione del valore come valore reale della nostra produzione in comune.6
Per Nancy quella di Marx è una vera e propria onto-teologia rovesciata, una te(le)ologia della materia, nella quale il movimento di rottura chiamato “rivoluzione” è la rivelazione, la presa di coscienza delle relazioni di produzione che coinvolgono gli essenti, di contro alle mistificazioni evocate del capitale e alla distorsione che esso opera del valore, facendone un principio di sfruttamento. La rivoluzione è perciò la liberazione di un valore che deve essere riportato alla sua dimensione reale, alla produzione libera e comunicativa degli essenti. Nonostante in Marx si esalti la teologia dell’homo faber, l’operatore della propria essenza, Nancy vede un elemento “dissonante” nella teoria marxista. Un elemento che sottrarrebbe lo stesso Marx a un prematuro accantonamento della sua proposta filosofica e a una sua lettura unicamente rifacentisi alla scontata dialettica struttura-sovrastruttura, a una visuale esclusivamente schiacciata sui riflessi di una causa da ricercarsi molto banalmente sui rapporti economici7. Se si analizza infatti il concetto di valore in Marx, di valore-in-sé – l’umanità che produce la sua
6 J.-L. Nancy, La creazione del mondo, cit., p. 11. 7 «Marx, insomma, non vuole affatto ribaltare la presunta visione «hegeliana» della storia, passando da una sua determinazione ideale a una determinazione materiale: semplicemente vuole abolire ogni determinazione che
125
libertà attraverso il lavoro – si scopre un nucleo che va al di là di ogni finalità, un senza-ragione esentato da ogni giustificazione: è quello che Nancy rende prossimo alla parola “dignità”, un nucleo verso il quale ogni potenza non si esaurisce nel ciclo produttivo, ma si definisce nell’atto, nell’esposizione attualizzante8. Questa diversa interpretazione di Nancy vuole portare al limite estremo la tesi di Marx circa l’umanità liberata che si compie nella produzione. Questo regno della libertà in cui l’umanità godrebbe finalmente della produzione liberata dallo sfruttamento del capitale, sarebbe, dice Nancy, non un vero fine, non un telos. Il godimento comunista della libera produzione mondiale, per Nancy, sarebbe un eccesso della produzione stessa che espropria, umilia la logica del possesso e dell’appropriazione, in quanto godimento condiviso che scioglie il valore dalle catene di ogni finalità e di ogni ragione: Mentre l’estorsione del plus-valore trae profitto dal valore creato dal lavoro, per riversarlo sul conto dell’accumulazione regolata dall’equivalenza generale […] il godimento invece si profila come l’appropriazione condivisa – o la condivisione appropriante – dell’inaccumulabile e dell’inequivalente, vale a dire del valore stesso (o del senso) nella singolarità della sua creazione.9
La ratio del capitale è diretta alla conversione in merce di ogni prodotto umano secondo il metro di un’equivalenza, un regime del valore, che è inserito, fin da principio, in una logica dello sfruttamento, in una valutazione mistificante della produzione. La rilettura nancyana di Marx, piuttosto che insistere sul rovesciamento dei rapporti, che implicano nient’altro che
prescinda dalla produzione dell’uomo da parte dell’uomo, determinazione che per l’appunto non è determinata da nulla» (ivi, p. 31). 8 Cfr. ivi, pp. 26-27. 9 Ibidem.
126
la replica di segno opposto di una logica della produzione, si insinua in ciò che, della produzione, sfugge alla legge del valore, in ciò che sfugge alla produzione stessa come produzione in vista di un fine, che è appunto il valore stesso privo di ogni ragione fondativa e finale, ciò che non può essere ridotto a merce, ciò che apre alla condivisione: l’essere nella sua singolarità come creazione infinita. Il godimento senza-ragione in Marx apre alla possibilità del Mit-sein.
127
Sovranità senza soggetto
La souveraineté dont je parle a peu de choses à voir avec celle des États, que définit le droit international. Je parle en général d’un aspect opposé, dans la vie humaine, à l’aspect servile ou subordonné. (G. Bataille, La souveraineté)
1 Ex nihilo summum è il titolo di una relazione a una conferenza che Nancy tenne nel 2001 e che appare come breve saggio nel suo volume sulla mondializzazione1. A partire da questa significativa locuzione latina – che consta di un sostantivo neutro che funge da soggetto e di un moto da luogo – Nancy si propone di esplorare non solo ciò che nella cultura occidentale definisce la sovranità, ma pure come lo stesso summum abbia spesso incrociato nozioni come dominio, potere, comunità. Già il termine «sovranità», condotto alla purezza dell’etimo2, rimanda obbligatoriamente alle altitudini, alle vette, al senso di elevazione nei confronti di una spazialità (che auspica sempre una distinzione, una gerarchia), al dominio su un’orizzontalità in cui giacciono «le cose schiacciate l’una contro l’altra, inca1 J.-L. Nancy, Ex nihilo summum (Della sovranità), in Id., La creazione del mondo, cit., pp. 94-113. Come specifica l’autore in una nota, trattasi, nella prima stesura, di un saggio presentato a un convegno svoltosi a Château des Castries nel luglio del 2001 sul tema de La Souveraineté. 2 Ivi, p. 94.
128
stonate nelle loro mutue azioni e reazioni»3; sigilli che, nell’incarnazione della persona del sovrano, rappresentano le figure archetipiche della detenzione e dell’esercizio del Potere. Storicamente il Signore è la figura sovrana dell’epoca feudale, a cui succede, dopo il passaggio all’epoca “borghese” post-medioevale, il Proprietario. Nancy ha qui l’occasione per mostrare una certa prossimità con le posizioni di Hans Blumenberg4: la Modernità rivendica una propria legittimità nel presupposto a-teologico dell’espunzione del concetto di crea tura. Il vincolo che tiene la diade creatura/Creatore, il rapporto di fede, ha in passato plasmato i rapporti di fiducia che reggevano l’esercizio del potere da parte del Signore medioevale: la modalità con cui si articola la relazione di vassallaggio verso un feudatario è il medesimo che vincola la creatura a un Creatore esterno al Mondo. La Figura del Proprietario subentra dunque quando cede il particolare schema medioevale della sovranità, fondato sul rinvio a un Signore come ultimo riferimento (che legittima potestas e auctoritas nel creato, autorità spirituale e potere temporale), l’Onnipotente Creatore e ordinatore del Mondo. Data questa successione delle “forme del superiore” che hanno compendiato intere epoche, la questione della sovranità per Nancy è, comunque, una questione eminentemente moderna. Principalmente perché è proprio della sovranità quella di 3 Ivi, p. 95. 4 Cfr. H. Blumenberg, La legittimità dell’età moderna, tr. it. di C. Marelli, Marietti, Genova 1992. A proposito: «la legittimità dell’età moderna, quale io la intendo, è una categoria storica. Proprio per questo la razionalità dell’epoca è concepita come autoaffermazione e non come autodelega di pieni poteri» (ivi, p. 102). La critica schmittiana alla legittimità dell’epoca moderna, all’abuso che Blumenberg fa del termine “legittimità”, è in C. Schmitt, Teologia politica II. La leggenda della liquidazione di ogni teologia politica, tr. it., a cura di A. Caracciolo, Giuffrè, Milano 1992, pp. 89-103.
129
ruotare esclusivamente nell’orbita di un linguaggio nel quale l’orizzonte del religioso volge al tramonto. L’assunto a-teologico della modernità è il suo terreno di fioritura. Nancy, in questo senso, ricalibra le conclusioni di Carl Schmitt: parlare di “secolarizzazione del teologico” è un’assurdità poiché pretendere una soluzione di continuità tra le sfere del divino e dell’immanente è qualcosa di impossibile; al contrario, l’individuazione della dislocazione della sovranità nei luoghi del monoteismo conduce inevitabilmente allo svelamento del segreto entro cui è racchiuso il concetto medesimo. L’emersione della sovranità nell’epoca moderna, la possibilità della sua esistenza, ha origine dal dinamismo di quel vortice che sgretola gli “edifici religiosi”: il «tutti i concetti più pregnanti della moderna dottrina dello Stato sono concetti teologici secolarizzati»5 dovrebbe leggersi: la mondanizzazione degli attributi sovrani è il risultato dell’azione eversiva dell’ateismo teologico occidentale. L’auto-nomìa, la luce che svela il punto sorgivo dello Stato moderno, accade dunque quando il monoteismo (cristiano) decostruisce al suo interno le venature del religioso (il rinvio a un ordine dato, il diritto divino, il vincolo fondato sul religioso). La teologia atea del cristianesimo depone queste ultime avvisaglie rendendo possibile l’auto-posizione, la sovranità che deve fondare se stessa. Porsi in auto-nomìa significa dunque istituirsi, darsi da sé la propria legge; in questo punto emerge tutta l’ambiguità del soggetto moderno, attore e suddito al medesimo tempo della sua legge, con tutto il carico conflittuale che lo caratterizza intimamente: il rapporto costitutivo con sé, che lo costringe a estenuarsi in una sequenza infinita
5 C. Schmitt, Teologia politica, in Id., Le categorie del ‘politico’, tr. it., a cura di G. Miglio e P. Schiera, il Mulino, Bologna 1972, p. 61. Sui rapporti tra Nancy e Carl Schmitt si veda M.L. Saidel, Dis-chiusura della sovranità teologico-politica in Jean-Luc Nancy. Verso la sovranità del “con”, in U. Perone (a cura di), Intorno a Jean-Luc Nancy, cit., pp. 35-40.
130
nell’ansia febbrile di situarsi intorno a un fondamento stabile, nella pretesa di dare un’identità a qualcosa che, per sua natura, non può che sfuggirgli6. In quel gioco di specchi che è il Politico della modernità, sollecitato dall’interrogativo circa la natura di quella sommità che è la sovranità, Nancy mostra l’evidente dualismo che la contraddistingue: da un lato la sovranità che brilla come superlativo assoluto, dall’altro essa si piega a essere il termine apicale di un sistema di assi ortogonali che si incontrano in un punto. In quest’ultimo caso la sommità «entra in un rapporto per lei essenziale con un fondo, che è sempre un latifondo; un’assise, un piano, un vassoio, una garanzia che costituisce una risorsa e un capitale d’autorità, di legittimità e di potere esecutivo»7. Questa configurazione è, per Nancy, la base su cui si è edificato lo Stato moderno, l’istituzione politica di una figura come il soggetto che tenta di suturare entro confini certi la sua privazione. Ecco, dunque, la necessità di una «circoscrizione che consente l’inscrizione di una sommità»8 regolata attraverso un criterio: quello dell’equivalenza. La sovranità si erge come una scala di misurazione che poggia su un fondo, nel quale riporre il profitto accumulato. Lo Stato moderno interseca l’avventura di un capitalismo senza più l’inibizione (medioevale) riguardo la convertibilità di ogni parte del creato in valutazione terrena, al signore che detiene il potere in grazia di un diritto dato, che riceve in appalto, succede colui che si pone come compito quello di approfittare di uno spazio del quale si è auto proclamato proprietario, «ecco quindi la ragione dell’accoppiamento tra lo stato moderno e il capitale: l’autofinalità che 6 «Il soggetto è prima di tutto sé, cioè l’ansa attraverso la quale un uno porta la propria unicità alla potenza dell’unità […], il soggetto è dell’ordine dell’unità identificante» (J.-L. Nancy, Il senso del mondo, cit., p. 130). 7 J.-L. Nancy, Ex nihilo, cit., p. 105. 8 Ivi, p. 107.
131
si configura come finalità senza fine, o l’autoprincipato che si conferisce da solo l’investitura»9. L’istituzione di un piano per l’accumulazione è l’ideale terreno di contesa per quelle figure hegeliane riunite nella diade signore/servo, ma è proprio all’interno di questa dialettica che Nancy fa emergere la contraddizione di una sovranità sottomessa alla sua stessa sottomissione, al progetto che incarna, al lavoro servile che utilizza per il proprio fine. Può una sovranità essere vincolata? Può essere compresa in un meccanismo servile? Questo smarcamento, il passaggio oltre questa economia, è riassunta dal filosofo francese con un celebre prestito tratto dal pensiero di Bataille (il contenuto, la verità, la lezione ultima della sua “esperienza interiore”10): «la sovranità non è NIENTE»11. La sovranità come superlativo assoluto si erge all’altezza di questo NIENTE poiché sfugge, per sua costituzione, a ogni torsione che la ripieghi a un fondo che ne faccia misura dell’esistente (il “valore”), e dunque vi è sovranità se non fuori da ogni continuum teleologico, che ne segnali i passi e ne assicuri i momenti. Questo salto al di là del circuito della sovranità moderna è possibile nella pienezza delle determinazioni della metafisica del soggetto, nella maturità che segnala il suo disfacimento, snodo epocale sul quale la verve polemica di Nancy nei confronti di Schmitt raggiunge toni abbastanza decisi: l’accusa mossa al pensatore tedesco è quella di non aver saputo declinare la sua definizione di sovranità all’altezza della metafisica che si annunciava12. La «resa della sovranità all’esi
9 Ivi, p. 102. 10 J.-L. Nancy, La comunità inoperosa, cit., p. 49. 11 G. Bataille, La sovranità, tr. it. di L. Gabellone, SE, Milano 2009, p. 23. 12 «Carl Schmitt […] non era in grado di apprezzare la metafisica della nostra epoca, cioè dell’inizio del XXI secolo – almeno se ci arriveremo senza
132
stenza»13 è lo schema stesso della sovranità, non l’estorsione della sua purezza inattingibile da parte di un signore (o di un fondatore) che accampa diritti di proprietà per il suo atto, movimenti del soggetto che desidera costantemente la meta dell’incommensurabile, quanto la pura (e mai convertibile) apertura sovrana all’esistenza, all’esistente-in-atto non definibile. La sovranità è dunque una faglia aperta, costantemente esposta agli agguati mossi dall’ambizione di occultarne l’irriducibilità e di mutarla in un “sacro suolo”, laddove quel “sacro” è un solco che manifesta la volontà di signoreggiare la sovranità e di definirla in un significato. L’epoca della decostruzione della metafisica del soggetto, vede tramontare le figure dell’auto-nomìa, e di conseguenza l’estrema debolezza degli attributi sovrani a cui da tempo va incontro la forma-Stato mostra come superati i presupposti del secolare rapporto col capitalismo, unico attore trionfante nell’epoca della mondializzazione (lo spazio privo di riferimenti esteriori, punto d’arrivo della decostruzione dei retro-mondi).
2 Negli anni che precedono la stesura de La comunità inoperosa, Nancy accetta la sfida-invito di Jacques Derrida per la creazione di un “Centre de recherches philosophique sur la politique” che ha come obiettivo dichiarato quello dell’indagine rigorosa sulla «co-appartenance essentielle (et non accidentelle ou simplement historique) du philosophique et du
ritornare agli “anni ’30” – […] quella che si può chiamare la metafisica della decostruzione dell’essenza, e dell’esistenza in quanto senso» (J.-L. Nancy, Il senso del mondo, cit., p. 116). 13 Ivi, p. 117.
133
politique»14. L’iniziativa non dura lo spazio temporale di un lustro ma ci consegna due pubblicazioni collettanee, nelle quali si nota, oltre la partecipazione, tra gli altri, di esponenti già affermati come Luc Ferry, Jean-François Lyotard, Étienne Balibar, quella del deuteragonista dello stesso Nancy, Philippe Lacoue-Labarthe, coppia che si distinse come il vero motore e la più convinta animatrice del Centro15. Nel passaggio che abbiamo appena riportato (e che campeggia nell’Ouverture come un’insegna, accompagnando alla stregua di un manifesto d’intenti la proposta di questo Centro) è piuttosto esplicita l’ambizione di riportare in superficie quello che Nancy indica come l’elemento originario sul quale poggia l’intero edificio del Politico occidentale: la coppia sapere-potere che segna, nella modalità di una formula, quel connubio che, dai primordi dell’Occidente, lega essenzialmente il filosofico e il politico. Una chiarificazione di questo intreccio epocale apriva le pagine del primo resoconto delle attività del Centro: Cette implication réciproque du philosophique et du politique (le politique n’est pas plus extérieur ou antérieur au philosophique que le philosophique, en général, n’est indépendant du politique), cette implication réciproque ne réfère seulement pour nous, même sur le mode de l’«historialité», à 14 P. Lacoue-Labarthe - J.-L. Nancy, Ouverture, in Iid. (a cura di), Rejouer la politique, Galilée, Paris 1981, p. 14. Cfr. pure A. Esposito, Variazioni sul politico in Jean-Luc Nancy, in U. Perone (a cura di), Intorno a Jean-Luc Nancy, cit., pp. 29-34. 15 I lavori del Centro sono concentrati in due quaderni pubblicati a distanza di un paio d’anni: P. Lacoue-Labarthe - J.-L. Nancy (a cura di), Rejouer la politique, cit., e Iid. (a cura di), Le retrait du politique, Galilée, Paris 1983. I contributi presenti nei due volumi (oltre a Jean-Luc Nancy e Philippe Lacoue-Labarthe) portano la firma di Luc Ferry, Jean-François Lyotard, Étienne Balibar, Denis Kambouchner, Claude Lefort, Jacques Rancière, Philippe Soulez, Jacob Ragozinski.
134 l’origine grecque – soit d’un raccourci, à la polis sophistique et à son répondant, l’anthropos logikos. C’est en réalité notre situation ou notre état […]. L’interrogation sur le politique ou sur l’essence du politique, c’est au contraire ce qui doit pour nous faire retour jusqu’au présupposé politique lui-même de la philosophie (ou si l’on préfère: de la métaphysique), c’est à dire jusqu’à une détermination politique de l’essence. Mais cette détermination ne fait pas une position politique; c’est la position même du politique, de la polis grecque à ce qui s’est déployé dans l’âge moderne comme la qualification du politique par le sujet (et du sujet par le politique).16
Sin dalle sue origini la filosofia, come pensiero dell’Occidente, coltiverebbe un’ambizione politica. Il lascito più significativo del “Politico” greco, il punto di riferimento della successiva storia politica occidentale, la polis, luogo d’esposizione dell’essere-in-comune senza un’origine comune (espressione urbana che si lascia alle spalle le rovine della civiltà palaziale micenea), sin dagli inizi sarebbe caratterizzata da uno spasmo, da una contrazione che da spazio di “esposizione del comune” muterebbe a teatro di scontro delle diverse idee per il governo. Come se l’assenza di fondamento, di un’origine comune fosse un continuo stimolo per un logos politico interessato a comporre (e a imporre) condizioni e motivazioni di questa unione di esseri finiti che è la città. La città, la polis, l’esposizione della spaziatura, sarebbe da sempre alla mercé dell’irrequietezza di un logos incapace di rassegnarsi a una comunità come apertura, come esposizione della presenza dell’esser-finito. Questa tendenza alla chiusura sarebbe il presupposto che animerebbe ogni impresa della storia politica occidentale. L’esposizione dell’essere-comune solleticherebbe l’appetito di una theoria per definizione orientata al predominio cittadino. 16 P. Lacoue-Labarthe - J.-L. Nancy, Ouverture, cit., pp. 14-15.
135
A ciò non sarebbe estranea una delle definizioni più storicamente rilevanti del “Politico” della civiltà occidentale, l’aristotelico zoon politikon, che sarebbe niente di più che l’espressione sicuramente più felice di una “metafisica del politico”: un’individualità politica che ha come obiettivo la realizzazione della sua supposta essenza, verso la quale, per compiersi, deve soddisfare i propri bisogni, interessi, diritti. La città perderebbe così lo status di comunità disgiunta, priva di ogni legame dato come esposizione degli esseri finiti senza un’origine che li comprenda e li definisca, diventando lo spazio pubblico di proiezione di un logos politikos in grado di dettare e giustificare le condizioni per edificare la sua circoscrizione. L’interesse di Nancy è rivolto a individuare un elemento che possa insidiare quel sistema che, segnato dalla coppia saperepotere, definisce ab origine l’intreccio epocale che lega il filosofico al politico. La traccia che invita alla presa decostruttiva è un punto-limite che attraversa discretamente e sottotraccia la civiltà occidentale: «dans le Politique de Platon, par exemple, dans le Souverain de Hobbes ou dans celui de Rousseau, et qu’il reconduit ses problèmes dans la “souveraineté” de Bataille»17, Nancy la ritrova proprio negli anfratti di un pensiero, come quello hegeliano, che rappresenta l’apogeo del soggetto teorico. La ricognizione che Nancy compie di alcuni testi di Hegel (in particolare i Lineamenti di filosofia del diritto e l’Enciclopedia) lo porta a individuare «le lieu d’une singulière complication dans le théorie hégélienne elle-même»18. Questa complicazione non deve essere vista come una sfilacciatura all’interno delle maglie del pensiero hegeliano, una crepa all’interno di un
17 J.-L. Nancy, La juridiction du monarque hégélien, in P. Lacoue-Labarthe J.-L. Nancy (a cura di), Rejouer la politique, cit., p. 52. 18 Ivi, p. 55.
136
sistema, che darebbe ragione e conferma a tutte quelle interpretazioni di un Hegel teorico dello Stato totale, della totalità sociale come organismo (per il filosofo francese ciò sarebbe la rappresentazione di un Hegel distorto, frutto di una lettura piuttosto superficiale), al contrario segnalerebbe l’esistenza di un punto-limite, un’ombra carica di straordinarie precauzioni, che seguirebbe costantemente l’elaborazione del Politico nel pensiero occidentale. Nancy è attirato dalla nozione di “unione come tale” («die Vereingung als solche»), ovvero la verità soggettiva dello Stato come compimento della relazione. Ma questa soggettività come compimento della relazione tra i membri dello Stato è qualcosa che trascende l‘organizzazione come somma dei membri stessi. È un eccesso che eccede lo Stato, sia come organismo tecnico regolatore degli interessi dei singoli, lo Stato-Tecnica conforme ai desiderata della società civile, sia allo stesso Stato-Soggetto come organizzazione sociale ispirato dalla Totale Sittlichkeit, in cui le relazioni sono sostanziate eticamente. Per Nancy queste due configurazioni sono due facce della stessa medaglia, in quanto ad ambedue sfuggirebbe lo specifico del politico, l’eccesso19. Se l‘unione come tale, la verità soggettiva dello Stato come compimento della relazione, è qualcosa che eccede l‘organismo statale, di che natura sarebbe questo eccesso come tratto “esorbitante” della teoria hegeliana? Cette complication est elle de la théorie du monarque. Et elle l’est, tout d’abord, pour une raison formellement aussi simple, qu’apodictique: si l’État est la vérité, la vérité de cette vérité est le monarque.20
19 J.-L. Nancy, La sovranità persona, in V. Conti (a cura di), Sapere e potere, Atti del Convegno internazionale di Genova, 27-30 novembre 1980, Multhipla, Milano 1984, vol. I, p. 31. 20 J.-L. Nancy, La juridiction du monarque hégélien, cit., p. 55.
137
Che per “verità dello Stato” si intenda il monarca può ovviamente generare una miriade di equivoci, a partire dalla nutrita schiera di interpreti di Hegel, i quali hanno intravisto nella figura del monarca le prove di una sua vicinanza a un controverso decisionismo monarchico. Abbaglio al quale, Nancy lo rileva, è andato incontro il Marx della Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico21. Se così fosse, il monarca potrebbe rivendicare il suo ruolo in virtù di un dato, di un fondamento (il “diritto divino” o il “diritto del più forte”), e la comunità, lo Stato sarebbe il luogo di disposizione dell’esercizio di un dominio. Più che di lettura distorta di Hegel, si tratterebbe di un totale fraintendimento della sua filosofia. Per Nancv, infatti, il monarca hegeliano è “l’unione come tale” e dunque il compimento della relazione, l’eccedente che trascende la relazione stessa, l’esposto della comunità. Ma Nancy è consapevole che questo trascendimento, questa immediatezza del monarca, questa certezza sensibile della relazione, rischia da subito il coinvolgimento in quel processo che nella filosofia hegeliana è la “lotta per il riconoscimento”, che per primo pone la questione del rapporto.
21 J.-L. Nancy, La sovranità persona, cit., p. 27. All’individualità hegeliana dello Stato raffigurata nel monarca, Marx dedica molte pagine della sua Critica. Il capovolgimento operato dal filosofo di Treviri può essere così sintetizzato: «La sovranità esiste soltanto come autodeterminazione astratta, perché senza fondamento, della volontà, nella quale autodeterminazione si trova l’estremo della decisione. È questa l’individualità dello Stato in quanto tale, che, esso medesimo, soltanto in ciò è uno (e nella costituzione sviluppata a razionalità reale ciascuno dei tre momenti del concetto ha il suo per sé reale separato aspetto). Perciò questo momento assolutamente decisivo della totalità non è l’individualità in generale, ma un individuo, il monarca» (K. Marx, Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico, in Id., Opere filosofiche giovanili, tr. it. di G. Galvano della Volpe, Editori Riuniti, Roma 1977, p. 34).
138
Nancy lavora sui passi di alcuni testi hegeliani, nei quali la questione sarebbe stata affrontata dal filosofo tedesco con estrema prudenza: Nous serions donc fondés à chercher, au lieu même du rapport non encore stabilisé dans la domination e le besoin, c’està-dire au lieu de la lutte même, le principe de l’État.22
Nella lotta per il riconoscimento, quando affiora per la prima volta la questione della comunità, del comune tra autocoscienze, l’incontro tra esseri finiti è già da subito viziato, secondo Nancy, dal bisogno e dalla cura dell’appagamento del desiderio che anima la coscienza. In questo rapporto, dunque, non matura la co-presenza tra esseri liberi, bensì la risoluzione di questo incontro è nelle prospettive di soddisfacimento della soggettività. La tenace insistenza di Nancy su questo punto, accompagnato da alcune incursioni in particolar modo del § 433 dell’Enciclopedia, ha come scopo quello di chiarire che lo stesso Hegel concede alla “lotta per il riconoscimento” soltanto un aspetto esteriore, “fenomenico”, non sostanziale. Il principio sostanziale dello Stato non può declinarsi come “lotta per il riconoscimento”: questa lotta è la manifestazione che certifica il passaggio all’autocoscienza come atto di fondazione di uno Stato. Una lotta anche di puro prestigio, che esibisce il lato desiderante della singolarità non può essere un principio sostanziale, bensì un fenomeno di questo principio. Questo “eccesso di prudenza” di Hegel è rilevata da Nancy quando quest’ultimo si spinge a pensare che la “lotta per il riconoscimento” intercetta una domanda essenziale: quella della relazione che precede il suo assorbimento nella dialettica. La relazione, l’esser-comune è un orizzonte già da sempre presente, che precede la lotta quale incontro tra gli essenti: «Il
22 J.-L. Nancy, La juridiction du monarque hégélien, cit., p. 66.
139
problema del rapporto – o dell’essere – uno sui generis della socialità – vi è risolto anticipatamente»23. Ma in Nancy questa ontologia della relazione è incessantemente sotto la pressione di una curvatura metafisica che tende a condurla sull’orlo di un precipizio: la comunità già da sempre accaduta è, per il filosofo francese, nella versione occidentale, da sempre esposta al rischio delle insidie della “metafisica del politico”. Negli edifici politici della civiltà dell’onto-teo-logia, il “monarca hegeliano” è una figura sfuggente, che eccede i suoi istituti. Non è un “funzionario” al servizio dello Stato, seppur di grado superiore, e in quanto non assegnabile ad alcun istituto di rappresentanza, non permette alcun rinvio a qualcosa che ha a che fare con una raffigurazione puramente astratta, qualcosa che ha a che fare col simbolico. Quell’unione come tale che è il “monarca”, sfugge alle definizioni della “metafisica del politico”, poiché è con lui che si assiste a un trapasso: «Le monarque effectue donc l’Umschlagen de l’État dans l’existence, la conversion de l’union comme telle dans l’unité d’une personne réelle»24. Il “monarca” non è un astratto, è un qualcosa di reale, esistente, intuizione della comunità; una presenza concreta che non viene catturata dai concetti e dai significati che precipitano nelle geometrie dello zoon politikon: esso non ha ruolo alcuno, che il luogo del suo eventuale esercizio sia la società civile o la variante protesica del Leviathan hobbesiano. In questo senso il monarca non è un soggetto e non si piega alla sua legge. Se il monarca fosse un essere coinvolto in questa lotta sarebbe nient’altro che la cima di un organismo comunque ordinato gerarchicamente, soffocato nelle spire di una propensione dialettica, in competizione con la coscienza ser23 J.-L. Nancy, La sovranità persona, cit., p. 32. 24 J.-L. Nancy, La juridiction du monarque hégélien, cit., p. 60.
140
vile, ricompreso pertanto nella totalità delle relazioni tra i vari individui dello Stato. Esso è “presenza” non estorta in identità, non convertita in soggetto e in quanto “intuizione della comunità” in perenne sottrazione alle rappresentazioni della totalità organica dello Stato. Il monarca espone la comunità, è l’esistenza concreta della comunità. È quell’assoluto del popolo come persona esistente che non partecipa allo Stato, non è parte dello Stato, ma paradossalmente ne è il compimento come unità, in una modalità differente dalla somma, seppur organizzata in modo gerarchico, degli individui: est donc ainsi le tout de l’État […], un homme en plus. Qui ne pas nombre avec les autres individus, mais qui fait, au contraire exister leur union comme unité. Le monarque est l’accomplissement du rapport.25
Il monarca che espone la comunità ma si sottrae all’esercizio delle sue funzioni è la cifra che riassume quel “senso ontologico del politico” che colloca il “monarca” al di là dell’incrocio fatale tra il filosofico e il politico, ovvero di un sapere che si “vuole” totalmente potente. Il non essere sotto il giogo delle ambizioni del teorico fanno del monarca non soltanto un “impotente” quanto lo rendono indifferente alla seduzione del sapere. Quando Nancy pone la domanda: «che cosa devono sapere coloro che devono regnare?»26, lo stesso filosofo francese poche righe prima, anticipava la risposta: «il sapere implica contemporaneamente la padronanza dell’oggetto e quella del suo stesso processo»27. Tutta la storia dei filosofi-re, della filosofia politica occidentale, nasconde la lunga ombra di un de-
25 Ivi, p. 58. 26 J.-L. Nancy, La sovranità persona, cit., p. 30. 27 Ivi, pp. 29-30.
141
siderio di asservimento alla volontà di conoscenza. Il monarca non è figura del Sapere: non è una competenza, né una potenza […], firma per il popolo […], è un’esistenza e una prestazione. È una persona insomma, non è un nessuno, colui che firma con il suo nome è l’anonimo di un’esistenza naturale.28
Cosa firma il monarca? Quale decisione per il monarca? Il monarca «firma» il popolo che espone, non facendo ombra con la sua mano e non facendo ombra nell’atto del suo ritiro. Questa esposizione e il suo simultaneo ritiro preservano il monarca dal fascino di uno sguardo “puntato” verso la comunità. Lo sporgersi in avanti è la vertigine di una sovranità che rischia di mutarsi in signoria e, conseguentemente di costringere la comunità in una comunità d’essenza, in una comunione. Il monarca, dunque, deve essere separato dal suo esercizio poiché qualora superasse questa inibizione sarebbe l’ipostasi di una figura, di un significato. Ecco perché l’atto politico che istituisce il diritto, la giuris-dizione, è un enunciato che non fa tema, è tanto poco un’operazione che un voler-dire senza oggetto. Il «senso ontologico del politico» preserva l’esser-comune dalla caduta in un significato metafisico, custodisce la comunità, come con-divisione di un qualcosa che esorbita, che è inequivalente a tutte le definizioni di una totalità immanente compiuta. La traccia di questo eccesso irriducibile è il monarca.
28 Ivi, pp. 36-37.
143
Democrazia inoperosa
Dort, wo der Staat aufhört – so seht mir doch hin, meine Brüder! (F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra)
Lo schema della sovranità in Nancy, la salvaguardia del NIENTE che apre alla comunità (lo statuto della quale passa sempre, è bene non scordarlo, per la riforma dell’ontologia operata nei confronti di Heidegger), raccoglie la sfida del capitalismo espiantatore principe della sovranità moderna, ormai teso a filtrare tutto l’esistente attraverso la legge dell’equivalenza, attraverso il recupero della memoria di una nozione impigliata, negli ultimi tempi, da una rete di equivoci: democrazia. È questo l’ultimo Nancy: il pensatore che aveva assistito al crollo dell’ultima manifestazione di una volontà perennemente dispiegata nel circoscrivere l’essere in un senso compiuto e che assiste al trionfo globale del capitalismo. Democrazia non sarà allora il nome, passato a lucido, di un nuovo regime politico o il ripristino di ciò che rimane di una concezione della sovranità ormai frantumata. È il passaggio della politica all’inoperosità, il luogo in cui non è più ammissibile l’ambizione di “una visione” che vorrebbe ricondurre lo spazio della comunità al proprium, all’interesse privato; è la riconversione del paradigma dell’equivalenza che mira alla preservazione dell’incalcolabile, del senza-valore, alla possibilità di un senso non misurato in anticipo; è la memoria storica
144
della particella anarchica del demos, il cui potere sarà sempre quello di insidiare, di opporsi, di mettere in scacco la volontà di dominio di un Principio, così da farsi carico, per tutti e per ciascuno, dell’apertura infinita1. Nancy è consapevole che la democrazia è espressione del medesimo contesto dal quale anche il capitalismo ha avuto origine2. Democrazia e capitalismo dunque si toccano, si affrontano, spesso si confondono, si contrastano nella “spaziatura cittadina” fin dagli inizi. Parlare del capitalismo come di un qualcosa di connaturato all’Occidente delle origini, è un discorso appropriato, pienamente sottoscrivibile anche nei riguardi della democrazia. La sua co-appartenenza all’origine occidentale la obbliga a condividerne interamente il destino (e gli eventi). Nel 2008 Nancy diede alle stampe un agile volumetto, una sorta di pamphlet, dal titolo Verità della democrazia. Dal titolo sembrerebbe il tentativo di fissare un’identità al termine democrazia, un’esposizione circostanziata sul tema, una digressione storica, quanto può contenere lo spazio di un pamphlet. Ma l’occasione che portò alla scrittura di questo piccolo volume è di tutt’altro tenore. Un ricordo, contornato dalla scadenza (i 40 anni del ’68) di un avvenimento, che nella scrittura di Nancy affiora con particolare evidenza come non-concluso. Un accadimento storico, un punto della Storia, che ancora contiene la possibilità di “fare evento”. Un’interrogazione sulla verità della democrazia: 68 non è stato né una rivoluzione, né un movimento di riforme (benché ne siano derivate tutta una serie), né una contestazione, né una ribellione, né una rivolta, né una insurrezione,
1 J.-L. Nancy, Verità della democrazia, tr. it. di R. Borghesi e A. Moscati, Cronopio, Napoli 2009, p. 64. 2 Ivi, p. 47.
145 benché sia possibile rintracciare in esso i tratti di tutte queste posture, postulazioni e ambizioni e attese. La caratteristica più propria e singolare del 68, che gli ha conferito quasi naturalmente il diritto di portare a guisa di patronimico il suo monogramma calendariale – come prima di lui 89, 48 o 17 – può essere individuata solo abbandonando, almeno parzialmente o relativamente, tutte queste categorie.3
Il primo obiettivo di Nancy è, dunque, quello di contestare la facile lettura che del ’68 si è data e che è diventata senso comune, ciò che nella narrazione dei fatti propagandati dall’informazione è ormai un dato massimamente condiviso. La verità del ’68, l’apertura successiva all’emergere della contraffazione messa in atto dallo pseudo-’68, la si può raggiungere soltanto con l’abbandono delle devianti categorie universalmente accettate. Per Nancy le definizioni di comodo, giornalistiche, pretestuosamente ridicole, occultano ciò che è stato realmente il ’68: un “tempo di pensiero” nel quale è stato possibile, per alcuni attimi, intravedere un avvenire e comprendere la fine di un’epoca. La frammentazione di questa “visione” ha segnato molti degli aspetti relativi al ’68 come contraddittori. Innanzitutto, con ciò che lo precedeva, con l’anelito democratico successivo dalla fine della Seconda guerra mondiale, che aveva creato le condizioni di possibilità del ’68. Se, infatti, le forme del tempo in cui si sarebbe articolato questo pensiero erano quelle relative all’esaurimento di un pensiero della Storia, alla fine dell’epoca delle immagini del mondo, il movimento democratico che precedette il ’68 non lo capì affatto, preferendo porre come problema principale quello di pensare ancora un soggetto della Storia, una nuova politica pianificata. Il problema della distorsione della democrazia non fu preso in considerazione. Di fronte a una critica di stampo totalitaristico, il problema “democratico” non poteva che rimanere relegato a 3 Ivi, p. 11.
146
residuo di un mondo al tramonto, sopportato tutt’al più come male minore, in fondo caratterizzante una fase transitoria di fronte all’inarrestabile avanzata del sol dell’avvenire. Ciò che cercava l’Europa post-bellica (un nuovo soggetto storico, una nuova organizzazione, un nuovo progetto) era dunque in contrasto con ciò che annunciava la nuova epoca, la fine de “l’epo ca delle immagini del mondo”. Da questa frattura col passato più prossimo, scarsamente presa in considerazione, secondo Nancy sorse un equivoco. Il pensiero della democrazia del ’68 più che di continuità col movimento democratico dei decenni precedenti, si fondava sul sentimento di disillusione per quel ritorno alla democrazia avvenuto più di vent’anni prima, il quale veniva accusato di aver tradito le premesse e le promesse e del quale si sanciva il fallimento degli obiettivi che si era preposto dalla fine del secondo conflitto mondiale. Il tentativo di ovviare a questo fallimento, si concentrò nel porre alla ribalta i focolai delle lotte di liberazione dei popoli oppressi dal colonialismo. Alla dimensione “borghese” che aveva assunto la democrazia, si rispose con il modello umanistico di emancipazione, nella sua versione di “decolonizzazione”. L’appoggio che questi movimenti ricevettero da quella che un tempo si usava definire come “la guida del movimento operaio internazionale” fu la conferma, per Nancy, che dietro la nozione di democrazia aleggiava ancora un soggetto storico che si era attribuito il compito di faro del comunismo internazionale: In vari modi, i Consigli o le Autogestioni, le Democrazie dirette o le Rivoluzioni permanenti, occupavano un orizzonte che restava quello della possibilità di un’azione organizzata, ossia organica, e di una pianificazione o di una prospettiva il cui schema formale si era introdotto perfino nella concezione dello Stato.4
4 Ivi, p. 14.
147
I piani quinquennali o le visioni totalizzanti delle dittature popolari sono la testimonianza di come la risposta comunista al totalitarismo dell’orrore del nazionalsocialismo – che il ripristino della democrazia nel dopoguerra pensava aver posto a tacere per sempre – finì per realizzare un vero e proprio cortocircuito del pensiero, alle cui spalle ricomparivano prepotentemente, accompagnate da una loro tenace riproposizione, le “immagini del mondo”. La stessa democrazia finiva sotto i colpi di una “visione del mondo” che la rifiutava come frutto immaturo della dinamica di emancipazione e liberazione dell’umanità, un residuo “borghese”, totalmente superato dall’ascesa del movimento operaio. Questo presunto “tradimento” della democrazia è una formula che nasce in relazione a una sua totale identificazione con la democrazia liberale borghese e quindi a un suo appiattimento verso le forme di produzione tipiche del capitalismo. Una critica a senso unico quest’ultima che, per Nancy, fu la spia di una mancata riflessione sull’inadeguatezza della democrazia nei confronti della sua stessa idea, che già nella prima metà del Novecento, tra le due guerre, aveva prodotto l’opzione totalitaria. Un’inadeguatezza che nascondeva quello che uno dei nodi centrali dell’argomentazione di Nancy, l’incomunicabilità, la sospettosità, l’estrema divaricazione in quegli anni tra l’esigenza comunista e la nozione di democrazia: abbiamo visto la democrazia attaccata, ma non abbiamo visto che essa stessa si era esposta agli attacchi e chiedeva di essere reinventata, e non solo difesa così com’era. 68 è stato il primo insorgere dell’esigenza di una tale invenzione.5
Alle molteplici indicazioni equivoche che si sono susseguite a partire dal secondo dopoguerra, il ’68 auspicava una reinvenzione della democrazia. Piuttosto che un rinnovato soggetto 5 Ivi, p. 18.
148
della concezione, ormai avviatosi verso il maelstrom del nichilismo, il ’68 poneva l’esigenza di un suo superamento, di una “trasvalutazione dei valori” in senso nietzschiano. Reinventare la democrazia alla luce dell’esaurimento del pensiero della Storia era un riferimento, consapevole o meno, a quell’uscita dal nichilismo così come l’aveva concepita Nietzsche. Una nuova tavola di valori come approdo dal distacco del paradigma della visione e da una teoria “totalizzante” che ancora prefigurava e progettava orizzonti. A quest’esigenza il ’68 rispose, in modo piuttosto confuso e frammentario, ma allo stesso tempo con tratti originali per quel tempo, con tutta una serie di condotte, comportamenti, atteggiamenti, corpi di pensiero. Quella che per Nancy fu una caotica esplosione d’immaginazione non priva di fascino fa da sfondo a una meditata sezione della sua opera più conosciuta, La comunità inoperosa, in quel capitolo emblematicamente intitolato Il comunismo letterario. Come abbiamo accennato in precedenza, questo titolo provocatorio, non è un omaggio né al comunismo come forma politica realizzata né al sistema letterario generale; piuttosto è l’aver luogo di una comunità articolata nella forma di un’opera esposta, opera aperta, che non si esaurisce in se stessa, non è conclusa ma offerta, nella sua costante esposizione, alla comunicazione infinita: L’inoperosità è offerta, infatti, dove la scrittura non porta a termine una figura o una figurazione, e quindi non ne propone o non ne impone il contenuto o il messaggio esemplare (il che vuol dire immediatamente leggendario: mitico).6
Per Nancy, il contenuto di questo passaggio, nel ’68, ha mostrato una certa vitalità in situazioni piuttosto marginali, caratteri-
6 J.-L. Nancy, La comunità inoperosa, cit., p. 160.
149
stiche di chi rifiutava una visione della politica come messa in opera. Movimenti che hanno cercato di immaginare il politico entro forme artistiche, secondo modalità e canali che, però, sono estranei a tutto ciò che usiamo definire come “politicizzazione dell’arte”, dimostrazione palese di subordinazione, di fiancheggiamento dell’opera nei confronti dell’operazione politica (che ha mostrato spesso la rapace volontà di appropriazione da parte delle organizzazioni sia partitiche che sindacali), quanto al contributo dell’arte come apertura di politiche di condivisione: La scena del letterario e, quindi, siamo legittimati a dire, la scena dell’opera d’arte, gli appare come evento di interruzione, di sospensione del mito o del logos. […] Nel letterario quindi avremmo a che fare con una sospensione, con un venir meno […] in una ritrazione senza traccia, apre una comunità che non si conclude né in una comunione e neppure in una semplice indifferenza numerica. Nancy arriva persino a sostenere che la scena del letterario mostrerebbe in un modo speciale l’inoperatività o la non operatività della messa in opera in cui una comunità potrebbe sottrarsi a quell’umanesimo in cui i comunismi del Novecento avrebbero preteso di produrre essenzialmente la propria essenza.7
Proprio il tentativo di sussumere ogni esistenza alla pratica politica, computarne le possibilità intorno a un progetto, concludere quell’inoperosità che assicurava il letterario, avverte Nancy, è l’errore che ha condizionato il ’68 nel fare proprio lo slogan “tutto è politico”. Non si trattava di preservare un aspetto privatistico (ridicolizzato come borghese) di contro a un aspetto comunistico-comunitario che, come istanza alternativa alla privatizzazione borghese, avrebbe dovuto impregnare tutte le sfere dell’esistenza. Il “tutto è politica”:
7 C. Meazza, La comunità s-velata, cit., pp. 19-20. Si veda pure il recente volume di M. Villani, Arte della fuga. Estetica e democrazia nel pensiero di Jean-Luc Nancy, Mimesis, Milano-Udine 2020.
150 contro ogni apparenza, è una massima perfettamente neoteologica.8
Proprio da uno degli slogan più in voga del ’68, viene a galla dunque uno degli aspetti più distintivi della democrazia rispetto alle configurazioni reali socialiste e comuniste. Se per queste ultime la politica doveva circonfondere ogni momento del quotidiano, per Nancy, in tutto ciò è già in attività una volontà di veicolare l’esistente – l’essere-in-comune – in un’identità, di segnarlo secondo una ipostasi, una figura totalitaria. Proprio in questa prevenzione dall’ipostatizzazione avanzata da Nancy è possibile «tracciare il contorno democratico della politica»9. Distinguere la politica10. Far emergere il suo specifico perimetro aiuterebbe a comprendere la natura del potere politico, la sua specificità, dal riduzionismo antagonista che tenta costantemente di esorcizzare il potere (e, di conseguenza, il politico tout court) identificandolo nel puro dominio11; lasciare alla politica la possibilità di distinguere di fronte all’indistinto che propugna il capitalismo secondo i canoni della legge dell’equivalenza: Ciò che ha determinato la critica nietzschiana dei “valori” e la nota debolezza della “filosofia dei valori” è stato il fatto di pensare i valori come riferimenti dati – ideali o normativi – sulla base di un’equivalenza degli stessi gesti di valutazione. Il valore, invece, consiste innanzitutto nella distinzione del gesto che lo valuta, lo distingue e lo crea. Abbiamo bisogno di questo apparente ossimoro: una democrazia nietzschiana.12
8 J.-L. Nancy, Verità della democrazia, cit., p. 43. 9 Ivi, p. 44. 10 Ibidem. 11 Ivi, pp. 44-45. 12 Ivi, p. 45.
151
La democrazia non è un regime su cui innestare una soggettività portatrice di una causa in vista di un obiettivo – poiché degraderebbe il senso democratico, consegnandolo nelle mani di un individuo interessato a sacrificarla in nome di una visione totalizzante –, così come la democrazia non è lo spazio omogeneo entro il quale possono convivere istanze variamente conflittuali, poiché la garanzia della loro vitalità sarebbe sempre subordinata al paradigma neutralizzante portato avanti dalla legge dell’equivalenza generale del capitale. La democrazia, per Nancy, non è un regime della “concezione” e non è un contenitore vuoto. La “democrazia nietzschiana” di Nancy pretende una nuova tavola di valori, non portatrice di dati immutabili e misure perenni, che deve passare obbligatoriamente per «una trasformazione del paradigma dell’equivalenza»13; tutto ciò affinché sia possibile l’emersione di un senso della valutazione incompatibile con un sistema scalare di misure determinate, che affermi, al contrario, la sua “incomparabilità” infinitamente incommensurabile alla legge dell’equivalenza capitalistica: «un senso della valutazione, dell’affermazione valutativa che offra a ciascun gesto di valutazione – decisione d’esistenza, d’opera, di contegno – la possibilità di non essere già misurato in anticipo da un sistema dato»14. La “democrazia nietzschiana” di Nancy «rinuncia a darsi una configurazione: rende possibile una proliferazione di figure affermate, inventate, create, immaginate e così via»15, non essendo più il terreno di conflitto fra pretendenti al potere, ma la possibilità di ognuno di identificarsi, sapendosi come parte, partizione di un essere-comune e non di un’unità che vorreb-
13 Ivi, p. 49. 14 Ibidem. 15 Ivi, p. 54.
152
be risucchiarli e sottomettere alla verità risurrezionale di un essere-Tutto. La liberazione della democrazia da ogni possibilità di identificarla con un regime particolare, rifiuto di un assoggettamento pre-ordinato ai termini e ai luoghi del potere indistinto, è, per Nancy, un andare al di là della forma in cui la democrazia può incarnarsi, assumerne lo spirito, il soffio desiderante che supera ogni forma di declinazione formale. Contro l’umanesimo che definisce un idealtipo che rivendica come assoluto, la democrazia è il soffio dell’uomo che supera infinitamente l’uomo. È questa, per Nancy, l’esigenza comunista che possiamo trovare in Marx: l’uomo che attraverso il lavoro, produce incessantemente la sua libertà e proprio così oltrepassa la sua definizione di uomo in senso valoriale e valutativo. Lo spirito della democrazia è, dunque, un assoluto in atto che sfugge a ogni tentativo di reificazione, di identificazione. L’assunzione di questo spirito, per Nancy, l’inebriarsi dello spirito dell’inequivalenza intriso dell’esigenza comunista, come anelito all’essere-in-comune, è possibile solo a patto che non si precipiti nel tentativo di incarnarlo in un soggetto (stato, partito, istituzione), ma pensandolo come quella “forza” che apre ai possibili16. L’opera dello spirito deve resistere alla tentazione di farsi compimento. Lo spirito è incalcolabile, sfugge alla misurazione, non è scambiabile. È qualcosa verso cui la politica deve ispirarsi, ma non assumersi il compito di realizzarla, poiché, quando ciò avviene essa si è già perduta nella pratica totalizzante che la Modernità ha sovente esaltato come principio del politico. Nel Medioevo, infatti, era ancora possibile una disgiunzione: allo spazio politico era adiacente uno spazio divino che la po-
16 Ivi, p. 54.
153
litica non poteva sussumere: e così l’Islam e le religioni civili greche che non si confondevano con le iniziazioni salvifiche17. La politica non deve concludere l’essere-comune né chiudere le esistenze entro un significato definitivo. Essa deve impregnarsi di quell’inoperosità – del più-che-opera – in cui un’opera non si chiude in un processo di auto-asfissia, ma procede per una speciale confidenza col senza-valore, l’eccedente che non può essere valutato, il mistero della creazione degli esseri singolari rimessa all’essere comune. Compito della politica, della sua esistenza come custode dell’Aperto (la possibilità dell’impossibile, la creazione di un mondo dal nulla, ovvero «senza preamboli e senza modelli, senza principio e senza fine. Perché è questa la giustizia ed è questo il senso di un mondo»18) sarà, per Nancy, salvaguardare quell’incalcolabile che la immunizza dalla tentazione totalitaria.
17 Ivi, pp. 36-37. 18 J.-L. Nancy, La creazione del mondo, cit., p. 41.
Indice
I Mito La destituzione del senso dato L’appello al mito
p. 11 p. 41
II Sacrificio Comunità dell’immanenza, comunità del sacrificio Sacrificio antico e moderno
p. 77 p. 83
III Comunità Immagini di città L’esigenza comunista Sovranità senza soggetto Democrazia inoperosa
p. 105 p. 119 p. 127 p. 143
Passages
Collana di Storia della Filosofia Diretta da: Umberto CURI e Carmelo MEAZZA
1. Lucrezia Ercoli, Filosofia dell’umorismo. 2. Marco Fortunato, Decisione – Indecisione. 3. Andrea Panzavolta, Caro Herr Mozart, cari compositori. 4. Elio Matassi, Appunti sul presente. 5. Chiara Pasqualin, Il fondamento “patico” dell’ermeneutico. 6. Alexander Schnell, Husserl e i fondamenti della fenomenologia costruttiva. 7. Nicola Comerci, Vedere «da cento occhi». Nietzsche e la relazione. 8. Laura Sanò, Metamorfosi del potere. Percorsi e incroci tra Arend e Kafka. 9. Enrique Dussel, Le metafore teologiche di Marx. 10. Pierre Gisel, Cos’è una tradizione? Ciò di cui risponde, il suo uso, la sua pertinenza. 11. Andrea Panzavolta, La promessa delle sirene. Filosofia dell’opera lirica.
12. Antonio Lucci, La stella ascetica. Soggettivazione e ascesi in Friedrich Nietzsche. 13. Giuseppe Pintus, La monade spirituale. Studio su Luigi Stefanini. 14. Gian Paolo Faella Wittgenstein, maestro o dilettante. Esercizi critico-speculativi su un caso di controversa popolarità filosofica. 15. Marco Mantovani, Einverleibung e «organismo sociale». Modelli e metafore della relazione individuo, Stato e società in Nietzsche. 16. Angelo Cicatello, Ragione umana e forma del mondo. Saggi su Kant. 17. Jérôme Lèbre, Velocità. 18. Antonello Nasone, Il problema Occidente. Mito, sacrificio, comunità nel pensiero di Jean-Luc Nancy.
Passages | 18 Mito, sacrificio, comunità, sono termini che hanno costantemente inquietato il pensiero di Jean-Luc Nancy lungo tutto il suo itinerario filosofico. In questo volume si è cercato, grazie anche allo studio di scritti del filosofo francese tuttora inediti in lingua italiana, di riportare alla luce ascendenze, consonanze e riferimenti che fossero in grado di contribuire a dare una visione più ampia del percorso intellettuale di uno dei maggiori filosofi degli ultimi 40 anni. Dall’indagine sulla “nuova mitologia” dei romantici di Jena ai tentativi di tracciare i lineamenti di un’insolita “democrazia nietzschiana”, dal “mito nazi” al “nuovo sacrificio”, dagli esordi con Lacoue-Labarthe fino alle ultime prove prima della scomparsa, il pensiero di Nancy non accenna ad attenuare quella tensione, quella profondità di visione verso tematiche di carattere politico che, ancora oggi, è possibile trovare nei suoi scritti.
Dottore di ricerca in Filosofia, attualmente è docente a contratto di Filosofia Politica presso il Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università di Sassari e di Filosofia e Fenomenologia della Religione all’ISSR di Sassari della Facoltà Teologica della Sardegna. I suoi principali interessi di ricerca sono la teologia politica, la nozione di sovranità, la genesi dello Stato moderno, il federalismo. Ha pubblicato diversi saggi per le riviste “Quaderni di Inschibboleth”, “Metábasis” e “Heliopolis”. Per i tipi di Inschibboleth è stato tra i curatori del volume collettaneo Filosofia dell’avvenire. L’evento e il messianico (2017).
€ 9,00
ISBN ebook 9788855294140

![Il problema dell'esposizione speculativa nel pensiero di Hegel [Zeugma. Lineamenti di filosofia italiana ed.]
9788855290876, 9788855290883](https://ebin.pub/img/200x200/il-problema-dellesposizione-speculativa-nel-pensiero-di-hegel-zeugma-lineamenti-di-filosofia-italiananbsped-9788855290876-9788855290883.jpg)





![Giovanni Gentile. La vita e il pensiero. Il problema della religione. Sulla filosofia di Giovanni Gentile [Vol. 13]](https://ebin.pub/img/200x200/giovanni-gentile-la-vita-e-il-pensiero-il-problema-della-religione-sulla-filosofia-di-giovanni-gentile-vol-13.jpg)

