Fritz Lang 8880330225, 9788880330226
- Cod: 9788880330226
146 81 5MB
Italian Pages 176 [118] Year 1995
Recommend Papers

- Author / Uploaded
- Stefano Socci
File loading please wait...
Citation preview
Stefano Socci è saggista e critico cinematografico. Dal 1989 è docente nelle Accademie di Belle Arti; insegna Regia e Storia del cinema e del video all’Accademia di Belle Arti di Firenze. Ha tenuto corsi e conferenze per atenei statunitensi, partecipa regolarmente a convegni e festival, ha collaborato a quotidiani, ha pubblicato interviste, recensioni e numerosi saggi su riviste specializzate, interessandosi anche alla pittura. Questi i volumi pubblicati: Hans Jürgen Syberberg, Bernardo Bertolucci, Miti ed eroi nel cinema, Il cinema e la Bibbia, L’ombra scura della religione, Shakespeare fra teatro e cinema.
Il Castoro Cinema n. 168 © 2005 Editrice Il Castoro srl viale Abruzzi 72, 20131 Milano [email protected] www.castoro-on-line.it Edizione digitale: 2013 www.ridigito.it In copertina: La strada scarlatta ISBN 978-88-8033-702-7
Stefano Socci
Fritz Lang
FRITZ LANG
Cinema, arte, pubblico Se qualcuno mi spingesse a prendere una posizione per così dire teorica davanti al tribunale dell’opinione pubblica, non esiterei a confessare quel che penso, che il cinema ha la ferma vocazione a diventare un criterio di valutazione della nostra cultura. Noi pensiamo di essere autorizzati a ricostruire l’immagine di un’epoca lontana grazie alle testimonianze che la tradizione ci ha lasciato nelle creazioni estetiche, nell’architettura e nei documenti scritti, operazione in cui il punto di vista soggettivo dell’osservatore è decisivo per la loro stima e classificazione. Un’epoca successiva alla nostra troverà più facile far rivivere sotto i suoi occhi, a scopo di studio, il nostro secolo caotico quando esso sarà ormai da tempo fissato in aforismi. Aprirà una scatola che contiene della vita condensata e lascerà semplicemente che il film le scorra davanti. Senza prendere in considerazione il fatto che, al di fuori del cinema, non esiste altra forma d’arte capace di offrire un quadro così vasto della nostra epoca, quest’ultima si caratterizza per aver lasciato che il cinema diventasse un ricercato bene comune e per il genere di film che preferisce. Sarebbe politica dello
struzzo negare che il cinema sotto molti aspetti ha preso il posto del teatro. Regista e produttori Il guaio con quella che viene chiamata “l’industria” è che non devi soltanto convincere il pubblico. Io amo il pubblico, ma prima di poterlo convincere, devo convincere gli intermediari, che non capiscono niente. (…) Conosco dei produttori creativi, questo è fuori discussione, ma quando dico così penso ancora a una persona che usa sceneggiatore, regista, attore, solo per fare quello che vuole. È un buon produttore ma, a mio parere, non è questo il modo in cui si dovrebbero fare i nostri film. Ho letto un articolo da qualche parte in cui dicevo che il teatro è finito per la comparsa di questa nuova arte. Sa com’è, una di quelle dichiarazioni folli in cui ovviamente credevo, perché il cinema era la mia ossessione. Il cinema è il grande amore della mia vita. Ma il cinema è stato tradito da coloro che si preoccupano soltanto di quanti soldi fa un film. È diventato molto più importante fare soldi con i film che fare film che facciano soldi. Ogni buon film farà soldi, ma da quando gli interessi commerciali hanno avuto la preminenza, i profitti sono andati in discesa. Un produttore potrebbe essere un buon amico per un regista, ma quanti produttori veri ho incontrato nella mia vita? Quattro o cinque, non di più. Le fiabe e il cinema sensazionale Gente che definirei “cretini che conoscono solo il cinema” gli rimproverano di andare incontro al desiderio di sensazione della massa. Ma, signore e signori, su questo punto che cos’altro fa il cinema se non quello che fanno le fiabe popolari, così apprezzate, e le tanto glorificate epopee eroiche? A queste siamo stati abituati nei secoli e per tradizione, ma – se guardiamo da vicino – che eccesso di brutalità, ferocia, delitti orrendi nei più soavi racconti tedeschi! (…) Bambini divorati dai lupi, matrigne recidive che avvelenano le loro figliastre e, per punizione, devono ballare con scarpe incandescenti fino alla morte. O decapitano un figliastro ingombrante con il coperchio di una madia. O sostituiscono cani e gatti ai figli di giovani regine, deponendo gli infanti in ceste di vimini sul fiume più vicino, e non hanno pace finché le vittime della loro perfidia si trovano sul rogo! Di contro, quali sono le sensazioni deliranti e gli orribili crimini mostrati al cinema? Per quale ragione i bambini stanno incollati alle fiabe come lappole e gli adulti ancor più, come testimonia il successo senza precedenti dell’edizione Diederichs delle favole della letteratura mondiale? Perché in questi racconti la legge più semplice e morale dell’umanità fa valere i suoi diritti: i buoni sono ricompensati e i cattivi puniti. I buoni ci commuovono con le sofferenze, i cattivi meritano tutto il nostro odio per i successi ottenuti con le loro malefatte. Summa summarum: è proprio la ricetta delle pellicole a effetto, contro cui si insorge. Qualcuno mi indichi un film a sensazione che osi capovolgere il destino riservato ai buoni e ai cattivi! L’innocenza perseguitata ottiene compenso come il malvagio viene liquidato dalla forza e dall’astuzia dell’eroe. Converrete con me che nella vita le cose procedono diversamente. Il cinema asseconda l’adempimento della legge morale ingenuamente come la fiaba, ma usando la forma che corrisponde alla nostra epoca. Tuttavia, deforma la realtà chi crede che le pellicole a effetto trovino il grande consenso del pubblico. Citerò alcuni successi, e sarebbe nient’altro che un vezzo passare i miei sotto silenzio: Caligari, Carmen, Madame Dubarry, Il signore delle tenebre, Fridericus Rex (di Arzen von Cserépy), il Rheinfilm (il documentario Des Rheines und der Liebe Wellen, 1923), gli Schneeschuhfilmen, I Nibelunghi, Nanook. Senza dimenticare Il monello. Quale di questi è un film a sensazione? Mabuse è una pellicola a effetto e un successo. Tale successo non deriva dall’appello al sensazionale, che resta ancora timidamente sullo sfondo, ma dalla valorizzazione del cinema come quadro della sua epoca o, meglio, è dovuto alla valorizzazione del cinema come documento dei suoi tempi.
I film a sensazione più ingenui, per esempio i western americani, ci mostrano uomini d’oggi con sentimenti primitivi simili a quelli che incontriamo nelle favole. Il film come documento dell’epoca (genere di cui Mabuse è stato un precursore che sente ancora nostalgia del paese d’origine) mostra – o piuttosto: dovrebbe mostrare – l’uomo d’oggi con lo stesso slancio con cui io ho provato a ritrarre i Nibelunghi. Non un uomo qualsiasi del 1924, ma l’uomo del 1924. Giacché l’individuo di cui parlo ha bisogno di grandezza sovrumana, nei sentimenti e nelle azioni, proprio quando diventa più piccolo e fiacco, miserabile. Necessita di stilizzazione, a differenza dei secoli passati. Non ne può più di monumenti al livello dell’asfalto. Per realizzare qualcosa di imponente deve elevarsi sopra la testa dei passanti. Di qui, per i cineasti, che sono al contempo creatori e osservatori che vivono e guardano la loro epoca, il doppio volto del cinema: da un lato il giudizio sullo spettatore valutato in base ai film preferiti – da cui si possono trarre conclusioni chiare riguardanti l’individuo come la massa – e, dall’altro, il cinema in sé, prodotto dei nostri tempi che offre un’immagine dei nostri tempi. Non mi riferisco soltanto all’Europa, ma a tutti i paesi civili in cui vivono persone che fanno cinema. Lavorare con gli attori Gli chiedo che cosa pensa della scena, parliamo continuamente: “Perché non la reciti così” – “Non mi piace così per il tale motivo…”. Può darsi che mi convinca lui, come può darsi che lo convinca io. Se è stato scelto correttamente, deve avere anche la capacità di interpretare la parte, o possedere già le caratteristiche del ruolo. Credo che un buon regista tiri fuori il meglio dell’attore. Io non voglio (come fanno molti registi) recitare la parte al suo posto perché poi lui mi imiti, non voglio vedere venti piccoli Fritz Lang correre qua e là per lo schermo. Due regali II primo regalo importante di cui siamo debitori al cinema è la riscoperta del volto umano che, mai prima d’ora, ci era stato rivelato così chiaramente nelle sue espressioni tragiche, grottesche, minacciose o spirituali. Il secondo regalo è di averci offerto delle intuizioni in immagini, nel senso delle rappresentazioni espressioniste del processo mentale. Al cinema, non partecipiamo più soltanto della manifestazione esteriore di ciò che si svolge nell’animo umano, né scorgiamo unicamente gli effetti dei sentimenti, ma li viviamo psicologicamente fin dal momento della loro comparsa, dal primo fremito del pensiero alla conseguenza logica dell’idea. Creare con il tempo Qualcuno pensa che gli artisti migliori siano quelli ossessionati dal loro specifico. È il criterio decisivo per separare l’artista cineasta dagli altri. Il regista cinematografico deve avere qualcosa di universale, cioè deve aver assimilato quel che c’è di basilare in ogni arte: lo sguardo del pittore, la sensibilità lineare dello scultore, il ritmo del musicista, la capacità sintetica del poeta. Necessita inoltre di qualcosa che è esclusivamente suo: il tempo. Tempo non vuol dire forzare la progressione con una precipitazione insensata. Tempo significa dare rilievo, comprimere, donare intensità, mandare a segno un pallonetto (sottolineatura nostra). Dare il tempo a un film non significa lasciare che gli avvenimenti si accumulino alla meglio, né accatastare le immagini l’una sull’altra. Vuol dire invece mantenere con rigore l’esatta vibrazione di ogni corda dello strumento che stiamo usando, giacché il più lieve rilassamento o una tensione troppo forte delle corde provocano un suono falso e la disarmonia. La dinamica dell’inseguimento di un criminale è diversa da quella di due esseri che si guardano in silenzio, senza muoversi, semplicemente misurandosi con gli occhi, cercando il punto in cui passa l’arteria dell’altro. Entrambe le scene, comunque, possono avere un tempo che porta al limite di rottura il cuore dello spettatore seduto in poltrona.
Violenza, paura, dolore In ogni caso, gusto e tatto. Se anche potessi far vedere la cosa più orribile al mondo per me, questa potrebbe non esserlo per qualcun altro. Tutto il pubblico – anche chi non osa permettersi di capire quello che è successo alla povera bambina (di M) – sente un brivido corrergli lungo la schiena. Ma ognuno prova una sensazione diversa, perché ciascuno immagina la cosa più terribile che potrebbe esserle accaduta. E non avrei potuto ottenere questo effetto se avessi mostrato una sola possibilità, ad esempio il maniaco che fa a pezzi la bambina. In questo modo costringo il pubblico a collaborare con me; suggerendo qualcosa ottengo un’impressione più forte, un coinvolgimento più profondo che facendola vedere. Per passare a un concetto semplice: una ragazza semisvestita è molto più sexy di una nuda. (…) In altre parole, io mostro il risultato della violenza. (…) Una volta scrissi un articolo in difesa della violenza, ma le guerre del nostro secolo hanno cambiato alcune cose. Pensa che in sala, oggi, ci siano ancora molti spettatori disposti a credere in una punizione dopo la morte? No. Quindi, di che hanno paura? Soltanto di una cosa, del dolore. Della tortura in un campo di concentramento nazista, ad esempio; non tanto della morte sul campo di battaglia, quanto di essere feriti, di rimanere mutilati. A questo punto la violenza diventa un elemento assolutamente legittimo, per rendere partecipe il pubblico, per fargli provare delle emozioni. Sulla lista di McCarthy Non mi davano lavoro, neppure Howard Hughes che, tramite un intermediario, mi aveva promesso Dio, il mondo e tutti i tesori di Golconda. Ero in castigo e non sapevo nemmeno perché. (…) Finalmente il mio avvocato scoprì che mi avevano inserito in una lista nera perché ero comunista! Io non sono mai stato comunista. Non sono mai stato membro del partito comunista. Avevo moltissimi amici comunisti. Ai tempi di Roosevelt era chic appartenere al partito. Quando venni in America, le grandi potenze – l’Inghilterra, anche la Francia – cercavano di contenere Hitler, e cosa successe in realtà? Che non importava niente a nessuno di quello che stava accadendo in Germania. Alcuni di noi lo capirono in anticipo, ma gli unici a opporsi veramente (noi credevamo che fossero gli unici) furono i comunisti. Questa fu una delle ragioni per cui tanta gente di Hollywood passò dalla parte dei comunisti, perché credevano che il partito comunista fosse il solo gruppo che combatteva effettivamente i nazisti. Creammo la Lega Antinazista e numerosi rifugiati famosi vennero ad aiutarci. (…) Più tardi il controllo di queste iniziative passò ai comunisti, così nell’era McCarthy molti di noi vennero accusati di essere comunisti. Non era vero: noi eravamo liberali. La filosofia dell’odio Giunsi a una conclusione: non c’è niente di costruttivo nell’odio. È un sentimento spregevole e improduttivo. Posso perdonare, anche se non dimenticherò mai. Questo mi ricorda qualcosa in cui vedo un grande pericolo, non soltanto per questo paese (gli Stati Uniti), che amo moltissimo e a cui sono molto riconoscente, ma per il mondo intero. Da ogni parte oggi si levano voci contro la cosiddetta Filosofia dell’Odio. Della Filosofia dell’Amore più nessuno osa parlare, perché gli riderebbero in faccia. “Ama il prossimo tuo come te stesso” – ah, ah. Non si parla più di Filosofia dell’Amore come non si parla più del Sogno Americano, che non è quello di una volta. Al massimo è diventato: “Come giocare in Borsa e fare fortuna”. O brutalmente ma, temo, con una buona dose di verità: “Come compiere il delitto perfetto e farla franca”. Tornando alla filosofia, ce ne sono altre – le filosofie dell’indifferenza e della superficialità – che ritengo molto più pericolose della Filosofia dell’Odio. E questo non succede solo in America. Le dichiarazioni sono ricavate da: F. Lang, Kitsch – Sensation – Kultur und Film, in E. Beyfuss, A. Kossowsky (a cura di), Das Kulturfilmbuch, Berlino, Chryselius 1924; F. Lang, Wege des grossen
Spielfilms in Deutschland, «Die Literarische Welt», n. 40, 1 ottobre 1926; F. Lang, Moderne Filmregie, «Die Filmbühne», Heft 1, aprile 1927; F. Lang, Die mimische Kunst im Lichtspiel, «Der Film», n. 1, 1 gennaio 1929; P. Bogdanovich, Fritz Lang in America, Movie Magazine Ltd. 1967, tr.it. Il cinema secondo Fritz Lang, Parma, Pratiche Editrice 1988.
PERCHÉ NON SCRIVIAMO DEI FILM INSIEME? «Ecco, dice l’Ecclesiaste, questo ho scoperto dopo aver esaminato ragionevolmente le cose una a una, che quello che la mia anima cercava non l’ho trovato.» Ecclesiaste 7, 27-28
Pittore, viaggiatore, soldato Friedrich Christian Anton Lang nasce a Vienna il 5 dicembre 1890, suddito di Francesco Giuseppe, figlio dell’architetto comunale Anton Lang e di sua moglie Paula Schlesinger. La famiglia risiede nella Piaristengasse. Frequenta la Volksschule e dal 1905 la Realschule, legge avidamente i romanzi d’avventura di Karl May e di Jules Verne. Tra i film visti con gli amici c’è il primo western dello schermo, The Great Train Robbery (La grande rapina al treno, 1903) di Edwin S. Porter. Nel 1907, seguendo la volontà paterna, studia architettura alla Technische Hochschule, ma appena un anno
dopo si trasferisce all’Accademia di Arti Grafiche per dedicarsi alla pittura. All’insaputa dei genitori lavora in due spettacoli di cabaret, Femina e Hölle (Inferno), partecipando del clima di melanconica spensieratezza che investe la capitale di un impero in rapido declino. Le sognanti qualità ebraicoviennesi della madre casalinga e il perfezionismo tecnico del padre ancora lottano in seno al giovane Lang, che nel 1911 si lascia alle spalle la casa e l’infanzia iscrivendosi alla Staatliche Kunstgewerbeschule di Julius Dietz a Monaco, dove segue i corsi del pittore simbolista Stuck. Nel 1912, con quaranta corone in tasca, inaugura una stagione di curiosità e di bohème viaggiando attraverso la Germania, il Belgio, i Paesi Bassi, la Russia, la Turchia, l’Asia Minore, il Nordafrica, la Cina, l’isola di Bali, il Giappone. Vive con quadri, acquarelli, cartoline e vignette per i giornali tedeschi, si improvvisa consulente artistico in un circo e presentatore di cabaret. Nel 1913 è brevemente in Italia, quindi si stabilisce a Parigi, in rue de Maistre. Frequenta la scuola di pittura di Maurice Denis e l’Académie Julian. Va al cinema con accanimento, probabilmente vede She (1908) di Edwin S. Porter, apprezza il Fantômas di Louis Feuillade, si diverte con Max Linder. Ricorda: «A Parigi vedevo film francesi d’avventura, del tipo spettacolar-popolare, in cui abitualmente un grande criminale diventava una specie di Robin Hood. Ne ho in mente uno intitolato Rocambole. Li guardavo con molto piacere, era un passatempo, e non saprei dire se mi hanno influenzato in seguito». Nel giugno del 1914 espone i suoi quadri, fra cui alcune vedute della cattedrale di Chartres, e la collezione di objets d’art europei ed esotici. Subito dopo la dichiarazione di guerra rientra a Vienna passando per il Belgio e il 15 gennaio 1915 si arruola volontario nell’esercito imperiale, preso da quello che lui stesso definisce un «patriottismo temerario». È artigliere. Ferito su fronti diversi (Russia, Galizia, Romania, Italia), ottiene la Karl Truppen Kreuz e due volte la medaglia d’argento di seconda classe per il coraggio dimostrato in combattimento. In quegli anni inizia a portare il monocolo all’occhio sinistro. Nel 1916 è congedato con il grado di tenente. Durante la lunga convalescenza a Vienna prosegue gli studi d’arte, recita in alcuni spettacoli di beneficenza della Croce Rossa, dirige e interpreta il dramma bellico Der Hias, lavora in un cabaret disegnando manifesti. Qui incontra un impiegato di banca che gli propone di scrivere dei film insieme. Le idee migliori sono di Lang, all’amico spetta il ruolo di vendere le sceneggiature. Nel 1917 Joe May ne accetta qualcuna, realizzando Die Hochzeit im Exzentrik Klub e Hilde Warren und der Tod. Sceneggiatore «Perché non scriviamo dei film insieme?». Molti hanno provato, qualcuno c’è riuscito. Lang tra i primi, quando il cinema era giovane. Wilhelm Meister e perdigiorno nello stile di von Eichendorff, Fritz cresce nel cuore della Mitteleuropa e presto, molto presto, inizia a costruire il suo personaggio: pittore, viaggiatore, collezionista, soldato, attore e patriota, dandy con il monocolo. Una singolare mescolanza di romanticismo, simbolismo e decadentismo. Zingaro barone incuneato fra Goethe e D’Annunzio il nostro poseur non ama l’alta letteratura, anzi mostra subito di prediligere il feuilleton, la narrazione a effetto, gli eroi popolari, le ragazze dei Kabarett e dei bistrot. Un lucido bohémien, senza troppe illusioni, se è vero quello che alcuni decenni dopo, nel 1965, avrebbe detto conversando con Peter Bogdanovich: «Le nostre vite scorrono molto più veloci di quelle dei nostri genitori. I miei andavano due volte al mese a teatro e poi discutevano di quello che avevano visto con gli amici, era un evento; assimilavano due storie sugli esseri umani. Ma quando sei abituato – com’ero io nel 1912, ’13, ’14 – a vedere un film, o anche due, ogni giorno, assimili molto di più – tanti fatti, tante storie sulla vita. E così noi viviamo meno lentamente di una volta e il tempo scorre molto più veloce. Quando si parla del problema della crisi dei matrimoni nelle giovani generazioni, forse bisogna chiedersi: a un uomo può bastare una sola donna e viceversa? Forse oggi si possono assimilare molte più cose di una volta, inclusi i mariti e le mogli». Sensazioni forti calibrate nel distacco: sperimentare e riflettere = imparare.
Joe May Wylliam Van Hoop, presidente del Club degli Eccentrici, si è innamorato di una donna che, tacendo il proprio nome, ha fatto una figlia con lui per poi svanire nel nulla. Tutte le ricerche per ritrovarla sono state inutili. Vent’anni dopo Van Hoop muore, lasciando un testamento in cui si dice che il nipote erediterà l’intera sua fortuna se entro sei mesi troverà e sposerà la figlia perduta del presidente. Il Club affida il caso all’investigatore Joe Debbs, che smaschera un ipocrita e ritrova in tempo la ragazza.
Die Hochzeit im Exzentrik Klub (t.l. Matrimonio al Club degli Eccentrici), undicesimo episodio della serie Joe Debbs, ideata da Joe May ed Ernst Reicher, è soltanto la seconda sceneggiatura di Lang. Nello stesso 1917 viene infatti annunciata la realizzazione del suo primo testo, ma Die Peitsche (t.l. La frusta), creato per la serie Stuart Webbs-Detektiv e affidato al regista Adolf Gärtner, non vide mai la luce. Nel 1914, seguendo la moda del Detektivfilm, il regista-montatore-produttore Joe May, insieme a Reicher, aveva creato per la Continental-Kunst-Film la figura del poliziotto privato Stuart Webbs. Il viennese Joe May (nome d’arte di Julius Otto Mandl), trasferitosi a Berlino, aveva fondato la sua casa di produzione – May-Film GmbH – nel 1915. Dirige e produce anche Hilde Warren und der Tod (t.l. Hilde Warren e la Morte), dove Mia May, moglie di Joe, sostiene il ruolo di una diva del palcoscenico. La Morte ogni tanto fa visita a Hilde Warren, invitandola al viaggio estremo. Hilde invece sogna una vita eterna e un’eterna bellezza, sdegna l’amore di Hans von Wengraf, soprintendente del Teatro di Corte, vive solo per la sua arte. Ma si invaghisce del giovane Hector Roger e lo sposa. Questi è un bandito. Durante l’assalto a una banca uccide un uomo e deve fuggire in America. Hilde viene arrestata dalla polizia. È sconvolta, perché ha in grembo il figlio di Hector, il figlio di un omicida. La Morte riappare e rinnova l’invito, ma Hilde torna al suo paese, dove mette al mondo il bambino. Wengraf vorrebbe sposarla, a condizione che si separi dal figlio. Lei rifiuta. Il soprintendente si suicida, mentre il figlio di Hilde cresce in tutto simile al padre: diventa un criminale e un assassino. Prima che la polizia lo arresti, la madre lo uccide e si consegna alla legge. Compare la Morte, che le offre consolazione e sollievo dal dolore. Hilde questa volta non può rifiutare.
Fritz dice di aver interpretato ben quattro parti nel film: la Morte, un anziano sacerdote e un giovane messaggero, dell’ultima non si ricorda. I primi testi di Lang realizzati sullo schermo mostrano un evidente dualismo tematico e psicologico. In Die Hochzeit la sparizione di una donna fatale, di una Milady, quei “vent’anni dopo”, l’eredità (il tesoro) di Van Hoop (sembra il nome di un pirata) e l’investigatore Debbs recuperano le frequentazioni letterarie dell’infanzia, la passione per l’esotico-avventuroso, i film visti a Parigi. Prima di tutto Dumas padre, maestro del roman feuilleton, il romanzo d’appendice, e Ponson du Terrail, scrittore di formidabili best-seller tardoromantici come la serie dedicata al ladro-gentiluomo Rocambole. Quindi lo scrittore tedesco Karl May, la letteratura seriale e il poliziesco statunitense (dove il detective è un’attualizzazione degli eroi popolari e sottilmente moral-immorali dell’Ottocento), che allo stesso modo coniugano mistero, esotismo, senso del destino. La vita è ripetizione inesorabile. In Hilde Warren invece troviamo l’altra identità di Lang, quell’essenza oscura che già rinnega la sua evidente ricerca del prodotto spettacolare di consenso. L’incombere della Morte svela l’umana fusione di Jekyll e Hyde. Il frutto dell’amore di Hilde è un mostro, ma per non separarsene lei provoca il suicidio di un uomo che l’ama. La rosa adombra le vuote occhiaie del teschio, come un sembiante voluttuoso annuncia il feretro che lo ospiterà. Le nebbie del romanticismo tedesco, gli elementi visionari e fantastici della pittura nordica velano di intimismo e di meditazioni cupe questi primi avventurosi intrecci, ispirati a una tradizione letteraria popolareggiante e melodrammatica che solare non fu mai. Non dimentichiamoci del Dumas fils della Signora dalle camelie e di due romanzieri americani contemporanei di Lang: Dashiell Hammett e Raymond Chandler. Erich Pommer
Nel 1918 Lang incontra Erich Pommer, che lo chiama a Berlino nella sua casa di produzione, la Decla (Deutsche Éclair). Scrive soggetti e sceneggiature. In Die Rache ist mein (t.l. La vendetta è mia) di Alwin Neuss, con Lil Dagover, che ancora si faceva chiamare Martha Daghofer, il figlio di un re della Borsa vorrebbe vendicare suo padre, rovinato da un concorrente e prossimo al suicidio, ma si innamora della figlia del nemico: gli amanti riconciliano i genitori e tutto finisce bene. Seguono Wolkenbau und Flimmerstern (t.l. Composizione di nuvole e stella scintillante), vietato ai minori e confezionato per Ressel Orla, attrice sexy sotto contratto alla Decla, Die Bettler GmbH, commedia grottesca diretta da Neuss, e Totentanz (t.l. Danza macabra) di Otto Rippert. L’infermo dottor Sephar (Werner Krauss) vive solo per diffondere nel mondo la morte e la distruzione. Il suo docile strumento, la sua anima dannata, è una bella danzatrice, “Sie” (Sascha Gura), che seduce le vittime prescelte dal dottore e le uccide. Un giorno si innamora di Stuart O’Connor (Joseph Roemer) e decide di fuggire con lui. Sephar li scopre e promette la libertà all’uomo se troverà l’uscita del labirinto che si estende sotto la sua malefica abitazione. Stuart muore e Sephar tenta di violentare la ballerina, ma un malvivente compare all’improvviso e lo strangola. Sie danza lungamente intorno al cadavere di Stuart, poi vi si accascia, morta.
In Lilith und Ly di Erich Kober, Lang si ispira a un manoscritto sanscrito. Frank Landov (Hans Marschall), scienziato e seduttore, sta lavorando all’invenzione di un telespecchio. Durante una vacanza in India trova i frammenti di un’antica pergamena che contengono il segreto della creazione della vita. Grazie a un rubino riesce ad animare la statua di un amico scultore che ritrae la signora Ly Delinaros (Elga Beck). Nasce così Lilith, e il protagonista se ne innamora. Landov completa il telespecchio, ma non può restare a lungo con la stessa donna: ama contemporaneamente Lilith e Ly. Purtroppo Lilith si trasforma in un vampiro e gli appare nelle spoglie di Ly. Quindi lo scienziato spezza il tele-specchio, che gli ha mostrato questi orrori, e distrugge la statua da cui è nata Lilith. Infine getta il rubino nel fiume, liberando Ly e se stesso da questo sogno di cose oscure e inquietanti.
Pest in Florenz (t.l. La peste a Firenze) e Die Frau mit den Orchideen (t.l. La signora dalle orchidee), entrambi di Rippert, rispettivamente affrontano peccati e punizioni rinascimentali, la psicologia di un’altra femme fatale. Nel 1919 Lang è anche co-sceneggiatore e aiuto regista di Joe May per il ciclo in sette parti Die Herrin der Welt (La signora del mondo). Regista Nel clima euforico e macabro della Germania postbellica, tra il 1918 e il 1919 (abdicazione di Guglielmo II, rivoluzione berlinese, Ebert diventa cancelliere, nasce la Repubblica di Weimar), due generi trionfano ancora nel cinema nazionale: l’erotico-pornografico occupa i bassifondi del pubblico, mentre il kolossal storico si situerebbe nelle alte sfere dell’arte, come auspicato dai fondatori dell’UFA (Universum-Film Aktiengesellschaft), diretta espressione della cultura cinematografica guglielmina. Nel 1919 Lang debutta dietro la macchina da presa, girando in cinque giorni, su una sua sceneggiatura, Halbblut (t.l. Mezzosangue), con Ressel Orla, perciò vietato ai minori. La meticcia Juanita ha ereditato tutti i vizi della sua doppia origine, è prostituta e tossicomane. Un uomo la sposa nonostante l’avvertimento di un amico («Non si deve avere una meticcia per amante, men che meno prenderla in moglie.» ) e lei – udita la frase – si vendica di entrambi: uno si ritrova in prigione, l’altro in manicomio. La meticcia dirige una casa da gioco clandestina, il “Klub”. Vorrebbe fuggire in Messico con il bottino, ma ritrova una delle sue vittime e sconta con la morte le numerose furfanterie.
Poi dirige Der Herr der Liebe (t.l. Il signore dell’amore), da una sceneggiatura di Leo Koffler. Attraverso le foreste dei Carpazi giungiamo al castello del nobile ungherese Disescu (Carl de Vogt): la fidanzata Yvette (Gilda Langer) è signora della casa, lui è signore del suo amore. Una servetta, giovane e graziosa, segue tuttavia in adorazione il castellano e lo ritiene schiavo di un profumo magico, con cui Yvette imbriglia i suoi sensi. Mentre Disescu, in visita a un vicino, si innamora della figlia, che lo seduce danzando, la servetta impara la formula del profumo inebriante. Rientrato al castello, Disescu tiene a distanza la fidanzata e nottetempo seduce la servetta, scambiandola per la figlia del vicino. Il mattino dopo Yvette scopre
l’infedeltà dell’amato e scaccia la ragazza, ma cade nello stesso peccato invaghendosi di un mercante ebreo. Disescu fa imprigionare il mercante, condannato a morire di fame. Yvette lo libera, il castellano la uccide, poi si suicida. La scena finale è allegorica. Davanti al tribunale divino Disescu si accusa. Gli viene detto: “Solo Dio è il Signore dell’Amore”.
Le prime due opere di Lang sono perdute, mentre resta copia del terzo film, Die Spinnen – Die Abenteuer des Kay Hoog in bekannten und unbekannten Welten (t.l. I ragni – L’avventura di Kay Hoog nei mondi conosciuti e sconosciuti). 1. Abenteuer: Der goldene See (t.l. Prima avventura: Il lago dorato, 1919). Kay Hoog (Carl de Vogt), noto sportivo e uomo di mondo, trova in mare una bottiglia con il messaggio di un professore di Harvard, ucciso sotto i nostri occhi da un Inca, che rivela l’ubicazione di un tesoro sepolto nel Lago Dorato. Kay ne parla al Club Nautico in presenza della bella Lio Sha (Ressel Orla), capo dell’organizzazione segreta “I ragni”, incaricata dai servizi segreti dell’India di ritrovare un diamante con la forma di una testa di Budda. La leggenda dice che chi ne entra in possesso solleverà i popoli dell’Asia diventando signore del mondo. Lio Sha e il dottor Telpha sorvegliano Kay Hoog e fanno rubare il documento dai loro uomini, ritenendo che il diamante possa trovarsi nel Lago Dorato. A Cuitan, Kay ritrova l’amico Harry, che dirige una stazione metereologica. Recupera il prezioso documento, fugge in pallone con Harry e scende in paracadute sul lago. Giusto in tempo per salvare Naela (Lil Dagover), sacerdotessa del Sole, da un serpente che la insidia durante il bagno rituale. La fanciulla lo nasconde in una caverna sotto il tempio: è molto pericoloso per un bianco farsi trovare durante le Feste del Sole, sarebbe subito offerto alla divinità. Intanto Lio Sha ha raggiunto le rive del lago e viene catturata dagli Inca, che vogliono sacrificarla nel tempio. Kay la salva e, mentre i Ragni massacrano gli Inca, fugge con Naela. I malviventi scoprono il tesoro degli indigeni, ma fanno scattare una trappola e le grotte si riempiono d’acqua. Presi dal panico si uccidono tra loro per uscire. Qualche mese dopo, a San Francisco, Lio Sha vorrebbe confessare il suo amore a Kay Hoog, ma lui ha sposato Naela. Lio decide di vendicarsi e quando l’uomo torna in città trova il cadavere della moglie sotto un arbusto fiorito del parco, con un ragno sul petto.
2. Abenteuer: Das Brillantenschiff (t.l. Seconda avventura: La nave dei diamanti, 1920) I Ragni pensano che il diamante a forma di testa di Budda sia nelle mani del Re dei diamanti, il londinese John Terry (Rudolf Lettinger). Kay Hoog, ancora in lutto, guida una spedizione della polizia nel quartier generale dei suoi nemici. Lio Sha riesce a fuggire, ma Kay trova la mappa del passaggio segreto che conduce nella città cinese situata sotto San Francisco. Vi penetra e ascolta una conversazione fra Lio Sha e i suoi complici, da cui apprende che il celebre John Quattrodita (Edgar Pauly) sorveglia la casa del Re dei diamanti. Poi sfugge a un trabocchetto tesogli dalla perfida Lio. I Ragni rapiscono Ellen Terry (Thea Zander): la restituiranno al padre in cambio del diamante. Terry si rivolge a Kay Hoog che, dalle carte di un capitano di vascello, viene a sapere il luogo in cui si trova la pietra preziosa. Anche John Quattrodita ha scoperto il segreto e lo comunica a Lio tramite un piccione viaggiatore. Kay giunge per primo nella grotta dell’isola delle Falkland in cui si trova il diamante, ma viene catturato dai Ragni. Esalazioni venefiche uccidono Lio Sha e la sua banda. Di ritorno a San Francisco, Kay incontra il Gran maestro dei Ragni (Georg John), di cui i servizi segreti dell’India non si fidano più. Vorrebbe fuggire, ma viene eliminato da alcuni agenti indiani, mentre in extremis Kay riesce a strappare Ellen dalle mani dei banditi.
Tra i due episodi di Die Spinnen si inserisce Harakiri – Die Geschichte einer jungen Japanerin (t.l. Harakiri – La storia di una giovane giapponese), diretto da Lang nel ’19, su una sceneggiatura di Max Jungk che adatta il dramma Madam Butterfly di John Luther Long e David Belasco. Ben più interessante l’incarico che nello stesso periodo gli giunge da Erich Pommer: realizzare Das Kabinett des Dr. Caligari, scritto da Carl Mayer e Hans Janowitz. Il regista propone una modifica sostanziale del testo originale e per le scenografie si rivolge al pittore Kubin, ma i distributori di Die Spinnen premono affinché completi la pellicola. Così Pommer sostituisce Lang con il mediocre Robert Wiene. Nel 1920 Lang ottiene la cittadinanza tedesca e lascia la Decla per la May-Film GmbH. Qui incontra la scrittrice trentaduenne Thea von Harbou, che è stata già moglie dell’attore Rudolf KleinRogge. Lavorano insieme. Quello stesso anno la sua prima compagna si suicida. Viene dai paesi baltici, è figlia di un pastore protestante, molto bella, si chiama Lisa Rosenthal. Lotte Eisner
racconta che la ragazza aveva sorpreso Lang sul divano del loro appartamento mentre amoreggiava con Thea von Harbou: così, era andata in camera sua e si era sparata un colpo al cuore. Fritz e Thea dovettero giustificarsi in tribunale per mancata assistenza, troppo tempo infatti era trascorso fra il suicidio e la notifica alla polizia. Il regista da quel giorno non mancò più di annotare fatti e situazioni sul taccuino, obbligando i suoi ospiti ad appuntare ogni chiamata telefonica, ogni visita e ogni uscita. Sfumata la possibilità di dirigere Il gabinetto del dottor Caligari, vero e proprio manifesto del cinema espressionista, Lang firma un contratto con la May-Film, scrivendo un serial in quattro parti, Der Silberkönig (t.l. Il re d’argento), e la prima sceneggiatura in collaborazione con Thea von Harbou, Das wandernde Bild (t.l. La statua errante, 1920), titolo provvisorio Madonna im Schnee (t.l. La madonna della neve), di cui è anche regista. Un flashback ci informa che Irmgard (Mia May) ha avuto un figlio da John Vanderheit (Hans Marr), partigiano dell’amore libero. Quando l’uomo viene a sapere che la ragazza ha sposato il suo fratello gemello Georg, per dare un padre al neonato, si fa eremita. Un giorno, passando davanti a una statua della Madonna con bambino eretta sul bordo di un nevaio, formula un voto: scenderà dalla montagna solo dopo che la statua avrà camminato verso la valle. Intanto Irmgard lo cerca e presso un lago montano si imbatte in un cugino di Georg in vacanza (Rudolf Klein-Rhoden = Klein-Rogge). Sull’alpeggio la donna ritrova John e con lui si rifugia in una capanna. Usando la dinamite Georg li seppellisce nella roccia. Il cugino soccorre gli amanti, Georg si suicida. In una notte di tempesta Irmgard salva un bambino e lo porta in braccio al paese. La stessa notte una valanga fa scivolare la statua ai piedi della montagna. I valligiani pensano che sia stata la Madonna a compiere il miracolo e John raggiunge la sua Irmgard.
Il film, considerato perduto e ritrovato da Walther Seidler nel 1985 alla Cineteca di San Paolo del Brasile, è una pausa di meditazione romantica nel flusso quasi ininterrotto di suggestioni esotiche e donne fatali. La luce e lo spazio aperto delle vette si oppongono alle ambientazioni precedenti, dove la tendenza tedesca verso la Grubelei (scavo interiore) diventava gioco scenografico, quindi schema testuale e psicologico. Essere e apparire si collocano, in Lang, ai poli di una netta cicatrice, che diventa uno schermo e un accesso. Così Frank Landov, protagonista di Lilith und Ly, vede materializzarsi sul tele-specchio i suoi più profondi pensieri, mentre Lilith e Ly rappresentano – alludendo al personaggio di Lulu – le due metà, ugualmente oscure, del pianeta donna nell’accezione maschile. E l’avventuriero Kay Hoog passa continuamente da un mondo di superficie a un universo sotterraneo (il tempio del Sole edificato su recessi oscuri, la chinatown nel sottosuolo di San Francisco), dove gli vengono fornite le risposte ai quesiti dell’apparente. Sopra vagano quasi incorporee le fanciulle ideali, spose e sorelle (Naela, Ellen Terry), sotto invece incontriamo il prototipo della ragazza acciaio e veleno: Lio Sha. L’eterno femminino è un mistero insondabile come la psiche umana. In Totentanz, Stuart O’Connor muore cercando l’uscita del labirinto che sostiene la casa del dottor Sephar, ed è giusto. Come potrebbe trovare una strada verso il cuore vero della danzatrice? Sie (Lei) è un robot nelle mani del ragno malvagio, un guscio effimero che ospita, a sorpresa, le essenze mutevoli di ogni donna, come un’ampolla preziosa contiene profumi o vapori mortali. Lilith, Sie, Lio sono proiezioni dell’incubo virile, e al contempo la chiave di qualsiasi segreto. Sono sempre identiche, incarnano lo stesso punto interrogativo: la “She” di Sir Henry Rider Haggard, l’indistruttibile Emilia Marty di Karel Čapek (Il caso Makropulos), la marionetta inquietante dei Racconti di Hoffmann o del saggio di Kleist dov’essa possiede «nessuna o un’infinita coscienza». Lilith è una creatura artificiale, che si attiva in modo simile al Golem. Vive in una dimensione esoterica e prismatica: doppione e riprova dell’esistenza di Ly. Potremmo definire la prima come personaggio (apparire) e la seconda come attore (essere): la maschera e il volto. Parlare di doppi e di sosia significa anche chiedersi che cosa sia recitare, sostenere una parte, entrare in un ruolo. Significa illustrare uno dei temi fondamentali dello spettacolo e della vita. Lang lo sapeva bene. Per questo il libero pensatore John Vanderheit (Das wandernde Bild) si riflette in un ambiguo fratello gemello, mentre Irmgard stranamente è una, concreta, indivisa, autentica Madonna.
Lisa o Thea, il mistero rimane. Anzi la sua seconda fidanzata svela un inconscio fertilissimo. Nel 1920 Thea scrive un soggetto intitolato Das Indische Grabmal, ispirato a un sogno fatto in preda alla febbre, e con Fritz ne trae una sceneggiatura per una pellicola in due parti. Joe May la legge e, intuendo il successo, salta a piè pari il giovane Lang dirigendo egli stesso il film. Das Indische Grabmal (Il sepolcro indiano, 1921), vicenda esotica e misteriosa che più non si potrebbe, otterrà un notevole riscontro di pubblico. Lang e Thea, giustamente offesi, hanno già lasciato la May-Film per la Decla-Bioscop di Pommer. Scrivono insieme Kämpfende Herzen (t.l. Cuori in lotta), che poi si chiama Die Vier um die Frau (1920; t.l. Quattro intorno a una donna). Basato su un testo teatrale di Rolf E. Vanloo, questo film di Lang, considerato perduto e ritrovato a San Paolo nel 1986, è una farraginosa storia d’amore e malavita. Florence Forster (Carola Tölle) ha sposato, per volontà del padre, il mediatore-falsario-illusionista Harry Yquem (Ludwig Hartau) e anche se amava Werner Krafft (Anton Edthofer) – che ha un fratello gemello di nome William, ladro inveterato – non segue affatto il consiglio dell’amica Margot («Tutto sommato, una bella donna non deve necessariamente essere fedele al marito.»). Harry invece vorrebbe sapere se il primo amore di sua moglie è finito, poiché ha trovato un ritratto di lei con la dedica «A Werner Krafft, la sua Florence». Nel City Hotel, Margot pranza con William Krafft, spiata da Harry, che ha lì una camera, e da Charles Meunier (Robert Forster-Larrinaga), un corteggiatore di Florence. Harry organizza un appuntamento tra sua moglie e William, inviandogli una lettera firmata Florence che lui stesso ha falsificato. Quest’ultima, che ha appena ricevuto Meunier, incontra William e, nonostante la somiglianza, si accorge che non è Werner. Yquem compare pistola alla mano, William lo disarma: si spiegano. William, interessato ai gioielli di Florence, la mette sotto la sua protezione, mentre Yquem scopre e uccide il subdolo Meunier. Durante il pranzo all’Hotel, William ha rubato un prezioso anello di Margot sostituendolo con una copia. La donna si accorge dell’inganno e chiama la polizia. Harry chiede perdono a Florence per aver dubitato di lei. Intanto il ricettatore Upton (Rudolf Klein-Rogge), che gestisce un locale malfamato, e l’ex proprietario di un collier, entrambi truffati da Yquem, lo stanno cercando, a loro volta seguiti da Werner Krafft, che ha udito i loro propositi di vendetta. La polizia irrompe nell’abitazione di Yquem, trova il cadavere di Meunier, ammanetta William e rivela a Florence che il collier donatole da Harry è un oggetto rubato. Upton e il suo complice sorprendono Florence in una stanza della casa. Werner difende l’amata, che tuttavia viene ferita da un colpo di pistola sparato da Upton. La polizia arresta i due malfattori. Harry segue la loro sorte e Florence, congedandosi, gli ricorda: «Io ti amo. Ti aspetterò e ti sarò fedele fino a quando avrai scontato tutti i tuoi errori».
Nonostante lo schematismo e una certa rigidezza teatrale, Die Vier um die Frau espone, nel gioco di finzioni, l’irriducibile polarità essere/apparire. Yquem è un illusionista. Con coerenza Lang rende quello che vediamo un problema di luce, un semplice gioco di prestidigitazione. Le fulminee apparizioni di Margot, borghese eccentrica e spregiudicata, quasi eclissano l’onesta Florence. I gemelli Werner e William Krafft sono una persona sola. Der müde Tod (Il signore delle tenebre) Un trivio. In un vortice di polvere si materializza una figura con un mantello scuro (Bernhard Goetzke). Agita il bastone da passeggio, ferma la diligenza e sale. I suoi chiari occhi magnetici intimoriscono due giovani amanti (Lil Dagover, Walter Janssen) che siedono all’interno. «Una piccola città persa nel passato», recita la didascalia. Qui lo straniero affitta per 99 anni un terreno confinante con il cimitero: ha viaggiato molto, vuole riposare. Fa erigere un muro gigantesco intorno alla proprietà, privo di porte e finestre. All’osteria ritrova i fidanzati, che stanno bevendo nell’apposito boccale detto «Calice dell’Amore». La coppia nota l’impugnatura del bastone: un piccolo scheletro. Lei si assenta e quando torna i due uomini sono scomparsi. Nella notte ricerca il fidanzato e scorge una processione di spettri che agevolmente attraversa la muraglia fatta costruire dallo straniero. Perde i sensi e viene soccorsa dal farmacista, che raccoglie erbe al chiaro di luna. Nella farmacia la ragazza legge dal Cantico dei cantici («Mettimi a sigillo del tuo cuore, a sigillo della tua mano, poiché l’amore è forte come la morte. La gelosia è crudele come la tomba, e il suo fuoco ardente e le fiamme veementi.»), beve da un’ampolla e si ritrova presso il muro, dove si è aperta una stretta porta gotica. Sale una scala (fot. 1), nel giardino trova lo straniero, chiede notizie dell’amante. Risposta: «Io non l’ho rapito, era solo giunta la sua ora». Entrano in una grande sala dove arde una foresta di candele (fot. 2). «Bruciano per un po’ e poi si spengono», dice lui. «L’amore è più forte della morte», replica lei. Al che la Morte, stanca del suo lavoro, stipula un contratto con la ragazza: le riporterà il fidanzato se lei salverà la vita di almeno una delle tre luci che si stanno esaurendo. La prima fiammella è un europeo (Walter Janssen) che, amante di
Zobeide (Lil Dagover), sorella del califfo della Mecca, viene da quest’ultimo scoperto e fatto uccidere durante il Ramadan. Il giardiniere El Mot (Bernhard Goetzke) gli scava la fossa. La seconda fiammella è il veneziano Giovanfrancesco (Walter Janssen), drudo di Monna Fiammetta (Lil Dagover) e inviso al potente Consiglio della città. Nel corso del Carnevale, Girolamo (Rudolf Klein-Rogge), fidanzato legittimo, scopre la tresca e fa in modo che sia proprio la donna a far uccidere l’amato dal servitore moro. La terza fiammella è il cinese Liang (Walter Janssen), assistente del mago A-Hei insieme alla fidanzata Tiao Tsien (Lil Dagover). Per divertire l’imperatore nel giorno del suo compleanno i tre organizzano una serie di giochi illusionistici, ma il figlio del Cielo si invaghisce della ragazza. Nonostante le magie operate da una bacchetta di giada, la fuga degli innamorati si conclude tragicamente: Liang viene ucciso dall’arciere dell’imperatore (Bernhard Goetzke). La fanciulla non è riuscita a tenere accesa neppure una fiammella, ma la Morte le dà un’altra possibilità: se entro un’ora le porterà la vita di un uomo che ha ancora tempo da vivere, riavrà il suo innamorato. Lei implora l’anziano farmacista, un mendicante, una vecchia: niente da fare. Poi una candela caduta appicca il fuoco alla locanda e un neonato viene dimenticato all’interno. La ragazza si getta tra le fiamme, la Morte le chiede il bambino, lei invece lo porta salvo dalla madre. È mezzanotte: di fronte al bel gesto, la Morte riunisce gli amanti in un probabile paradiso.
FOT. 1
FOT. 2
Der müde Tod – Ein Deutsches Volkslied in 6 Versen (Il signore delle tenebre, 1921), scritto insieme a Thea, è un apologo romantico che allude, con la sua sconcertante inattualità, a momenti realmente difficili per la Germania di Weimar. Dopo il Putsch di Kapp il marco si deprezza giornalmente, mentre il giovane Hitler compie i primi passi sulla scena politica. Pommer, che nel ’20 ha unito la Decla e la Deutsche-Bioscop A.G., proprietaria di una catena di sale cinematografiche, viene nominato direttore di produzione dell’UFA, che assorbe la neonata Decla-Bioscop. Il signore delle tenebre riprende un elemento importante della cultura nordica come il monito e l’insegnamento che gli uomini ricevono al cospetto della morte. Vi ricordate Hilde Warren und der Tod? Dopo aver rifiutato l’infante alla Morte, la ragazza di Il signore delle tenebre esclama: «Non potevo pagare un tale prezzo! Prendi ora la mia vita, perché senza amore non ha alcun senso!». Amore e morte, morte e trasfigurazione. Con uno stile netto e incisivo Lang recupera, nell’ambientazione romantica, il clima delle fiabe popolari e la leggenda medievale di Jedermann (l’uomo qualunque), che simbolicamente rappresenta il destino di tutti. Mangiare, bere, amare: ogni cosa finisce nella morte. Questo scarno esempio di moralità puritana diventa, nel film, un dolcissimo memento amoris. Persino la Morte – figurazione straordinaria, indimenticabile – coglie l’onda e l’alloro della vita. Il giardiniere ha incontrato una rosa che non sfiorisce, ma si erge rigogliosa nel fuoco puro del cuore. L’eroina è, con ogni evidenza, il Bene, mentre il Male non corrisponde alla morte, quanto all’errore morale. La morte è soltanto l’ago della bilancia, funge da
mediatrice tra ciascun essere umano e le sue azioni (fot. 3).
FOT. 3
Lang rinnega il mito faustiano, anche se di esso utilizza in pieno l’elemento tempo. La candela che si consuma (la vita), la storia delle tre fiammelle (l’Islam millenario, il Rinascimento italiano, l’antichissima Cina), quell’ora che occorre per riavere un tesoro di anni, ci portano al tema della fusione simbolica tra vita e cinema. Come la protagonista-spettatrice di Il signore delle tenebre, in sala noi restiamo prigionieri di un incantesimo che annulla ogni scansione temporale. Siamo incuranti della morte perché proiettati in essa. Morire è quindi una condizione di intensità vitale. La fanciulla si ribella al “film” delle Tre Luci, ed è proprio la ribellione che le consente di sciogliersi dall’abbraccio del giardiniere di pietra: la cripta. La vita è sogno. Il cinema è la vita (fot. 4).
FOT. 4
Su queste solide basi Lang costruisce il suo primo, vero successo. Il film è distribuito in Francia (con il titolo Les trois lumières), Inghilterra e Stati Uniti (Destiny), dove Douglas Fairbanks lo acquista, copiando molti effetti speciali per la produzione di The Thief of Bagdad (Il ladro di Bagdad, 1924), diretto da Raoul Walsh. Il cast formidabile e sperimentato, gli ingredienti esotico-avventurosi (l’ancella di Zobeide si chiama Ayesha, come l’eroina del romanzo She di Rider Haggard), il messaggio finale di speranza, le suggestioni espressioniste (il farmacista-alchimista, la bottega polverosa gremita di ossa e alambicchi, dove comunque troviamo il Libro di Salomone), l’inedito senso plastico, che reagisce allo stile eminentemente grafico e lineare di allora: tutto contribuisce al gradimento del pubblico e della critica. Domina, ben dichiarato nel titolo italiano, il Leitmotiv del regista: la lotta degli uomini contro il lato oscuro. Dr. Mabuse, der Spieler (Il dottor Mabuse) 1. Teil: Der grosse Spieler – Ein Bild der Zeit (Prima parte: Il grande giocatore -Un quadro dell’epoca)
Il dottor Mabuse (Rudolf Klein-Rogge) mescola le fotografie dei suoi travestimenti come fossero carte da gioco (fot. 5). Ne estrae una, la porge al pallido assistente, il cocainomane Spörri, e da lui si fa truccare come l’uomo del ritratto. Protetto dal travestimento, truffa e specula in Borsa (fot. 6). Alle Folies Bergère, mentre la danzatrice Cara Carozza (Aud Egede Nissen) incanta il pubblico, Mabuse ipnotizza Gerhard Hull (Paul Richter), figlio di un ricco industriale. In un club esclusivo il giovane perde ben centosettantamila marchi giocando con Hugo Balling, in realtà Mabuse. Hull corteggia Cara, che alloggia all’Hotel Excelsior, senza sapere che la ragazza è una pedina di Mabuse. La polizia lo protegge, perché sta indagando su giocatori d’azzardo che hanno eccessiva fortuna e Balling potrebbe essere uno di questi. Cara scopre il legame fra Hull e il Procuratore di Stato von Wenk (Bernhard Goetzke). Nel circolo privato di Emil Schramm, losco proprietario di un noto ristorante, Hull gioca a carte con un Mabuse senza travestimenti: volto da gufo, grandi occhi chiari. La contessa Told (Gertrude Welcker) invita von Wenk al tè delle cinque ringraziandolo per la discrezione mostrata: non ha rivelato al marito le sue frequentazioni di luoghi torbidi e malfamati, nonchè l’insana passione del gioco. Questi le propone di aiutarlo nella lotta contro un diabolico criminale, definito «Il grande sconosciuto». In un covo fumoso di giocatori Mabuse, nell’ennesimo travestimento, cerca di ipnotizzare von Wenk. Il Procuratore fugge inseguito dal criminale, poi la situazione si rovescia ed è il poliziotto a tallonare Mabuse. Dopo averlo seguito fino all’Hotel Excelsior, von Wenk prende un taxi, dove cade addormentato da un gas soporifero sommistratogli dall’autista, complice di Mabuse; viene abbandonato su una barca e salvato da alcuni marinai. Mabuse decide che Hull deve morire: Carozza sarà l’esca. Dopo l’inaugurazione del “Petit Casino” la ballerina conduce Hull in un vicolo, dove gli uomini di Mabuse lo uccidono.
FOT. 5
FOT. 6
2. Teil: Inferno – Menschen der Zeit (Seconda parte: L’inferno del crimine – Uomini dell’epoca) Continua la lotta fra il grande criminale e il campione della legge e dell’ordine. La contessa Told, d’antica nobiltà, organizza una seduta spiritica a cui si reca anche Mabuse. Il marito è un tipo languido fino all’atonia. Mabuse parla con la signora, annoiata dalla vita, e le rivela che c’è ancora qualcosa di interessante nel mondo: giocare con le persone, con il destino degli uomini. Vorrebbe farla sua. Anche von Wenk ha un debole per la contessa e le offre delle sensazioni forti, chiedendole aiuto. Dovrà far parlare Carozza, che è stata imprigionata dopo l’assassinio di Hull. La sera stessa la donna si fa chiudere in cella con la ballerina, che ormai delira: «Nessuno lo conosce! Ma c’è! Vive! Si stende sulla città, la domina come una torre. È la danna-zione e la felicità eterna! È il più grande uomo mai esistito! E mi ha amato!». Non lo tradisce e muore avvelenata. Durante una partita a poker, la contessa rivela di essere innamorata e Mabuse risponde: «Non esiste l’amore, esiste solo il desiderio. Non esiste la felicità, c’è solo la volontà di potenza». Quindi gli occhi del lestofante perforano la nuca del conte, che vince sfacciatamente e viene poi scoperto a barare. La moglie sviene e Mabuse se la porta via. Il Procuratore prende d’assalto la casa del bandito, un vero fortilizio. Nel duro combattimento che segue Hawasch, Georg e la cameriera Fine sono uccisi dalla polizia, Spörri viene arrestato. La contessa è libera e Mabuse, ferito, raggiunge attraverso le fogne un laboratorio di falsari.
Scoperto il passaggio, la polizia trova il criminale in preda alla follia e lo conduce in manicomio.
Dopo l’evidente riuscita di Der müde Tod, il loro anti-Caligari, Fritz e Thea adattano un romanzo di Norbert Jacques, Dr. Mabuse, le joueur, ricavandone un film in due parti, Dr. Mabuse, der Spieler (Il dottor Mabuse, 1922), dove l’espressionismo ottiene una piccola rivincita. Dati l’intreccio rocambolesco, la diffusione internazionale e le diverse versioni dell’opera che sono in circolazione, Il dottor Mabuse è un pregevole incubo. Prima di tutto, il problema del volto. Mabuse indossa una serie di maschere, ma quando Lang ci mostra il sembiante originale, quello del bandito, anch’esso appare stravolto dal trucco. Vediamo un’altra maschera, dietro la quale si nasconde Rudolf Klein-Rogge. Quindi l’identità del vero Mabuse è quella poliedrica di ogni attore: gioco di apparenze. Abilissimo nell’arte del travestimento, il protagonista sa sedurre gli uomini, possiede magnetismo, è un ipnotizzatore, tende all’imperialismo del crimine e al controllo del destino (fot. 7).
FOT. 7
Attore e persuasore, Mabuse tesse la sua tela. Lavora nell’ombra, come il dottor Sephar (Totentanz) o l’organizzazione dei Ragni (Die Spinnen). La ragnatela, si sa, è un prodotto di estrema precisione. Mabuse è un perfezionista, un maniaco della puntualità, cioè un adoratore del Tempo. Quando il conte Told gli chiede un parere sull’espressionismo, il dottore risponde: «L’espressionismo è già passato… Ma perché no? Oggi ogni cosa è divorata dal tempo che passa». Lang distribuisce ovunque orologi e quadranti. Come esistono una periferia e un punto focale dell’orologio, così il ragno attende ai margini e colpisce al centro della tela. Qualcuno ha giustamente paragonato il volto “base” del criminale – che, abbiamo detto, non è un volto – a quello della Gorgone (fot. 8). Nelle sue raffigurazioni quest’ultimo ha infatti la struttura centripeta di una ragnatela o di un orologio: lo sguardo dello spettatore corre subito verso gli occhi. Occhi grandi e chiari di Mabuse, orbite di stregone, approfondite dal trucco e da folte sopracciglia, tele-specchi (Lilith und Ly) che possono modificare il senso del tempo. L’intuizione geniale di Lang è quella di estendere la composizione del volto di Mabuse a tutta la scenografia. Lo spazio diventa sede del volto: quando la figura di Mabuse vi compare per intero, immediatamente identifichiamo la silhouette con gli occhi del dottore, e il gioco è fatto. Ne risulta per il pubblico la sensazione di un’effettiva onnipresenza del personaggio. Mabuse si trova fuori e dentro il tempo-ragnatela, ne è signore incontrastato. Mabuse è il regista. Il superomismo del personaggio, la sua volontà di plagio e seduzione, corrispondono a un’idea del cineasta-demiurgo-accentratore piuttosto diffusa ai tempi di Lang. Così è facile pensare che lo sguardo di Mabuse sia quello della macchina da presa e, come il piglio di Medusa, un vitreo accesso all’inconscio (fot. 9 e 10).
FOT. 8
FOT. 9
Il sogno oscuro di Mabuse è anche quello di un popolo. Per questo il dottore – giocatore e grande burattinaio – enuncia alcuni slogan della destra in ascesa. «È permesso ciò che piace», questa la filosofia di ambigua tolleranza che governa il Petit Casino; dove una ragazza balla nuda su una piattaforma che all’occorrenza può scendere dal soffitto a coprire le attività della sala da gioco. Essere e apparire. E non solo. Ruolo e interprete, maschera e volto sono sempre più confusi. Mabuse fabbrica illusioni, come un neo-dittatore, un attore o un regista-produttore, ma nel finale perde il senno. Lo smarrisce proprio nel santuario della finzione, quel laboratorio di falsari in cui resta prigioniero di porte e finestre bloccate. Una ridda di spettri e figurazioni del rimorso occupa i suoi occhi magici prima che questo terminale dell’inconsco sia spento, o spezzato, come accade al protagonista di Lilith und Ly. Ma il vampiro sogna ancora, nella trance minacciosa di un backup file.
FOT. 10
Die Nibelungen (I Nibelunghi) 1. Teil: Siegfrieds Tod (Prima parte: La morte di Sigfrido) Primo canto: Come Sigfrido uccise il drago Un grande arcobaleno corona una montagna. Nelle caverne in cui vivono i nani, o Nibelunghi, il giovane Sigfrido (Paul Richter) ha appena temprato una spada, affilata come un rasoio. Il guerriero inforca un destriero bianco, mentre i nani gli descrivono il castello di Worms sul Reno, dove vive la bella regina dei Burgundi. Passano davanti ai nostri occhi le formidabili architetture della reggia. Il fabbro Mime gli indica la strada, e cupamente profetizza: «Cavalca bene Sigfrido, figlio di re Sigmund, non giungerai mai a Worms!». Nella grande foresta il protagonista sorprende il drago Fafner, che sta bevendo presso una cascata, e lo uccide. Gli uccelli annunciano che il bagno nel sangue del mostro ha reso Sigfrido invulnerabile, tranne il punto in cui è caduta una foglia di tiglio.
FOT. 11
Secondo canto: Come Volker cantò la canzone di Sigfrido a Crimilde e come Sigfrido giunse a Worms. La bionda regina Crimilde (Margarete Schön) ricama presso una finestra del castello. Il bardo Volker canta che non esiste uomo pari a Sigfrido, l’uccisore del drago. Nebbie nella foresta: Alberico, custode del tesoro dei Nibelunghi, tende una trappola a Sigfrido e, sconfitto (fot. 11), in cambio della vita promette al guerriero l’elmo che rende invisibili. Nell’antro di Alberico, Sigfrido ammira l’enorme bacile che contiene l’oro dei Nibelunghi (fot. 12), fra cui la meravigliosa spada “Balmung”. Alberico lo assale e viene ferito, poi – compiendosi la maledizione – resta pietrificato. Sigfrido impugna Balmung e diventa signore del tesoro dei Nibelunghi, poi conquista dodici regni e dodici re si fanno suoi vassalli. Crimilde dona un mantello a Volker, che ha cantato bene. Una tromba annuncia l’arrivo dell’eroe, che vuole incontrare il re Günther (Theodor Loos). Il nobile Hagen Tronje (Hans Adalbert Schlettow) mette in guardia il sovrano. Sigfrido tuttavia viene fatto entrare e chiede in sposa Crimilde, sorella di Günther. Siccome il re è innamorato dell’invincibile Brunilde, regina d’Islanda, Hagen propone che Sigfrido sperimenti contro di lei il proprio valore.
FOT. 12
Terzo canto: Come Sigfrido sconfisse Brunilde per Günther. Günther e Sigfrido giungono per mare alla rocca di Brunilde (Hanna Ralph). Una profetessa ha annunciato alla regina l’arrivo degli stranieri. Tre volte Günther dovrà battere la donna: nel lancio della pietra, nel salto in lungo, nel lancio del giavellotto. Sigfrido, reso invisibile dall’elmo magico, aiuta il sovrano, che vince il duello. Quarto canto: Come Brunilde si recò prigioniera a Worms e come i reali celebrarono le nozze. Rientrati a Worms, Brunilde promette a Günther: «Sarò tua schiava, non sarò mai tua moglie». Dopo la cerimonia della fratellanza, in cui Günther e Sigfrido bevono il loro sangue mischiato, vengono celebrate le doppie nozze: Brunilde e Günther, Crimilde e Sigfrido. L’eroe diventa nuovamente invisibile, aiuta il re a piegare l’orgoglio della regina d’Islanda e le sottrae un bracciale. Quinto canto: Come, sei mesi dopo le nozze, la dote di Sigfrido, il tesoro dei Nibelunghi, arrivò a Worms e come le due regine ebbero una lite. Il cupo e selvaggio Hagen suggerisce a Günther di usare l’oro dei Nibelunghi per ridare splendore al regno. Intanto Sigfrido ha trovato indosso a Crimilde il bracciale sottratto all’altra. Scongiura la moglie di toglierselo, narrandole come l’ha avuto: da esso dipende l’onore di Günther. Andando a messa le due regine litigano per una questione di precedenza. Offesa, Crimilde si vendica svelando a Brunilde l’autentico vincitore del duello che l’ha portata a Worms. Quest’ultima chiede spiegazioni al consorte: i rapporti fra Günther e Sigfrido si fanno tesi. Hagen si offre di uccidere l’eroe, Brunilde afferma: «Colui che mi ha preso il bracciale, ha preso anche il mio corpo, la mia verginità». Il re bandisce una caccia: c’è un “lupo” da uccidere. Sesto canto: Come Günther ruppe il patto di fedeltà con Sigfrido. Hagen dice a Crimilde che la caccia potrebbe essere pericolosa e, per poter difendere il suo sposo, le chiede il punto in cui è vulnerabile. Crimilde lo indicherà con una piccola croce cucita sull’abito di Sigfrido. Suonano i corni dei cacciatori nell’Oderwald, Crimilde ha fatto un brutto sogno e ha tristi presentimenti. Hagen sfida Sigfrido a correre fino a una sorgente che si trova nella foresta. Il biondo eroe vuole riconciliarsi con Günther. «Dopo che avrai bevuto», dice il re. Sigfrido arriva per primo e Hagen lo colpisce fra le spalle a tradimento. L’eroe muore, la caccia è chiusa. Settimo canto: Come Crimilde giurò vendetta ad Hagen Tronje. Un cane si lamenta nella notte. Crimilde si sveglia. I guerrieri portano la salma di Sigfrido. La regina bruna festeggia. La bionda Crimilde piange sul cadavere dello sposo, poi maledice l’assassino: «Che tu ti nasconda fra la gente o dietro gli altari di Dio, non sfuggirai alla mia vendetta, Hagen Tronje!». Ordina di comunicare a re Günther che sua sorella è morta. «Così finisce la storia di Sigfrido», recita la didascalia.
2. Teil: Kriemhilds Rache (Seconda parte: La vendetta di Crimilde)
Primo canto: Come Crimilde si affllisse per la morte di Sigfrido e re Etzel, tramite Rüdiger von Bechlarn, chiese la sua mano. Il margravio von Bechlarn (Rudolf Rittner), messaggero di re Etzel (o Attila), chiede a Günther la mano di Crimilde. La vedova intanto si adopera affinché l’assassinio di Sigfrido resti vivo nella memoria del popolo. Mentre Hagen getta nel fiume il tesoro dei Nibelunghi, che quindi non potrà servire a forgiare armi contro il regno di Borgogna, von Bechlarn giura a Crimilde che re Etzel saprebbe vendicare la morte dell’eroe. Crimilde accetta l’offerta di matrimonio. Secondo canto: Come Crimilde lasciò la sua terra e fu accolta da Etzel. Presso la fonte dove Sigfrido fu ucciso, Crimilde promette di tornare. Saluta soltanto la madre Ute e raggiunge il paese degli Unni. I sudditi di re Etzel (Rudolf Klein-Rogge) sono sporchi e selvaggi. Viene ricevuta da Blaodel, fratello del sovrano, poi il re stesso – colpito dalla sua bellezza – giura che sarà vendicata. Terzo canto: Come re Etzel stava davanti a Roma e come Crimilde fece chiamare i suoi fratelli. L’esercito degli Unni assedia Roma, ma Etzel esita a saccheggiare la città e riposa nella sua tenda. Un bardo commenta: «La bianca Signora ci ha rubato Etzel!». Giunge notizia che Crimilde ha partorito un figlio. Etzel, felice, torna subito a casa, dove si offre di esaudire un desiderio della regina. Crimilde, che ha nostalgia di Worms, gli chiede di invitare i suoi fratelli a palazzo. Quarto canto: Come Crimilde accolse i suoi fratelli. Il giovane Giselher di Borgogna si innamora di Dietlind, unica figlia di Rüdiger von Bechlarn, e la sposa. I Burgundi giungono da Etzel per la festa del Solstizio. Il rozzo sovrano degli Unni adora il suo bellissimo figlio. Crimilde gli ricorda il giuramento di vendetta. Etzel temporeggia: i Burgundi sono pur sempre ospiti. Quinto canto: Come gli Unni festeggiarono con i Nibelunghi la festa del Solstizio. I piccoli guerrieri Unni festeggiano il Solstizio insieme ai poderosi Burgundi, fra cui svetta Hagen. Sempre più eccitati, gli Unni escono dalle loro grotte, mentre i fedeli di Crimilde si passano spade e pugnali, attaccando in forze presso le porte della reggia. «Tradimento!», grida Hagen, che subito uccide il figlioletto del re con la spada di Sigfrido. Etzel maledice i Burgundi (che sono detti anche Nibelunghi) e con i suoi lascia il palazzo. Sesto canto: Le pene dei Nibelunghi. Hagen, che ha catturato il capo dei partigiani di Crimilde, lo libera in modo che narri alla donna la ferocia e il valore dei Nibelunghi. Ancora battaglia: gli alti guerrieri massacrano gli Unni, che poi, galvanizzati da Crimilde, espugnano il palazzo di Etzel. Sulla vasta scalinata che reca al grande portone della reggia i Nibelunghi cadono uno a uno. «Sorella, pensa a nostra madre!», dicono i fratelli. «Consegnatemi l’assassino di Sigfrido e sarete liberi», replica lei. I superstiti si difendono bene e respingono nuovamente gli Unni. Crimilde fa chiamare von Bechlarn: è tempo di mantenere le promesse. Rüdiger è disperato, perché dovrà combattere contro Giselher, che ha appena sposato sua figlia. Settimo canto: La fine dei Nibelunghi. Etzel parla con il mercenario Dankwart: se gli consegneranno Hagen, i Nibelunghi potranno andarsene liberi. Il soldato risponde: «Voi non conoscete l’animo tedesco, Etzel!». Intanto Rüdiger, entrato nella sala assediata, uccide Giselher e cade a sua volta. Gli Unni circondano il gruppo dei Nibelunghi. Il rapace Hagen torreggia nella sala: vorrebbe consegnarsi a Crimilde, ma gli altri glielo impediscono. Volker accorda il liuto e canta l’ultima canzone: «Ah, se fossimo lungo il fresco e verde Reno». Le fiamme divorano il palazzo e il tetto crolla. Dankwart prende prigionieri Günther e Hagen. La spada di Sigfrido è nelle mani di Crimilde, che decapita Günther e trafigge l’odiato Hagen. Anche Crimilde viene uccisa: Etzel entra nella reggia in fiamme con il suo cadavere fra le braccia.
«Al popolo tedesco», sigla la frase che immediatamente precede le due parti di Die Nibelungen (I Nibelunghi, 1924). L’incantatore Lang, cementato con Il dottor Mabuse il proprio successo, realizza un film in cui la leggenda narrata sconfigge la letteratura. Il regista e Thea, che simpatizza per il movimento di Hitler, si ispirano al Nibelungenlied, grande poema germanico degli inizi del tredicesimo secolo, alla Saga di Norse e ad altre fonti che tuttavia accantonano l’epoca più feroce dell’Edda scandinava. Entrambi pensano anche alle quattro giornate del wagneriano Der Ring des Nibelungen (L’anello del Nibelungo, 1854-76) e per la scenografia replicano alcune formidabili creazioni del pittore svizzero Arnold Böcklin. Due anni di lavoro, sette mesi di riprese, un costo
enorme, accentuato dall’inflazione galoppante. Prodotto dall’UFA e finanziato dal ministro Stresemann, Die Nibelungen si gira negli studi e negli spazi intorno a Neubabelsberg e Staaken. Il film, distribuito a livello internazionale, ottiene un immediato, caloroso successo. La versione originale, 6.792 metri, subito ridotta per il mercato statunitense, è stata più volte modificata e sonorizzata. I temi sono quelli che già contrassegnano l’opera di Lang: una tragica sequenza di amore, odio, gelosia e sete di vendetta, a cui si aggiunge l’oro, il lucore di un metallo più fatale dell’acciaio. Ha un bel dire Stresemann che il film è adatto «a creare legami d’unità fra i popoli», quando lo presenta al pubblico dell’UFA-Palast am Zoo di Berlino, il 14 febbraio del ’24, con il sottotitolo Ein Deutsches Heidenlied (Un’epopea tedesca). A modo loro vedono più chiaro i nazionalisti, irritati perché vi si ritraggono gli antenati «come se fossero banditi». Proposito degli autori è comunque un omaggio al germanesimo, veicolato in uno stile kolossal che certamente guarda all’America (dove fu proiettato con la musica di Wagner diretta da Hugo Reisenfeld), ricordando anche gli anni di Guglielmo II, la dignità delle superproduzioni storiche, l’architettura – detta “di Monaco” – che caratterizzò la fine del Secondo Reich. Il film si distacca dai principi dell’espressionismo per cogliere manifestazioni “genuine” dell’animo tedesco: c’è anche, non troppo velata, un’intenzione propagandistica che riprende la politica originaria dell’UFA e precorre Goebbels. Detto questo, I Nibelunghi è un capolavoro assoluto. Il rigore dell’impianto scenografico, il ritmo lento e solenne, studiato per concentrare l’attenzione sulla “vera azione”, che non è la catena di inganni e delitti, bensì «lo snodarsi degli istinti che covano e delle passioni che lentamente maturano» (Kracauer), ci riportano al grande tema del destino. Lo scorrere del Reno, che nel film non vediamo quasi mai, è come il fluire delle armonie wagneriane: soprattutto un avvenimento psicologico. Il fiume è uno schermo e uno specchio, adombra le profondità dell’inconscio e ne custodisce la chiave, cioè l’oro. Abbiamo lasciato Mabuse che dorme nella trance di un file che si è temporaneamente perduto, così come il drago – nei cicli mitologici e nel libretto di Wagner – riposa nelle oscure profondità di una caverna o in una grande, ombrosa foresta. Quando Sigfrido lo uccide, evitando il suo alito mortale, non vede come la coda del mostro abbia fatto cadere una foglia di tiglio che, posandoglisi tra le spalle, marca il punto della sua vulnerabilità. Colpa dell’eroe è aver affrontato e steso il drago (l’inconscio). Da qui scaturisce la necessità di una punizione: Sigfrido è condannato. Quant’è diversa e simile a Der müde Tod la struttura dei Nibelunghi. L’uomo – Jedermann o Sigfrido – sconta il peccato di Prometeo e di Adamo: la ribellione al fato e al divino. Peccato di consapevolezza e di orgoglio che, nella sua audacia, sfida il potere superno rendendo l’uomo simile agli dei. Accanto a questo Übermensch nietzschiano c’è una superdonna, Crimilde, che – emulando l’eroica fanciulla del Signore delle tenebre – per amor suo combatte, raggiungendolo poi nell’aldilà. Amore e morte, morte e trasfigurazione. Il racconto di questa splendida ed eterna caduta si articola in quattordici canti e due parti realizzate in stile diverso. Sigfrido è retto da una ferrea concezione architettonica, in Crimilde dominano invece gli incendi, i massacri e il caos di un terrificante crepuscolo degli dei. La storia si svolge in ambienti fortemente teatrali, in un universo geometrico che non prevede l’irrazionalità dell’arabesco vegetale. Tutto è magniloquente, simmetrico e petroso. Sigfrido cavalca in una foresta di fiori finti, dove i tronchi sono di cemento, modellati dalla luce elettrica (riferimenti al Grande Pan, a Silenzio nella foresta e L’isola dei morti di Böcklin). Il drago è opera dell’abile artigiano Vollbrecht. Le straordinarie campiture della reggia di Worms restituiscono – con il loro gusto un po’ superato – la mitica, oleografica compattezza e l’ovvia irrealtà del mondo nibelungico. Così lo sfregiato Hagen è ritratto spesso in un’immobilità statuaria, con la spada poggiata orizzontalmente sulle ginocchia (fot. 13), come Alberico, un altro ragno, è tutt’uno con il tronco cavo di un albero e i gas venefici della landa. I nani che sorreggono il tesoro diventano simulacri di pietra. Crimilde è legata all’immagine di un ciliegio fiorito, mentre Brunilde
porta un elmo sovrastato da un cigno nero (fot. 14). Nel primo sogno della regina di Borgogna (un cartoon araldico realizzato da Walter Ruttmann) due falchi neri attaccano in volo una colomba (fot. 15). Architettura animata: come i grandi scudi dei guerrieri che, in primo piano, incorniciano e schermano lo snodarsi dei cortei, o le due schiere di soldati che, immersi nell’acqua, fanno da pilastri del molo a cui approdano Günther e Brunilde (fot. 16). Poi le scale: quella monumentale che conduce alla cattedrale di Worms, dove la figuretta bianca di Crimilde viene dominata dal triangolo nero della forma di Brunilde, o la scalinata che – al modo di Max Reinhardt – si fa scena dello scontro fra Nibelunghi e Unni.
FOT. 13
FOT. 14
FOT. 15
Architettura come elemento drammatico. Non solo si ripete lo schema – centrale in Lang – dell’alto e del basso, ma questo diventa sempre più espressione di una realtà sociale: sopra stanno i re e i capi guerrieri, mentre sotto una massa indistinta – agglutinata, silenziosa – meccanicamente esegue senza discutere. Diversamente da Wagner, qui gli dei non compaiono mai, non si parla di loro, non esistono Walhalla o paradisi nella saga di Lang. Anzi, potenza espressiva e intreccio soggiacciono al decorativo, che trionfa sull’umano, come nel periodo guglielmino l’arte e il cinema erano al servizio della propaganda. Geniale masochismo di Fritz, nazionalsocialismo di Thea? Chi sa, forse entrambe le cose. In più l’intuizione dell’importanza che la coreografia di massa sta assumendo in Germania. I nuovi dei – tutti umani, s’intende – cercano di fondere essenza e apparenza. Gli obbiettivi di un popolo verranno espressi in adunate che sembrano un fregio ingigantito, desunto dalle scenografie dei Nibelunghi. Der Triumph des Willens (Il trionfo della volontà) di Leni Riefensthal, film ufficiale del Congresso del Partito nazista a Norimberga (1934), mostra chiaramente che nell’organizzare le cerimonie collettive gli architetti di Hitler si ispirano direttamente a Lang.
FOT. 16
Metropolis (Id.) Metropolis, una grande città del 2026. Cambia il turno degli operai che, inquadrati come formiche, grazie a enormi ascensori lavorano nel sottosuolo, azionando i complessi macchinari che regolano l’esistenza di superficie. Sopra, in piena luce, una casta di privilegiati assiste ai giochi nello Stadio olimpico (fot. 17), si riunisce nei club, si rilassa e amoreggia nei giardini eterni di Yoshiwara. Qui Freder (Gustav Fröhlich), figlio del grande monopolista Joh Fredersen (Alfred Abel), vede un giorno comparire una fanciulla spettrale, giunta dalle profondità. I bambini dei poveri le si stringono intorno (fot. 18). Freder resta folgorato dall’apparizione. Comincia a interessarsi alla vita degli operai e assiste all’esplosione di una macchina che, in un’allucinazione, gli sembra divorare le maestranze come Moloch le sue vittime (fot. 19). Si reca sulla cima della torregrattacielo (fot. 20) da cui il padre coordina le attività cittadine, e gli narra le sue sconvolgenti esperienze. Joh risponde che nelle società funzionanti ognuno sta al suo posto e quello degli operai è appunto il sottosuolo.
FOT. 17
Groth, guardiano della Macchina Centrale, consegna a Fredersen delle carte con strani graffiti eseguiti dagli operai. Quest’ultimo licenzia il segretario Josaphat, che non gli ha segnalato l’esplosione della macchina e l’esistenza dei fogli in codice, poi incarica lo Smilzo di sorvegliare Freder. Il figlio infatti ha deciso di passare dalla parte delle maestranze e si è sostituito all’operaio 11.811 della sala macchine. Intanto Joh ha raggiunto una vecchia casa del centro cittadino, sormontata da grattacieli luminosi, in cui abita l’inventore Rotwang (Rudolf Klein-Rogge). Qui contempla una stele funeraria dominata dal grande ritratto di Hel, la donna che ha preferito Fredersen a Rotwang, la madre di Freder. Lo scienziato annuncia che Hel sta per resuscitare e gli mostra una sua creatura artificiale, a cui manca soltanto il volto della defunta.
FOT. 18
Rotwang scopre che i volantini sono una mappa delle catacombe situate sotto i quartieri operai e, per un passaggio segreto, scende con Joh nel sottosuolo. Dove Maria (Brigitte Helm), la ragazza che ha affascinato il giovane Fredersen, promette alla folla – tra cui Freder – che verrà un mediatore, capace di unire le mani e la mente con la forza del cuore. Quindi racconta la storia della Torre di Babele. Rotwang e Joh la osservano. Il signore di Metropolis suggerisce all’inventore di dare alla sua creatura i tratti di Maria, ordinando poi al robot di incitare gli operai a una rivolta che sarà facilmente repressa. Rotwang accetta, ma fa in modo che la
seconda Maria obbedisca solo a lui, con lo scopo di distruggere Fredersen e vendicarsi della perdita di Hel. Maria intuisce che Freder è il mediatore atteso e gli dà appuntamento alla cattedrale gotica, ma viene catturata da Rotwang, che la usa per dare volto e vita al robot. Freder, che non ha trovato la ragazza alla cattedrale, recatosi da Rotwang e poi nell’ufficio di Joh, scorge la falsa Maria flirtare con il genitore e cade ammalato.
FOT. 19
La seconda Maria viene presentata ai magnati di Metropolis e subito si mette all’opera, provocando contese e duelli. Quindi il robot scende nelle catacombe e spinge alla rivolta gli operai, che restano sordi alla denuncia di Freder, anzi tentano di ucciderlo. Mentre il giovane fugge, le maestranze iniziano a distruggere le macchine. Fredersen lascia fare, poi si preoccupa e va a casa di Rotwang per un consiglio. Sorprende lo scienziato mentre racconta a Maria i suoi progetti di vendetta e lo aggredisce, stordendolo. La ragazza ne approfitta per fuggire. Mentre il robot guida i diseredati contro la città di superficie, la Macchina Centrale esplode e i quartieri operai vengono rapidamente inondati. Maria raduna i bambini del sottosuolo e li portasu con l’aiuto di Freder e Josaphat. Gli operai credono i propri figli annegati e Groth accusa pubblicamente la falsa Maria, che viene bruciata come una strega. Rotwang si risveglia e davanti al ritratto di Hel giura che la riporterà a casa. Come pazzo, scorge Maria presso la cattedrale gotica, la scambia per Hel e la insegue sul tetto. Joh segue con apprensione le gesta del figlio, che riesce a salvare Maria. Rotwang precipita nel vuoto. Sul sagrato della cattedrale, in presenza delle masse, Freder suggella la stretta di mano fra Groth e suo padre.
FOT. 20
La meteora del giovane Sigfrido non si è ancora spenta, che Lang realizza un altro capolavoro. Metropolis (id., 1926) nasce dopo il Putsch di Monaco (il 9 novembre 1923 Hitler e Ludendorff marciano sulla Feldherrnhalle) e dopo un viaggio di Lang negli Stati Uniti (ottobre 1924), dove visita New York e Hollywood. Thea, che nell’agosto del ’22 è diventata sua moglie, mescola ingredienti già usati e alcune novità significative. Metropolis è una perla dell’immaginario collettivo, un autentico cult movie. Lo testimoniano omaggi come Star Wars di George Lucas e soprattutto Blade Runner di Ridley Scott. Le sue soluzioni tematico-architettoniche esercitano una suggestione straordinaria su prodotti di fantasy e fantascienza. Ne esistono versioni diverse, in cui ad esempio non compare la storia di Hel. Nel 1984 Giorgio Moroder ha presentato alla Mostra di Venezia una copia virata con il procedimento Rotoscope, aggiungendovi una colonna sonora rock. «Guardai le strade – le luci abbaglianti e gli edifici imponenti – e fu in quella occasione che concepii Metropolis», confessa il regista, a New York nel ’24, per la prima volta in America. Il film costò sette milioni di marchi, in diciassette mesi di lavorazione. Si girarono 620.000 metri di pellicola, furono impiegati otto attori di primo piano, 25.000 uomini, 11.000 donne, 1.100 calvi, 250 bambini, venticinque neri, 3.500 paia di scarpe speciali, cinquanta automobili. Metropolis rivela una consistenza “prismatica” che è il segreto della sua immortalità. Lang unisce
mirabilmente l’esperienza espressionista e il fascino/repulsione per ogni società brutalmente tecnologica. Tra questi due elementi il regista, memore di Pastrone (Cabiria) e Griffith (Intolerance), insinua un tema coagulante già sperimentato nel Signore delle tenebre e nei Nibelunghi: la scenografia “mesopotamica” e trionfal-operistica. La sua passione per l’esotismo si rivela in questo caso utilissima. Fra il vecchio e il nuovo mondo ce n’è un terzo, l’Asia, a cui lo spirito tedesco deve molto, da Schopenhauer a Nietzsche e Hermann Hesse, passando per Wagner naturalmente. Freder non è altro che l’incarnazione di Siddharta. Il principe indiano, chiuso nel lusso e negli agi della reggia paterna, un giorno scorge un mendicante e improvvisamente si specchia nella realtà del dolore, nell’umanità: da qui la sua trasformazione nel Buddha. È un conturbante vento di Sud-Est, portato nel film anche dalla breve ma abbacinante narrazione della leggenda della Torre di Babele. Certo Rotwang assomiglia molto al gobbo Quasimodo in NotreDame de Paris di Victor Hugo, come Maria sembra una nuova Esmeralda. Lang accosta le forme nette di una città del futuro e le contorte sopravvivenze dell’universo gotico. Lo scenziato è diviso fra due componenti: il volto che fu di Mabuse separa la sua mano sinistra, di carne e ossa, dalla destra, che è un arto meccanico. Tornano poi i Leitmotiv cari al regista. Il mondo alto (apparire) e il mondo basso (essere), dove un grande orologio amministra il tempo e il lavoro degli operai, per mutarsi in una sanguinaria divinità mediorientale. La dolce pasionaria Maria opposta al suo doppio artificiale, corrotto e demoniaco. Il robot – levigato, composto e minacciosamente addormentato come un Bodhisattva (Lucas ne ha reso una versione comica e dorata in Guerre stellari) – è un vampiro. Accadeva già in Lilith und Ly, ma qui c’è di più. Il ritratto statuario di Hel, che domina la capannuccia espressionista di Rotwang, rappresenta come sempre l’eterno femminino, specchio dell’inconscio: Lilith, Sie, Lio Sha. Spesso la femme fatale è anche ballerina, o docile strumento (marionetta) nelle mani di un sedicente Dottore, che adombra la figura del regista (fot. 21).
FOT. 21
A questo proposito esiste in Metropolis una coincidenza interessante. Lang inizia a sintetizzare alcune strutture tematico-scenografiche. Nel Dottor Mabuse una ragazza ballava nuda su una piattaforma del Petit Casino, che poteva essere calata dall’alto a coprire le attività illegali del locale. Nei Nibelunghi un enorme bacile rotondo sorretto da nani incatenati conteneva il tesoro di Alberico: schiavi e guardiano sono poi pietrificati dalla maledizione. Il robot di Metropolis, chiamato Ultima Futura Automaton, viene mostrato ai notabili della città: la finta Maria, seminuda e velata come una danzatrice pagana, si erge al centro della sala. Cento mani si levano ad acclamarla. Questa deaprostituta così ci appare: sette africani in catene sostengono una grande urna rotonda che,
scoperchiata, rivela un mostro asiatico dalle molte teste fra cui è adagiata la tentatrice. I mori intanto si sono trasformati nelle statue gotiche dei sette peccati capitali. Rappresentazione piramidale che fonde in modo brillante il percorso creativo langhiano, una chiara Weltanschauung (visione del mondo) e l’analisi di un momento politico-sociale. Il nuovo Dio è la macchina, ma l’acciaio rilucente, facilmente scambiato per oro, non è altro che apparenza. Tuttavia gli uomini si dannano per il denaro e per il potere. Il dispotismo è orientale, e il nazismo riscopre l’antico simbolo della ruota del carro del sole, la croce uncinata, ma dall’Asia giungono anche la benedizione del Nirvana e una filosofia della sostanza che pone in primo piano i valori dell’essere (fot. 22). Al crocevia della Storia, Lang fulmineamente coglie in un fascio l’intero campo di tensioni, e con un’acutezza rara ci offre un lieto fine assolutamente improponibile, falso come la seconda Maria.
FOT. 22
Spione (L’inafferrabile) Guerra di spie a Londra: sottrazione di una cartella diplomatica, attentato al Ministro del Commercio, assassinio di un agente di sicurezza, furto di documenti riservati. Un testimone viene ucciso poco prima di svelare l’identità di colui che sta dietro tutto questo. Il Ministro degli Interni si copre di ridicolo e un collaboratore del capo della polizia Burton Jason (Craighall Sherry) viene scoperto mentre sta fotografando con una microcamera il misterioso agente 326. Per chi lavora? Vediamo la mente criminale, pizzetto e baffi scuri, dietro una grande scrivania bianca: sembra invalido e usa la sedia a rotelle (fot. 23). Haghi (Rudolf Klein-Rogge), direttore generale della banca omonima, ricatta Lady Leslane (Hertha von Walther): se non lo informerà del luogo e dei partecipanti a un importante trattato segreto giapponese, informerà suo marito Roger di quello che lei fa il martedì e il venerdì sera. Haghi e l’invalido sono la stessa persona.
FOT. 23
Entra l’avventuriera Sonja Baranikowa (Gerda Maurus), che ha appena sedotto il vanitoso colonnello austriaco Jellusic (fot. 24). All’Hotel Olympic l’agente 326 (Willy Fritsch) offre rifugio a una sconosciuta – l’abile Sonja – che racconta di aver ucciso un uomo perché importunata. Lei, come ringraziamento, gli sottrae alcuni documenti, lascia un messaggio e scompare. La ritroviamo da Haghi: lo prega di non farla combattere contro 326, che le ricorda il fratello Sascha. Un flashback ci mostra il padre e il fratello di Sonja condannati a morte dall’Ochrana, la polizia zarista. Invitato da Sonja per un tè, 326 si lascia sedurre volentieri. Lei, innamorata, gli regala un medaglione con Madonna e bambino, poi cenano e ballano al “Danielli”, dove c’è anche Haghi. Il servizio segreto giapponese li sorveglia e Haghi, agente russo, sorveglia i giapponesi. Un biglietto del capo costringe Sonja a uscire in fretta per recarsi da Jellusic, ma è costretta a fuggire perché l’uomo la infastidisce con insistenza. Raggiunto l’appartamento di Sonja, 326 lo trova vuoto. Si amano, ma la vita li separa: lui beve per dimenticare, lei accarezza piangendo la sua fotografia. Il dottor Akira Masimoto, agente giapponese, rivela a 326 che Sonja è una spia e un’artista della seduzione. Troviamo poi 326 – che in realtà è il detective Donald Tremaine – con Jason. Jellusic ha preso l’Orient-Express: per precedere gli agenti inglesi. Haghi denuncia Jellusic come spia all’Alto Comando asburgico. Il colonnello, piuttosto che farsi
arrestare, si suicida. Tremaine trova 20.000 sterline nella cassetta postale di Jellusic, ma gli agenti di Haghi informano il loro capo. Sonja è indecisa: con Haghi o contro di lui? Il criminale decide di tenerla prigioniera fino a che la partita con 326 non sia conclusa. Intanto Masimoto – ignaro di aver accolto un agente di Haghi nel proprio letto – scopre che la biondina Kitty gli ha rubato il testo del trattato segreto e si suicida facendo harakiri. Haghi promette a Sonja che, portato oltre confine il documento segreto, potrà correre libera dall’uomo che ama. Jason e Tremaine incontrano in un music hall l’agente 719, il clown Nemo (Rudolf KleinRogge), affinché vigili che la firma del trattato segreto si compia in condizioni di sicurezza, nonostante il furto del documento.
FOT. 24
Sul treno che trasporta Sonja le spie di Haghi sganciano l’ultima carrozza, su cui viaggia Tremaine. Questa si scontra con il treno successivo, ma 326 non muore, anzi neutralizza il killer Morrier e ritrova Sonja. A Londra gli uomini di Haghi vengono fermati dalla polizia, Morrier informa il capo che Tremaine è vivo e Sonja li ha traditi, poi si avvelena. I poliziotti entrano nella banca Haghi e requisiscono una grande quantità di documenti. La voce amplificata del criminale-che, chiuso nella sua stanza segreta, ha preso in ostaggio Sonja, minaccia di ucciderla se entro quindici minuti la banca non sarà sgombrata, poi ordina ai suoi di immettere gas nell’edificio. La ragazza e l’agente 719 si liberano, mentre la polizia espugna la centrale di Haghi. Dov’è il bandito? Vengono offerti 10.000 marchi di ricompensa a chi lo trovi, poi un dettaglio rivela che l’agente 719, il clown Nemo, è Haghi. Un teatro, Nemo è in scena: Jason, Tremaine e Sonja lo osservano dalle quinte. Il clown, circondato, estrae una pistola e si uccide gridando: «Calate il sipario!».
Distrutto il simulacro ingannevole di Maria, squarciato il velo di Maya, ecco Spione (L’inafferrabile, 1928), primo film diretto e prodotto da Lang, che nel giugno 1927 – dopo che l’UFA è quasi fallita per il costo di Metropolis – crea la Fritz Lang-Film GmbH. Ogni interpretazione univoca della sua opera è inevitabilmente errata. Lui stesso ce lo ricorda nell’Inafferrabile, tratto da un romanzo della moglie. Intanto ha conosciuto un’altra donna, la definisce «l’unica che abbia veramente amato»: l’attrice Gerda Maurus. I film di Lang, come la sua vita, si alimentano di una sostanziale ambiguità. Il regista installa l’attrice nell’appartamento diviso con Thea. Intanto l’UFA passa nelle mani di Alfred Hugenberg, poi Ministro dell’Economia del Terzo Reich. Spione non è il prodotto migliore di Lang. Il calo di ispirazione si avverte soprattutto nella seconda parte, dove l’intreccio si annoda malamente, generando lacune e confusione narrativa. L’opera – ricostruita e restaurata nel 1977 al Museo del cinema di Monaco – affascina tuttavia per la ricchezza di idee e intuizioni. Anzitutto Lang torna al poliziesco di matrice statunitense (la rivista «Black Mask», gli eroi di Hammett e Chandler), cioè rispolvera Die Spinnen e Die Vier um die Frau, aggiunge qualche ingrediente rocambolesco (gli scambi e i travestimenti, ad esempio), molti elementi teatrali (fra cui le tante porte che si aprono e si chiudono), ma soprattutto guarda a Lubitsch e Stroheim.
FOT. 25
Il gioco delle ombre e delle mani, una poetica insistita del dettaglio, i corridoi e le scale piranesiane (fot. 25), insieme a una ripetizione ossessiva di formule, codici, sigle e numeri, testimoniano la passione del regista per gli enigmi grafici. Il film è un gigantesco ideogramma. La cultura pittorica e architettonica dell’autore si esplica nella composizione ferrea dell’inquadratura. Se il cinema è matematica più sogno, Lang è veramente il suo profeta. Un espressionismo pacato governa la scenografia degli esterni, mentre la “maniera” espressionista si rivela nella prima apparizione di Kitty: esile, fradicia di pioggia, dice di essere scappata di casa perché il padre è un sadico e la madre una puttana alcolizzata. Domina, invece, la brava e bellissima Gerda Maurus (fot. 26 e 27), a cui il regista dona una serie di primi piani quasi incredibili per gusto e modernità del taglio. Lang, si sa, è anche un feticista. Accanto a lei Rudolf Klein-Rogge sostiene il ruolo ormai abituale del criminale dalle molteplici identità: l’invalido assomiglia vagamente a Lenin e siede alla scrivania di Mabuse; Haghi ricorda a Sonja che i suoi familiari sono morti, «perché non sono stati abbastanza prudenti da tenere nascoste le loro opinioni». Il ritmo incalzante, le trappole e gli inseguimenti sono amministrati, come sempre, da orologi che appaiono regolarmente. Interessante il ritratto del dandy mitteleuropeo Jellusic, che sembra una proiezione ironica del regista. Infatti il colonnello – elegantissimo, baffi impomatati – divora con gli occhi le forme procaci di Sonja, la molesta, vorrebbe farla sua. Passato, presente e futuro di Lang si mescolano curiosamente nel turbine della carriera: il regista fonde e sublima la vita nel cinema. Donald Tremaine svapora come l’ingranaggio minore di un meccanismo collaudato. L’eroe buono non stimola Lang: dev’esserci, per il pubblico, e basta. La pronuncia del suo nome ricorda quella del cacciatore Allan Quatermain, protagonista di alcuni celebri romanzi di Haggard. Tremaine e Quatermain sono personaggi meta-letterari, silhouette del fumetto fantastico che Lang sta elaborando da tempo. Come non riconoscere, nel teatralissimo finale di Spione, questa tendenza al melodramma su striscia (fot. 28)? Ma, potremmo chiederci con Hitchcock, qual è il MacGuffin? Il clown Nemo manipola gli umani e platealmente si congeda come il perfido Joker, avversario di Batman sull’orizzonte di un’altra metropoli neogotica. Il suo nome è nessuno, la sua maschera cela un enigma, il suo volto è, al solito, inafferrabile: un geroglifico e uno specchio.
FOT. 26
FOT. 27
FOT. 28
Die Frau im Mond (La donna nella luna) Il professor Georg Manfeldt (Klaus Pohl) si è reso ridicolo davanti ai colleghi affermando che esistono miniere d’oro sulla Luna. Trent’anni dopo Wolf Helius (Willy Fritsch), che intende costruire una navicella per raggiungere l’astro notturno, fa visita a Manfeldt e cerca degli sponsor. La studentessa di astronomia Friede Velten (Gerda Maurus) e il suo fidanzato, l’ingegnere Hans Windegger (Gustav von Wangenheim), sono interessati al progetto. Il gruppo che controlla il mercato dell’oro accetta di finanziare i quattro, dopo che il misterioso Walt Turner (Fritz Rasp) ha mostrato documenti e fotografie della faccia nascosta del satellite, a condizione di partecipare all’avventura. Helius, che si è svegliato per primo dallo svenimento del decollo e ama Friede, timidamente corteggia la ragazza, provocando la gelosia di Hans. La studentessa scopre un clandestino, il giovane Gustav, con cui aveva letto delle riviste di fantascienza, mentre Manfeldt è inchiodato al telescopio.
FOT. 29
L’allunaggio riesce, anche se Helius deve calmare Hans, che teme lamanovra, quindi un’esplosione danneggia parte dell’attrezzatura. Gli astronauti scoprono che l’atmosfera lunare è respirabile (fot. 29), ma una conduttura si è rotta e Manfeldt va alla ricerca dell’acqua con la sua bacchetta da rabdomante. Siccome il professore non torna, Turner propone di cercarlo e quando Friede medica la mano di Helius, ferita liberando la nave insabbiata, è evidente che sono innamorati. Mentre Helius e Gustav lo cercano, Manfeldt trova l’oro in una caverna. Rientrato, il professore si imbatte nel subdolo Turner: lottando perde l’equilibrio e cade in un crepaccio. Arrivano Helius e Gustav, che scorgono il corpo senza vita di Manfeldt. Turner intanto ha legato Hans, ma non riesce a entrare nell’astronave, perché Friede ha chiuso il portello. Hans si libera e affronta Turner che, prima di morire, spara a un deposito d’ossigeno. Constatati i danni, si tira a sorte chi deve attendere i soccorsi sul satellite. L’ingegnere estrae la paglia più corta, ma rifiuta di restare. Così Helius addormenta i fidanzati e incarica Gustav di pilotare durante il ritorno. L’astronave scompare nello spazio, Helius piange, poi si accorge che Friede è rimasta: sono finalmente soli.
Die Frau im Mond (La donna nella luna, 1929), ispirato a un romanzo di Thea, è l’ultimo film muto di Lang e l’ultima opera realizzata per l’UFA. Al termine delle riprese la produzione voleva aggiungere il sonoro nelle scene più spettacolari (il decollo dell’astronave, ad esempio), ma il
regista si oppose con fermezza. Come altri autori anche Lang resiste al preteso arricchimento della settima arte, in nome della tradizione e della specificità visiva del linguaggio cinematografico. Perciò Die Frau im Mond è un omaggio all’Ottocento, a Jules Verne e soprattutto al pioniere Georges Méliès, maestro di illusionismi ed effetti “meravigliosi”. Georg Manfeldt è giusto una proiezione ironica e affettuosa del regista di Le voyage dans la Lune (1902). Il professore muore in uno di quei crepacci aguzzi tipici della scenografia lunare teatralissima del film di Méliès e non potrebbe essere il contrario (fot. 30). Hermann Oberth e Willy Ley, consulenti tecnici per l’ambientazione e per la costruzione del razzo-proiettile (fot. 31), diventarono importanti nella vera ricerca spaziale: il primo con i nazisti, l’altro negli Stati Uniti. Lang intuisce che un’epoca è finita, che il “paganesimo” e il cinema artigianale delle origini – con i suoi maghi e stregoni – cedono di fronte alla tecnologia e a moderne organizzazioni produttivo-commerciali, come quella statunitense (fot. 32).
FOT. 30
FOT. 31
Fritz ha capito che il regista-demiurgo, Prospero shakespeariano, deve togliere il costume di scena e mimetizzarsi nel pubblico. La morte di Manfeldt sancisce questa trasformazione. Pertanto Die Frau im Mond è un’opera minore, crepuscolare, nostalgica. Il personaggio di Gustav allude melanconicamente ai sogni dell’infanzia e dell’adolescenza, alle prime letture avvincenti. Friede è la donna che liberamente sceglie, una brillante signorina tedesca che al grigio e quadrato Hans preferisce il genio e la solarità di Helius. Walt Turner invece esemplifica un tema fondamentale di Lang, l’impersonalità del male. Per l’autore il capitalismo dei monopoli – il male – è inafferrabile come il destino. Dopo la donna e l’inconscio questo è il terzo mistero della vita. L’anglosassone Turner, legato ai capitalisti e all’oro, è l’inquietante Signor Nessuno, l’abisso, il buco nero, il cilindro magico del prestigiatore da cui sono usciti Harry Yquem e William Krafft (Die Vier um die Frau), Mabuse, Haghi, Nemo e gli altri. Così il triangolo Hans-Friede-Helius si allontana vorticando nel firmamento, destinato a perdersi e a diventare nient’altro che una romantica stella fissa.
FOT. 32
M (M, il mostro di Düsseldorf) Un circolo di bambini in un cortile: «Scappa scappa monellaccio, se no viene l’uomo nero, col suo lungo coltellaccio, per tagliare a pezzettini… proprio te!» (fot. 33). Il prescelto è fuori dal gioco. Una donna si affaccia al balcone e ricorda alla figlia di averle proibito quella «maledetta canzone». Si commentano le brutte notizie su un uccisore di bambine. Tornando da scuola Elsie Beckmann (Inge Landgut), la biondina dell’inizio, incontra un uomo che le compra un palloncino (fot. 34). Il giorno dopo un’edizione straordinaria riferisce che la bambina è stata uccisa nel parco. I giornali ricevono lettere del mostro. Nonostante la taglia di 10.000 marchi i poliziotti da otto mesi brancolano nel buio, panico e sospetto si diffondono in città: chiunque potrebbe essere l’assassino. Chi incautamente avvicina una minore viene fermato e denunciato dalla folla. La polizia setaccia dormitori pubblici, stazioni ferroviarie, quartieri malfamati, ma senza risultato, perché il mostro non lascia tracce. Gli affari della malavita vanno a rotoli per le indagini provocate dai misteriosi omicidi. Viene indetta una riunione dei rappresentanti delle Organizzazioni Unite, presieduta da Schränker (Gustaf Gründgens), il capo, in cui si decide l’eliminazione del mostro, «senza indugio e senza pietà». In parallelo le autorità cittadine discutono il problema, giungendo alla conclusione che sono gli istinti del momento a fare un assassino. Schränker affida all’organizzazione dei mendicanti il compito di rintracciare il mostro: fra essi c’è il cieco (Georg John) che ha venduto il palloncino a Elsie. La polizia indaga su coloro che sono stati dimessi dai manicomi. Un agente si presenta a un’affittacamere chiedendo del signor Becker. Becker (Peter Lorre) nel frattempo avvicina per strada una bambina e inizia a fischiettare un motivo di Grieg, quello dell’incontro con Elsie: tace improvvisamente, perché la bambina ha raggiunto sua madre. Nella stanza di Becker il poliziotto ha trovato un pacchetto di sigarette Ariston, la stessa marca rinvenuta presso il corpo di un’altra minore uccisa. Più tardi il venditore cieco ode il fischiettio di Becker, ricorda di averlo già sentito e chiede a un amico di pedinare l’uomo che sta parlando con una bambina. Non visto questi segna la spalla sinistra di Becker con una grande “M” di gesso. Davanti a un negozio di giocattoli la biondina di turno fa notare a Becker la lettera sul cappotto (fot. 35). L’uomo cerca di cancellarla, poi fugge. Il mostro, braccato dai mendicanti in un dedalo di vicoli e palazzi, riesce a rifugiarsi in una soffitta. Schränker, informato, manda rinforzi. I malviventi entrano nel palazzo, ma uno dei guardiani suona l’allarme: il tempo stringe. Becker viene trovato due minuti prima dell’arrivo della polizia. Il commissario Karl Lohmann (Otto Wernicke) fa parlare uno dei malviventi e viene a sapere che il mostro è stato portato in una distilleria abbandonata. Nello scantinato della distilleria la malavita celebra un regolare processo a Becker. Vengono ascoltati l’accusatore, il difensore e i testimoni. L’imputato pretende di essere consegnato alla polizia, ma le prove e la folla sono contro di lui: è condannato a morte. L’ingresso della polizia lo salva in extremis.
FOT. 33
FOT. 34
FOT. 35
M (M, il mostro di Düsseldorf, 1931) è uno dei film più importanti e noti di Lang, il suo preferito, dove la complessità è direttamente proporzionale alla chiarezza del testo, scritto a quattro mani con Thea. La M del titolo dichiara ancora una volta la passione del regista per gli ideogrammi e gli enigmi. M significa Mörder (assassino) e Monstrum (creatura fantastica), eppure la lettera – come la A scarlatta del romanzo di Hawthorne – si presta a un divertimento plurilinguistico. Il concetto simboleggiato dal personaggio di Becker in tedesco si dice Schlechte, in inglese evil. Per rispettare il gioco dell’iniziale è necessario ricorrere ai vocaboli francese, spagnolo e italiano: M = mal, male. M vuol dire anche Mabuse, nome proprio assolutamente internazionale, e Mabuse, si sa, è veramente il male. Così una semplice iniziale diventa la chiave di molte interpretazioni, esprimendo allo stesso tempo l’ambiguità di ciascuna. Il primo segno forte, nell’opera, è quel cerchio di bambini inscritto nel quadrato del cortile: i minori vengono protetti dai simboli dell’apparato sociale (cortile, casa, quartiere, città, Stato), ma anche li subiscono, ne sono schiacciati. Per molti, più deboli, emarginati o malati come Becker, l’apparato sociale si configura come una prigione. Il mostro è già all’inferno, come rivela la sua autodifesa al processo (fot. 36).
FOT. 36
Becker: Non è colpa mia! Lo giuro! Schränker: E di chi è la colpa? B.: Ma chi sei tu? Ma cosa dici tu? Chi sei tu che vuoi giudicarmi? E chi siete voi? Un branco di assassini, di malviventi. Ma chi credete di essere, solo perché sapete come si fa a scassinare una cassaforte o ad arrampicarsi sui muri e sui tetti. Sapete fare questo e nient’altro. Non avete mai lavorato in vita vostra. Non avete mai imparato un lavoro onesto. Siete un branco di maiali. Niente altro che un branco di maiali pigri. Ma io che posso fare? Che posso fare d’altro? Non ho forse
questa maledizione in me? Questo fuoco, questa voce, questa pena! S.: Vorresti dirmi allora che tu devi ammazzare. B.: Quando cammino per le strade ho sempre la sensazione che qualcuno mi stia seguendo, ma sono invece io che inseguo me stesso. Silenzioso, ma io lo sento. Spesso ho l’impressione di correre dietro a me stesso. Allora voglio scappare, scappare, ma non posso fuggire! Devo uscire ed essere inseguito. Devo correre, correre per strade senza fine. Voglio andare via, ma con me corrono i fantasmi di madri, di bambini. Non mi lasciano un momento, sono sempre là, sempre, sempre, sempreee. Soltanto quando uccido, solo allora… E poi non mi ricordo più nulla. Dopo, dopo mi trovo dinanzi a un manifesto e leggo quello che ho fatto. E leggo, leggo. Io ho fatto questo? Ma se non ricordo più nulla! Ma chi potrà mai credermi? Chi può sapere come sono fatto dentro? Che cos’è che sento urlare dentro al mio cervello? E come uccido: non voglio! devo! non voglio! devo! E poi sento urlare una voce, e io non la posso sentireee. Aiutooo, non posso, non posso, non posso… Il personaggio, ispirato al celebre “Vampiro di Düsseldorf”, diventa per Lang una vittima e un eroe negativo. La scelta di Peter Lorre – attore teatrale, allievo di Brecht – ci dice molto delle intenzioni registiche. Due titoli provvisori – Eine Stadt sucht einen Mörder (Una città cerca un assassino) e Mörder unter uns (L’assassino è tra noi) – chiariscono che M deriva dal Kammerspiel tradizionale, da un realismo diverso da quello magico e allusivo dell’espressionismo. Gli anni che precedono l’incendio del Reichstag sono particolarmente difficili per le minoranze, i poveri e coloro che vivono fuori dal contesto sociale. In strada o chiuso in cella, per Becker non fa differenza. Quel che al protagonista non sembra giusto, invece, è morire, l’eliminazione: è morto tante volte, ormai, espia vivendo. Il tema dell’ambiguità dei ruoli di giudice e assassino si pone al centro di un caleidoscopio di motivi ricorrenti. I film di Lang scorrono come partiture musicali, da cui di volta in volta estrapoliamo i refrain. L’insistito schema circolare: circolo dei bambini, palloncino, palla e piatto vuoto di Elsie. Spirale in vetrina e pozzo delle scale (fot. 37 e 38) che visualizzano la vertigine in cui cade il mostro quando uccide, le profondità inconoscibili della psiche umana. Alto/basso, ombre proiettate, tema delle mani, gioco di carte e del destino, il diabolico criminale Schränker (interpretato da Gründgens, il grande attore descritto nel Mephisto di István Szabó) in gara con il bravo poliziotto Lohmann, gli orologi che scandiscono l’azione (= tema del tempo). Le mappe cittadine, i manifesti e i numerosi titoli di quotidiani che, nonostante il parlato, informano il pubblico. Il fischiettio di Becker, che diventa un segnale sonoro. L’elemento della banalità del male e del suo Mistero, con l’opposizione individuo/folla già svolta in Metropolis: altre due M. A cui dobbiamo aggiungere il remake diretto da Joseph Losey nel 1951 e la doppia versione – teatrale (M, 1972) e cinematografica (Ombre e nebbia, 1991) – che del film di Lang ha dato Woody Allen.
FOT. 37
FOT. 38
«Aber ich bin noch nicht am Ende!» (Ma io non ho ancora finito!) scrive l’assassino nella lettera ai giornali. Gli crediamo, perché l’ingresso della polizia come deus ex machina e la frase di rito – «In nome della legge…» – sono proprio un finale inverosimile. Ci immaginiamo Becker nel braccio della morte o pronto per essere gasato in un lager, in mezzo a gente minuta oppressa da un fato inesorabile, che in modo rocambolesco evade e continua a uccidere, uccidere, uccidere. Das Testament des Dr. Mabuse (Il testamento del dottor Mabuse) L’ex poliziotto Hofmeister, reduce da un misterioso scantinato in cui si odono rumori ritmici di macchine, telefona al commissario Lohmann (Otto Wernicke/ Jim Gérald), perché ha inteso il nome di qualcuno che trama nell’ombra, credeva fossero falsari, invece… La conversazione si interrompe e improvvisamente Hofmeister inizia a canticchiare un ritornello: è impazzito. Il professor Baum (Oskar Beregi/ Thomy Bourdelle), direttore del manicomio che ospita Mabuse (Rudolf Klein-Rogge), tiene una lezione sul noto criminale, proiettando un documentario che lo ritrae nella sua cella, affetto da inarrestabile grafomania, letteralmente sommerso dalle pagine del testo che sta scrivendo. In casa di Hofmeister il commissario trova alcune lettere tracciate sul vetro della finestra: un messaggio? Intanto Mabuse scrive e scrive, infaticabile, cupo, concentratissimo. Baum crede di vedere il sembiante del criminale – cioè uno sdoppiamento dell’Io del malato – che lo osserva beffardo. Il dottor Kramm, assistente di Baum, racconta al professore di aver scoperto una coincidenza sensazionale fra gli scritti dell’internato e un furto appena compiuto: se Mabuse fosse un simulatore? Il domestico di Baum ascolta la conversazione e poco dopo Kramm viene assassinato da uomini della banda dello scantinato, prima che riesca a informare la polizia dei suoi sospetti. Intanto la legge ha ritrovato il delirante Hofmeister. Thomas Kent (Gustav Diessl/ Maurice Maillot), uno dei gangster, che corteggia la biondina Lilli (Wera Liessem/ Monique Rolland) e medita di uscire dalla banda, si reca a un appuntamento con il Capo. Questi è su un palcoscenico, dove una cortina trasparente ne rivela la silhouette: gli ordini giungono tramite un amplificatore. La voce rimprovera Kent e ricorda che ogni tentativo di ribellione sarà punito. Mentre la polizia decifra i segni sul vetro lasciati da Hofmeister, da cui risulta il nome Mabuse, il direttore del manicomio viene informato che il criminale è morto. Davanti alla salma, Baum recita un elogio funebre in cui difende il genio di Mabuse e i suoi progetti, che avrebbero potuto purificare il mondo. «Il Vangelo secondo San Mabuse» ironizza Lohmann. Nel suo studio Baum legge gli scritti visionari e messianici di Mabuse, che improvvisamente gli appare e lo ipnotizza. Lilli ricambia l’amore di Kent, che diserta un altro raduno della banda: la ragazza gli consiglia di informare Lohmann. Per strada i due vengono catturati dai gangster e portati nella sala delle riunioni, da cui – dice il Capo – non usciranno vivi. Kent spara alla silhouette dietro il sipario, ma scopre di aver colpito solo una forma di cartone. I discorsi del Capo sono incisi su disco e trasmessi da un microfono. Il tempo che resta loro da vivere è scandito dal timer di una bomba a orologeria. Mentre Kent tenta di aprire la porta blindata, la polizia circonda uno dei rifugi dei gangster. Dopo il combattimento Lohmann trova una connessione con il delitto Kramm e interroga i banditi superstiti, che non sanno neppure il nome del loro capo. Kent sventra il pavimento e rompe una conduttura: il locale si allaga rapidamente. L’acqua annulla l’effetto dell’esplosione, così gli amanti sono salvi. Lohmann – che sospetta Baum – lo convoca nel suo ufficio per un confronto con i malviventi. Arrivano Lilli e Kent. Prima di andarsene Baum riconosce Kent e pronuncia il suo nome, pur non avendolo mai visto. Il giovane riferisce a Lohmann che Mabuse vive ed è il capo della banda. Entrambi raggiungono la casa di Baum dove, forzata la porta dello studio, trovano un giradischi che sta trasmettendo la voce del professore, e una mappa di Berlino, in cui è indicato il luogo di un’azione da compiere la sera stessa. I due si precipitano alla fabbrica di prodotti farmaceutici oggetto dell’impresa criminale: l’edificio è in fiamme. Baum fugge
in automobile, guidato dal fantasma di Mabuse. Lohmann e Kent lo perdono a causa di una foratura. Al manicomio lo spettro del bandito consegna al professore i suoi scritti e lo conduce nella cella di Hofmeister. «Permettete che mi presenti: dottor Mabuse», dice Baum. Hofmeister lo aggredisce, accorrono gli infermieri, poi Lohmann e Kent. Ora Baum è seduto sul letto nella posizione che fu di Mabuse e straccia metodicamente le carte del criminale. Lohmann e Kent se ne vanno. La porta della cella si chiude sull’immagine di Baum impazzito (fot. 39).
FOT. 39
Come possono convivere spirito classico (razionale) e spirito romantico (irrazionale)? Lang sapeva che queste due metà dell’esistente si sposano bene nel potere e nei media. Chi è Mabuse se non l’esatta mescolanza di razionale e irrazionale? Il grande criminale – proiezione del cineasta creatore e di ogni manipolatore – torna in Das Testament des Dr. Mabuse/ Le testament du Dr. Mabuse (Il testamento del dottor Mabuse, 1932), scritto da Thea von Harbou che nello stesso anno aderisce al nazismo. Il film, basato sui personaggi del romanzo di Norbert Jacques, venne sollecitato dai proprietari delle sale dopo il successo del ’22. Ne furono girate subito due versioni, tedesca e francese, con la stessa équipe tecnica e interpreti diversi. Il commissario Lohmann – lo stesso che curiosamente guida le indagini in M – all’inizio domanda a un collaboratore: «Müller, ti piace la musica di Wagner? Ah, le valchirie! Sai, quelle fiere ragazze che prendono su i commissari morti sul campo dell’onore e li portano direttamente in cielo. Eh, già! A suon di musica e a cavallo». Le valchirie, com’è noto, raccoglievano i guerrieri caduti in battaglia per condurli nel loro paradiso, il Walhalla. Così Lohmann, poliziotto robusto e falsamente bonario (un altro Maigret), ci appare ironicamente trasfigurato dal mito degli eroi. Allo stesso tempo Lang suggerisce come nella realtà sia diversa la sorte dei rappresentanti della legge e quanto siano di moda, in quegli anni, le opere del fondatore di Bayreuth. Il nazismo, ormai alle soglie del potere, celebra Wagner come un precursore del nuovo pangermanesimo. In America nel ’43 Lang dichiarerà che il film era stato realizzato per denunciare i metodi terroristici di Heydrich, Himmler e Hitler. Mabuse infatti svolge un programma politico-filosofico assolutamente destabilizzante: «La fiducia del cittadino normale nei poteri che ha eletto dev’essere distrutta. E quando tutto sarà distrutto, su quel che rimarrà costruiremo il regno del crimine». Eppure c’è da chiedersi quanto Lang, nel 1932, pensasse a un’interpretazione solo politica dell’opera. La stessa Thea, apertamente nazionalsocialista, si dimostra favorevole alla legalità, ma sempre nel contesto ambiguo della crime story, a cui si intreccia l’abituale storia d’amore dei protagonisti giovani. Ritroviamo echi della linea stürmisch che caratterizzava Il dottor Mabuse, ma le immagini sembrano appannate da quello che potremmo chiamare l’alito del drago (fot. 40). Il criminale grosziano – dinamico e impetuoso, piccolo borghese senza cuore avido di denaro e nobildonne (sostituite nell’alcova da disinvolte ballerinette), sanguigno, rapace, dedito con astuzia allo sfruttamento degli altri – diventa qui l’ombra di se stesso. Riempie montagne di carta con teorie bizzarre e frasi spezzate, autentici crittogrammi. La sua volontà di potenza e dominio si esplica con la scrittura e l’ipnosi. Il volto di sparviero quasi scompare dietro occhi di lemure, enormi, bistrati, fissi, demoniaci (fot. 41). Come il Maligno, Mabuse carcerato sceglie un corpo da possedere interamente, un guscio in cui traslocare: il professor Baum, il suo medico. Fra i due si istituisce il classico transfert e il paziente trionfa sull’analista.
FOT. 40
A questa metafora Lang ne accosta una ben più significativa, che si rifà addirittura al mito platonico della caverna. I malviventi infatti ascoltano le direttive del Capo in uno spazio che replica l’antro di Platone e insieme il teatro, la sala cinematografica. L’ambiente è stato isolato dall’esterno con una serratura a combinazione: nessuno può uscire, i gangster sono imprigionati. Di fronte a loro sta un boccascena chiuso da una tenda sottile, su cui una lampada proietta i contorni del leader che, seduto all’interno del palco, comunica con messaggi registrati e distorti dall’amplificazione (fot. 42). Kent si ribella alla condizione passiva di spettatore-esecutore sparando all’icona del potere e schiude il sipario – la tela, lo schermo, il velo di Maya – per trovarsi davanti all’inganno supremo: scrivania, silhouette, giradischi, microfono, megafono, nient’altro (fot. 43). Questo è il Capo. La sua frustrazione è simbolica, adombra quella di un uditorio che sventatamente ha voluto scoprire il segreto dello spettacolo. Se gli spettatori fossero rimasti al loro posto, come avrebbero dovuto fare le maestranze di Metropolis, sarebbero stati oppressi ma inconsapevoli. Cercare la verità, proclama cupamente Lang, è legittimo ma inutile, soprattutto nel nascente reame dei media. I prigionieri incatenati di Platone conoscono solo i riflessi della realtà, proiettati sul fondo della caverna, ed è meglio per loro non muoversi. Come il pubblico che sogna il mondo esterno davanti al palcoscenico o al grande schermo. Se il re si denuda (o muore), evviva il re.
FOT. 41
FOT. 42
Questa spiegazione del nazismo, e di ogni assolutismo, nell’era della comunicazione di massa certamente è più consona alla sensibilità di Lang, portato al fantastico, dedito allo spettacolo (luogo dell’effimero, dell’apparenza, della superficie) eppure conscio, anzi appassionato, dei congegni meccanici, della tecnologia (essenza, forma soggiacente) che permettono la realizzazione dei suoi sogni. Per questo Mabuse – il mago, l’incantatore, il ciarlatano geniale – fa distruggere i suoi incartamenti (lascito di vaghe ideologie, geroglifici, esoterismi) e abdica in favore di un tecnico della psiche come Baum. La “grande partita” del primo Mabuse si svolge ormai ad altri livelli. Il medium tradizionale (l’ipnotizzatore, il telepatico) è superato o, come il veggente personale di Hitler, protegge/giustifica, tramite la sua maschera consunta e i trucchi da guitto, il lavoro immutabile e le trasformazioni del Persuasore. Il ritratto di Mabuse coincide sempre più con l’ideogramma langhiano, con il Grande Ambiguo, con quell’interrogazione rivolta all’inconscio che il regista continua a porgere attraverso lo schermo.
FOT. 43
Liliom (La leggenda di Liliom) Un luna park di Parigi. Sulle note della canzone «Viens, gosse de gosse», Madame Muscat (Florelle), proprietaria della giostra detta Hippo-Palace, osserva il suo impiegato Liliom Zadowski (Charles Boyer) che canta, flirtando con le signore di passaggio. Liliom è particolarmente interessato a Julie Boulard (Madeleine Ozeray), una graziosa cameriera accompagnata dall’amica Marie. Hollinger, un vicino geloso, riferisce a Muscat che Liliom sta corteggiando la ragazza. Tra i due uomini si accende un duello e il coltello di Hollinger si conficca in un piccolo gruppo ligneo che decora l’organetto di Barberia, proprio nella mela offerta da Eva al suo Adamo, mentre il serpente sta a guardare. Muscat apostrofa volgarmente Julie e ordina a Liliom di cacciarla. In risposta l’uomo prende giacca e cappello, allontanandosi con la fanciulla. È sera, si siedono su una panchina, Liliom le parla d’amore, ma giunge una ronda della polizia. L’ispettore mette in guardia Julie dal «pericoloso seduttore di servette» che le sta accanto, noto alla giustizia soprattutto come ladro. «Julie, ora mi conosci», replica Liliom. Due cuori incisi su un tronco d’albero: Julie è andata a vivere nel carrozzone di Liliom e aiuta una vicina, Madame Menoux, nella realizzazione di fotoritratti artistici. Litigioso (la schiaffeggia per non aver sorvegliato il caffè che bolle) e fannullone, Liliom non si è rivelato un buon compagno. Menoux vorrebbe sposare Julie a un onesto proprietario di magazzino. Liliom frequenta il locale “L’île d’amour”, dove corteggia una brunetta, gioca a carte per ore alleggerendo le tasche dei “polli” e rubacchia con l’aiuto del compare Alfred. Mite, casalinga, fedele, la bionda Julie lo attende sempre. Un giorno compare Muscat, che prova invano a “recuperare” Liliom. Julie aspetta un figlio. Il padre è felice, ma la sua cattiva natura lo spinge a cercare denaro con il furto. Liliom e Alfred tentano di derubare un passante, che reagisce. Arriva la polizia: i due fuggono, ma Liliom, circondato, decide di finirla piantandosi un coltello nel cuore. Assistito da Julie, il malandrino agonizza e muore. Due angeli con bombetta lo portano in Cielo. Dove le cose non cambiano: c’è un Commissariato, un flic con le ali, Liliom fa come sempre anticamera. Nella Sezione dei Suicidi vengono prese le sue generalità e il defunto non può tenersi dall’ammiccare a una graziosissima dattilografa. Si spengono le luci e viene proiettata una sequenza della sua vita: 17 luglio, ore 8.40 del mattino, il litigio con Julie. Se i suoi pensieri diventeranno buoni, dopo sedici anni di Purgatorio potrà scendere per un giorno sulla Terra e vedere la figlia. Scaduto il termine indicato i due angeli lo riportano a Parigi, dove Liliom parla con la figlia senza farsi riconoscere. Lei gli canta «Viens, gosse de gosse», rivelando al protagonista di essere cresciuta nel culto di un padre dolce e comprensivo. Liliom crudelmente infrange questa immagine. La fanciulla corre a casa, la madre la conforta, piangono insieme. Il defunto è subito richiamato in Cielo, dove la Bilancia della Giustizia oscilla incerta. «Sedici anni di Purgatorio non sono stati abbastanza» sentenzia il Commissario, ma Liliom viene perdonato grazie alle lacrime di Julie e di sua figlia.
Fra Il testamento del dottor Mabuse e Liliom (La leggenda di Liliom, 1934) molte cose cambiano per la Germania e per Lang. Il 30 gennaio 1933 Hitler prende il potere, il 27-28 febbraio il Reichstag è distrutto dal fuoco. Goebbels, nominato Ministro della Propaganda, il 13 marzo incontra a Berlino i professionisti del cinema, dichiarando tra l’altro: «Il gusto del pubblico non è quello che si immagina la coscienza di un regista ebreo. (…) Noi non vogliamo ostacolare il cinema e tantomeno porre dei limiti ai suoi creatori. Noi rifiutiamo il dogmatismo autoritario. (…) L’arte è libera e deve restare libera, pur rispettando alcune regole». Il Ministro aggiunge di aver apprezzato La corazzata Potëmkin, Anna Karenina, Der Rebell di Kurt Bernhardt e Luis Trenker, I Nibelunghi di Lang, ma il 29 marzo proibisce le due versioni del secondo Mabuse. Lo stesso giorno il consiglio di amministrazione dell’UFA decide di annullare i contratti con i collaboratori ebrei. Il 30 marzo viene inaugurato il campo di concentramento di Dachau, mentre Fritz Lang è convocato da Goebbels, che gli offre una posizione dirigenziale nell’industria cinematografica. Il regista accetta, ma poche ore dopo – senza neanche passare in banca – lascia il Paese e tutte le sue proprietà. Due progetti annunciati – Die Legende vom letzen Wiener Fiaker (t.l. La leggenda dell’ultima carrozza di Vienna) e Himmel über Deutschland (t.l. Il cielo sopra la Germania) – non saranno mai realizzati. Né Gerda né Thea lo seguono a Parigi. Liliom, scritto con Robert Liebmann e ispirato al testo teatrale omonimo di Ferenc Molnar, scrittore ungherese di origine israelita, è girato in Francia e prodotto da Erich Pommer per la Fox-Europa. Nel clima di incertezza e distacco dalle proprie radici, il regista ricorre a un testo molto popolare da cui la Fox aveva tratto, nel 1930, una pellicola diretta da Frank Borzage. La sua versione tuttavia non ha successo: il pubblico chiedeva un dramma e si trova di fronte a una tragicommedia. La vicenda poetica di Liliom, nel suo rifiuto della realtà e di ogni ideologia, nasce e si svolge sull’orizzonte demoniaco del Terzo Reich. Il sorriso del grande tentatore Goebbels aleggia ovunque e Lang viene raggiunto in Francia dalla notizia che Thea ha chiesto il divorzio. Le peripezie del piccolo imbonitore da fiera, candido e impetuoso, non hanno proprio niente a che fare con i giochi del macabro seduttore Mabuse. La scena iniziale del luna park dura ben ventidue minuti, e si sentono. Boyer gigioneggia, si imbroncia e sfarfalla sul set – rigidamente teatrale – allestito negli Studios des Reservoirs di Parigi. Migliore la seconda parte, soprattutto dopo la morte del protagonista. Al capezzale simbolico di Liliom, Lang ritrova l’ispirazione. Muscat ordina che si fermino la giostra e i giochi, perché Liliom sta spirando. Madame Menoux sistema due candele ai lati del lettuccio, da cui il moribondo sembra quasi resuscitare quando la coppia angelica lo porta a braccetto in cielo. Il guscio mortale resta in basso e i tre volano sulla città: brillano le luci di Parigi, ecco le nuvole, i pianeti, il valzer del firmamento. Ecco gli angioletti che suonano e cantano su cirri di cotone, protetti da un grande arcobaleno. Una stella a cinque punte diventa un mascherino, quindi una porta, quella del Commissariato. In Cielo è vietato fumare, non si può flirtare, anzi ti opprimono con la burocrazia e ti fanno persino rivedere uno dei tuoi momenti peggiori. In queste trovate c’è un Lang spiritoso e irriverente che sa far sue le lezioni di Molnar e di Lubitsch. Lubitsch, a sua volta, si ricorderà del Liliom di Lang per Il cielo può attendere (Heaven Can Wait, 1943). L’imbonitore parigino infatti è uno schlemiel, un minuscolo ebreo errante che si è perduto fra le galassie. Con la capacità di adattamento tipica di ogni grande viaggiatore, egli sa estrarre linfa e allegria anche da un luogo noioso come il commissariato celeste. Parafrasando il dramma di Toller (1927): oplà, noi viviamo! SOLO, LONTANO «Lontano è ciò che è stato e profondo il profondo; chi potrebbe raggiungerlo?» Ecclesiaste 7, 24
Fury (Furia)
Chicago. Joe Wheeler (Spencer Tracy) e Katherine Grant (Sylvia Sidney) guardano uno splendido abito nuziale in vetrina: sono innamorati, si baciano sotto la pioggia. Alla stazione l’uomo le consegna un souvenir e lei, in cambio, una fede matrimoniale con dedica appartenuta a sua madre (fot. 44). Partita la ragazza, Joe si sente solo e torna a casa, dove litiga con il fratello Charlie (Frank Albertson). Kate riceve una lettera del fidanzato, da cui viene a sapere che Joe ha acquistato un garage con i suoi fratelli, Charlie e Tom (George Walcott), e un’altra dove l’uomo parla di matrimonio accludendo una foto con l’automobile nuova. Joe parte per raggiungere Kate e sposarla, ma a Strand, località dell’Ovest, viene fermato dalla polizia, che sta cercando i rapitori della piccola Helen Peabody. Joe è sospettato, essendo un mangiatore di noccioline: la lettera che chiede il riscatto di Helen infatti reca tracce di sale e frammenti di arachidi. Lo sceriffo (Edward Ellis) trova nelle tasche di Joe un biglietto da cinque dollari con il numero di serie delle banconote del riscatto. Joe viene arrestato, quindi non giunge all’appuntamento con Kate.
FOT. 44
Nella bottega di barbiere, “Bugs” Mayers, assistente dello sceriffo, si lascia sfuggire la notizia che forse è stato trovato uno dei rapitori. I clienti discutono sugli impulsi che spingono l’uomo a commettere azioni criminose. Poi, uno dei due barbieri telefona alla moglie narrandole gli sviluppi del caso Peabody. La donna lo dice a un’amica e presto tutto il paese è al corrente. Un comitato di cittadini – di cui fa parte Kirby Dawson (Bruce Cabot), un losco individuo – accusa lo sceriffo di proteggere Joe. Alcune pietre lanciate dall’esterno spezzano i vetri delle finestre: la situazione si fa tesa e lo sceriffo avverte il Governatore. Intanto dal bar i cittadini si dirigono in massa verso l’ufficio dello sceriffo, chiedendo di parlare al prigioniero. Lo sceriffo rifiuta, dicendo che il caso è di competenza del procuratore distrettuale. Chiede l’intervento della guardia nazionale. Questa non arriverà, perché il Ministro ha deciso che un provvedimento simile, in un anno di elezioni, sarebbe un suicidio politico. La folla urla, lanciando pietre e pomodori. Kate sta ancora aspettando Joe: il barista racconta che lì vicino hanno arrestato un tale di nome Joe Wheeler. Intanto la folla abbatte la porta, disarma i poliziotti, dà fuoco all’edificio e fa esplodere della dinamite, rendendo felici i giornalisti e gli inviati dei cinegiornali. Joe è in trappola, ma viene raggiunto in cella dalla cagnetta Rainbow (fot. 45). Kate sviene in mezzo alla folla. Il Governatore, inferocito, parla con il Ministro e questi cinicamente conclude: «Ah, non prendertela. L’opposizione griderà un po’ allo scandalo, poi passerà a occuparsi d’altro». La polizia arresta la banda dei veri rapitori, la folla ha ucciso un innocente. Joe riappare improvvisamente (fot. 46) e, in un colloquio con i fratelli, annuncia di voler restare nell’anonimato, perché intende vendicarsi facendo accusare gli autori del linciaggio. Anche la fidanzata dovrà continuare a crederlo morto.
FOT. 45
FOT. 46
Il processo si svolge a Capitol City ed è radiotrasmesso: i media ne sfruttano l’eco sociale. Una delle prove d’accusa è un documentario in cui si riconoscono alcuni dei ventidue imputati e Kate testimonia di aver visto bruciare vivo il fidanzato, ma il cadavere non si trova. I giornali si chiedono: «È vivo quest’uomo?». Da alcuni indizi (l’impermeabile, la fede nuziale) Kate intuisce che Joe vive. Seguendo i fratelli, arriva fino a lui: «Se quella gente muore, anche Joe Wheeler sarà morto, e io non potrò sposarti». La giuria condanna tutti gli imputati, ma l’ingresso di Joe salva loro la vita.
Il primo giugno del 1934 Lang incontra David O. Selznick a Londra e si accorda per realizzare un film alla MGM. Cinque giorni dopo si imbarca sull’“Île de France”, qualche settimana più tardi è a Los Angeles: studia l’inglese, viaggia in automobile, legge molti giornali e fumetti. Scrive, inoltre, una sceneggiatura ispirata al Dottor Jekyll e Mr. Hyde di Robert Louis Stevenson. The Man Behind You (L’altro che c’è in noi, 1935) narra del famoso penalista Edward Moran, convinto che in ogni essere umano esista un’eredità atavica repressa da secoli di civiltà. Verso gli infelici «spinti a commettere certe azioni da una forza interiore che per un momento prende il sopravvento», Moran invoca la clemenza della società, tenuta a giudicarli secondo criteri diversi da quelli applicati ai comuni criminali. L’avvocato ben presto scopre dentro di sé la stessa componente oscura, smascherata dall’ambiguo professor Smith, che cerca la verità nei bassifondi, spacciando una droga sudamericana detta Monolak. L’impulso naturale, che tiranneggiava Becker (M) e caratterizzava Mabuse, conduce Moran alla follia. Ed è proprio una constatazione di Smith a gettare il ponte fra vecchio e nuovo mondo: «In Europa, dove la civiltà è più antica, il vizio e la dissolutezza sono tollerati per quello che sono, con meno isterismi». Il protagonista di Fury (Furia, 1936; titolo provvisorio Mob Rule, La legge della folla), primo film americano di Lang, è un pacifico borghese che rispetta le convenzioni, un anglosassone semplice e onesto. Appena salutata Kate alla stazione, si imbatte nel cane randagio che poi adotterà: «Tu sei proprio come sono io, piccolo e solo», commenta. I temi della solitudine e della fragilità non sono nuovi in Lang, ma nelle ultime pellicole europee acquistano un altro significato. La ragazza di Der müde Tod, la regina Crimilde (I Nibelunghi) e la profetessa Maria (Metropolis) compongono una trinità muliebre in cui solitudine e fragilità si trasformano in forza, desiderio di riscatto, pulsione eroica. La solitudine di Mabuse è quella superba dello scienziato, dell’artista, del despota. Diverse le situazioni del mostro di M e del malinconico lestofante Liliom: incerti, tremebondi, facile preda delle emozioni, di un’umanità che diventa destino. Jedermann e lo schlemiel, combinati con le nevrosi americane, producono il “Joe Doe” Wheeler, l’uomo comune d’oltreoceano. In Furia tuttavia emergono con prepotenza quattro temi strettamente connessi: il valore della legge, il potere dell’inconscio, il cinismo dei politici e dei media, la bestialità della folla. In mezzo a tutto questo il nostro Joe, piccolo e solo, decide di farsi giustizia da sé. Wheeler è un puritano ortodosso, confida nell’Antico Testamento, crede nella formula per cui «chi uccide sarà a sua volta privato della vita». La dinamite ha scardinato la porta della cella, uccidendo la coraggiosa cagnetta Rainbow (abile stoccata al cuore del pubblico statunitense), e Joe si è salvato calandosi per una grondaia: sente ancora l’odore della sua carne bruciata. Lang inserì nel film brevi scene con afroamericani che, ascoltando gli avvenimenti radiotrasmessi, implicitamente condannavano la pratica del linciaggio: furono tutte tagliate dalla produzione. Il protagonista riesce a vendicarsi dei malvagi
abitanti del villaggio emblematico di Strand (to strand = arenarsi, mettersi nei guai; strand = lido o sponda) portandone ben ventidue in tribunale. Qui Furia diventa un classico courtroom drama, svolgendosi l’azione quasi esclusivamente nello spazio chiuso, e teatrale, dell’aula di giustizia. I mass media seguono il processo con accanimento (fot. 47, sia Hawks che Wilder se ne ricorderanno nella Ragazza del venerdì e Un asso nella manica), i colpevoli stanno per essere puniti, ma ecco il colpo di scena. Joe entra in aula e si rivolge al giudice con accenti di perdono, concludendo: «Se sono qui è solo per me stesso. Era diventata un’ossessione, non c’era minuto della mia giornata in cui non pensassi a loro (gli imputati) e non volevo credere a Katherine quando…». Kate infatti è un’altra Maria, una delle «meravigliose ragazze comprensive» che appaiono nelle opere del regista. Eppure non è disinteressata: convince Joe a recarsi dal giudice perché questa è l’unica possibilità che hanno di iniziare una vita insieme. Quindi Kate è anche una fanciulla del tipo: e a me cosa ne viene? Quando si dice la genialità di Lang (fot. 48).
FOT. 47
FOT. 48
Fritz, uno degli austro-tedeschi di Hollywood (ci sono, tra gli altri, Stroheim, Sternberg, Wilder, Lorre, Preminger, Lubitsch, Pabst, Erich Pommer e Joe May), sfiora subito alcune ferite aperte della società americana e, lavorando con lo sceneggiatore Bartlett Cormack, realizza in Fury una solida convergenza di schemi. Il suo perfezionismo, deprecato dai produttori, le notevoli qualità di osservatore e l’isolamento reale dell’immigrato si fondono con elementi importanti, quali il refrain tecnico delle inquadrature dall’interno di una vetrina, quelli tematici del rapimento di una bambina e del processo (già in M), di lettere, manifesti e titoli di quotidiani usati come didascalie, del potenziale occulto dei media (Il testamento del dottor Mabuse), della mitica forma circolare (l’anello di Kate), del destino, della vendetta e dell’improbabile perdono. Nel viaggio dalla Germania agli Stati Uniti il superuomo si trasforma definitivamente in uomo qualunque, la vocazione architettonica langhiana si trasferisce dal set ai corpi degli attori. Il regista passa dal teatro alla strada, dalla saga alla cronaca, dalla dittatura alla presunta democrazia, dall’ubiquo leader autocratico che non può sbagliare (Haghi e Mabuse, occhio totale cinematografico simile a quello divino) al signore della porta accanto, con il suo punto di vista limitato e ristretto, necessariamente banale ma universale. La modificazione è anche stilistica: dall’arte/artigianato al prodotto industriale illuminato. Perciò niente paganesimi o scenografie trionfal-mesopotamiche e kolossal, quanto lo sguardo del reporter, lo spettacolo della realtà senza veli o illusioni. Se nei film tedeschi è il singolo a governare la folla, in America il rapporto si inverte: qui la massa decide il fato dell’individuo.
You Only Live Once (Sono innocente!) Joan Graham (Sylvia Sidney) si reca all’appuntamento con il ladro Eddie Taylor (Henry Fonda), uscito dal carcere per la terza volta: una di più e le leggi dello Stato gli imporranno l’ergastolo. Appena fuori, Eddie sposa la ragazza. I due trascorrono una breve luna di miele all’albergo Valley Tavern e visitano la casetta che stanno acquistando a rate. Eddie trova impiego come autista della Ajax Express, ma per un’ora sola di ritardo Williams, il proprietario, lo licenzia su due piedi. Il protagonista incontra un amico, a casa del quale dimentica il cappello, telefona alla moglie (lavorano in città diverse), poi tenta di farsi riassumere, ma Williams rifiuta. Eddie, esasperato, lo stende con un destro. Un uomo mascherato assale il furgone che trasporta i valori della Fifth National Bank, lasciando sul luogo il cappello di Eddie. Nella fuga sbanda ed esce di strada. I giornali riferiscono che la rapina è costata sei morti e un milione di dollari. Eddie viene arrestato in casa della moglie, scampando per miracolo all’ira della folla. Il suo difensore è Stephen Whitney (Barton MacLane), l’avvocato per cui lavora Joan. Pur proclamandosi innocente, Eddie riceve una condanna alla pena capitale e dopo cinque mesi trascorsi nel braccio della morte chiede alla consorte di portargli una pistola, che padre Dolan (William Gargan) riesce tuttavia a intercettare (fot. 49). Il protagonista inscena un suicidio, aggredisce i secondini e viene chiuso in cella d’isolamento, dov’è nascosta un’altra pistola, con cui prende in ostaggio il dottore. Durante un colloquio fra Eddie e il direttore del penitenziario, il telegrafo comunica che la polizia ha trovato il vero colpevole, l’amico di Taylor, dentro il furgone della rapina. Washington concede la grazia a Eddie che, non credendoci, evade sparando a padre Dolan. Ferito, il fuggitivo scopre che la grazia era autentica e telefona alla moglie, che lo raggiunge con l’automobile di Whitney. Minacciata da una taglia che sale da cinquemila a diecimila dollari, la coppia tiene sotto tiro i benzinai, ma viene accusata di furti non commessi. Joan, incinta, partorisce un maschio in una capanna lungo la strada, dove arrivano l’avvocato e la sorella Bonnie, a cui affida il neonato, ma a sei miglia dalla frontiera canadese la riconoscono mentre compra un pacchetto di sigarette. Moglie e marito superano un posto di blocco, vengono inseguiti e uccisi.
FOT. 49
Dopo le tensioni nate sul set di Fury – a causa del protagonista Spencer Tracy e soprattutto del produttore Joseph L. Mankiewicz, che giudicando mediocre il dialogo si mise a riscriverlo – Lang passa alla United Artists e realizza You Only Live Once (Sono innocente!, 1937), basato su un soggetto di Gene Towne vagamente ispirato alle gesta dei noti fuorilegge Bonnie Parker e Clyde Barrow. Nello stesso periodo il regista partecipa, con altri immigrati, alla creazione della Lega Antinazista. Il contatto con la democrazia americana e i primi lavori oltreoceano tuttavia non sono facili per Lang. L’episodio che nel film introduce la storia di Eddie e Joan è emblematico. In tribunale un fruttivendolo dal marcato accento tedesco parla con Joan, segretaria del pubblico difensore. L’uomo vuole denunciare un poliziotto che ogni giorno gli prende una mela senza pagare. Mentre i due discutono, un agente entra nell’ufficio e addenta una delle mele che il fruttivendolo ha posto sul tavolo (fot. 50). Questa l’ironia moderata di Sono innocente!. Per il resto si tratta di un’opera che l’autore stesso definisce «un po’ costruita», dove si sfrutta l’eco del buon successo di Fury. La pubblicità della United Artists infatti annunciava, regia: Fritz (FURY) Lang.
FOT. 50
In questa non troppo velata critica della società americana, Lang usa come esca il sentimentalismo (fot. 51). Due rane nuotano nel laghetto del Valley Tavern. «Se una muore, muore anche l’altra: non possono vivere separate», sussurra Eddie a Joan e i loro volti si riflettono nell’acqua. La canzone che funge da tema conduttore si intitola «A Thousand Dreams of You», mentre Padre Dolan aggiunge una coloritura lirica: «Ogni uomo, quando nasce, è generoso e nobile come un principe. Poi il contatto con il mondo gli fa subito dimenticare la sua origine. Forse per questo è stata creata la morte: per darci un’altra occasione di ricordare quello che siamo prima di rinascere». Ambigua sentenza, che addirittura cita – in un contesto estraneo – gli accenti gotici di Der müde Tod. Nel finale gli sposini banditi parlano d’amore guardando la Stella del Mattino. Poco dopo Joan viene ferita da un poliziotto del posto di blocco. Eddie la prende in braccio ed entra nel bosco, dove il mirino telescopico di un fucile innesca la suspense necessaria a ritardare l’esito (fot. 52): sparerà o non sparerà? Eddie viene ucciso e Joan spira all’unisono, dicendo: «Lo rifarei con gioia!».
FOT. 51
FOT. 52
You and Me (Id.) Il proprietario di un grande magazzino ha l’abitudine di assumere detenuti in libertà condizionata. Fra essi c’è Joe Dennis (George Raft), che ama Helen Roberts (Sylvia Sidney) e la sposa in segreto, poiché il signor Morris non vuole ammogliati nel personale. Quando Joe viene a sapere che la consorte gli ha mentito, essendo anch’essa in libertà sulla parola, decide di trascorrere il Natale con i vecchi compagni, ancora nel giro della malavita. Questi gli propongono di rapinare il magazzino. Helen li sorprende durante l’impresa e matematicamente dimostra che il crimine non paga. I lestofanti pentiti assistono alla nascita del figlio di Helen e Joe.
No, non sono angeli i protagonisti di You and Me (t.l. Tu e io, 1938), anzi concludono la cosiddetta trilogia «della critica sociale» o «del film carcerario». Queste definizioni importanti mal si addicono
al testo agile e spiritoso, ispirato a un soggetto di Norman Krasna, e tantomeno al ritmo vivace dell’unica commedia americana di Lang. You and Me è una garbata replica dei temi proposti con vigore in Furia e Sono innocente!: l’America anni Trenta, pregiudizi, disoccupazione, poliziotti, rivolte, la prigione. Un omaggio al grande fotografo newyorchese Paul Strand, che proprio in quegli anni svolgeva una ricognizione delle realtà economiche del Paese in forma drammatica, per realizzare «un’opera diretta, comprensibile a tutti». Non è un caso che in Furia il villaggio si chiami, appunto, Strand. Lang recupera il titolo originale dell’opera precedente, quel «si vive solo una volta» che fa rima con c’era una volta e, aggiungendo alcune canzoni orecchiabili, definisce l’ossatura leggera del film. L’esempio di Brecht è evidente, non tanto grazie a Kurt Weill, che se ne andò a metà delle riprese, quanto per le intenzioni – mancate – di Lang: «Non penso che You and Me sia un buon film. È in realtà il mio primo vero fiasco. L’ho diretto probabilmente sotto l’influenza del mio amico Bertolt Brecht, che aveva creato un genere teatrale epico, il Lehrstück, la commedia didattica. Volevo fare un film che insegnasse al pubblico come il crimine non paghi, vale a dire una menzogna, perché il crimine paga molto bene». La canzone composta da Weill suona così: «Non puoi avere niente per niente, devi pagare./ Ti piacerebbe avere questo bel braccialetto, non è vero? O forse questa gemma scintillante?/ Ricorda, non possono essere tuoi, finché non li paghi./ Non puoi avere niente per niente (…)/ Il vino che ci rinvigorisce, dobbiamo pagarlo./ Le macchine su cui viaggiamo, dobbiamo pagarle./ Il cibo per vivere, dobbiamo comprarlo./ Tu devi sborsare i quattrini, i baiocchi (…)». You and Me illustra, divertendo, alcuni temi fondamentali dell’esistenza. Questo significa la scenetta dei detenuti che, aspettando Natale, rimpiangono da fuori il sogno della libertà e i desideri inappagati che rendevano il carcere meraviglioso. Lang tuttavia dialoga con un pubblico poco abituato a cercare in una commedia dei significati profondi. La politica hollywoodiana dei generi ha un effetto, la sua favola didattica non piace. The Return of Frank James (Il vendicatore di Jess il bandito) Nell’ultima scena del film Jesse James (Jess il bandito, 1938) di Henry King, Jesse James (Tyrone Power) è ucciso a tradimento da Bob Ford mentre appende un quadro alla parete. Frank James (Henry Fonda), che si fa chiamare Ben Woodson e vive in una fattoria del Missouri, apprende dai giornali la notizia dell’assassinio del fratello. Condannato all’impiccagione, Bob Ford ottiene la grazia dal Governatore, spingendo Frank alla vendetta. Dissepolto il revolver, quest’ultimo si reca nella cittadina di Liberty, dove il maggiore Rufus Todd (Henry Hull), direttore della gazzetta locale, gli riferisce che i fratelli Ford sono passati da poco, diretti a Ovest. Il protagonista rapina un ufficio ferroviario, ma l’arrivo improvviso del figlioccio Clem (Jackie Cooper) provoca la morte dell’impiegato. Ricercati dalla legge, perseguitati da una taglia, i due organizzano un finto incontro pubblico in cui il più giovane racconta all’altro di aver assistito alla morte di Frank James, in Messico. Eleanor Stone (Gene Tierney), graziosa giornalista e figlia del proprietario del «Denver Star», intervista Clem, che ovviamente inventa tutto, e suscita l’interesse di Frank. Charlie e Bob Ford (John Carradine) hanno allestito uno spettacolo che narra la morte di Jesse James. L’intervento di Frank causa l’incendio del teatro e la fuga dei fratelli, il meno noto dei quali perisce cadendo in un burrone. Intanto Eleanor ha saputo da McCoy (Donald Meek), dirigente della Saint Louis Railroad, che Woodson e Frank James sono la stessa persona. La ragazza ottiene un appuntamento con il bandito, informandolo che il fido bracciante nero Pinky (Ernest Whitman) è stato accusato di complicità nell’assassinio compiuto da Frank e rischia l’impiccagione. Quindi entra Clem dicendo di sapere dov’è Bob Ford. Frank decide di lasciar scappare Bob per salvare il nero e, al termine di una lunga cavalcata, arriva con Clem alla stazione di Eldora: fa fermare un treno merci e raggiunge Liberty, Clay County, luogo del processo a Pinky. Qui viene arrestato e portato in tribunale, dove Rufus Todd dimostra che la morte dell’impiegato è dovuta a un incidente. Inaspettatamente compare Bob Ford che ascolta, beffardo, il verdetto della giuria: innocente! In strada si compie il destino di Bob, ma anche quello di Clem: entrambi muoiono nella sparatoria. Frank, che ha vendicato Jesse, può pensare adesso all’amore.
«Tra il sorriso di una donna e l’amore c’è soltanto un passettino», scrive Lang in Men Without a
Country (Uomini senza patria, 1939). Questo soggetto per la Paramount, realizzato in collaborazione con Jonathan Latimer, è una spy story che rievoca il mondo di Haghi e di Mabuse. Alla fine il super-criminale Gwyn Ellis, arrestato dalla polizia, viene trovato «accucciato come una bestia nel più remoto angolo della cella», dove cerca di barricarsi, ostinatamente muto. L’avventuriera May e il simpatico Mr. Banks, i due eroi giovani, ben poco hanno da spartire – se non la storia d’amore – con i protagonisti di Superstitions Mountains (La montagna della superstizione, 1939), una sceneggiatura che il regista curò a lungo, documentandosi sul Sudovest americano. Il titolo provvisorio, L’oro maledetto dell’Olandese, e una breve introduzione di Lang («molti degli eventi narrati in questa storia sono tratti da vecchi ritagli di giornali, racconti di testimoni e atti giudiziari») ci dicono già qualcosa delle intenzioni di questo western atipico. Il MacGuffin langhiano è una miniera d’oro dell’Arizona, trovata e perduta nel 1848 dal comandante don Pedro Peralta, di cui esiste una mappa su pergamena ingiallita che tutti vorrebbero e pochi hanno visto. Si dice che due immigrati tedeschi, Jacob Waltz detto l’Olandese e il suo compare Jacob Wiser, abbiano individuato e sfruttato brevemente la ricca vena aurifera, ma la maledizione degli indiani apache brucia come il sole implacabile delle Superstitions Mountains. Nessuno ha goduto il metallo prezioso, perché tra guglie di pietra e aridi crepacci dimorano gli dei del Tuono. Gli spagnoli hanno inciso sul nero macigno fatale una doppia circonferenza, dal cui centro si dipartono a raggiera delle linee rette (una ruota). Dopo Waltz e Wiser (nomi a specchio, emblematici quant’altri mai), la leggenda della «Miniera perduta dell’Olandese» ha fatto numerose vittime, ma la febbre dell’oro è una malattia incurabile: vi sono caduti molti Joe Doe e il protagonista Jim Webster (web = rete, ragnatela, trappola) non fa eccezione. Jim ha un amico, il maturo Lorenzo, che colleziona arte indigena e non ha mai mancato alla parola data a un nativo. Il suo negozio è «il punto d’incontro dei vecchi del luogo e le storie che vi si raccontano sono tali da creare un bel complesso di inferiorità nell’anima di qualunque scrittore di professione». Tra antichi tappeti navajo, monili d’argento, bambole hopi e ceste intrecciate, proprio lì nasce la saga, l’epopea del West. Che importa se Jim, nel finale, dà fuoco alla mappa e sceglie di tornare da Ann? La ruota gira, ripete nel tempo «la fame rapace dell’oro, il tradimento, l’assassinio, la morte e l’amore». Storia splendida mai realizzata, che si ispira indirettamente al romanzo Der Schatz der Sierra Madre (1927) dello scrittore americano di lingua tedesca Ben Traven, da cui John Huston ricaverà nel ’47 The Treasure of the Sierra Madre, un capolavoro del cinema avventuroso. Superstitions Mountains, coacervo di temi langhiani, vale al regista un contratto con la Fox di Darryl F. Zanuck, quello per The Return of Frank James (Il vendicatore di Jess il bandito, 1940). Lang affronta per la prima volta sia il colore che il western, ma lo fa a modo suo, considerando questo genere cinematografico l’equivalente del ciclo teutonico dei Nibelunghi, a cui affianca il West immaginato dal romanziere tedesco Karl May. The Return of Frank James – che costituisce il seguito del film di King – non ha niente delle atmosfere accattivanti della sceneggiatura Superstitions Mountains. Anzi, è un’opera di passaggio e sperimentazione. L’intreccio banale, insieme alle direttive del produttore-dittatore Zanuck, che tutti temono, non impediscono a Lang di familiarizzarsi con la tecnica del colore. Si diverte visitando un teatro d’epoca a Tombstone, entra in un palco e si chiede se è abbastanza nascosto al pubblico perché una ballerina e un cowboy possano farvi l’amore, attraversa in automobile il Sudovest. Tutto inizia il 3 aprile 1882, quando Jesse James, uno dei fuorilegge più celebrati del West, è colpito alle spalle dal maligno Bob Ford. La ballata di Frank, fratello nascosto dell’eroe leggendario, si nutre di un’epica scarna e sbrigativa. Vive sotto il falso nome di Woodson (= figlio del bosco), che adombra il suo destino, quello di un Robin Hood vendicatore della memoria aurea di Jesse. Nonostante gli inseguimenti e le cavalcate spettacolari, la Storia narrata nel film è essenzialmente un gioco teatrale. Questo West è un’invenzione, sembra dire il regista, e una fantasticheria romantica, come la recita di Clem che sceneggia la falsa morte di Frank. La leggenda è in effetti una serie di
quadri e reperti oleografici, un corpus di interviste con illustri mentitori (complici i giornalisti della frontiera), una balla colossale. Per questo la geografia del territorio è un’opinione riassunta in coloratissime galoppate, per questo il processo è una farsa e il film si conclude nella redazione della «Liberty Gazette». Qui il maggiore Todd osserva, al di là della vetrata, Eleanor e Frank che si congedano per strada. La macchina da presa li lascia (si sono detti soltanto arrivederci) per indugiare su un dilavato e lacero avviso di taglia: 5.000 dollari per la testa di Jesse e Frank James, svaligiatori di treni. Western Union (Fred il ribelle) Vance Shaw (Randolph Scott) salva l’ingegnere Edward Creighton (Dean Jagger), che si è ferito individuando i punti di passaggio di una nuova linea telegrafica tra Omaha e Salt Lake City. Quest’ultimo offre a Vance un lavoro per la Western Union, che consiste nel proteggere gli operai dagli attacchi indiani. Creighton ha capito che l’altro è un bandito, ma crede nella sua fondamentale onestà. Vance corteggia Sue (Virginia Gilmore), sorella dell’ingegnere, e trova un rivale in Richard Blake (Robert Young), il piedidolci. Durante la costruzione della linea un uomo viene ucciso e un altro ferito dai pellerossa, i quali sono in realtà dei fuorilegge travestiti, guidati da Jack Slade (Barton MacLane). È la vecchia banda di Shaw che, pur avendolo ritrovato, lo lascia in pace. Un giorno Sue inaspettatamente si dichiara a Vance, donandogli un medaglione con il suo ritratto. Indiani ubriachi attaccano le maestranze della Western Union. Creighton, Shaw e Blake fanno passare corrente nei fili e gli indigeni, toccandoli, si convincono del potere del telegrafo. Poi Blake, innervosito, ne uccide uno. La tribù si scatena e i banditi ne approfittano per razziare il bestiame di Creighton. Spinto da vecchi e nuovi rancori Slade fa prigioniero Shaw, dando fuoco al campo. Liberatosi, Vance non vuol dire a Creighton dov’era nel corso dell’incendio. Licenziato, si trasferisce in città per il duello finale. Slade, che in realtà è suo fratello, lo uccide sparandogli alle spalle e Blake lo vendica. La Western Union intanto è riuscita nell’impresa.
«Caro signor Lang, abbiamo visto Western Union e questo film descrive il West molto meglio dei migliori film che sono stati fatti sul West». Chi scrive è un club di veterani di Flagstaff, Arizona. Eppure del romanzo di Zane Grey da cui Western Union (Fred il ribelle, 1941) è tratto non resta quasi niente. Lang – che a Hollywood è più o meno un cineasta indipendente, impegnato volta per volta con le case di produzione – realizza alla Twentieth Century-Fox anche il suo secondo western. Intanto Brecht è arrivato negli Stati Uniti grazie a un fondo speciale raccolto da Lang e Lily Latté. Il Technicolor accurato, la consulenza di esperti del folclore indiano, i “tocchi di regia” creano, in Western Union, l’illusione e il sogno della frontiera. Il vero protagonista dell’avventura, l’ingegnere responsabile della costruzione della linea in mezzo a un paese ancora selvaggio, era sposato e aveva sette bambini. Gli ostacoli da superare, in realtà, furono soltanto le zecche dei bisonti, che spingevano gli animali a grattarsi contro i pali telegrafici facendoli cadere. Il resto è sceneggiatura. Dati gli sforzi del regista per rendere verosimile e insieme romantico il West (Lang visse per un periodo con gli Hopi e i Navajo, ma i pellerossa nel film sono ancora psicologicamente indifferenziati e fungono da catalizzatori dell’occhio nel paesaggio), scontate le angherie di Zanuck (che fece dipingere di giallo e viola i carri della Compagnia perché questi erano i colori del modulo dei telegrammi), Western Union risulta adulterato come altri western dell’epoca, più chiaramente “falsi” e teatrali. Lo storico Ovest dei pionieri si riduce a una cartolina davanti alla vigorosa intuizione dei due fratelli nemici. Slade e Shaw sembrano personaggi di Stevenson (The Master of Ballantrae), come Waltz e Wiser di Superstitions Mountains replicano il vecchio tema langhiano del doppio e della fatale attrazione del male. Cifre di un mistero identico su entrambe le sponde dell’oceano. Man Hunt (Duello mortale) «Somewhere in Germany. Shortly before the War». In un bosco che sovrasta una residenza alpestre di Hitler (si allude alla Hütte di Berchtesgaden) il capitano Alan Thorndike (Walter Pidgeon) coglie nel mirino telescopico l’immagine del dittatore, ma non spara (fot. 53). Prima che possa introdurre il proiettile nella canna del fucile un SS lo scopre. Lottano, Thorndike viene catturato. Un azzimato ufficiale con monocolo
(George Sanders) lo interroga e Thorndike – noto cacciatore, fratello di un Lord, inviato dal Primo Ministro britannico in missione di pace – spiega che la sua intenzione era sportiva: voleva «stanare la preda», nient’altro. Il tedesco replica consigliandogli di sottoscrivere un documento in cui si dichiara sicario del governo inglese. Thorndike rifiuta, viene torturato e condannato a morte. Un medico nazista lo spinge in un burrone, ma il protagonista si salva e raggiunge un porto, dove sale su un cargo danese con destinazione Londra. Sulla nave il giovane mozzo inglese Vaner (Roddy McDowall) lo aiuta a nascondersi durante un’ispezione della Gestapo. Il comandante non sa che il fuggiasco è a bordo e accetta di buon grado un passeggero pagante: Mr. Thorndike, in realtà Jones (John Carradine), una spia tedesca. Appena arrivato a Londra il vero Thorndike cade in un agguato degli uomini di Jones e chiede aiuto a una ragazza incontrata per strada, Jenny Stokes (Joan Bennett), che lo nasconde con riluttanza ma poi gli presta dieci scellini per il taxi. Insieme raggiungono l’abitazione del fratello di lui, il diplomatico Lord Gerald Risborough. Parlando con Gerald, Alan viene informato che un distinto gentiluomo, il maggiore Quive-Smith (George Sanders), lo sta cercando. Da un dettaglio (porta il monocolo) Thorndike intuisce la verità.
FOT. 53
FOT. 54
Trascorsa castamente la notte a casa di Jenny – che si è innamorata di lui – Thorndike le regala una spilla a forma di freccia (fot. 54), in sostituzione di quella che ha perso, e cinquecento sterline. Jones lo aggredisce in un tunnel della metropolitana (fot. 55) e viene ucciso. Il giorno dopo i giornali riportano che l’uomo assassinato è il capitano Thorndike. Alan rivede Jenny e le chiede di aiutarlo a mantenere i contatti con Gerald, perché è ricercato dalla polizia e ha deciso di “sparire” per tre settimane. Quando lei rientra nell’appartamento, vi trova Quive-Smith con tre complici. I tedeschi apprendono dalla ragazza che Alan ha un recapito presso l’ufficio postale di Lyme Regis.
FOT. 55
Vistosi scoperto, il protagonista si rifugia in una grotta nel bosco, vicino a un torrente, e legge una lettera di Quive-Smith, da cui deduce di essere in pericolo. Peggio ancora: il tedesco è già lì e ha chiuso dall’esterno l’entrata della grotta. Thorndike sarà libero solo se firmerà il documento in cui confessa di aver voluto assassinare il Führer per ordine del governo inglese. La confessione legittimerà un’altra dichiarazione di guerra, aggiunge Quive-Smith, in quanto la Germania ha già invaso la Polonia. Con il pretesto di leggere il documento, Alan confeziona in fretta un arco e una freccia usando come punta la spilla di Jenny, oggetto passatogli dal tedesco a riprova della morte della ragazza. Scaduti i quindici minuti concessi da Quive-Smith, l’inglese trafigge la gola del nemico, che prima di morire lo ferisce con un colpo di pistola. Immagini dell’esercito tedesco in Polonia e dei bombardamenti su Londra. Alan in ospedale ricorda i momenti trascorsi con Jenny. Un aereo della RAF lascia il paracadutista Thorndike sopra Berlino. La voce fuori campo conclude: «Un uomo con un fucile di precisione e una grande abilità nell’usarlo stava così penetrando in territorio tedesco. Ma questa volta quell’uomo sapeva bene che il risultato della sua caccia avrebbe potuto cambiare il destino del mondo».
Con Man Hunt (Duello mortale, 1941) Lang non lascia la Fox ma torna a un bianco e nero congeniale, quello delle piogge e dei vapori nordeuropei. La vicenda di Thorndike era originariamente apparsa a puntate sull’«Atlantic Monthly Magazine». Poi l’autore, Geoffrey Household, l’aveva condensata nel romanzo Rogue Male. Pronta la sceneggiatura, Zanuck si era rivolto a John Ford e, dopo il suo rifiuto, a Lang. Il regista, una volta tanto alle prese con un testo già confezionato (dall’eccellente Dudley Nichols), realizza una delle opere migliori del periodo americano. Se gli crediamo quando afferma che Shaw (Western Union), «essendo l’eroe, deve essere ucciso», in Man Hunt viene da chiedersi chi sia effettivamente tale. Il titolo parla di una «caccia all’uomo», dove i cacciatori – inglesi e tedeschi – sono anche preda gli uni degli altri. È il grande gioco dello spionaggio e della guerra, chi insegue è seguito, senza scampo, come nelle grandi foreste descritte da James Fenimore Cooper. Il film inizia, tuttavia, in un tranquillo boschetto alpino ricostruito in studio, dove il simpatico Walter Pidgeon si aggira in pantaloni alla zuava, con fare sospetto: quasi subito scopriamo perché. Tutto ruota intorno al quasi, ogni avvenimento nasce da un ritardo impercettibile, da un esiguo scarto temporale che genera suspense. Man Hunt non è solamente un thriller. Nel denso colloquio tra l’ufficiale tedesco e il suo prigioniero Thorndike affiorano elementi diversi. Il primo si rimprovera per non aver considerato «l’eventualità che esistesse un uomo con le doti di un animale da preda». L’inglese sottolinea di aver voluto soltanto pregustare la caccia. Come spesso accade in Lang, gli equivoci – e il fascino – nascono dalla contrapposizione parola-immagine. Se il dialogo ci comunica che Alan è cacciatore e l’altro una preda, l’inquadratura conferma giusto il contrario, perché il maggiore, elegantissimo e gelido, fissa dall’alto l’inglese intrappolato. La rapacità e il superomismo diabolico caratterizzano il ruolo di Sanders, mentre Thorndike è uno sportsman, cioè un amabilissimo dilettante. Il criminale mabusiano deve sempre vedersela con un blando rappresentante della giustizia, apparentemente fragile perché dotato di un cuore. Nel colloquio si confrontano due ideologie. Il maggiore: Noi stiamo per iniziare una nuova era e lo faremo attraverso la riscoperta delle antiche tradizioni. Alan: Legalizzando i soprusi, la barbarie e la violenza? Il maggiore: Non ci spaventa la distruzione, se serve a creare un mondo nuovo. Alan: Dio lo protegga. Io ho pietà di voi. I temi della solitudine, del sacrificio e della dedizione a una causa, importanti nel film, sono annunciati da un bronzo di San Sebastiano che Lang inserisce proprio fra i due contendenti (fot. 56). La statua del soldato-martire – che sembra chiamare a raccolta le forze del bene, anche quelle del cattolicesimo romano, contro le nebbie e i barbari guerrieri germanici – ci dice anche, con perfetta, squisita genialità, quale sarà la sorte dell’oppressore e chi brilla, nella vicenda, come autentico eroe.
La freccia scoccata da Thorndike è senz’altro la romantica Jenny (fot. 57). «Devo ammettere che tutto il mio cuore andò a questo personaggio interpretato da Joan Bennett, la piccola prostituta che si innamora di Pidgeon, un amore condannato fin dall’inizio». Anche senza la dichiarazione del regista il ruolo di Jenny appare centrale per molte ragioni. La ragazza risolve magnificamente il contrasto femminile langhiano, che oppone le fanciulle acciaio e veleno, come Lio Sha o Crimilde, all’ambiguo stereotipo di Jane Doe. Jenny è una Sonja (Spione) e una May (Men Without a Country) rivedute e corrette. «In fondo quella freccia ti assomiglia. Anche tu sei fiera e splendente ed è così che ti ricorderò sempre», fantastica Thorndike nel letto d’ospedale. Noi invece ci immaginiamo Jenny torturata e uccisa dagli spietati agenti tedeschi, ed è qui che il regista trionfa: il dardo fatale – simbolo di battaglia e d’amore – alla fine ha deviato, trafiggendo un tenero cuore. La stessa freccia comunque significa caccia e cavalieri celtici sulle orme del drago (Thorndike/Sigfrido, QuiveSmith/Fafner): in questo caso, il nazismo. E non solo. Secondo l’Ufficio Hays (il codice “morale” di Will Hays era entrato in vigore nel 1934), Lang non poteva mostrare né rendere affascinante una prostituta. Il regista si vide costretto a mettere una macchina da cucire in bella evidenza nell’appartamento di Jenny, così che non sembrasse più una puttana, bensì una sartina. La spillafreccia, nell’immaginazione di Lang, probabilmente tallonava anche altri bersagli.
FOT. 56
FOT. 57
Hangmen Also Die! (Anche i boia muoiono) Praga 1942. Siccome gli operai della Skoda non lavorano abbastanza il “Reichsprotektor” Reinhard Heydrich ordina alcune esecuzioni per dare un esempio. Poco dopo viene ferito grave mente in un attentato. I tedeschi proclamano lo stato di emergenza e impongono il coprifuoco. Il dottor Frantisek Svoboda (Brian Donlevy), l’attentatore, viene accolto in casa del professor Stepan Novotny (Walter Brennan), un patriota. Quest’ultimo è preso in ostaggio dalla Gestapo insieme a quattrocento notabili di Praga. Quando si costituirà l’attentatore? Svoboda vorrebbe, ma un amico lo dissuade: «Quattrocento vite che cosa sono mai in questa guerra di milioni di uomini?». Mascha Novotny (Anna Lee) lo prega di salvare la vita di suo padre, quindi si dirige in carrozza verso il comando della Gestapo. Un volantino («Cittadini di Praga, tacete!») la fa riflettere. Poi, spaventata dall’intervento dell’amico di Svoboda, chiama la polizia: subito viene circondata dalla folla, minacciata e ingiuriata. Alla Gestapo, Mascha viene messa a confronto con una testimone dell’attentato che è stata torturata (fot. 58), ma entrambe le donne tacciono. I tedeschi perquisiscono l’abitazione di Novotny e Jan Horak (Dennis O’Keefe), fidanzato di Mascha, è interrogato dall’ispettore Alois Gruber (Alexander Granach).
FOT. 58
Svoboda si fa vivo con la ragazza e, coperto da uno pseudonimo, finge di esserne innamorato. In carcere intanto il poeta Nezval sta scrivendo un poema che diverrà famoso. I membri della Resistenza ceca diffidano di Emil Czaka (Gene Lockhart), ricco birraio e doppiogiochista, quindi lo mettono alla prova raccontando una barzelletta in tedesco. Lui ride, e viene smascherato, ma i poliziotti circondano l’edificio e arrestano i patrioti. Svoboda e Mascha sventano una trappola di Gruber facendosi trovare a letto insieme. L’ispettore invita Jan al Deutsches Kabarett («Vietato l’ingresso ai cechi e ai cani») e tenta di portarlo dalla sua parte. Heydrich spira, le esecuzioni si susseguono ogni due ore, muore anche il capo della Resistenza, ferito in uno scontro a fuoco. Nel ristorante “Alla quaglia d’oro”, Mascha insulta pubblicamente Czaka, facendo in modo che venga sospettato dell’uccisione di Heydrich, poi lo denuncia alla Gestapo, ma viene trattenuta. Mentre la Resistenza persegue l’obbiettivo di eliminare Czaka salvando gli ostaggi, Nezval è giustiziato, Gruber intuisce da una notazione di Jan l’identità dell’attentatore e, legato il giovane, si reca all’ospedale di Svoboda. Qui l’ispettore è soffocato con i cuscini dai patrioti. Jan, che si è liberato e li ha raggiunti, accusa Czaka dell’omicidio. Gli agenti della Gestapo eliminano il birraio, Mascha viene rilasciata. Qualche tempo dopo si scopre che Czaka era innocente. Il nuovo “Reichsprotektor” scorre un documento segreto: «Considerando che un inasprimento del terrore non avrebbe indotto la popolazione a denunciare l’assassino, siamo stati costretti – per non infirmare il principio tedesco di autorità – ad attenerci al partito di riconoscere in Czaka il colpevole e chiudere così le indagini».
Dopo Man Hunt Lang, sotto contratto alla Fox, inizia le riprese di Confirm or Deny (t.l. Conferma o nega), ma un attacco alla cistifellea lo costringe a fermarsi per otto giorni. Così, il film passa ad Archie Mayo. Nel 1942 pensa a un’opera sul celebre pistolero Billy the Kid e lavora per i primi quattro giorni a Moontide (Ondata d’amore), dopodiché viene rimpiazzato dal solito Mayo. Nel 1943 insieme a Oliver H.P. Garrett scrive Hell Afloat (t.l. L’inferno galleggiante), un soggetto basato sull’incendio della «Moor Castle», che viene rifiutato dalla Metro. Infine coglie una buona occasione alla United Artists e – contravvenendo al monito del suo ex persecutore Zanuck («Non faccia vedere troppe svastiche. Non vogliamo vederle in questo paese.») – realizza Hangmen Also Die! (Anche i boia muoiono). Dieci giorni dopo l’attentato a Heydrich, il regista stende insieme a Brecht una scaletta dell’opera. In seguito ci saranno problemi con John Wexley che – nonostante le proteste di Lang e Hanns Eisler – riesce a farsi accreditare come unico autore della sceneggiatura. Com’è diverso il clima cupo di Anche i boia muoiono da quello comico, e polacco, del film antinazista To Be or Not to Be (Vogliamo vivere!), diretto da Lubitsch appena un anno prima, proprio per la United Artists. Forse i produttori si aspettavano da Lang una prova analoga, ma una cosa è certa: all’Ufficio Hays non piacque. «Credete che possiamo approvare un film in cui ogni ceco – implicitamente – viene presentato come un mentitore?», dissero i censori. La polemica si estese alle organizzazioni puritane, che mal tolleravano una così ovvia «giustificazione della menzogna». Lang dovette piegarsi e modificare in parte l’assunto, ma il tocco di Brecht resta e
brucia ancora. Hangmen Also Die! non è un capolavoro. Anzi, si sviluppa tortuosamente e a strappi, seguendo l’intenzione didattica degli autori. Vi troviamo comunque situazioni e personaggi indimenticabili. Così Heydrich, effeminato e feroce, di continuo si tormenta un foruncolo sul viso, mentre il professor Novotny matematicamente illustra la virtù del silenzio: «Di certe cose è meglio non parlare. Ad esempio: tu ne parli ad A, A ne accenna a B, B lo confida a C, C lo dice in segreto a D, che a sua volta è vicino a E e a F, F ne parla a G e G significa Gestapo». Gruber è un ritratto grosziano, come è ambigua e piccante la falsa relazione tra Mascha e Frantisek. Rimangono nella memoria le strade “espressioniste” di Praga, ma anche gli interni gelidi del comando della polizia tedesca, le ombre “sataniche” che avvolgono l’anziana popolana torturata in un modo semplicissimo e radicalmente crudele: facendo cadere tutta la notte una stecca dello schienale di una sedia, per poi chiederle di raccoglierla. Un secondino con la frusta passa e ripassa davanti alla cella della donna, mentre la luce proietta una rete di sbarre all’interno (fot. 59, come non pensare a un’influenza di Lang sul Rossellini di Roma città aperta?). Nella piazza della città vecchia di Praga la statuetta della morte suona, sul celebre orologio, l’ora del funerale di Heydrich e quella dell’esecuzione dei patrioti (fot. 60). Infine il gioco del destino alla «Quaglia d’oro», individuato dai tre tavoli a cui siedono rispettivamente Czaka, una spia di Gruber e Mascha con Svoboda. Le menzogne della Resistenza sono volte al bene.
FOT. 59
FOT. 60
The Woman in the Window (La donna del ritratto) Università di Gotham, Maine. Il criminologo professor Richard Wanley (Edward G. Robinson) tiene una lezione sull’omicidio, i cui gradi devono essere distinti in base alla diversità degli impulsi che l’hanno preceduto (per dovere di chiarezza sulla lavagna è scritto: Sigmund Freud). Inoltre «colui che uccide per legittima difesa non può essere considerato alla stregua dell’uomo che uccide per lucro». Wanley saluta la
moglie e i due figli alla stazione, poi si incammina verso il Club, quando la bellezza di un ritratto di donna esposto in vetrina attira la sua attenzione (fot. 61). Al Club, gli amici Michael Barkstone (Edmond Breon) e Frank Lalor (Raymond Massey) rivelano di conoscere il quadro: l’hanno denominato «La ragazza dei sogni». Insieme discutono sull’opportunità di amori occasionali: Frank, procuratore distrettuale, li sconsiglia, Richard, uomo di mezz’età, dice che per lui tutto si riduce ormai a un sigaro e una buona dormita. Certo – scherzano – se si trattasse di Ginger Rogers, Rita Hayworth o la donna del ritratto! Sono le 22.30. Wanley, fermatosi ancora davanti alla galleria, improvvisamente scorge, proprio accanto alla pittura, riflesso nella vetrina, l’originale in carne e ossa. Lei dice di chiamarsi Alice Reed (Joan Bennett), propone di bere qualcosa e lo invita a casa sua, dove gli mostra alcune prove del ritratto. Ambiente elegante, champagne nei bicchieri. Entra un uomo maturo, robusto, che schiaffeggia la ragazza e aggredisce Richard. La donna passa un paio di forbici al professore e lui pugnala l’energumeno. Il morto era un amante di Alice. Wanley telefona alla polizia, ma riaggancia: in fondo è stata legittima difesa. Il professore, ritrovata la calma, esce nella notte piovosa, prende la propria macchina, viene fermato dalla polizia perché guida a fari spenti, torna da Alice, avvolge il defunto in una coperta, lo infila in automobile, lascia la ragazza («Non ci rivedremo mai più, addio.»), sale in auto e si libera del cadavere in un bosco fuori città. Il giorno dopo, al Club, Frank legge la notizia della scomparsa del noto finanziere Mazard, le cui iniziali corrispondono a quelle che Wanley ha letto sulla catena dell’orologio del morto: C.M. (fot. 62). Barkstone, medico, replica che lo conosceva: un tipo violento, in cura per i nervi. Wanley chiede chi l’ha ucciso, gli amici si stupiscono: nessuno ha detto che è stato assassinato.
FOT. 61
FOT. 62
Un boy-scout trova il cadavere (fot. 63), la polizia indaga, Frank tiene al corrente gli amici degli sviluppi del caso, poi compie un sopralluogo nel bosco, invitando Richard. Quest’ultimo si tradisce ancora dirigendosi senza esitazione sul luogo esatto del ritrovamento. Gli amici ridendo ipotizzano che sia lui l’assassino. L’ispettore Jackson, che guida le indagini, ha condotto lì un’indiziata. Inaspettatamente Alice telefona a Wanley per felicitarsi della promozione a titolare di cattedra (i giornali hanno pubblicato la notizia e una sua foto), poi la ragazza riceve la visita della guardia del corpo di Mazard (Dan Duryea), che la accusa, trova indizi compromettenti, le chiede 5.000 dollari in contanti per tacere (fot. 64). Lei chiama Wanley, che decide di eliminare il ricattatore usando una dose massiccia della polvere per il cuore datagli da Michael.
FOT. 63
FOT. 64
A casa di Alice l’uomo non beve il whisky avvelenato, anzi esige altri 5.000 dollari per il giorno dopo. Richard è disperato, stanco, versa la polvere in un bicchiere d’acqua e si addormenta. La polizia uccide per strada il ricattatore e Alice telefona a Wanley. Troppo tardi? No, Richard si sveglia esattamente alle 22.30, sulla poltrona del Club: è stato tutto un sogno (fot. 65). Uscendo riconosce nell’addetto al guardaroba il finanziere defunto e nel portiere l’astuto ricattatore. Davanti alla galleria una donna lo avvicina, si specchia nella vetrina, accanto al ritratto, chiede un fiammifero. Questa volta il professore se la dà a gambe.
FOT. 65
Lang ormai è cittadino americano e vive in una bella casa di Santa Monica, con la sua collezione di oggetti d’arte primitiva e una biblioteca di oltre cinquemila volumi. L’Europa è lontana, ma la presenza di Brecht probabilmente rievoca la stagione convulsa di Weimar, l’espressionismo, le ragazze dei bistrot e dei cabaret. «Ora, cos’altro è il finale di Caligari – in cui incontriamo persone che abbiamo visto nel “sogno” – se non il finale di The Woman in the Window? E lo feci inconsciamente. Quando mi venne l’idea del film non pensai affatto che stavo copiando me stesso». L’ispirazione nasce da un romanzo di J.H. Wallis, Once Off Guard, che passa allo sceneggiatore Nunnally Johnson, anche produttore del film per la RKO. Quando hai abbassato la guardia può succedere di tutto, se la moglie è in vacanza e sei solo in città, garbatamente insoddisfatto dei tuoi cinquantanni (per Lang sono cinquantaquattro), ecco, può succedere di tutto. Sembra un song di Kurt Weill, e accade a un criminologo in pantofole, un prepensionato a vita come Richard Wanley. Pertanto la ragazza dei desideri si concretizza, anche se – abbiamo detto – è proprio un sogno, non la realtà. Sfogliando il Cantico dei cantici (ricordate Der müde Tod?) sulla comoda poltrona del Club, il protagonista si addormenta con quella frase in testa («l’amore è più forte della morte») e vive il suo rimpianto. The Woman in the Window (La donna del ritratto, 1944), un altro bel film e un meccanismo perfetto, mostra che Lang ha imparato bene la lezione di Hays. Infatti, Joan Bennett, che manifestamente interpreta una prostituta, si chiama con accortezza Alice, contraddicendo il ruolo che sostiene nell’opera. Come nel celebre testo di Lewis Carroll, tutto si svolge oltre lo specchio, che in questo caso è la vetrina di una galleria d’arte. Tema abituale in Lang, lo specchio/schermo/accesso assume qui un valore iniziatico. Quanti spettatori sono disposti a entrare nel Club di Wanley? In quel confortevole rifugio per uomini soli aleggia sentore di eternità: chi ne oltrepassa la soglia sperimenta la morte. Wanley è un altro Liliom, perciò l’aldilà non è differente dal mondo degli umani, anzi vi si confonde. La donna del ritratto è Lilith o Ly? «Sono il primo a odiare questo senso di torpore, questa grassa tranquillità da cui mi sento invadere. Per me qui si smorza il gusto della vita e finisce ogni avventura dello spirito», medita Richard
seduto con i due amici. Rammentate la coppia angelica che porta Liliom in Cielo? Lalor e Barkstone lo introducono all’ombra, sono guide dantesche per l’Averno. La selva oscura è, come sempre, l’inconscio. E l’inconscio colpisce in ogni luogo. «I guai nascono spesso da cose insignificanti, create da inclinazioni naturali sconosciute a noi stessi», sottolinea Frank. Come dargli torto? Il tema dell’impulso che provoca il male, spezzando l’Io a metà, caratterizza Wanley come Mabuse e il patetico mostro di M. Questa è l’America del Codice Hays: anche se il professore è un assassino, meglio pensare che l’abbia sognato. Il regista comunque non resiste alla tentazione di fornirci una piccola chiave simbolica attraverso il nome del finanziere. Mazard: mistery più hazard, cioè mistero e azzardo, ovvero il mistero è fonte di pericolo. L’esca dell’avventura e del gioco rischioso si trova giustamente per strada, di notte (fot. 66). Lei indossa un abito scuro con lustrini e fuma da un lungo bocchino, mentre l’ala nera che decora il cappello scende a coprirle il lato destro del viso. La bruna signora scaturita dalle tenebre – disponibile, accogliente – è soltanto uno dei mascheramenti dell’eterno giardiniere di pietra, la morte. La femme fatale, o dark lady nella tradizione anglosassone, si rivela infatti remota, quasi asessuata, e Richard non riesce ad averla, difficile persino toccarla. Dopo l’omicidio si dicono addio, ma lei ritorna, gentile, comprensiva, rassicurante com’era in Hilde Warren und der Tod. Si propone discretamente, senza forzare i tempi, ma non vince, perché una breve immersione nel maelström è abbastanza per Wanley e per altri nel pubblico.
FOT. 66
Con La donna del ritratto Lang dimostra che si può fare cinema brechtiano e didattico con l’ironia e la leggerezza del noir. L’odore di zolfo resta, tuttavia, e con esso il sollievo/amarezza del risveglio. Wanley non è un personaggio romantico, bensì la versione appena più colta di Joe Doe. In lui è d’obbligo identificarsi: perciò è grassottello, pavido, un po’ stanco, miope, debole di cuore. Niente paura, anche Wanley è stato un brutto sogno. Ministry of Fear (Prigioniero del terrore) Un orologio a pendolo segna le sei del mattino. Stephen Neale (Ray Milland) lascia il Lembridge Asylum, la clinica psichiatrica in cui era ricoverato. Aspettando il treno per Londra passeggia tra i padiglioni di una fiera di beneficenza indetta da «Mothers of Free Nations». La signora Bellane, una chiromante (fot. 67), gli consiglia di partecipare alla lotteria che mette in palio una grossa torta. Mentre la Ruota della Fortuna gira alle sue spalle, Neale vince la lotteria e prende il treno. Nello scompartimento entra un falso cieco che, prima di mangiare il dolce offertogli da Stephen, lo sbriciola accuratamente. Aerei tedeschi stanno bombardando Londra, il treno si ferma, l’uomo colpisce Neale, prende la torta e fugge nella campagna. Stephen non riesce a raggiungerlo, perché una bomba distrugge il rudere in cui lo sconosciuto si è nascosto. Nella capitale il
protagonista si rivolge a George Rennit, dell’agenzia investigativa Orthotex, e con lui raggiunge la sede dell’organizzazione «Mothers of Free Nations», dove i fratelli Carla (Marjorie Reynolds) e Willi Hilfe (Carl Esmond), profughi austriaci, gli forniscono l’indirizzo della chiromante.
FOT. 67
L’affascinante Mrs. Bellane (Hillary Brooke) che Neale e Willi si trovano davanti non è la donna della fiera, anche se sostiene il contrario. La signora li invita a una seduta spiritica. Stephen, accusato di un assassinio compiuto nel buio (fot. 68), fugge con l’aiuto di Willi, si reca all’ufficio di Rennit – devastato – e telefona a Carla, da cui apprende di essere ricercato dalla polizia. Fissato un appuntamento con la ragazza, i due sono costretti a trascorrere la notte in un rifugio antiaereo, dove il protagonista spiega i motivi del soggiorno al Lembridge Asylum. La moglie, molto malata, lo supplicava di ucciderla e lui – comprato il veleno – non aveva avuto il coraggio di farlo. Così, la donna si era suicidata, mentre su Neale ricadeva l’accusa di omicidio. Giudicato pazzo dal tribunale aveva scontato la pena nella clinica psichiatrica.
FOT. 68
La mattina dopo, cessato l’allarme, Carla e Neale giungono alla libreria Newland, dove notano l’edizione recentissima di un’opera del dottor J.M. Forrester, The Psychoanalysis of Nazidom. L’autore – presente alla serata in casa Bellane – è un noto psichiatra e consigliere del Ministro dell’Interno. Saputo che anche l’artista Martha Penteel ha partecipato alla seduta spiritica, Carla porta Neale a casa della donna, dove trovano Mrs. Bellane. La bella signora chiarisce che alla fiera di Lembridge si era fatta sostituire: Neale per caso ha pronunciato la frase concordata con la chiromante vincendo la torta destinata a un altro. Gli Hilfe si accorgono che numerosi membri della loro organizzazione sono stati raccomandati da Forrester. Da Newland, mentre Carla e Neale scoprono di amarsi, lo psichiatra telefona ordinando una voluminosa pubblicazione medica. Gli innamorati si offrono di consegnarla, Forrester non è in casa, la valigia con i libri esplode. Stephen si sveglia a Scotland Yard, dove l’ispettore Prentice lo informa che Rennit è stato ripescato cadavere nel Tamigi. Neale spiega di non essere colpevole della sua morte e rivela al poliziotto che una banda di spie è in azione a Londra. Si recano sul luogo in cui la bomba ha ucciso il finto cieco, recuperano un frammento della torta, vi trovano un microfilm con i piani dello sbarco alleato sul continente (fot. 69). Raggiungono l’abitazione del sarto che avrebbe dovuto ritirare i libri per conto di Forrester: Mr. Travers (Dan Duryea) è la persona che, arrivata in ritardo, non ha potuto vincere la torta a Lembridge e quella data per morta in casa Bellane. L’uomo si chiude in ufficio e si suicida con un paio di forbici (fot. 70). Prima di spirare ha telefonato a un cliente che aspettava un vestito.
FOT. 69
Neale compone lo stesso numero e – dato che Carla risponde alla chiamata – si precipita alle Prince Consort Mansions, dove lo attendono la ragazza e Willi. Un fattorino lo ha preceduto consegnando l’abito confezionato da Travers. Carla rivela che il fratello è un agente nemico, lo colpisce con un candeliere, lo stende con un colpo di pistola, informa Stephen che l’abito di Travers contiene i negativi del prezioso microfilm. Sopraggiungono Forrester e le spie tedesche. Gli amanti scappano sul tetto e vengono salvati dagli uomini di Scotland Yard.
FOT. 70
Ministry of Fear (Prigioniero del terrore, 1944) – diretto dopo ma distribuito prima della Donna del ritratto – è tratto dal romanzo omonimo di Graham Greene (t.it. Quinta colonna). La Paramount aveva acquistato il libro e il produttore Seton I. Miller lo modificò in modo tale da sconvolgere il regista inducendolo a rinunciare. Il contratto tuttavia era firmato e Lang onorò l’impegno. Realizzato senza molto interesse, Ministry of Fear è un mazzo di elementi langhiani mescolato male. L’inizio coniuga il tema del tempo (l’orologio a pendolo) e il momento della rinascita: «Libero! – esclama Stephen – Almeno il primo mese voglio sentirmi urtato e sballottato da un’enorme folla, voglio sentir parlare, ridere, dopo quel tic tac. Un mare di uomini mi riequilibrerà». Pare che il protagonista voglia socializzare, ma la chiromante gli legge la mano e la ruota del destino si mette a girare rivelandosi ben presto dotata di uncini acuminati. La frustrazione di Neale è la stessa di Joe Wheeler e Eddie Taylor. Perseguitato dal prossimo, randagio nella metropoli fredda e ostile, l’eroe purtroppo non ha niente in comune con il brillante Thorndike di Man Hunt. A Londra si gioca una feroce guerra di spie. Posta: la libertà. Neale si ritrova solo nel suo Paese assediato da Hitler, una ragazza coraggiosa gli è accanto, fornendoci una flebile variante del modello Man Hunt: Carla fugge il nazismo, ma è pur sempre un’austriaca. Estraneo in patria, Neale è soccorso da una straniera. Di individui senza terra né famiglia pullula la tradizione della spy story, ma questi due caratteri tratteggiati alla meglio non rendono giustizia al libro di Greene, ai suoi toni realistici e amari. Lang recupera la seduta spiritica e alcuni volti ambigui del Dottor Mabuse, ripropone il tema del doppio (la veggente grassa e matura si trasforma in una donna fatale; il lato buono e quello malvagio dei fratelli Hilfe), pensa all’Hitchcock di The Lady Vanishes (1938) e di Foreign Correspondent (1940), volge in uno scialbo lieto fine la gustosa conclusione della Donna del ritratto, ricamando da artigiano intorno a un MacGuffin inesistente, imbrogliato da Hollywood (fot. 71).
FOT. 71
Scarlet Street (La strada scarlatta) New York. Il banchiere J.J. Hogarth regala al cassiere Christopher Cross (Edward G. Robinson) un orologio da tasca in oro, come ringraziamento per venticinque anni di fedele servizio. Accompagnato dal collega Charles Pringle alla fermata dell’autobus, Chris si chiede che cosa si prova a essere amati da una bella ragazza come la fidanzata di Hogarth. Da giovane – aggiunge -sognava di diventare un grande artista, ora dipinge solo la domenica. Nel Greenwich Village un uomo aggredisce una ragazza, Cross lo mette in fuga e chiama la polizia. Lei è Katherine Marsh, detta Kitty “Lazy Legs” (Joan Bennett), attrice. Cross si dichiara pittore. Non aspettano il poliziotto, bevono un caffè, parlano di un Cézanne che vale 50.000 dollari, alle 2.10 del mattino si dividono. Brooklyn: Chris – costretto dalla moglie (Rosalind Ivan) a dipingere nel bagno di casa (fot. 72) – riceve Charlie e gli mostra i suoi quadri. Intanto Kitty litiga con l’amante Johnny Prince (Dan Duryea), che ha bisogno di 3.000 dollari per aprire un garage con alcuni amici. È lo stesso uomo che l’ha percossa in strada per adescare il gonzo di turno. Perché la ragazza non li chiede a Cross, che si è innamorato e le scrive? Kitty ha invitato il cassiere a cena: discutono d’arte, lui afferma che ogni quadro è un atto d’amore e dipingere è come innamorarsi. La ragazza propone di affittare un appartamento, in cui lei vivrebbe e Cross potrebbe lavorare indisturbato. Sua moglie Adele continua a tormentarlo: odia la pittura e l’odore dei colori, gli nega il prestito di una parte dei soldi dell’assicurazione. Chris – che ha già sottratto denaro in banca – rubacchia dal deposito nel cassettone di Adele.
FOT. 72
L’ennesimo scontro spinge Cross ad affittare un appartamentino nel Greenwich Village, portandovi le tele. Kitty vi riceve Johnny e l’amica Millie. Arrivato improvvisamente, Chris pensa che l’uomo sia il fidanzato di Millie. Johnny è sempre più avido, tenta persino di vendere le opere del cassiere che non sono firmate. Un giorno il rigattiere a cui le ha consegnate lo informa che il noto critico d’arte Janeway (Jess Barker) le ha acquistate in blocco. Kitty dice di essere l’autrice e, davanti al critico, ripete le frasi di Cross. Quest’ultimo trova la ragazza con Johnny, intuisce qualcosa e, dopo un litigio, le propone il matrimonio. Lei gli consiglia di darsi con maggiore impegno alla pittura. Adele scorge nella vetrina di Dellarowe un dipinto del marito e lo accusa di copiare le tele di Katherine Marsh, che si vendono a 500 dollari l’una. Scoperto l’inganno, Chris inaspettatamente acconsente, decidendo di restare nell’ombra, anzi dipinge subito un “autoritratto” di Kitty. Il quadro riscuote un notevole successo nella personale di Katherine alle Dellarowe Galleries. Cross scorre felice le ottime recensioni. Ricompare l’ex marito di Adele, che lo ricatta: sparirà solo in cambio di denaro. Il cassiere gli promette i soldi dell’assicurazione, poi fa in modo che l’uomo e Adele si trovino faccia a faccia, giocandoli entrambi. Finalmente libero, si reca al Village, scopre Kitty e Johnny nell’intimità, si rifugia in un bar per affogare il dolore. Johnny, furioso, batte la ragazza. Quando Chris torna nell’appartamento e chiede a Kitty di sposarlo, il suo rifiuto gli fa perdere la testa: la colpisce ripetutamente con lo scalpello del ghiaccio, uccidendola. Cross è licenziato da Hogarth – che ha scoperto i furti del dipendente – ma in compenso Johnny è accusato dell’assassinio di Kitty e muore a SingSing, sulla sedia elettrica. Nell’appartamento vuoto del Village, Chris ode le voci di Kitty e di Johnny, tenta di
impiccarsi ma viene soccorso, diventa uno dei tanti barboni che dormono sulle panchine del Central Park. Tutti lo credono pazzo, perché dichiara di aver ucciso due persone e chiede di essere condannato. Nei giorni che precedono Natale, Cross passa davanti alla vetrina di Dellarowe, da cui è stato appena rimosso il ritratto di Kitty, venduto per 10.000 dollari. L’autore si allontana barcollando, perseguitato da una frase della ragazza: «Johnny, non sai quanto ti amo. Johnny!».
Nell’aprile del 1945 Lang crea la Diana Productions, Inc., di cui fanno parte Walter Wanger (vicepresidente e produttore esecutivo), sua moglie Joan Bennett e Dudley Nichols. Durante l’estate si trasferisce a Beverly Hills, Summitridge Drive, con Lily Latté, la sua nuova compagna, già sposata a un direttore della Tobis Klang-Film che era fuggito con lui dalla Germania. Il primo impegno della Diana è appunto Scarlet Street (La strada scarlatta), ispirato al romanzo La chienne di Georges de La Fouchardière e al dramma omonimo redatto dallo scrittore in collaborazione con Mouézy-Eon. Nel ’31 Renoir ne aveva tratto un buon film, con un grande Michel Simon. Lubitsch avrebbe dovuto girare il remake per la Paramount, ma non venne mai a capo della storia, mentre lo sceneggiatore di Lang, il bravo Dudley Nichols, ebbe l’idea di spostare l’azione da Montmartre al quartiere degli artisti di New York, completamente ricostruito in studio. Questa Kitty del Greenwich Village deve fare i conti con il solito Hays e – da prostituta qual era nell’originale francese – diventa una simbolica gattina d’appartamento (fot. 73).
FOT. 73
La chiave, come sempre, risiede nei nomi. Il cassiere è un personaggio destinato a soffrire, un santo (Christopher) che porta la sua croce (Cross), come tutti. Per questo Lang sceglie Edward G. Robinson, everyman sperimentato con successo nella Donna del ritratto (fot. 74). Il nostro Chris Cross (criss-cross in inglese significa segno di croce, ma anche reticolo, incrocio) si imbatte nella bruna Katherine, soprannominata “Lazy Legs” (Gambe Pigre), cioè incontra la sua legittima trappola. O meglio Christopher crosses Lazy Legs (Cristoforo incrocia Gambe Pigre), dove l’espressione to cross the legs parallelamente indica il valore seduttivo dell’accavallare le gambe. Preso nella rete di un paio di gambe incrociate (fot. 75 e 76), il protagonista segue la sorte di Michel Simon e, prima ancora, quella di Emil Jannings nel celebre Der blaue Engel (L’angelo azzurro, 1930) di Joseph von Sternberg.
FOT. 74
Il gioco di parole suggerisce non solo che l’uomo è preda della femmina. Vale anche il contrario: Kitty subisce amando le angherie di Johnny (fot. 77) e muore per la gelosia di Chris che l’ama. Prince, viziato sfruttatore di donne, sconta al posto di Cross, che tuttavia trascina la sua croce vivendo. Un triangolo classico, eterno, implacabile. Più che una commedia nera, Scarlet Street pare
un autentico melodramma.
FOT. 75
Tragico e comico, tuttavia, si inseguono. «Prima o poi diventerai pazzo, ti metterai a dipingere donne nude», motteggia Adele. Nel dipinto più interessante di Chris le spire di un serpente gigantesco avvolgono una colonna della sopraelevata, mentre i lampioni proiettano teatralissimi coni di luce sul marciapiede deserto. Il pittore John Decker, amico di Lang, si era ispirato alle opere del “Doganiere” Rousseau, ma il clima è anche quello di un’Opera da tre soldi formato esportazione (fot. 78). Quando il cassiere fruga nel cassettone della moglie, un brutto ritratto dell’ex marito di Adele lo osserva dalla parete con burbera calma. Dopo il primo litigio con Kitty (questo è anche il nome della biondina che incastra Masimoto in Spione), Chris le chiede di sposarlo e Lazy Legs – la parte di lei fornita di senso pratico – gli consiglia invece di sudare al cavalletto. La frustrazione affettivo-sessuale spinge l’ometto a uccidere, come Mr. Hyde, come Becker in M, come sogna di fare Wanley nella Donna del ritratto. Gli impulsi naturali (essere) popolano un universo oscuro e non visti assediano l’esistenza diurna (apparire): questo significa il quadro del serpente. Eppure la sofferenza di Cross – che sublimando raggiunge comunque il bersaglio dell’arte – può mutarsi in un sadico piacere. «È diventato un uomo dominato dalle furie. Cerca, senza riuscirci, di impiccarsi. C’era anche un’altra scena – spiega il regista – (che eliminai io stesso – non funzionava, mi sembrava comica): la sera che Dan Duryea doveva essere giustiziato sulla sedia elettrica a SingSing, Robinson saliva su un palo del telegrafo, in cima a una collina che dava sulla prigione, per vedere il bagliore della luce nella cella della morte. Era troppo».
FOT. 76
FOT. 77
Sul valzer delle pulsioni e degli istinti – una volta per tutte visualizzato in M dalla ruota-spirale che gira, dalla freccia che sale e scende nella vetrina del negozio di giocattoli – cala il sipario dell’oro. L’orologio donato dal banchiere al cassiere, l’avarizia di Adele, il patologico disinteresse e i furti di
Chris, la cupidigia di Johnny si legano all’ossessionante ripetizione di somme uguali. Chris chiede in prestito 500 dollari per Kitty come Alan regala 500 sterline a Jenny (Man Hunt); il ritratto di Kitty vale 10.000 dollari, come l’ammontare del ricatto in The Woman in the Window, come la taglia sulla testa di Eddie Taylor (You Only Live Once) e su quella dei rapitori di Fury, come i 10.000 marchi offerti per avere notizie del mostro di M. Cifre dell’incubo: il denaro induce all’abiezione e al delitto, a una mostruosità quotidiana. Ecco che i volti di Kitty e di Alice Reed – similmente al ritratto di Dorian Gray – esprimono, nella loro compiuta bellezza, tutto l’orrore e il mistero della corruzione morale (fot. 79). Di nuovo il teschio e la rosa del romanticismo tedesco, la cupa meditazione davanti ai sepolcri, la repulsione e il fascino della caduta spirituale, l’elegia delle effimere spoglie mortali. Un Lang teso e cattivo, quello di Scarlet Street, riproduttore crudele della miseria umana al pari dell’artista William Hogarth, che non a caso presta il cognome al banchiere dell’inizio, semplice ingranaggio nel quadrante del destino.
FOT. 78
FOT. 79
Cloak and Dagger (Maschere e pugnali) Confine montano tra Francia e Spagna, sul finire della guerra. Due agenti americani vengono uccisi mentre trasmettono notizie importanti a Washington. Alvah Jasper (Gary Cooper), docente di fisica nucleare alla Midwestern University, riceve la visita di Pinky, membro della sezione “Cloak and Dagger”, spionaggio bellico degli Stati Uniti. Il professore è scapolo e parla bene ildesco, perciò si recherà in Germania per impedire al nemico di portare a termine la costruzione della bomba atomica. Raggiunta la Svizzera, Jasper si registra in albergo come Andrew Wilson, commerciante di orologi, e durante un balletto al Teatro dell’Opera entra in contatto con un altro agente (fot. 80), poi con Katarin Loder, una famosa ricercatrice ungherese ricattata dai nazisti. In albergo una donna con cagnolino, bella e molto elegante, attira la sua attenzione, ma appena Jasper le si siede accanto, una telefonata lo avverte che questa Ann Dawson (Marjorie Hoshelle) è una spia tedesca. Jasper la corteggia, quindi le tende una trappola, comunicandole di aver spedito una lettera alla Gestapo dove è scritto che la donna avrebbe ricevuto 5.000 franchi svizzeri dall’americano Andrew Wilson.
FOT. 80
I nazisti chiudono Katarin Loder in un hotel di montagna e la uccidono prima che gli uomini di Jasper possano liberarla. Un sottomarino porta il professore in Italia, dove viene accolto da un gruppo della Resistenza, di cui fa parte l’avvenente Gina (Lilli Palmer), che gli appare in sottoveste bianca (fot. 81). Jasper si finge un medico tedesco e riesce a incontrare lo scienziato Giovanni Polda (Vladimir Sokoloff), custodito dagli agenti dell’OVRA e dal loro capo, il temibile Luigi. L’anziano ricercatore ha paura, perché i nazisti tengono in ostaggio sua figlia Maria. Jasper promette di salvarli portandoli oltreoceano. L’americano e Gina trascorrono una notte insieme, dormendo separati. Lei sogna di essere interrogata dai tedeschi, il giorno dopo trova un appartamento per entrambi, dove cede al corteggiamento di Jasper, definendosi una “cortigiana dello spionaggio”.
FOT. 81
Lui invece sa che Gina è una brava ragazza. Incalzati dal nemico fuggono in campagna e apprendono che Maria Polda è stata liberata dalla Resistenza. Jasper uccide Luigi e con lo scienziato raggiunge il luogo in cui un aereo proveniente dalla Corsica raccoglierà padre e figlia. All’appuntamento Giovanni scopre che un’altra donna recita la parte di Maria. La sconosciuta rivela che la signorina Polda si trova ormai da sei mesi nel cimitero di Perugia. I nazifascisti circondano il casale. Mitra alla mano, Gina guida Jasper e Polda in un passaggio sotterraneo che li conduce sul fondo di un pozzo. Salgono e si scoprono liberi, in aperta campagna. Mentre gli uomini della Resistenza si sacrificano impegnando il nemico, l’aereo inglese attende lo scienziato e il professore. Jasper promette a Gina di tornare dopo la guerra. Si baciano. L’aereo decolla e la ragazza lo segue finché non scompare nel cielo.
Con Cloak and Dagger (Maschere e pugnali, 1946) Lang torna sul binario antinazista. Albert Maltz e Ring Lardner jr. si ispirano al romanzo omonimo di Corey Ford e Alastair McBain; produce Warner Bros., musica di Max Steiner. Una confezione tradizionale, volutamente senza sorprese. Per il regista la cosa più significativa del film era la conclusione. L’intera bobina venne tagliata dalla Warner: Lang ritiene a causa dell’allora recentissima operazione su Hiroshima e Nagasaki. Nel finale originale, lo scienziato italiano muore per un attacco cardiaco sull’aeroplano e per proseguire la missione gli alleati si affidano a una fotografia che ritrae lo scienziato insieme alla figlia, con una formazione montuosa molto particolare sullo sfondo. I servizi segreti americano e inglese stabiliscono che la montagna può trovarsi solo in Baviera. Qui rintracciano una pista d’atterraggio abbandonata e una grande caverna vuota. Un sergente riferisce che sotto la caverna ci sono i cadaveri di 60.000 prigionieri, costretti a lavorare come schiavi alle macchine, ora scomparse. Davanti alla caverna c’è un paracadutista, un giovane americano che mastica un filo d’erba. Il sole brilla, gli uccelli cantano. Jasper profetizza: «Questo è l’Anno Uno dell’era atomica. Dio ci aiuti se pensiamo di poter nascondere questo segreto al mondo, e tenerlo per noi». Senza la critica al nucleare, Cloak and Dagger (letteralmente: mantello e pugnale; così si indicano in inglese i film di cappa e spada) è una spy story di gusto rinascimentale, dove i nazifascisti sono gli sgherri del duca Valentino e l’agente dell’OSS (Office of Strategic Services) – personaggio ispirato a Oppenheimer – si comporta da vago intellettuale qual è, ma soprattutto da americano alla corte di re Artù. Per dire che Maschere e pugnali è giusto una favola hollywoodiana, con alcune varianti langhiane.
FOT. 82
All’inizio Jasper bofonchia contro gli esperimenti atomici: «Se questi soldi invece fossero spesi per vincere il cancro…». In Svizzera cadrebbe tranquillamente nella rete di una Mata Hari, se gli amici non stessero attenti. In Italia si innamora della sottoveste di Gina e, senza il valido contributo della Resistenza, certamente lo vedremmo godersi la vacanza e la storia d’amore all’ombra di rovine e romantiche torri saracene, buono soltanto a riempire una parete di formule matematiche e graffiti astrusi (“geroglifici” tipicamente langhiani, fot. 82). Everyman colpisce ancora, questa volta nei panni del Joe Doe cinematografico per eccellenza, Gary Cooper. Lang ci fa sorridere quando racconta che era difficile togliere a Gary la sua esclamazione preferita, quello “Yup” che lo rende un’amabile versione di Goofy. I violini di Steiner non si perdono un istante del lungo intermezzo giocato dal timido Alvah e dalla sensuale Gina. Quando Jasper si intenerisce per un gattino affamato, lei – femmina latina in guerra – commenta: «Gli americani amano i gatti, ma siete in Europa e ora i gatti li trovate dal macellaio». Seguono abbracci, lacrime, un passo di danza e una canzone, un fiore appuntato davanti allo specchio. Schermaglie in un contesto fin troppo mediterraneo, dove gli italiani sembrano tutti greci o levantini. Il “tocco” di Lang colpisce all’improvviso, quando luci di taglio individuano chiavi e maniglie nel buio, dove le ombre impugnano una pistola (fot. 83), nel duello muto e spietato fra Jasper e Luigi (fot. 84), un pallone rimbalza e si ferma presso il cadavere del fascista: il regista si cita da M), nella passione per le cifre tonde, la giostra e gli specchi, nel recupero del clima esotico-avventuroso di Die Spinnen. Nella splendida intuizione del finale censurato, l’incubo dell’atomica e gli spettri dell’Olocausto si fondono con le tristi maestranze di Metropolis: sopra l’altero dominio della scienza, sotto gli schiavi, le segrete, i sepolcri. La cappa e la spada del sedicente Andrew Wilson nascondono Jasper, fulgido eroe della libertà, aggiornamento di Kay Hoog e Freder Fredersen, mentre all’orizzonte è comparsa un’altra doppia Maria.
FOT. 83
FOT. 84
Secret Beyond the Door (Dietro la porta chiusa) Da una sequenza in cui l’Io narrante della protagonista accompagna immagini di nuvole riflesse in uno specchio d’acqua, su cui vediamo una barchetta di carta e ombre di narcisi, passiamo all’interno di una chiesa, il giorno del suo matrimonio: presso l’altare il passato ritorna in un flashback. Celia (Joan Bennett), una ricca ereditiera, ha appena rotto un fidanzamento e con un’amica lascia New York per il Messico, dove la vista di un improvviso duello rusticano la turba stranamente. Avverte il fluido magnetico che proviene da un uomo nel cerchio di folla intorno ai contendenti: è l’architetto Mark Lamphere (Michael Redgrave), che di lì a poco diventerà suo marito. Trascorrono la luna di miele alla Villa degli Incanti, sostano presso la Fontana degli Innamorati, oziano nel patio, fra statuette precolombiane e musica di chitarre. Una sera qualcuno tenta di aprire la porta della camera, chiusa a chiave da Celia, che si sta pettinando. La donna lo racconta al marito, che reagisce in modo convulso, frantumando il bicchiere che ha in mano. Ricevuto un telegramma, Mark si reca per affari a Città del Messico, ma la cameriera Paquita informa Celia che alla Villa non vengono mai recapitati telegrammi. Preoccupata dalla menzogna del consorte, Celia fa brutti sogni. Il giorno dopo lo chauffeur le consegna una lettera in cui Mark le dà appuntamento, cinque giorni dopo, a Lavender Falls. Sul luogo trova la cognata Caroline (Anne Revere) che, accompagnandola alla residenza dell’architetto, la informa dell’esistenza di David (Mark Dennis), figlio di Mark, avuto dalla prima moglie Helen. Caroline ha sempre diretto la casa, Celia la prega di farlo ancora. Nello studio del marito incontra Emma Robey (Barbara O’Neil), segretaria. La donna ha un velo sul lato sinistro del viso, perché è rimasta sfigurata durante un incendio (fot. 85). Celia attende il marito alla stazione (porta all’occhiello dei lillà), ma appena arrivato Mark trova subito una scusa per ripartire. La moglie è perplessa, vorrebbe lasciarlo, poi resta.
FOT. 85
Iniziato un buon rapporto con David, Celia chiede spiegazioni a Mark. L’uomo parla del matrimonio precedente, aggiungendo che non riuscì ad affezionarsi né alla moglie né al bambino. Nel corso di una festa, Mark si svela collezionista di interni e mostra agli ospiti sei stanze, fra cui: 1) il salotto dove Celeste, nobildonna segretamente ugonotta, sposata a un Guisa, spirò per mano del marito la notte di San Bartolomeo; 2) la cantina di una casa del Missouri, in cui un figlio legò la madre a una sedia e la fece affogare durante un’inondazione per riscuotere l’assicurazione sulla vita; 3) la camera da letto di don Ignazio, ricco latifondista del Paraguay, educato a Parigi, dove furono strangolate con una sciarpa di seta Costanza, Maria e Isabella, fanciulle di rara bellezza. La visita si conclude davanti alla settima porta, che Mark lascia chiusa. Celia è attonita, pensava che nelle stanze si fossero svolti eventi lieti e non brutali omicidi. Il marito replica che, per lui, felice significa «utile a un effetto, idoneo, adatto, come un edificio che è armonico con le cose che vi accadono». Quando la moglie gli chiede di aprire l’ultima stanza, rifiuta con veemenza. Celia raccoglie indizi contrastanti su Mark. Da piccolo era emotivo e ipersensibile, come David: una volta Caroline lo aveva chiuso a chiave in camera e lui ne era uscito sconvolto. David afferma che il padre non amava Helen, anzi l’ha uccisa, facendo togliere dopo il funerale tutti i lillà e gli altri fiori dal giardino. Una domestica narra che la signora era inferma e il padrone le somministrava ogni giorno la stessa medicina: così buono e gentile! Celia decide di aprire, per la salute di Mark, entrambe le porte: quella della bontà e la n. 7, ancora chiusa a chiave. Dal giorno della festa il marito è diventato freddo e scostante. Un giorno incautamente lascia scorgere alla moglie il nascondiglio della chiave della stanza misteriosa, quindi si assenta per lavoro. Celia scopre che Miss Robey non è deturpata: salvò David dall’incendio e si fece una plastica al volto, confidando che Mark la sposasse. Mentre il marito è sotto la doccia, la protagonista fa un calco della chiave proibita. Una notte, mentre lui dorme, apre la settima porta ed entra in una camera da letto uguale alla propria (quella di Helen). Le finestre sono murate e non ci sono oggetti personali: che sia incompiuta? Improvvisamente intuisce che la stanza è per lei e fugge precipitosamente, incontrando Miss Robey. La segretaria le consegna il cappotto e le chiavi della macchina. Sulle scale Celia trova la sciarpa di don Ignazio, esce, cammina nella notte nebbiosa, fra gli alberi, scorge una silhouette maschile, urla.
La mattina dopo Mark, davanti allo specchio del bagno, agisce come se fosse accusato da un immaginario tribunale, esclama: «Siamo tutti figli di Caino!». Aggiunge che se Celia fosse lì, dovrebbe ucciderla ancora (ha la sciarpa di don Ignazio), perché è inutile combattere le forze oscure e l’impulso omicida. L’amava però, che Dio lo perdoni! Il giorno dopo licenzia Miss Robey perché si è immischiata nei suoi affari. Celia riappare, dichiarando di volergli stare a fianco «nel bene e nel male». Mark ribadisce che le donne gli hanno sempre impedito di essere se stesso e, spaventato, lascia nuovamente la casa per lavoro. Poi rientra perché ha dimenticato qualcosa. Mentre infuria un temporale, la moglie torna nella settima stanza (fot. 86), mette dei lillà in un vaso, si siede, aspetta il marito e, quando entra, lo convince a svelare ciò che è nascosto nella sua mente. Mark ricorda i lillà che Celia portava alla stazione, rievoca un settembre ormai lontano, in cui sua madre colse dei fasci di lillà: separata dal marito, doveva recarsi a un ballo con un uomo e chiuse in camera il figlio geloso, che pianse, strappò i fiori, la odiò e sentì che un giorno, un giorno… stasera, si sarebbe vendicato. «Non fu tua madre a chiudere la porta, fu Caroline», replica Celia, spezzando l’incubo, ma Miss Robey ha incendiato la casa, pensando che Mark sia fuori. Questi salva la moglie, per poi tornare con lei in Messico, alla Villa degli Incanti.
FOT. 86
Seconda e ultima realizzazione della Diana Productions, Secret Beyond the Door (Dietro la porta chiusa, 1948), tratto dal racconto Museum Piece Nb. 13 di Rufus King, è un film affascinante. Lang racconta che l’opera fu sfortunata sin dall’inizio, che tutta l’idea scaturì da una sequenza di Rebecca (Rebecca, la prima moglie) di Hitchcock (1940), dove Judith Anderson parla della defunta e intanto mostra a Joan Fontaine i suoi effetti personali. Sovente autocritico, questa volta il regista non rende giustizia a se stesso, perché Secret Beyond the Door conserva una folgorante, misteriosa vitalità.
FOT. 87
Subito la voce di Joan Bennett scorre morbida e densa come l’angoscia o lo stream of consciousness joyciano. «Mi ricordo che tempo fa lessi un libro che interpretava i sogni. Diceva che se una ragazza sogna una barca, o una nave, arriverà in un porto sicuro; se invece sogna narcisi è in grave pericolo. Ma oggi non è il caso di pensare al pericolo. Oggi è il mio giorno di nozze» (fot. 87). Quei narcisi riflessi in una pozza oscura, che al contempo cattura il firmamento, sono la chiave dell’opera e restano impressi nella memoria come un’autentica negativa dell’inconscio. Ascoltiamo ancora la voce fuori campo di Celia. «Il cuore mi batte forte, perché sto annegando nell’ignoto. Dicono che quando anneghi tutta la vita ti passa davanti come una visione». È appena entrata in una chiesa vecchia di quattrocento anni, decorata e ombrosa. Un flashback la riporta indietro nel tempo, al duello rusticano. La giovane messicana dev’essere fiera di aver causato lo scontro – medita la protagonista – poi sente due occhi «che la toccano come dita» e un flusso impalpabile, magico e stregonesco, proveniente da un uomo nella folla. La presenza della morte e l’attrazione fatale per Mark si specchiano in uno dei primi giudizi del futuro marito: «C’è qualcosa nel tuo volto che mi
ricorda il South Dakota, il paese del grano: aria di ciclone. Un po’ prima del ciclone nell’aria c’è una gran calma, una calma piatta, tutta luccicante d’oro. Tu ce l’hai sul volto, la calma prima della tempesta. E quando sorridi è come il primo soffio di vento che piega il grano, ma io so che dietro quel sorriso c’è un tumulto di…»: le ultime parole di Mark sono cancellate dalla voce fuori campo di Celia, che in quel momento pensa ai narcisi. Durante la luna di miele visitano il Pozzo dei Desideri (fot. 88), si baciano in una minacciosa scenografia di rami contorti: «Una porta si chiuse e un’altra si aprì», sigla la signora Lamphere. L’ereditiera presto si accorge di aver sposato un estraneo: «Forse avrei dovuto seguire il mio oscuro istinto, avrei dovuto fuggire».
FOT. 88
Insieme ai toni onirici usati dalla sceneggiatrice Silvia Richards, queste prime frasi indicano il binario reticolare langhiano: acqua/specchio, barca/flashback, pozzo/istinto, desiderio/oro. Celia è, per Mark, una “bella addormentata”, cioè vive in un sogno, si immerge nel profondo, scandaglia l’inconscio. Celia è uno specchio oscuro. Se consideriamo poi che il suo nome è l’anagramma di Alice, ecco svelato un altro gioco del regista. Tornano l’infante morbosa di Lewis Carroll, il suo viaggio, i simboli e gli enigmi già enunciati nella Donna del ritratto. «Gli uomini pensano, le donne mentono», aggiunge Mark. Perciò Celia/Alice – come la Sfinge – offre al marito e al pubblico una serie di menzogne esplicative, il costante interrogativo langhiano. Celia è il cinema specchio dell’inconscio, luogo del fascino e del mistero (fot. 89). Il ritratto dell’eroina – che rinnega la parte di moglie-madre castratrice incoronata di lillà – entra comunque nel museo dell’eterna femmina dominante, dove troviamo Hel (Metropolis), evocata qui dal nome della prima moglie di Mark. Il simulacro della dea/sembiante della star scherma il reale e ne scioglie i nodi, lo psicanalizza. Il flusso e l’empatia che inizialmente legano i protagonisti – gli occhi/dita dello sconosciuto nella folla – sono metafora della condizione di ogni spettatore cinematografico. Il segreto oltre la porta (lo schermo-soglia) è una camera vuota, che ognuno può arredare a piacere con i propri, originalissimi spunti d’immaginario.
FOT. 89
Secret Beyond the Door è allusivo come tutti i noir, chiarisce solo in parte (fot. 90). Citazioni e riferimenti si incrociano. Celia, moglie curiosa di Barbablù, adombra il personaggio di Joan Fontaine e restituisce la memoria al suo uomo come fa Ingrid Bergman in Spellbound (Io ti salverò, 1945) di Hitchcock. Miss Robey duplica la governante di Rebecca, e non solo. Il velo che le copre la metà sinistra del viso è un’esemplificazione del dilemma più antico. Bene e male (le due porte dischiuse da Celia) combattono all’interno di ognuno. Il velo di Emma Robey è come l’ala nera del
cappello di Alice Reed (The Woman in the Window), cifre dell’ordito langhiano uguali alla M che trionfa sulla spalla di Becker. «Siamo tutti figli di Caino!», esclama l’architetto Lamphere (to lamp = risplendere). Si chiama Mark (= marchio, indizio), porta anche lui il segno luminoso del peccato. Grazie al salto oltre la porta, in una dimensione sospesa, iniziatica ed esoterica, suprema evasione nel narcisismo (la protagonista si specchia molte volte, fot. 91), Celia viene illuminata di conoscenza e può svolgere la rapida, efficacissima psicanalisi di Mark. Come dire: la maledizione di Caino spiegata e risolta da una buona favola. Estirpata la «radice del male», quel piccolo bulbo che ha tenuto Mark incatenato per anni, la porta si chiude temporaneamente sulla psiche e Celia/Alice, tornata nella Villa degli Incanti (Hollywood), giustamente può dire: «Abbiamo ancora molta strada da fare».
FOT. 90
FOT. 91
House by the River (Bassa marea) Una linda casa vittoriana presso il fiume. Sulla corrente galleggiano tronchi d’albero e carcasse di animali. Lo scrittore Stephen Byrne (Louis Hayward) sta lavorando, osserva un insetto nero che attraversa la pagina e sente il rumore dello scarico del bagno al piano superiore, dove la domestica Emily Gaunt (Dorothy Patrick), bionda, giovane e bella, si sta lavando. Quando la ragazza scende le scale, Byrne tenta di baciarla. Al suo rifiuto la strangola. Stephen, attonito, racconta l’accaduto a suo fratello John (Lee Bowman) e riesce a dissuaderlo dal chiamare la polizia, poi infila la ragazza in un sacco. Dopo aver informato un’anziana vicina di casa, Mrs. Ambrose (Ann Shoemaker), che sua moglie Marjorie è incinta, Stephen e il fratello prendono la barca e gettano il cadavere nel fiume. In casa, qualcuno scende le scale, Byrne immagina per un istante che si tratti di Emily, invece è Marjorie (Jane Wyatt). Mentre i giornali parlano della ragazza scomparsa e Stephen rafforza le voci che la dicono “facile”, il suo nuovo romanzo ha successo. Ne inizia un altro, The River, ma non vuole che Marjorie legga il manoscritto, com’era abituata a fare. La governante di John non trova più il sacco per il giardino prestato a Stephen, contrassegnato dalle iniziali del proprietario. Il protagonista, che sta scrivendo in giardino, lo vede galleggiare sul fiume e subito corre alla barca. Intanto Marjorie si lamenta del marito con John: è gentile, affascinante, ma le nasconde una parte di sé e questo la spaventa. Dal colloquio scopriamo che la donna non aspetta un figlio e che John la ama in segreto. Stephen è sul fiume, di notte: ombre, radici, la luna velata di nubi, le fronde minacciose degli alberi. Tornato a casa, John litiga con la governante, troppo insistente e materna, che indispettita si licenzia. Stephen individua il sacco e tenta di recuperarlo, ma questo si schiude liberando i capelli di Emily, poi si allontana sulla corrente. I due fratelli si incontrano. «Emily ritorna!» esclama Stephen, sconvolto, e il giorno dopo identifica il sacco di John, in cui un poliziotto ha rinvenuto il corpo della ragazza uccisa. John viene accusato e in tribunale la governante non si mostra tenera con lui, mentre Mrs. Ambrose lo difende con impegno. Non si trovano prove della sua colpevolezza e il giudice chiude il caso: Emily Gaunt è stata assassinata da «sconosciuti». Marjorie, costantemente seguita dalla polizia, litiga con Stephen, che
ha ipotizzato una sua relazione con John. La ritroviamo a casa di quest’ultimo, depresso e poco disposto ad ascoltare un resoconto delle malvagità del fratello. Stephen sorveglia la moglie. Una sera entra in casa di John, blocca l’orologio a pendolo e raggiunge il fratello sul pontile. Questi ricorda un’altra notte sul fiume, Stephen lo accusa di essere l’amante di Marjorie, lo colpisce, lo getta in acqua, torna a casa e trova la moglie che sta leggendo il manoscritto, il cui titolo è diventato Death on the River. Lei ormai sa che il marito è un mostro, Stephen non ha scelta: la ucciderà e farà ricadere la colpa su John. Quest’ultimo entra zoppicando, Stephen fugge, ma nel corridoio incontra lo spettro di Emily – solo una tenda mossa dal vento – e nel tentativo di liberarsi cade dalle scale rompendosi il collo.
La fama di autore sadico e perfezionista non impedisce a Lang un costante impegno a Hollywood. Dopo Secret Beyond the Door il regista si dedica, con Silvia Richards, a un western ispirato al romanzo Winchester ’73 di Stuart N. Lake, ma poco soddisfatto del risultato abbandona il soggetto. Lavora brevemente a un adattamento di All the King’s Men di Robert Penn Warren e nel ’49 tenta di coinvolgere alcune case di produzione in Rocket Story (t.l. La storia del missile), centrato sulla ricerca spaziale e sui tentativi di raggiungere la luna. House by the River (Bassa marea, 1950), tratto da Floodtide di Alan P. Herbert, gli viene offerto dalla Republic. Lang passa i soliti guai con l’Ufficio Hays, perché aveva previsto che Emily fosse una ragazza di colore (fot. 92).
FOT. 92
«I hate this river» (odio questo fiume), la frase prediletta di Mrs. Ambrose, sottolinea come una didascalia le prime immagini d’acqua. Al fluido denso che scorre presso la casa sono subito collegati i temi della maledizione e della morte. Nell’abitazione dei Byrne, Emily usufruisce del bagno della signora, che è assente, vuota la vasca e si asciuga davanti allo specchio. La cinepresa si sofferma sul liquido che vorticando entra nel tubo di scarico: il rumore attira dabbasso l’attenzione di Stephen. Poche, scarne notazioni che – anticipando di un decennio Psycho di Hitchcock – creano attorno all’orifizio della vasca una buona metafora. La spirale fluida ci riporta a quella grafica del negozio di M, segno di inconscio e di pericolo, al gorgo emozionale di cui sono preda molti personaggi langhiani. La caratterizzazione mefistofelica del ruolo di Stephen è a questo proposito emblematica: sembra sempre “agito da”, di punto in bianco si trasforma nel suo Hyde, come se il romanzo che sta scrivendo lo inducesse a praticare il male. Se Emily ha sostituito Marjorie nel bagno – aggravando la già notevole confusione del protagonista davanti al femminile (anche Stephen, come Mark di Dietro la porta chiusa, vive in un mondo regolato dalle donne) – ecco che il corrotto Byrne si riflette nell’acqua pura del fratello John, come i narcisi si specchiano in un lago tranquillo all’inizio di Secret Beyond the Door. Una coppia muliebre si oppone a quella virile illustrando ancora la netta divisione fra bene e male. I biondi capelli fluttuanti di Emily, una curiosa citazione dell’Ofelia (1852) di John Everett Millais, sono i morbidi tentacoli del mostro che risiede nel profondo. È opportuno ricordare che nell’alveo del Reno mitologico giace indisturbato l’oro. Nelle indicazioni per la scenografia del suo celebre Rheingold, Wagner scrive: Tutto il fondo è un selvaggio dentato groviglio, in nessun punto completamente piano, e lascia supporre in tutte le direzioni recessi più profondi in densissima tenebra. Woglinde, Wellgunde, Flosshilde, le Figlie del Reno, nuotano intorno a uno scoglio solitario che si erge tra i flutti. Sono le leggiadre custodi dell’Anello, che viene loro sottratto – insieme a una simbolica verginità – dal lussurioso Alberico, il nibelungo salito dall’abisso. Questi è uno gnomo
irsuto, gobbo, nero, calloso, sulfureo: un’ovvia sintesi del male. Per dire che i serici capelli di Emily vellicano la sessualità di Stephen come le agili Rheintochter scherzano sull’onda che avvolge il pene/scoglio di Alberico. Certamente un gioco d’azzardo. La seduzione, in Lang, è quasi sempre un rituale macabro e oscuro, un sabba lancinante che porta a galla la colpa primigenia, il marchio di Caino, e la duplicità degli umani. L’anello del Nibelungo diventa ruota della necessità, progressione inesorabile della maledizione legata al furto dell’oro, all’aver preferito quest’ultimo all’amore. La simbologia circolare langhiana esprime, negli Stati Uniti, una concezione sempre più tetra dell’esistenza. Il sentimento è affogato dai turbini del sesso o dall’avidità del denaro. L’odioso flusso di coscienza che scorre vicino alla casa identifica il tempo, i liquidi corporei, l’alto e il basso, ciò che si fa di giorno e quello che sovente accade di notte. Non esiste scampo e soprattutto non c’è redenzione nel cosmo langhiano. Il fato incatena i fratelli specchio e delle due parti la società puritana bandisce, come sempre, l’istintuale. Tornano le ombre stevensoniane, che il regista singolarmente mescola con brividi preraffaelliti e con il prototipo del malvagio machiavellico. «Il fine non giustifica forse i mezzi?», sibila Stephen poco prima di tentare l’eliminazione di John/Jekyll. L’aspetto inquietante, volgare, indecente e “olfattivo” del nostro Nibelungo/signore di Ballantrae è ben evidenziato da Marjorie: Oh, Stephen, you are insane. You have a filthy mind. You are a swine, Stephen. Un uomo sporco e vizioso, che imbratta di malignità il casto affetto tra John e Marjorie. Quella parola, insane, risuona in questo labirinto vischioso come la frase di Mrs. Ambrose: «I hate this river».
American Guerrilla in the Philippines (I guerriglieri delle Filippine) 1943. Un’unità della flotta statunitense viene affondata dai giapponesi e alcuni marinai, raggiunta la costa, sfuggono alle mitragliatrici grazie all’intervento dei patrioti filippini. Il guardiamarina Chuck Palmer (Tyrone Power) decide di raggiungere l’Australia con una barca e con coloro che vorranno seguirlo per continuare la guerra. Si congeda dal colonnello Benson, che attende l’arrivo dei giapponesi, e gli raccomanda una francese, Jeanne Martinez (Micheline Presle). Quest’ultima ringrazia Chuck sulla riva e lo saluta. Il battello si rovescia, il guardiamarina e i suoi uomini vengono salvati dagli indigeni. Così, scelgono di restare e combattere accanto a loro. Iniziata la guerriglia, Palmer si reca dal piantatore Juan Martinez (Juan Torena) e vi trova Jeanne, che è sua moglie. Entra poi in contatto con il colonnello filippino Dimalanta, che gli promette un’imbarcazione se accetta di raggiungere il colonnello Phillips, capo della Resistenza. Chuck e gli altri rubano una motovedetta nipponica. Dopo un lungo viaggio per mare e attraverso la giungla trovano il campo di Phillips (Carleton Young), che li manda subito indietro per organizzare una rete radiofonica e preparare il ritorno del generale MacArthur. Palmer comunica con San Francisco, ma i giapponesi scoprono la stazione e durante la caccia agli americani uccidono Martinez. Jeanne viene interrogata, riesce a fuggire, raggiunge Palmer, che si sposta rapidamente con l’emittente, gli dichiara il suo amore. Aiutati dai sottomarini, i guerriglieri logorano il nemico, ma appena tornati da una missione rischiosa, che hanno concluso con successo, vengono intrappolati dai giapponesi nella chiesa di un villaggio, dove Jeanne li raggiunge. Lo scontro, sempre più violento, termina bruscamente quando i nemici, scorgendo nel cielo le formazioni serrate degli aerei di MacArthur, si danno alla fuga. Il generale sbarca tra ali di folla osannante e tutto finisce per il meglio.
Nel 1950 David O. Selznick propone a Lang The Devil’s General, un soggetto ispirato alla vicenda di Ernst Udet, il pilota tedesco che non volendo combattere per Hitler aveva distrutto il suo aereo, ma l’autore ha già firmato un contratto con la Fox per realizzare American Guerrilla in the Philippines (I guerriglieri delle Filippine). L’opera, curiosamente, ottiene in America critiche migliori di House by the River. Il «New York Daily News» recita: «Uno splendido film in Technicolor che, grazie al tema e alla linearità della storia, suscita un’impressione di autenticità e un’atmosfera emozionante da cui difficilmente lo spettatore può liberarsi». Pochi mesi dopo, infatti, inizia la guerra di Corea. Il film, ispirato a un romanzo di Ira Wolfert e girato interamente on location, rientra nello schema codificato dei generi hollywoodiani, dove war movie significa azione ed eroismi in battaglia, su un bel fondale di natura magniloquente, sovente con femmina trepidante innamorata del soldato. Sarebbe inutile cercare altro nel film, se non qualche bella ripresa documentaria. Lang, come abbiamo visto, non disdegna la politica dei generi, anzi l’abbraccia con un certo ironico compiacimento. Giustamente si è scritto che MacArthur sembra ansioso di tornare nelle Filippine soprattutto per assistere al matrimonio di Tyrone Power e Micheline Presle. La coppia, sul set dell’isola di Luzon, si cala agevolmente nel clima bellico-sentimentale, svolgendo le rituali, esasperanti, ben note schermaglie amorose. La Marina dà una mano per girare a Bataan e il film viene presentato a New York il 7 novembre 1950. Peccato che Douglas MacArthur non possa vederlo: è già andato in Corea. Durante la lavorazione di American Guerrilla in the Philippines, Joseph Losey dirige il remake di M. La fuga precipitosa di Lang dalla Germania gli aveva impedito di recuperare i contratti, e ora gli impedisce di difendere la sua opera. Un finanziatore, in verità, lo interpella prima di Losey, ma l’autore rifiuta persino l’ipotesi di un rifacimento. Il secondo M, distribuito regolarmente, non resta a lungo in programmazione. «Fu un grosso fiasco – racconta Lang a Bogdanovich – e in tutta la mia vita non ho ricevuto critiche così buone come quando fu recensito questo film. Il mio era un documentario sulla Germania di quel periodo. Il signor Losey, scoprii più tardi, aveva cercato di descrivere il personaggio fuori dal suo ambiente, eccetera, eccetera. Espresse anche, me lo lasci dire, dei giudizi iniqui sul mio film. Disse che il suo era di gran lunga migliore e che il mio probabilmente al giorno d’oggi non avrebbe retto». Rancho Notorious (Id.)
Wyoming. Mentre Vern Haskell (Arthur Kennedy) è nella prateria con le mandrie, una coppia di fuorilegge svaligia il negozio della fidanzata Beth Forbes. Kinch (Lloyd Gough) violenta la ragazza e la uccide. Vern, lo sceriffo e un gruppo di cowboy li inseguono. Kinch elimina il complice, che prima di morire ha il tempo di sussurrare ad Haskell il luogo in cui è diretto l’assassino: Chuck-A-Luck. Il cowboy lo cerca in tutto il West, poi viene a sapere che Chuck-A-Luck appartiene ad Altar Keane (Marlene Dietrich). A Virginia City, la ragazza di un bar racconta a Vern come Altar, nota cantante di saloon, era bella, seducente, estrosa. Flashback: in una sala da gioco Altar incontra il pistolero Frenchy Fairmont (Mel Ferrer) e vince alla roulette verticale (sulla frontiera chiamata Chuck-A-Luck), perché l’uomo conosce la leva segreta che la comanda. Tanto riferiscono a Vern donne e mandriani conosciuti durante il viaggio. Quando Fairmont viene imprigionato, Haskell si fa arrestare. Evadono insieme, cavalcando fino a un ranch solitario presso il confine messicano: Chuck-A-Luck. Il casale fortificato è un asilo per banditi, amministrato da Altar Keane. Tutti hanno nomi falsi e false identità. Wilson (George Reeves) è un donnaiolo con una vistosa cicatrice sulla guancia sinistra, Altar e Frenchy sono amanti, Vern si fa notare come esperto domatore di cavalli. La donna trattiene il dieci per cento delle somme rapinate dai fuorilegge e la sera dirige il tavolo del poker. Nel giorno del suo compleanno la non più giovane Altar canta «Get Away, Young Man» e indossa la spilla che Vern aveva regalato alla promessa sposa. I giocatori barano, vincono e perdono. Haskell sospetta che Wilson sia l’assassino di Beth. Intanto, sfida Fairmont in una gara di tiro alla pistola. Il giorno dopo il protagonista esce a cavallo con Altar e, durante una sosta nel deserto, chiede alla donna se è tutto vero quello che si racconta di lei. Frenchy, geloso, decide che Haskell parteciperà a una rapina alla banca di Clay Springs. Il colpo riesce, ma termina con una sparatoria, in cui Fairmont viene ferito. Estraendo la carta più bassa si sceglie chi consegnerà il dieci per cento ad Altar. Vern bara e ottiene l’incarico. A Chuck-A-Luck la donna lo riceve in abito da sera, suonando il pianoforte. Si baciano, parlano. Haskell apprende che la spilla è la percentuale versata ad Altar dal bandito Kinch. Nel saloon di Silver City, Vern affronta l’assassino di Beth, ma lo sceriffo arresta Kinch prima che il duello si compia. Intanto Frenchy, tornato al ranch, trova Altar sul punto di partire e cerca di fermarla. Liberato Kinch, i fuorilegge vanno a Chuck-A-Luck per uccidere sia Fairmont che la donna. L’arrivo di Vern risolve al meglio lo scontro fra la coppia e i ribelli. Altar è colpita da una fucilata diretta ad Haskell e muore. Frenchy e Vern, rivali ora vedovi, lasciano insieme il ranch.
Nell’aprile 1952 Lang si giustifica con la Commissione McCarthy, affermando di non aver mai fatto parte di un’organizzazione comunista. L’amicizia con Brecht, Eisler e John Wexley, la partecipazione alla «Hollywood Anti-Nazi League» e ad altre associazioni lo rendono sospetto. Ring Lardner jr. e Albert Maltz, co-sceneggiatori di Cloak and Dagger, figureranno presto tra i dieci di Hollywood. In questo clima neogotico nasce il western migliore di Lang, Rancho Notorious (id., 1952). Daniel Taradash adatta il racconto Gunsight Whitman di Silvia Richards, a cui lega, su suggerimento del regista, la ballata «The Legend of Chuck-A-Luck» (cantata da William Lee). Rancho Notorious è il primo western ad avere un riconoscibile motivo conduttore. Lang dispone del Technicolor e di Marlene Dietrich, ma il budget è limitato: deve girare in studio. Dal plein air dei Guerriglieri delle Filippine, il regista torna – suo malgrado e per fortuna – allo spazio congeniale dei teatri di posa. Il film è dedicato a Marlene, che curiosamente Lang aveva conosciuto in Francia, sul set di Liliom. Gli piaceva molto, ma creò problemi e fomentò dissidi, citando anche, ostinatamente, ad esempio il suo pigmalione Sternberg: alla fine delle riprese non si parlarono più. Lang inoltre aveva davanti un finanziatore di carattere, il bizzarro Howard Hughes, che agilmente cambiò il titolo originale, Chuck-A-Luck, in Rancho Notorious. Il riferimento al film di Hitchcock (1946) è evidente, ma spiegabile solo in parte con le dichiarazioni del produttore, che non gradiva un titolo oscuro per il mercato europeo. Rancho Notorious è più chiaro? Emigrata negli USA, la chanteuse Lola-Lola (L’angelo azzurro) batte la frontiera e mette da parte un gruzzolo per la vecchiaia, che le consente di acquistare un rancho ai confini del Messico, denominato Chuck-A-Luck. Questo potrebbe essere sinteticamente il nucleo della saga di Altar Keane (che nel doppiaggio italiano scioccamente diventa Ambra Altair King). La canzone dice: «Ascolta la leggenda di Chuck-A-Luck, Chuck-A-Luck. Ascolta la ruota del fato; mentre gira e rigira con un mormorio, diffonde la vecchia, vecchia storia di odio, assassinio e vendetta». Tornano in questo western – crepuscolare ante litteram – gli incrollabili motivi langhiani. Ricordate il soggetto mai realizzato di Superstitions Mountains? L’incipit suona: «un’antica storia che
continua a ripetersi nel tempo… l’antica storia che racconta la fame rapace dell’oro, il tradimento, l’assassinio, la morte e l’amore». Dai cupi contrafforti dell’Arizona attraversati dall’“Olandese” Jacob Waltz, dalla memoria dello splendido Greed (Rapacità, 1924) di Stroheim scaturiscono l’essenza e la scenografia di Rancho Notorious. Wiard B. Ihnen, l’architetto che aveva realizzato il set di Duello mortale, deve allestire un ampio esterno in studio: la terrazza rocciosa di una montagna che guarda sul ranch e sul deserto. Si direbbe la quadratura del cerchio e infatti non riesce. Qui si svolge il dialogo tra Altar e Vern: in una “scatola” così finta e televisiva da sembrare quasi ispirata. La cinica stella Altar scende dal suo divistico stallone bianco e concede una breve intervista al più recente dei fan, l’incantato Vern Haskell. Lui: Ciò che desidero, se mi fosse permesso chiedere, è soltanto sapere tutto di voi: dove siete nata, perché siete venuta nel West, dove vi siete procurata l’abito che avevate alla festa, chi vi ha regalato quei gioielli, quali storie su di voi sono vere e quali no. Lei: Il vestito viene da New Orleans e almeno una favola sul mio conto posso smentirla: assolutamente non ho mai portato i capelli verdi. Lui: È vero che hanno dato il vostro nome a una linea ferroviaria? Lei: Una linea del Kansas, l’Altar Keane. Lui: E quel diamante famoso di cui tutti parlano, grande come un limone? Lei: Il fatto è vero ma la pietra falsa. L’uomo che me lo ha dato era un tipo come voi, insistente e con un’ingenua faccia da galantuomo. E voi, dove avete la vostra ragazza? Si tratta di non risposte, perché la donna sa che il mito deve restare avvolto nel numinoso. Lang mostra di conoscere bene la storia dell’Ovest americano, delle sue illusioni, di onorate primedonne come la vedette Lillie Langtry. La star è per definizione inaccessibile, ma non sempre: altrimenti il “Joe Doe” Haskell, che rappresenta l’uomo comune nel pubblico, come potrebbe innamorarsi di lei? In questa frontiera teatrale di fine Ottocento e sul filo della maledizione che aleggia intorno al rancho di Altar, gira l’eterna ruota del destino. Il gioco, l’oro, il desiderio, la femme fatale, la rapacità degli umani, l’ostilità della natura, la certezza della solitudine, una ballata d’amore e morte sono ingredienti langhiani che sicuramente influenzano un cult western uscito due anni dopo, Johnny Guitar (famosa la canzone omonima, che sull’esempio di Lang serve come Leitmotiv). Nel film di Nicholas Ray un’altra diva, Joan Crawford, interpreta il ruolo di Vienna, ex avvenente soubrette di saloon. Da dove viene? Come si è arricchita? Nessuno lo sa e tutti lo immaginano (anche Will Hays). Bruna, vestita di un bianco accecante, suona il pianoforte nel silenzio, su un fondale di roccia sanguigna, mentre i pistoleri Dancing Kid e Johnny Logan – uccisore convertitosi alla pratica della chitarra – si disputano il suo cuore. Prima di lei Altar/Marlene ha celebrato accompagnandosi al piano, in un elegante décolleté nero che esalta i biondissimi capelli, proprio il trascorrere del tempo e la caducità degli affetti, da vera esistenzialista. La voce dura e sensuale della Dietrich evoca tabarin e Kabarett della vecchia Europa, la ballata malinconica dell’avventuriera si chiude in un soffio, per una romantica ferita al petto, come il primo amore di Lang. Clash by Night (La confessione della signora Doyle) È l’alba, i pescherecci rientrano a Monterey accompagnati dalle grida dei gabbiani. Peggy (Marilyn Monroe) si sveglia e va al lavoro, in uno stabilimento in cui si conserva e si inscatola il pesce. Intanto Mae Doyle (Barbara Stanwyck) è tornata dopo dieci anni di assenza, durante i quali ha viaggiato cercando fortuna e amore. In un bar ritrova il pescatore Jerry D’Amato (Paul Douglas), che vive con il padre depresso e lo zio Vince, alcolista. Mae si reca poi dal fratello Joe (Keith Andes), che l’accoglie freddamente, presentandole la fidanzata Peggy. Toccata dalla bontà e dalla tenerezza dell’onesto Jerry, Mae accetta di uscire con lui. Al cinema, D’Amato le fa conoscere il suo migliore amico, il proiezionista Earl Pfeiffer (Robert Ryan). Jerry, innamorato, la chiede in sposa e lei accetta, nonostante il subdolo interesse di Earl, che soffoca a stento le
proprie emozioni. Dopo la nascita di un figlio, la vita di Mae scorre anche troppo placida e tranquilla. Durante una festa sulla spiaggia Earl, ubriaco, la corteggia con insistenza. Qualche tempo dopo il proiezionista trascorre una calda notte estiva con i coniugi D’Amato e la mattina, uscito Jerry, fa l’amore con Mae. Vince racconta l’accaduto al nipote, che tenta di strangolare Earl nella cabina di proiezione. L’arrivo di Mae impedisce il delitto. Jerry se ne va con il bambino e rifiuta di incontrare la moglie. Lei comprende il suo errore e lascia Earl, raggiungendo il marito sul peschereccio. Jerry le perdona l’avventura, la famiglia è riunita.
Clash by Night (La confessione della signora Doyle, 1952) viene offerto a Lang da Jerry Wald, produttore della RKO. Lo sceneggiatore Alfred Hayes riscrive il dramma omonimo di Clifford Odets (t.it. Scontro nella notte), ambientandolo in un villaggio di pescatori. Nel testo originale il tema è l’angoscia della disoccupazione, che porta al delitto, mentre Lang tende al ritratto di una donna comune infedele al marito. Le riviste femminili spiegano che il settantacinque per cento delle mogli americane intrattiene relazioni extraconiugali, motivo sufficiente per ricavarne un film. Trama lineare, un cast bilanciato. Purtroppo c’è Marilyn, qui in uno dei suoi primi impegni importanti (fot. 93). I giornalisti snobbano Barbara e intervistano «la ragazza con le tette grosse» (le hanno viste bene sul noto calendario, edito proprio in quel periodo), che s’impunta, civetta, bamboleggia: difficile prova, per Lang.
FOT. 93
Il tocco del maestro è all’inizio. «Io e Musuraca (un magnifico operatore e un mio intimo amico) andammo a Monterey da soli – niente attori, nessun altro. Ero un po’ seccato e gli dissi: “Sai com’è, può darsi che ci faccia comodo girare del materiale documentario”. Così cominciammo col riprendere dei gabbiani. Poi rientrarono le barche, e ci appassionammo tanto che lavorammo per due o tre giorni – entrambi amavamo molto fare del cinema. Alla fine dissi: “Oh, oh, abbiamo girato tremila metri! Dio onnipotente. Ci strapazzeranno come non mai”. Spedimmo il materiale e aspettammo che si facessero vivi gli altri». Il telegramma entusiasta di Wald – secondo Lang un produttore realmente “votato” al cinema – garantisce il prodotto e permette che Clash by Night abbia un prologo insolitamente lungo, autentico documentario sull’industria del pesce in California. Quest’aurora serena e operosa del Nuovo Mondo – venata di consapevolezza letteraria (lo Steinbeck di Cannery Row) e di sincero realismo – introduce il classico triangolo sentimentale, dove una donna forte logorata dalla vita è preda di D’Amato e di Pfeiffer. Il cognome simbolico di Jerry e la sua professione rassicurano lo spettatore: è un’ancora, il marito ideale. L’altro invece passa il tempo dietro la finestrella della cabina di proiezione: un dannato ozioso. Tra il buono (un po’ grigio) e il cattivo (perché istintivo), Mae oscilla come ogni donna, ma senza superficialità. Si abbandona all’alto e al basso, alla ragione e ai sensi, con lucida, puritana fermezza. Una caratterizzazione asciutta, una Crimilde dimensione casalinga, adultera fra le pentole e il bar con tutto il distacco e la signorilità di una dama in esilio. Chissà quante ne ha fatte in quei dieci anni d’avventura! «I Hear a Rhapsody» s’intitola la canzone, eseguita da Tony Martin. I trascorsi epici di Mae, il poema della sua giovinezza forse sono quelli di Altar Keane, ma la signora Doyle ha più coraggio: si concede al brav’uomo, lo inganna, si pente, conquistando infine il perdono… fino alla prossima sbandata. The Blue Gardenia (Gardenia blu)
Casey Mayo (Richard Conte), noto giornalista del «Los Angeles Chronicle», visita la sede della West Coast Telephone Co., dove una centralinista spregiudicata, Crystal Carpenter (Ann Sothern), gli dà il suo numero. Il disegnatore Harry Prebble (Raymond Burr), che le sta facendo il ritratto, viene presentato a un’amica, la dolce Norah Larkin (Anne Baxter). Crystal, Norah e Sally Ellis (Jeff Donnell) affittano insieme un appartamento. La sera Crystal incontra l’ex marito Homer (Ray Walker), mentre Sally esce a comprare una delle amate riviste poliziesche. È il compleanno di Norah, che cena sola, davanti a una fotografia del fidanzato, combattente in Corea (fot. 94). George le scrive che si è innamorato di un’infermiera e vuole sposarla. Harry telefona e la invita nel locale «The Blue Gardenia», dove si aspetta di veder comparire Crystal. L’equivoco si risolve al meglio. Lei beve il cocktail «Pescatori di perle dei mari del Sud», lui le offre una gardenia, Nat “King” Cole canta «The Blue Gardenia» (fot. 95). Norah si ubriaca e Prebble la porta a casa sua, dicendo che lì troveranno alcuni amici. È falso, ma a lei non importa. Il giradischi di Harry suona ancora «The Blue Gardenia». La ragazza si toglie le scarpe. Si baciano. Norah ha abbassato la guardia, ma subito reagisce, respingendo il disegnatore. Lottano, il fiore cade, lei frantuma con l’attizzatoio il grande specchio sopra il caminetto e sviene. Ripresi i sensi, vede Harry che giace inanimato, fugge sotto la pioggia. Il mattino dopo è svegliata da Crystal e non ricorda niente. Anzi, parla con le amiche della lettera di George, poi, nel bagno, si guarda attonita allo specchio. Prebble è morto, la polizia trova la gardenia (fot. 96), delle scarpe femminili, un fazzoletto bordato di pizzo e sul giradischi il Tristano e Isotta di Wagner. Mayo e il fotografo Al sono presenti. Interrogata dal giornalista, la fioraia cieca del locale notturno dice che saprebbe riconoscere il fruscio particolare del vestito dell’accompagnatrice di Harry e il tono dolce e pacato della sua voce. I quotidiani raccontano che Prebble era un dongiovanni e ritraeva «ragazze da calendario», Mayo scopre che l’assassina indossava un abito di taffetà nero. Le amiche fanno congetture: una ragazza che usciva con Harry non poteva essere “per bene”. Norah replica che forse Gardenia Blu (così la stampa ha battezzato la donna del mistero) difendeva il proprio onore, ma è sempre più nervosa. Uscita in giardino, brucia il vestito di taffetà nell’inceneritore dei rifiuti. Il caso appassiona il Paese. Mayo vuole trovare l’assassino prima della polizia e fare uno scoop: scrive una lettera alla sconosciuta e la pubblica sul giornale. La ragazza riceverà aiuto se confesserà in esclusiva per il «Los Angeles Chronicle». Quando Homer, scherzando, telefona chiedendo di parlare con Gardenia Blu, Norah – sconvolta – litiga con le amiche. È solo l’inizio: molte donne chiamano Casey spacciandosi per l’assassina, che infine telefona facendosi riconoscere con l’esatta descrizione delle scarpe. Un poliziotto passa vicino alla cabina telefonica e la ragazza fugge, non senza lasciare traccia: un secondo fazzoletto bordato di pizzo. Norah richiama e questa volta riescono a fissare un appuntamento, al «Chronicle». La verità in cambio della parcella di un ottimo avvocato, sentenzia Casey, poi vanno al bar, dove il reporter – che si sta innamorando – gettona «The Blue Gardenia». Norah vuole fargli credere di essere solo un’amica dell’assassina. Due colleghi bloccano Casey, la ragazza scompare su un taxi.
FOT. 94
FOT. 95
FOT. 96
A casa, Crystal si lamenta perché voleva indossare l’abito di taffetà e le scarpe di antilope, ma non li ha trovati: ha capito tutto. Al bar, Crystal avverte Mayo che qualcuno lo attende dietro un séparé. Gardenia Blu si svela, il cronista non sa che fare, il barman avverte la polizia, la ragazza viene arrestata, i quotidiani recitano: Casey Mayo cattura Gardenia Blu. Questi è all’aeroporto, pronto a partire per un nuovo lavoro, quando gli altoparlanti diffondono il brano di Wagner, la stessa musica che la polizia ha trovato da Prebble. Non coincide con quella che il giradischi suonava la notte del delitto. Il giornalista e l’ispettore Haynes si precipitano nel negozio in cui l’ucciso ha acquistato il disco. La commessa Rose Miller (Ruth Storey) va in bagno, si taglia le vene e prima di morire racconta – in un flashback – come andarono veramente le cose: innamorata del disegnatore, lo aveva raggiunto nell’appartamento, aveva messo il disco di Wagner, scorto il fazzoletto di Norah aveva colpito in preda alla gelosia, era fuggita. Crystal offre nuovamente a Casey il proprio numero di telefono, ma il cronista, che ama Norah, getta in strada la sua affollata agenda di scapolo.
Nonostante l’aiuto di Harry Cohn della Columbia Pictures, che nel ’53 difende Lang davanti alla House Committee of Un-American Activities (Commissione per le attività antiamericane) del senatore McCarthy, dopo Clash by Night il regista segna il passo. Il suo avvocato scopre che, nel quadro della “caccia alle streghe”, Lang risulta inserito in una delle liste redatte dalla Commissione, perché comunista. I produttori lo ritengono sostanzialmente estraneo alle vicende politiche, ma preferiscono non dargli lavoro. The Blue Gardenia (Gardenia blu, 1953), finanziato dalla Warner Bros., arriva dopo tredici mesi di disoccupazione: un’occasione da non perdere. Lang lo gira in tre settimane, già provato dall’affare McCarthy.
FOT. 97
GR 1466, il numero telefonico di Crystal; Madison 60025, quello di Mayo; Michigan 5211, la polizia. Norah rompe uno specchio e, quando sviene in casa di Harry, un vortice come quello di House by the River si lega in sovrimpressione alla spirale grafica del negozio di M (fot. 97). I quotidiani titolano: «Painter of Calendar Girls Murdered in Studio Mistery» e «Police Dragnet Closes in on Blond Murderess». Casey innesca la trappola per Gardenia Blu scrivendo una «Letter to an Unknown Murderess» (fot. 98) e la incontra nella redazione del giornale. Nella grande stanza, buia e deserta, la figuretta di Norah spicca nel riquadro luminoso della porta (fot. 99). Fuori c’è molta nebbia, la ragazza chiede: «Mr. Casey, crede che si possa uccidere un uomo senza ricordarlo?». Quando parlano la prima volta nel bar, Norah finge di essere un’altra (e Casey: «Sono quasi deluso che lei non sia Gardenia Blu.»), e la seconda volta si fa schermo di Crystal (nome emblematico), dicendo poi: «Non sono che una donna innamorata di uno che ne ama un’altra» (con riferimento al fidanzato George). Casey, all’aeroporto: «Che cos’è?». Il fotografo Al: «Musica, in scatola. Mettono tutto in scatola oggigiorno». Il flashback dell’omicidio svolto per immagini
commentate dalla voce di Rose e il ritorno del numero di Crystal: GR 1466.
FOT. 98
Un meccanismo perfetto e una griglia inesorabile: soprattutto questo è Lang. Non si può restare indifferenti dinanzi a questa magica – eppur semplice, chiarissima – coincidenza di temi e situazioni. Ogni film rimanda agli altri, con cenni sparsi o per una fulminea convergenza strutturale. Se in Gardenia blu l’autore descrive con asprezza e cattiveria l’universo articolato dei media (telefono, stampa, radio), la chiave volumetrica dell’opera è giustamente una scatola. Il mobileradio, la cabina telefonica, il giradischi, l’altoparlante: contenitori, altari, feretri. Le telecomunicazioni uccidono. Il disegnatore, isolato e frustrato proprio dalla natura arcaica del suo lavoro, è solo la copia maligna del grande pittore della domenica Christopher Cross (Scarlet Street). Mentre Norah è una pallida versione delle dame brune che ossessionano Lang, è l’ombra di Alice (The Woman in the Window) e di Celia (Secret Beyond the Door). Per questo ci appare nel vano della soglia-cornice-specchio. I numeri di telefono e i titoli dei quotidiani (crittogrammi dell’incubo) svolgono l’ulteriore trionfo della lettera M. L’autocitazione del vortice liquido fuso con una spirale di carta rievoca i motivi psicanalitici, le amnesie del mostro vero (Becker) e del falso (Mark Lamphere), la teoria langhiana dell’istintualità. Al «Blue Gardenia», Norah avrebbe dovuto essere Crystal e si vergogna, ma Prebble la rassicura: «Gli impulsi non sono mai stupidi». C’è poi un tenerissimo riferimento ai giochi triangolari del melodramma mitteleuropeo. La «Lettera a una sconosciuta» redatta da Mayo, cronista fatuo e fortunato, allude a Letter from an Unknown Woman (Lettera da una sconosciuta, 1948) di Max Ophüls, storia d’amore sofferta in una Vienna totalmente ricostruita in studio. In Blue Gardenia è l’uomo che scrive, essendo questo il suo mestiere. Mestiere e denaro, appunto, routine, pratica brutale dello scoop a ogni costo. Come credergli? Eppure il lettore ha bisogno di menzogne avvolte nel sentimentalismo – di un qualche Tristano, di una certa Isotta – e il nostro piccolo manipolatore di notizie, giusto un ragnetto rivestito, s’improvvisa reporter galante, detective per signora. Mayo confeziona un involucro rosa, un bel testo, in cui la fanciulla dal piede nudo e leggero, di taffetà nero vestita, possa soavemente cadere. Come fa il lettore del «Chronicle», coinvolto in una love story epistolare con l’enigmatica e certamente sexy Gardenia Blu.
FOT. 99
The Big Heat (Il grande caldo) Il poliziotto Thomas Duncan si uccide con un colpo di pistola, dopo aver preparato una lettera indirizzata al District Attorney di Kemport (fot. 100 e 101). La moglie Bertha (Jeannette Nolan), resasi conto che lo scritto denuncia i capi della malavita locale, avverte il boss Mike Lagana (Alexander Scourby), che muove subito il fidato Vince Stone (Lee Marvin). Bertha si finge sconvolta e nasconde l’esistenza della lettera al sergente Dave Bannion (Glenn Ford) che, constatato il suicidio, archivia il caso.
FOT. 100
Mentre cena con la moglie Katie (Jocelyn Brando, fot. 102), Bannion viene chiamato da Lucy Chapman, una entraineuse del locale «The Retreat». La ragazza svela di essere stata l’amante di Duncan, che si apprestava a divorziare da Bertha e quindi non aveva motivo di uccidersi. Tornato dalla vedova, il sergente scopre che il defunto era un donnaiolo, per di più ricco, possedendo anche una casa nell’East Side. Lucy viene uccisa, dopo una lunga tortura, testimoniata da bruciature di sigaretta su tutto il corpo. Il tenente Wilkes (Willis Bouchey) ordina a Bannion di lasciar perdere il caso Duncan, ma il sergente torna nel locale notturno per interrogare il barman Tierney. Questi è una pedina di Lagana e, uscito il poliziotto, subito informa il boss.
FOT. 101
Quella sera Katie Bannion risponde al telefono e viene insultata. Poi lo sconosciuto diffida il sergente dall’impicciarsi degli affari altrui, altrimenti… Dave si reca nell’abitazione di Lagana, lo accusa e pesta una guardia del corpo. Wilkes ammonisce Bannion: non ha intenzione di rovinarsi la carriera per colpa sua.
Mentre il sergente addormenta la figlia Joyce, Katie esce per mettere l’auto nel garage. La macchina esplode, la donna muore tra le fiamme. Il commissario Higgins (lo abbiamo visto giocare a poker con Stone) promette a Dave che il colpevole sarà punito. Il sergente ribatte che anche il superiore è uomo di Lagana e viene licenziato.
FOT. 102
Joyce è ben custodita in casa del cognato e Dave – amareggiato, duro persino con gli amici migliori – va a vivere in albergo, rifiutando l’aiuto dell’ex collega Burke. Nell’appartamento di Stone, Lagana spiega che Bertha ha nascosto la lettera del marito e chiede 500 dollari alla settimana per tacere. Poi accusa di incompetenza il killer Larry Gordon: le elezioni sono vicine, perché ha lasciato il cadavere di Lucy in mezzo alla strada, che bisogno c’era di eliminare Katie Bannion? La ragazza di Vince, Debby Marsh (Gloria Grahame), prepara i cocktail e si burla del fidanzato. Dave interroga il principale di Slim Farrow, sospettato di aver messo la bomba nell’auto. Slim è morto, ma Bannion riceve un aiuto insperato dall’anziana segretaria Selma Parker. La donna racconta che Slim, prima di morire, aveva incontrato due uomini, fra cui un certo Larry, reperibile a «The Retreat». Qui Dave trova Vince e Debby. Il gangster perde ai dadi e per sfogarsi brucia con la sigaretta la mano di una ragazza. Bannion, senza preamboli, gli chiede se è lui il torturatore di Lucy Chapman, Stone si defila e il sergente esce dal locale, tallonato da Debby, che lo accompagna in albergo. La ragazza spiega che ci sono dei vantaggi a frequentare un bruto come Stone – denaro, abiti, viaggi – e simpaticamente tenta di sedurre Bannion, che la respinge con fermezza. Tornata a casa, Debby mente al fidanzato, ma un gangster l’ha vista allontanarsi con Dave e, mentre lei si trucca davanti allo specchio, Vince le getta in faccia del caffè bollente.
FOT. 103
Condannata a morte da Lagana, Debby – che ha bendato il lato sinistro del viso (fot. 103) – trova rifugio nell’albergo di Bannion e gli comunica l’indirizzo di Larry. Selma Parker riconosce in lui l’individuo che ha parlato con Slim. Dave lo fa parlare: Vince ha ordinato l’omicidio di Katie, Slim ha collocato la bomba, i Duncan erano da anni nella banda. L’ex sergente quasi strangola la vedova per sapere dove ha nascosto la lettera, ma Lagana – avvertito – ha chiamato la polizia, che allontana Bannion. I gangster tentano di rapire la figlia di Dave con la complicità di Higgins, che ordina agli agenti di interrompere la sorveglianza. Bannion accorre, ma gli ex commilitoni del cognato fanno buona guardia e il sequestro va in fumo. Poco prima, in un tenero colloquio, Dave ha raccontato a Debby alcuni episodi della vita con Katie. L’ex ragazza di Vince si reca da Mrs. Duncan e la uccide. Stone entra in casa, accende la luce e viene ustionato da un getto di caffè bollente lanciato da Debby, che gli mostra il lato devastato del viso (fot. 104): Bertha è morta, per lui e per Lagana si sta avvicinando la fine. Vince le spara, ma arriva Bannion, che ferisce il gangster e lo consegna a due ex colleghi. Debby chiede ancora dettagli del carattere di Katie, sorride alle parole di Dave, spira serenamente. I giornali riferiscono che Higgins e Lagana sono indagati. Dave viene reintegrato in servizio, un altro caso lo attende.
FOT. 104
Dopo The Blue Gardenia Lang stende un soggetto, The Running Man (t.l. L’uomo che corre), ispirato a un articolo del «New Yorker» intitolato Lost (Perduto), dove il protagonista sfrutta l’amnesia per evitare, inconsciamente, le proprie responsabilità. Il regista porta gli occhiali e talvolta un feltro protettivo sull’occhio destro, sempre più debole. The Big Heat (Il grande caldo, 1953), tratto dal romanzo di William P. McGivern, uscito in un primo tempo a puntate sul «Saturday Evening Post», testimonia ancora la predilezione di Lang per i temi della letteratura popolare. The Big Heat è uno dei suoi film più noti, sovente programmato in televisione, spesso citato. Che sia un’imbarazzante sensazione di déjà vu il segreto del successo? Il debito evidente nei confronti del cinema poliziesco che si richiama ai libri di Raymond Chandler – primo fra tutti The Big Sleep (Il grande sonno), realizzato nel ’46 da Hawks con la coppia BogartBacall – viene saldato dal regista proprio restando fedele a se stesso. Dave Bannion è un uomo onesto nella città corrotta, duro abbastanza da sfidare il crimine organizzato e vincere da solo, se non contiamo l’apporto decisivo della ragazza. Tuttavia non è Marlowe: fa parte di una struttura pubblica (la polizia), ha una famiglia, evita osservazioni retoriche e melanconie sul significato dell’esistenza. Non è un eroe da romanzo, difficile mitizzare Bannion, che parte integrato, via via si riscuote e quasi s’impenna – stavolta come Marlowe – contro il verdetto della sorte. Il detective privato chandleriano aggira le alte pareti del destino filosofando da esistenzialista e si rompe la testa solo quando non ha scelta; il sergente langhiano invece è un ariete, un cupo montone infuriato. Sentore di zolfo vela la sua storia o, meglio, puzzo di bruciato: quante sigarette spente sulla carne viva, e il fuoco che divora Katie, e il volto ustionato di Debby. Dave, creatura celeste o schiavo del Maligno? Nient’altro che un Joe Doe, un bravo cittadino che ha visto offesi i suoi diritti, oltraggiati gli affetti. Sempre labile il confine tra bene e male: Bannion si libera (temporaneamente) degli impacci della legge, Debby riscatta la propria metà oscura togliendo le castagne dal fuoco a Dave. Chi si brucia e uccide è lei, non l’ex sergente. Il protagonista, lacerato dal conflitto tra dolore legittimo, che spinge alla vendetta, e osservanza del codice morale, non decide quasi niente. Essere o non essere? Indaga, ma questo era il suo mestiere, dov’è l’impeto e l’assalto degli istinti? Dave Bannion – come Joe Wheeler (Fury) un amleto americano – non conosce la psicologia del profondo o non se ne cura, perché la sua tozza, quadrata silhouette è la porta che il regista schiude allo spettatore, chiamato a risolvere gli enigmi seminati nel testo. Calandosi nel ruolo di Dave, il pubblico si identifica, indossa i suoi panni, visita – in un’ideale soggettiva – i luoghi dell’azione. Lo sceneggiatore di Lang, il giornalista Sidney Boehm, esperto di cronaca nera, tende a presentare i fatti dal punto di vista di Bannion, suscitando un interrogativo che sembra naturale (cosa avrei fatto io al suo posto?) e la vecchia lusinga dei media (anche voi potrete dire: c’ero anch’io). Semplice, molto efficace. Il nostro caro angelo nell’inferno, marito fedele e padre amorevole, si specchia nell’impuro Duncan – suicida, adultero, prezzolato, stretto nella morsa di Bertha e Lucy – come Debby, versione conturbante di Emma Robey (Secret Beyond the Door), si riflette nel volto di Katie (ventisette anni, dolce, bionda, occhi azzurri), che peraltro non ha mai conosciuto. Debby Marsh è sorella di Jenny Stokes (Man Hunt), in quanto si immola per amore di un uomo che non potrà mai avere, e di Kitty Marsh (Scarlet Street), perché – nonostante Hays – dichiara quasi apertamente il suo mestiere. La
sintesi di queste figure muliebri si compie quando la ragazza, con il lato sinistro del viso bendato, si presenta a Bertha (fot. 105): «In fondo ci somigliamo – dice – tutte e due con il visone». Spara tre colpi di pistola a Mrs. Duncan, che scivola dietro la scrivania del marito, non dissimile da quella di Mabuse o di Haghi. Un’altra ragazza-freccia ha colpito il cuore del mefitico dragone. Sono comunque sgualdrine dalle “gambe pigre” che il sentimento ha mutato in valchirie, fanciulle segnate dal marchio d’infamia (l’ustione simbolica), irrecuperabili, emarginate, reiette. «Io non tocco quello che appartiene a Vince, nemmeno con le molle», commenta Bannion davanti alle seduzioni di Debby. Ancora l’odore di zolfo, la parete invisibile tra dannazione e salvezza che il puritano eleva nel proprio intimo. L’arcidiavolo Stone, il satanico Lagana, la sventurata Debby, nel loro sfrenato sabba di emozioni, sono certamente più vivi e brillanti degli ordinari campioni del bene.
FOT. 105
Human Desire (La bestia umana) Rotaie, viadotti, gallerie, ponti. Jeff Warren (Glenn Ford), reduce da tre anni di guerra in Corea, ha ripreso il lavoro di macchinista delle ferrovie. Affitta una stanza in casa del collega Alec Simmons (Edgar Buchanan) e regala un kimono a sua figlia Ellen (Kathleen Case), che è innamorata di lui. Alla stazione i due amici incontrano il caposquadra Carl Buckley (Broderick Crawford), che si è sposato da poco. Vicki (Gloria Grahame), la sua bella moglie, lo attende oziando sul letto. Carl ha perso il posto e le chiede di persuadere l’alto funzionario Owens a reintegrarlo in servizio. Vicki fissa un appuntamento e insieme al marito sale sul treno per Chicago, condotto da Jeff e Alec. La donna lascia Carl nell’appartamento dell’amica Jean e raggiunge l’ufficio di Owens, dove si trattiene per alcune ore. Al rientro, Vicki informa il marito che ha riavuto il suo posto, ma questi si è ingelosito a causa del ritardo. Non crede che in quelle tre ore abbiano solo parlato e quando la moglie lo respinge, disgustata, l’uomo la induce a confessare di essere stata l’amante del funzionario, quando sua madre lavorava per lui. Il marito la obbliga a scrivere un biglietto per Owens, in cui programma un incontro sul treno della notte. Carl accoltella Owens sotto gli occhi di Vicki, gli sottrae orologio e portafoglio e controlla il corridoio, dove Jeff sta fumando una sigaretta. La moglie fa da esca ed esce per prima, chiedendo al macchinista indicazioni per il ristorante. Lui propone di bere un whisky. Il ristorante è chiuso, i due fumano in uno scompartimento vuoto, ma un sobbalzo del treno spinge Vicki tra le braccia di Jeff: si baciano. La mattina dopo i coniugi Buckley scendono dal treno e incontrano il macchinista, che finge di non conoscere la donna. Carl brucia nella caldaia di casa gli oggetti di Owens, ma conserva il biglietto scritto da Vicki, un eccellente strumento di ricatto. Facendo colazione con Vera ed Ellen Simmons, Jeff racconta dell’omicidio sul treno. In tribunale un frenatore testimonia di averlo incontrato in corridoio la notte del delitto. Jeff viene messo a confronto con i Buckley, che occupavano lo scompartimento adiacente a quello dell’ucciso, ma anche stavolta mente per proteggere Vicki. Ritrova marito e moglie al bar. Carl, ubriaco, si allontana e Jeff, rimasto solo con Vicki, ascolta la sua versione dei fatti: era andata da Owens perché era un conoscente di sua madre e l’aveva trovato morto. Quindi mostra al ferroviere i lividi causati dalle percosse di Carl, un bruto, la vita con lui un autentico inferno. Jeff l’abbraccia. Mentre questi è al lavoro, Vicki litiga con Carl, che non vuole distruggere il biglietto compromettente. Vicki scorge il marito che controlla il nascondiglio e, a sua volta, fruga dietro la griglia di areazione: niente lettera, solo il denaro di Owens. Quella sera incontra Jeff presso la ferrovia e racconta che ha sposato Carl per avere una casa. Il macchinista replica narrando la quotidiana brutalità della guerra in Corea. Si baciano. La donna gli dà appuntamento in città, a casa di Jean. Ellen Simmons vorrebbe accompagnare Jeff al ballo del Circolo Ferrovieri, ma si accorge che lui pensa soltanto a Mrs. Buckley e piange. Alec consiglia al collega di lasciar perdere le donne sposate: il paese è piccolo, la gente parla. Nell’appartamento di Jean, Vicki rifiuta di lasciare Carl per sposare Jeff, gli racconta la verità sulla morte di Owens e parla della lettera con cui il marito
la ricatta. Jeff si mostra comprensivo e promette di non lasciarla, ma sospetta di lei. Il giorno dopo Vicki informa l’amante che Carl è stato nuovamente licenziato e medita di andarsene con lei altrove. Se solo gli succedesse qualcosa… Carl esce ubriaco dal bar di Dugan, Jeff lo attende nell’oscurità piovosa, lo pedina tra i vagoni della stazione, afferra una pesante barra metallica. Tornato da Vicki, Jeff riferisce che, invece di uccidere Carl, l’ha aiutato a rialzarsi dopo una caduta. Vicki, furiosa, lo insulta e il macchinista comprende di essere stato usato, ma le consegna il prezioso biglietto, trovato nel portafoglio del marito. La mattina seguente i Buckley si incontrano sul treno condotto da Jeff. Carl supplica la moglie di restare. Vicki risponde che amail macchinista, ma lui non vuole saperne, poi narra i dettagli della relazione con Owens. Carl, disperato, la strangola. Jeff e Alec sono insieme sulla locomotiva: davanti a loro i binari indicano l’aperto orizzonte.
Il primo luglio 1954 Thea von Harbou muore a Berlino, dopo una proiezione di Der müde Tod. Lang sta girando Human Desire (La bestia umana) per la Columbia Pictures. Il titolo provvisorio, The End of the Line, Human Beast (La fine della corsa, la bestia umana), chiarisce meglio i riferimenti letterari dell’opera, liberamente ispirata al romanzo La bête humaine di Emile Zola. Il produttore Jerry Wald aveva molto apprezzato la versione diretta nel ’38 da Jean Renoir (t.it. L’angelo del male). «Il protagonista era Jean Gabin, nella parte di un maniaco sessuale: poteva fare l’amore con una donna soltanto uccidendola. Naturalmente, in un film americano, il protagonista non può essere un maniaco sessuale assassino. Non è possibile. Perciò Glenn Ford doveva interpretare il personaggio come Li’l Abner che torna dalla Corea – spiega Lang – un sano americano al cento per cento con comportamenti sessuali molto naturali (se mai esiste una cosa del genere)». Li’l Abner – rustico giovane di provincia, blando eroe del fumetto creato nel ’34 da Al Capp – diventa Jeff Warren, conteso da una dolce, comprensiva, vergine bruna e dalla rituale bionda senza scrupoli. Il ruolo di Vicki era destinato a Rita Hayworth, ma Gloria Grahame se la cava benissimo, accentuando in senso drammatico la già ottima caratterizzazione di Debby in The Big Heat. Binari, lacerti di ferro, ingranaggi, ruote stridenti siglano la vita dura e grigia dei ferrovieri. Carl lavora tutto il giorno «come una bestia». Le gallerie che tanto piacevano a Jerry Wald parlano chiaro: unica evasione, il sesso. L’avvenente mogliettina, certamente non destinata a lui, lo aspetta acciambellata sul letto come una gatta: è una pitonessa e soprattutto una sgualdrina rea confessa. La gelosia di Carl appare ingiustificata, visto che sfrutta spudoratamente le qualità seduttive di Vicki. Come se Johnny Prince fosse geloso di Kitty “Lazy Legs”. Di fronte alla concupiscenza del maschio, le donne reagiscono con cinismo (Jean a Carl: «Siamo tutte uguali. Con un volto diverso perché non possiate confonderci l’una con l’altra.») o ribrezzo (Vicki a Carl: «Giù quelle mani. Che schifo mi fate tutti!»). L’affetto è un’ipotesi. Lang gioca con la finzione sentimentale come ha fatto nelle sue convulse storie di spionaggio, ma questa volta il triangolo ha solide polarità letterarie e cinematografiche. Zola, certo, ma anche Il postino suona sempre due volte (1934) di James M. Cain, con le sue immagini di un’America desolata e fatale. La bête humaine di Renoir unita agli adattamenti del romanzo di Cain, da Le dernier tournant (1939) di Pierre Chenal a Ossessione (1942) di Visconti e The Postman Always Rings Twice (1946) di Tay Garnett, interpretato da John Garfield e Lana Turner. Con tanto passato, la scelta stilistica di Lang è quasi obbligata. Ma quale realismo? Sicuramente non quello “poetico” di matrice francese, bensì un calibrato incontro dell’opzione italiana con la sobrietà della linea statunitense. Questo ci riporta a un’altra caratteristica di Lang, la sua straordinaria capacità mimetica. Il regista aggiunge al melodramma un pizzico di nero britannico ricavato da Rope (Nodo alla gola, 1948) di Hitchcock. L’appartamento dei Buckley è una gabbia con due cavie. «Gatto e topo, gatto e topo» sussurra uno dei protagonisti di Rope, e non è forse questa la partita crudele che marito e moglie giocano nel soffocante interno domestico? Quella griglia nella parete che nasconde il tesoro, la lettera, è anche un modo per indicare l’unica via d’uscita concessa agli sposi nemici: autodistruggersi. Non è un tema nuovo per Lang. Sia Adele (Scarlet Street) che Mark (Secret Beyond the Door) lasciano trovare – come un’esca – il loro ripostiglio segreto (punto di forza e di vulnerabilità) al coniuge,
ansioso di scoprirne l’ubicazione. Warren, che monta abitualmente il “cavallo di ferro”, la locomotiva, in un primo tempo cede alle lusinghe di Vicki, la morbida gattina di città. Serrato nell’armatura rifulgente, il guerriero entra nel Venusberg che la bionda gli ha dischiuso, ben sapendo che c’è una soave Madama Butterfly (così Vera chiama sua figlia Ellen) ad attenderlo, di riserva. Per la piccola Simmons, Jeff è un bravo americano da salvare. Dopo avergli passato una telefonata di Vicki, la ragazza offre il suo aiuto. Parlano della donna adatta. «Non capisco che genere di amore può essere questo, se rende la gente infelice. Io non lo concepisco», gorgheggia Ellen in lacrime, ma è più fortunata di Cio-Cio-San. Lo scontro tra Jeff e Vicki – o il femminino inquietante – è svolto da Lang in due tempi, come fa Wagner nel duello Parsifal/Kundry. La donna si nega con una sequela di banalità (non c’è avvenire per noi due, se t’avessi incontrato prima sarebbe stato diverso, ora è tardi, basterebbe un niente, se solo gli succedesse qualcosa), accennando dimessa allo scopo. Quando il ferroviere si mostra incapace di uccidere, Vicki diventa aggressiva e lo accusa di essere proprio come tutti gli altri: «Su, dillo anche tu: prostituta!». Pronunciata la parola, superato il tabù, segue l’ovvia confessione: la moglie di Owens era invalida, la madre di Vicki era cuoca nella casa di campagna del funzionario, lei aveva sedici anni, lui la vide nuotare in piscina e non la mollò più. Alec aveva ben ammonito il collega: non è giusto né onesto correre dietro alle donne sposate. Anche se Kundry, per amore di Parsifal, si trasforma nella Maddalena evangelica, il giudizio della comunità resta, implacabile. Vicki, usando per l’ultima volta la perfidia di cui è capace lo stereotipo della femmina acciaio e veleno, stimola la reazione omicida di Carl, alcolizzato e senza lavoro. Troviamo qui l’iterazione della fine di Debby in The Big Heat. Poiché non avrà Jeff e le mani dell’altro sono una nauseante, concreta realtà, Vicki si annulla, facendosi uccidere dal degno consorte/reietto. Per lei non esiste redenzione né riscatto sociale: solo la morte. Coerentemente il regista definisce con i toni dell’aurora, del mattino e del pieno giorno le scene di lavoro, speranza e futuro, mentre la notte rimane consacrata alla disperazione, al sesso, all’intrigo, al delitto. Melodrammatiche luci di taglio solcano la fitta ombra, delimitando i confini tra bene e male. Vicki, creatura delle tenebre, muore nella scatola/ trappola (il vagone ferroviario) da cui non avrebbe potuto mai evadere. Moonfleet (Il covo dei contrabbandieri) Dorsetshire, Inghilterra, 1757. Il giovane John Mohune (Jon Whiteley) sta cercando qualcuno che suppone suo amico. Dalle coste e dagli anfratti selvaggi passiamo a un incrocio con l’indicazione per Moonfleet, davanti a cui il ragazzo si sofferma di notte. Vede accendersi gli occhi di un angelo statuario che decora il vicino cimitero, poi una mano spunta dalla terra. John si risveglia nel covo dei contrabbandieri, ma ha con sé una lettera della madre indirizzata a Jeremy Fox (Stewart Granger), il dandy che di lì a poco entra nella locanda in compagnia di una danzatrice gitana (fot. 106). Lo scritto, di pugno della defunta Olivia Mohune, induce il capo dei contrabbandieri a ricordare le glorie trascorse della famiglia di John, ridotta ora in povertà. Jeremy, innamorato di Olivia, era stato brutalmente respinto dai parenti di lei, che l’avevano sposata a un altro. In seguito Fox ha acquistato il maniero degli orgogliosi Mohune e John prova la sua identità mostrandogli l’anello con lo stemma del nonno. Dopo aver frustato Nat Greening, colpevole della sottrazione di alcuni barili di cognac, Jeremy deve difendersi dal coltello del gregario e lo stende con un colpo di pistola. Il fuorilegge vuole sbarazzarsi del ragazzo, ma John salta dalla carrozza che lo riporta in collegio e incontra la giovane amazzone Grace (Donna Corcoran), nipote del magistrato Maskew (John Hoyt), che indaga sui contrabbandieri. I due lo guidano alla residenza di Fox, dove il ragazzo osserva dall’esterno i convitati che mangiano e bevono, mentre la zingara esegue un numero di flamenco. Lord Ashwood (George Sanders), ubriaco, chiama malvivente il padrone di casa, che non replica all’insulto. Fox accoglie John, che durante il temporale notturno ha il suo incubo ricorrente: cani sciolti nel padiglione d’estate che sbranano l’accompagnatore di sua madre. La donna del bandito, Anne Minton (Viveca Lindfors), incautamente racconta al ragazzo che Jeremy ha alcune brutte cicatrici sul dorso. Fox decide di rimandare Anne nelle colonie d’oltremare. Il giorno dopo Grace porta John nel padiglione d’estate, invaso dalle erbacce. Il piccolo Mohune viene informato che nel cimitero inondato dalla burrasca è stato trovato il corpo di Greening: la gente attribuisce l’omicidio al fantomatico Barbarossa, ancora in cerca del suo diamante perduto. Il pastore ha
accusato i paesani di credere ancora alle apparizioni dello spettro di “Barbarossa” John Mohune, antenato del protagonista, la cui statua si trova in un angolo della chiesa. Questi tradì il suo re in cambio del diamante. Con quella pietra John medita di ricomprare la dimora degli avi e, munitosi di una lanterna, visita nottetempo il cimitero. Giunto davanti alla statua dell’angelo, cade nella cripta che serve da rifugio-magazzino ai contrabbandieri, dove trova la tomba del cavaliere Mohune. Lo scheletro reca un medaglione, ma giungono Fox e compagni. La ribellione serpeggia: questi esigono dal capo una percentuale più alta sulle mercanzie (cognac, seta, tabacco). Jeremy gioca a moscacieca in casa di Ashwood (fot. 107), che gli propone un affare di pirateria: sta armando tre navi a Rotterdam, vuole entrare in società con lui? L’avvenente Lady Ashwood (Joan Greenwood), amante di Fox, sostiene l’offerta del marito. Il contrabbandiere Ratsey, svegliato dalle grida di una donna che afferma di aver visto il fantasma di Barbarossa, trova John nella cripta e avverte Jeremy.
FOT. 106
FOT. 107
Nella locanda i fuorilegge discutono la sorte del ragazzo e Ratsey giudica privo di interesse il cartiglio con i versetti della Bibbia rinvenuto nel medaglione. L’edificio viene circondato dalle guardie del re, condotte da Maskew, che compiono un’accurata perquisizione. Arriva Fox, che parla con il magistrato e, usciti gli sbirri, affronta in duello Elzevir Block, pretendente al ruolo di leader. Sconfitto il rivale, Jeremy impedisce l’eliminazione di John. Intanto Anne ha scritto una lettera alla polizia, in cui segnala dove arrestare i malviventi. Gli uomini di Maskew sorprendono la banda di Fox presso l’approdo notturno del battello francese Bonaventure, che trasporta merci di contrabbando e dovrebbe condurre Anne e John nelle colonie. Il magistrato viene ucciso nella sparatoria, la donna muore intercettando una palla diretta a Jeremy, che fugge seguito dal ragazzo. Alla macchia, Fox decifra il cartiglio del medaglione, che indica come arrivare al diamante, nascosto probabilmente nel pozzo della fortezza di Hollisbrooke, di cui Barbarossa Mohune era stato governatore. I fuggitivi – su cui grava una taglia di cento ghinee – entrano nella fortezza. Fox, travestito da comandante delle guardie (fot. 108), individua il pozzo e cala John in un secchio. Recuperata la pietra, i due fuggono a cavallo all’arrivo del vero comandante.
FOT. 108
Gli Ashwood giungono alla spiaggia sotto la scogliera, nel rifugio del contrabbandiere, desiderosi di verificare la consistenza finanziaria del socio, che mostra il preziosissimo diamante. Lasciato un messaggio per John
(«Vostra madre non avrebbe dovuto riporre in me la sua fiducia.»), addormentato nella capanna, Jeremy si allontana in carrozza con James e Clarissa, superando un posto di blocco della polizia. Improvvisamente Fox si rende conto di essere nelle mani degli Ashwood, che inoltre vogliono sbarazzarsi di John. Nella lotta che segue il contrabbandiere viene ferito gravemente da un colpo di spada e uccide James con la pistola. La carrozza si rovescia, Fox tornaalla capanna, riprende il messaggio, sveglia John, gli consegna il diamante, che il ragazzo dovrà dare al pastore di Moonfleet, narrandogli l’accaduto. In quanto a lui, deve partire, ma si rivedranno appena possibile. Si salutano: l’uomo prende una barca e svanisce sul mare. John apre il cancello di casa Mohune alla presenza di Grace e del pastore, sicuro che l’amico Fox tornerà presto.
Nel 1954 Lang scrive, con lo pseudonimo di Michael Latté, la sceneggiatura Dark Spring (Cupa primavera), un giallo psicologico mai realizzato, e nel ’55 torna, dopo vent’anni, alla MGM per girare il suo primo Cinemascope, Moonfleet (Il covo dei contrabbandieri), dal romanzo omonimo di John Meade Falkner. Protagonista un adolescente, ultimo dei superbi, tirannici Mohune. L’inizio curiosamente replica quello di Der müde Tod (l’incrocio, un’apparizione), a cui il film è legato anche per la diffusa atmosfera romantica. Lang parla di influenza dickensiana, Moonfleet (letteralmente: La flottiglia della luna = i contrabbandieri) è piuttosto un rimpasto letterario. Anzitutto il quid, il diamante, che evoca la seconda parte di Die Spinnen, innescando la ricerca del tesoro: costante langhiana e argomento base di ogni avventura.
FOT. 109
Le vicende del giovane Mohune ricalcano quelle di David Balfour di Shaws, protagonista dello stevensoniano Kidnapped (Il ragazzo rapito, 1886). Presentando la statua dell’antenato Barbarossa (volto chiuso e lunghi capelli, impugna una grande spada, fot. 109), Lang coniuga l’inafferrabile ma petrosa specificità della Morte in Der müde Tod e la figura del pirata Long John Silver, infido e crudele, potenziale uccisore di ragazzi, che Stevenson ha reso celebre con Treasure Island (L’isola del tesoro, 1883). Il contrabbandiere gentiluomo Fox (= volpe) rappresenta uno stereotipo e al contempo cita il mitizzato fuorilegge Alan Breck Stewart, spirito ribelle e maestro di vita per il suddetto David Balfour di Shaws. Nel pastiche avventuroso non poteva mancare il messaggio affidato alla bottiglia, in questo caso un medaglione con cartiglio e versetti biblici (da Geremia, da Giosuè e dai Salmi; l’ultimo recita: «Dite al giusto che non cerchi la luna nel pozzo», ancora l’anello che giace sul fondo), la cui numerazione è stata appositamente sbagliata da Barbarossa onde consegnare il tesoro a chi sappia individuare la chiave, o cifra, del testo. Tipico di Lang, insieme alle opposizioni alto/basso e luce/ombra che governano il set. Come il piccolo John Mohune, noi tutti sappiamo che l’oscurità è il male, che i mostri concreti o inconsci risiedono nell’abisso. Heaven and Hell, secondo la storica ricetta del teatro elisabettiano: le figurazioni celesti scendono, i demoni e gli spettri salgono, mentre le tavole del palco stanno lì a separare due mondi. Le cadute simboliche del protagonista sono passaggi dall’uno all’altro universo, mediatore l’angelo del cimitero. Gli occhi innaturalmente bianchi e pulsanti della statua assomigliano a quelli dell’ipnotizzatore Mabuse, legittimando l’ipotesi che l’intera avventura di John sia nient’altro che un’allucinazione. Paure e orrori neogotici, grotte e castelli para-disneyani, un Settecento inglese totalmente ricostruito a Hollywood (esterni a Oceanside, California) compongono il quadro di Moonfleet, sostanzialmente tardo-barocco e visionario. Il regista ha citato, quale riferimento pittorico, le tele di William Hogarth
(1697-1764), cronista impietoso di un’epoca travagliata e dinamica come poche altre. Ritratti di Hogarth sono certamente gli Ashwood (fot. 110). Formidabile unione di libertinaggio e atteggiamenti canaglieschi, i due affondano – come sempre tramite i nomi – solide radici nella letteratura anglosassone. Lei direttamente richiama l’eroina del famoso romanzo Clarissa (1748) di Samuel Richardson, mentre lui, James, è un manigoldo astuto, che echeggia l’abile domestico protagonista degli Yellowplush Papers (1838) di Thackeray.
FOT. 110
«Il ragazzino ama e ammira l’eroe, Stewart Granger, che andandosene dice: “Tornerò da te”. Granger sta morendo e volevo far vedere che “tornerò da te” è l’ultima cosa che quest’uomo può fare per il ragazzo. Si allontana con la barca mentre il ragazzo resta sulla spiaggia. Vediamo che Granger muore, ma l’imbarcazione continua ad allontanarsi perché la sua mano, ormai senza vita, regge ancora la vela. Questa era la mia conclusione». Nonostante il lieto fine sgradito a Lang e aggiunto dalla produzione, Moonfleet è un esempio di coerenza nella diversità. Eastmancolor e Cinemascope (la risposta di Zanuck ai film tridimensionali) offuscano ma non possono cancellare il definito tocco registico, l’intuizione del criss-cross iniziale, quella trappola tesa nella notte all’eroe puro e solitario che stabilisce, come sigla ben nota, l’autenticità del dipinto. While the City Sleeps (Quando la città dorme) New York, 1956. La giovane bibliotecaria Judith Fenton viene assassinata sotto la doccia da un falso fattorino in giacca di cuoio, che usando il rossetto della vittima scrive sulla parete: «Ask mother» (chiedi alla mamma, fot. 111). Amos Kyne, magnate dei media, ha indetto una riunione dei capi servizio per discutere l’omicidio Fenton. Sono presenti: Mark Loving (George Sanders), responsabile della rete televisiva, Jon Day Griffith (Thomas Mitchell), direttore del «New York Sentinel», Harry Kritzer (James Craig), della sezione fotografica, e Edward Mobley (Dana Andrews), scrittore, giornalista, conduttore di un programma tv. Kyne ricorda a quest’ultimo, suo preferito, i doveri della libera stampa verso il cittadino, e poco dopo muore. Gli succede il figlio Walter (Vincent Price), un buono a nulla che si svela anche sadico istituendo una gara fra Loving, Griffith e Kritzer: chi scoprirà l’assassino di Judith Fenton sarà direttore generale.
FOT. 111
La cronista Mildred Donner (Ida Lupino), amante di Loving, funge da spia nei campi avversi, mentre Kritzer, amico di Walter Kyne e drudo della moglie, attende il suo momento. Mobley corteggia la segretaria Nancy Liggett (Sally Forrest), una brava ragazza, che lo convince ad aiutare Griffith. La polizia arresta il portiere del condominio di Judith Fenton, ma un’altra giovane muore. Presso il corpo dell’istitutrice Laura Kelly il mostro ha ironicamente lasciato una rivista poliziesca, «Lo strangolatore». Il reporter Gerald Meade fornisce a Loving una pista che si rivela falsa. Mobley si rivolge al «signor sconosciuto» dallo schermo tv, proponendo un identikit: ventenne, viziato, capelli castani, odia sua madre.
L’omicida Robert Manners (John Barrymore jr.) sta seguendo la trasmissione: da una battuta della madre veniamo a sapere che al suo posto avrebbe desiderato una bambina. Mobley annuncia il fidanzamento con Nancy, pensando di usarla come esca per l’assassino. Mildred tenta di sedurre Mobley per avvicinarlo al partito di Loving, ma il cronista, ubriaco, riesce soltanto ad abbracciarla in un taxi. Intanto Kritzer e Dorothy Kyne (Rhonda Fleming) sono nell’appartamento che hanno affittato, proprio davanti a quello di Nancy Liggett. Il sedicente fattorino Manners si fa aprire, vede la donna che si aggiusta una calza di fronte allo specchio (fot. 112) e blocca la serratura. Uscendo legge un biglietto di Eddie appeso alla porta di Nancy. Il giorno dopo Mildred racconta in redazione la sua avventura con Mobley. La fidanzata viene a saperlo e pensa di mollarlo, ma l’assassino la segue. Eddie improvvisamente intuisce che stavolta il mostro colpirà di giorno, «sotto gli occhi del poliziotto di scorta», e con l’amico tenente Kaufman corre a casa di Nancy. La ragazza tuttavia non ha aperto a Manners che, frustrato, entra da Dorothy. Questa si difende ed è accolta dalla vicina. L’omicida fugge ed è braccato in strada. Eddie lo affronta in un tunnel della metropolitana, ma l’arrivo del treno li separa. Manners, emerso da una bocca di aerazione, è arrestato dalla polizia. Mentre Loving crede di aver spezzato l’alleanza fra Griffith e Mobley, quest’ultimo riferisce gli ultimi avvenimenti al direttore del «Sentinel», che prepara un’edizione straordinaria, ma sbaglia inviando Mildred a intervistare «la donna che si trova in casa di Nancy», cioè Dorothy Kyne. Kaufman passa a Mobley il testo della confessione di Manners, che ha ucciso quattro donne. Quando il trionfo di Griffith sembra certo, Loving infuriato e sconfitto davanti alla prima pagina del giornale, ecco giungere Mildred e Kritzer, subito ricevuti da Kyne. Al bar con Griffith e Nancy, Eddie mestamente commenta che, ricattando Walter, Kritzer otterrà il posto e Mildred una rubrica tutta sua. Kyne entra e, non visto, ode le parole del cronista. Mobley, dimissionario, sposa Nancy. Durante la luna di miele in Florida, il quotidiano locale annuncia che Griffith è stato nominato direttore generale della Kyne Incorporated e Mobley redattore capo del «Sentinel».
FOT. 112
While the City Sleeps (Quando la città dorme, 1956), dopo Fury il film americano preferito da Lang, avrebbe dovuto chiamarsi News Is Made at Night. La redazione del «Sentinel» assomiglia a quella del «Los Angeles Chronicle» in Gardenia blu: in questo e nel primo gli eroi sono giornalisti, newspaper-men, creatori di notizie. Il titolo provvisorio già formula un giudizio sull’operato dei Mayo e dei Mobley alle prese con alcuni clamorosi omicidi. Entrambi si rivolgono allo sconosciuto attraverso i media, lo intrappolano solleticandone la vanità e lo individuano come autentici detective: la commessa Miller, il fattorino Manners, gente comune. Quattro “M”, tuttavia, giocate a specchio: Mayo e Miller, Mobley e Manners. Carnefici e vittime in Lang abitualmente si confondono, perciò chi è colpevole? Risponde l’autore: «Sono esseri umani. Forse lo stesso vale per Lorre in M – uccide perché deve. Queste persone, tolti Dana Andrews e Thomas Mitchell, fanno esattamente le cose che probabilmente anche lei fa (si rivolge a Bogdanovich), pur detestandole: correre dietro a un lavoro, avidi di denaro. Quante persone con una morale ha incontrato in vita sua?».
La mostruosità quotidiana e il potere manipolatorio dei media sono inseriti in un rigido schema geometrico: tre concorrenti al posto di direttore generale, ciascuno affiancato da una donna, e un battitore libero, Mobley, che tramite Nancy è legato all’onesto Griffith. La sceneggiatura, ispirata al romanzo The Bloody Spur (t.l. Lo sperone insanguinato) di Charles Einstein, risente della stretta collaborazione fra il regista e Casey Robinson. Appassionato collezionista di ritagli di giornale, Lang questa volta rispolvera un fatto accaduto a Chicago, dove l’assassino aveva scritto sullo specchio: «Per favore prendetemi prima che uccida ancora». Fa pensare a Becker di M, alla sua tragica richiesta di aiuto e sollievo dalla prigione degli istinti. Se ricordate le opinioni dell’ambiguo professor Smith nel soggetto non realizzato L’altro che c’è in noi, ecco riaffiorare un elemento base della filmografia langhiana, lucido e tagliente come una spada: più la società è civile e ben organizzata, più sofisticata è la maschera con cui l’individuo nasconde il proprio Io. L’essenza profonda di ciascuno non può essere a lungo soffocata e repressa: da qui l’esplosione e l’esorcismo del male, un delitto, il bagno di sangue. I riferimenti a una generica cultura psicanalitica partono dall’uccisione di Judith che sta per fare il bagno (fot. 113, si allude al vortice genialmente evidenziato in House by the River) e dalle parole – presumibilmente rosse – tracciate dall’assassino sulla parete, dove le radici edipiche del crimine vengono sintetizzate in modo lampante (murder si sovrappone idealmente a mother). Altri sono comunque i dettagli importanti. Quando Mobley, ubriaco, accompagna a casa Nancy (fot. 114), proponendo ciò che non si dovrebbe a una ragazza seria, la bacia e blocca la serratura della porta con un gesto analogo a quello iniziale compiuto da Manners a casa Fenton. Eddie snocciola l’identikit del mostro davanti ai telespettatori, mostrandosi talmente certo da suscitare il sospetto che l’omicida misterioso sia lui stesso. L’identikit dello sconosciuto è così comune e diffuso che tutti potrebbero aver ucciso Laura Kelly. È il transfert di massa: l’assassino ragionevolmente si cela in ognuno di noi. Inseguito come Becker per le strade della città, il malvagio scende nella metropolitana (così fa Jones in Man Hunt) e nell’underworld affronta il campione del bene. Il suo ambiente tenebroso lo protegge, appena risale in superficie viene arrestato. Sotto o sopra, comunque, è lo stesso. Le subdole strategie elaborate dai concorrenti al titolo di direttore generale sono forse meno crudeli di una stretta alla gola? Il mostro, quello tentacolare che si esprime nella massa indistinta degli esseri umani, è giustamente ovunque, ubiquo e trasparente come le telecomunicazioni. Un impasto oscuro incolla Adamo ed Eva al peccato, manette invisibili legano il giudice e l’assassino. Difficile scagliare la prima pietra, suggerisce il regista, soprattutto quando gli operatori dei media sono ratti nevrotici in una gabbia angusta, pronti a sbranarsi per una boccata d’aria, per uno spazio in più. La Kyne Incorporated, comunità chiusa e pettegola, simbolo e orgoglio della metropoli, è il luogo in cui di notte vengono fabbricate le notizie. Il grattacielo superbo non è diverso dall’umile dimora espressionista di Rotwang: in alto o in basso manipolatori e maghi tiranneggiano un esercito di robot. Il lieto fine non mitiga l’asprezza dell’assunto (fot. 115). While the City Sleeps è teatrale, rapido, leggermente involuto. Se la lettera M domina a livello simbolico, la K inscritta in un cerchio (fot. 116), che subito identifica il grattacielo Kyne, ha soprattutto valore di citazione. Parlando di media, come dimenticare Quarto potere (Citizen Kane, 1941) di Welles? L’azienda dei Kyne adombra la poderosa organizzazione di Charles Foster Kane, proprietario di giornali, monopolista romantico, grande anima ambigua. Un’acquisizione utile nella quadreria di Lang, un personaggio/ideogramma che arricchisce l’intreccio. Il cast affiatato, dove non mancano i ruoli della cinica seduttrice (Mildred e Dorothy), la tesa caratterizzazione dell’assassino, i ritmi della commedia mediatica di tradizione (Ida Lupino ricorda Rosalind Russell in His Girl Friday di Hawks), scampoletti sexy che testimoniano un alleggerimento della censura (le gambe inguainate di Dorothy o il sospetto che l’assassino sia lo stesso uomo che inizialmente rubava indumenti intimi a donne giovani) rendono Quando la città dorme un thriller persuasivo e avvincente, ma – strano a dirsi per Lang – sicuramente datato.
FOT. 113
FOT. 114
FOT. 115
FOT. 116
Beyond a Reasonable Doubt (L’alibi era perfetto) Los Angeles. Austin Spencer (Sidney Blackmer), proprietario del «Press Herald», e il futuro genero Tom Garrett (Dana Andrews), giornalista e scrittore di successo, assistono a un’esecuzione capitale. Austin è contrario alla pena di morte, sostenuta invece dal procuratore distrettuale Roy Thompson (Philip Bourneuf). Susan Spencer (Joan Fontaine) regala al fidanzato un accendino d’oro con dedica (fot. 117), mentre l’editore espone a Tom un piano per rinvigorire la loro battaglia contro la sedia elettrica. Bisogna creare un caso di condanna ingiusta: Garrett farà da cavia. La ballerina Patty Gray viene strangolata (fot. 118). La convivente Joan Williams riferisce che Patty la buttò fuori di casa all’improvviso ed era piena di soldi, quella notte. Altre due testimoni affermano che la defunta era una sgualdrina. Un uomo venne a prenderla la sera del delitto: automobile nera, corporatura media, soprabito grigio, fumava la pipa.
FOT. 117
Austin e Tom approfittano dell’omicidio per costruire una falsa pista. Nel locale di burlesque in cui lavorava Patty, il giornalista avvicina senza successo una delle ragazze (fot. 119) e, acquistato un cappotto grigio, si fa fotografare da Austin, che al contempo riprende se stesso riflesso nello specchio. Questa sarà la prova fondamentale del loro gioco e dell’innocenza di Tom. Il giornalista corteggia Sally Moore (Barbara Nichols), una delle tre conoscenti dell’uccisa, e la invita a cena, prendendo nota di una marca di cerone. L’«Herald» pubblica una foto di Tom al ristorante con la bionda e Susan, indignata, rompe il fidanzamento. Garrett e Spencer si recano sul luogo in cui è stata uccisa Patty: il primo vi lascia l’accendino, l’altro documenta con una fotografia. Intanto, Sally accoglie l’invito alla prudenza fatto da un’amica e informa il tenente Kennedy. Tom sparge il cerone sui sedili della propria auto e lascia cadere una calza da donna, Austin scatta altre foto. All’appuntamento con Garrett, Sally viene tallonata dalla polizia, che interviene appena lui tenta di baciarla durante una sosta in campagna. Tom è interrogato da Thompson e arrestato come sospetto omicida. Il processo viene teletrasmesso (fot. 120). Susan confida al procuratore aggiunto Bob Hale (Arthur Franz), suo ex pretendente, di non credere alla colpevolezza di Garrett. Thompson colleziona una serie di prove indiziarie che inchiodano l’imputato, Austin muore in un incidente stradale recandosi in tribunale per discolpare l’amico. L’avvocato difensore informa Garrett dell’accaduto, questi confessa tutto a Wilson, che ottiene una revisione del processo. Invano: l’alibi fotografico è andato distrutto nell’incidente (l’auto ha preso fuoco) e siccome Austin usava una Polaroid non esistono negativi. La giuria condanna Tom alla sedia elettrica. Susan ha avviato una campagna stampa per ottenere la grazia, ma l’esecuzione è imminente (fot. 121).
FOT. 118
FOT. 119
FOT. 120
Frattanto Hale ha saputo, dal gestore di un locale di Miami, il vero nome dell’uccisa. Emma Blooker aveva rubato del denaro al fidanzato, il batterista Mike Robinson, ed era fuggita; l’uomo, che aveva giurato di vendicarsi, è morto da quattro anni. L’esecutore testamentario di Spencer consegna al giudice una lettera del defunto in cui è provata l’innocenza di Garrett, che viene rilasciato. Quest’ultimo, furioso contro Thompson, incautamente pronuncia il vero nome di Patty discorrendo con Susan. Tom è veramente l’assassino e confessa. Si erano sposati perché lei aveva finto di essere incinta, ma avuti i soldi per sciogliere il matrimonio era sparita, ricomparendo dopo il primo successo letterario di lui, non divorziata. Il giornalista l’ha uccisa coperto dal piano elaborato con Austin. Susan, attonita, viene informata da Bob che Garrett sta per essere graziato, e si confida. Hale, ancora innamorato, avverte il governatore. Tom, sconfitto, rientra in cella.
FOT. 121
Beyond a Reasonable Doubt (L’alibi era perfetto, 1956) non ha matrici letterarie. Anzi, si svolge tutto in bilico tra due generi hollywoodiani e televisivi, newspaper movie e courtroom drama. Un riconoscibile motivo musicale – la canzone «Beyond a Reasonable Doubt» eseguita da The Hi-Los – ci guida nell’intreccio consueto di istinti e delitti, dove l’ambiguo ritratto di Susan provoca reminiscenze hitchcockiane. Lo scranno che all’inizio fulmina il condannato Peters, avviando la polemica contro l’esecuzione capitale, ha brillato già nel finale di Scarlet Street. Il regista si avvita su se stesso, sui temi abituali, in un gioco ben strutturato ma stanco, ripetitivo. Durante le riprese litiga con il produttore Bert Friedlob, che prima gli dà carta bianca, poi giudica troppo violente le scene ambientate nel braccio della morte. La misura è colma, per Lang, che affida l’opera al bravo montatore Gene Fowler, concedendosi una pausa di riflessione. Ha sessantasei anni ormai, anche se il volto angoloso ha acquistato in forza e autorevolezza. Non è più il dandy venuto dall’Europa a scambiare un preciso stile artisticoesistenziale con il colore e il profumo dei dollari. Nelle foto dell’ultimo decennio sembra piuttosto un guru, un severo maestro dell’ascesi mistica, assomiglia sempre più alla sua creatura Mabuse e a un altro grande cineasta, John Ford. Si accorge, inoltre, che il suo status di autore a Hollywood va riducendosi in favore della serialità. Sospinto nel ruolo angusto del mestierante, Lang corre il rischio di bloccarsi nella melma dei serial. Il prodotto seriale, com’è noto, vive della confusione di forma e contenuto. In questo indistinto baluginare di elementi compositi l’anima si spenge, il talento si annulla, l’identità del creatore sfuma nella tirannica iterazione degli schemi. Così vuole il cliente, che ha sempre ragione. L’indice di gradimento del pubblico determina la sorte dell’individuo, è un fatto. Questa e altre considerazioni passano, forse, nella testa di Lang, che immaginiamo seduto in collina, in compagnia di un buon sigaro e di una messe di ricordi. «Ripensai a tutto quello che era successo in passato – spiega a Bogdanovich – a quanti film erano stati rovinati. Poiché non avevo alcuna intenzione di morire d’infarto, dissi a me stesso: “Credo che me ne andrò da questa gabbia di matti”. E decisi di non fare più film in America». Se all’epoca di Fury, reduce dal nazismo, l’autore si era piegato con entusiasmo e molti spunti originali alle convenzioni ferree delle major hollywoodiane, alle evidenti schizofrenie di una democrazia puritana, tempo è venuto per rimpiangere lo stereotipo del creatore europeo nobile e solitario. Il ritorno e la rivalsa del superomismo mabusiano – rapace, autoritario, splendido nel divampare delle passioni – sanciscono, in Lang, la legittima aristocrazia del singolo opposta alle grigie moltitudini senza nome. L’estremismo sanguinario di Sigfrido, la determinazione oscura di Crimilde, le cupe foreste e i castelli su cui grava l’alito magico del drago premono
dall’interno sul protagonista di Beyond a Reasonable Doubt. Al di là di ogni ragionevole dubbio sta un continente quasi inesplorato, dove gli eroi furiosi celebrano in eterno la propria ribellione al fato e alle regole sociali. Chi è questo Tom Garrett, nome e volto comuni, se non l’ennesima e gloriosa personificazione della diversità? Un assassino, un malato (come Stephen Byrne, Harry Prebble, Vince Stone e Robert Manners), un illusionista. Paludato civilmente da giornalista-scrittore, Tom è invece un guerriero pagano a caccia nella giungla notturna della metropoli. È vittima della propria natura eccentrica, crea l’immagine di un falso assassino che dissimula il criminale vero. Niente di nuovo, né per Lang né per la tradizione del gotico e del thriller. Eppure si intuisce una ferocia immensa dietro il banale pretesto dell’omicidio. Il compiacimento netto e irredento del gesto anarchico, folle, liberatorio dell’uccidere onde affermare se stessi. A un passo dalla salvezza, il mefistofelico Tom viene battuto dalle ragioni del cuore altrui e da quelle più ovvie della giustizia. Torna in cella e presumibilmente spirerà sul rogo della sedia elettrica, ma gli spettatori non sanno che ha vinto, cancellando una volta per tutte, con uno scatto di luciferino orgoglio, la grazia e i pentimenti del lieto fine, imposti a una lunghissima catena di avi, irriducibili assassini-stregoni. Der Tiger von Eschnapur/ Das Indische Grabmal (La tigre di Eschnapur/ Il sepolcro indiano) Der Tiger von Eschnapur L’architetto tedesco Harald Berger (Paul Hubschmid) si reca a Eschnapur per costruire scuole e ospedali, assunto dal maragià Chandra (Walther Reyer), che sta rientrando dall’Europa. Durante il viaggio Harald incontra la danzatrice sacra Seetha (Debra Paget), diretta a Eschnapur con la serva Bahrani (Luciana Paoluzzi), e innamorato la salva da una tigre mangiatrice di uomini. Nel principato indiano, dove Berger viene ricevuto con tutti gli onori, la situazione politica è complessa: Ramigani, fratello di Chandra, Padhu, fratello della maharani defunta, e il gran sacerdote Yama complottano contro il maragià, ritenuto eccessivamente filoeuropeo. Chandra inoltre ha dichiarato incautamente di voler sposare una danzatrice, una prostituta sacra. In un colloquio con Seetha, l’architetto viene a sapere che il padre di lei è irlandese. Esplorando i sotterranei di Eschnapur, Harald assiste, non visto, a un’esibizione della ragazza davanti ai sacerdoti e scopre un lebbrosario. Il maragià apprende che l’architetto frequenta Seetha con la complicità di Bahrani e decide di vendicarsi. Invita i due a un banchetto, dove un fachiro trafigge con spade Bahrani, chiusa in una cesta intrecciata. Poi sospinge l’ignaro Berger nell’arena delle tigri, promettendogli la libertà solo nel caso che esca vincitore dal combattimento con uno dei felini. Il coraggioso Harald si guadagna la salvezza ma, prima di lasciare Eschnapur, rapisce la danzatrice. Qualche tempo dopo l’architetto Walter Rhode (Claus Holm) e sua moglie Irene (Sabine Bethman), sorella di Berger, giungono a Eschnapur, dove Chandra li informa che il parente sta cacciando la tigre. Il maragià commissiona a Rhode il progetto di un mausoleo che custodirà la salma della sposa tanto amata. I fuggitivi evitano gli uomini che Chandra ha posto sulle loro tracce, ma si perdono nel deserto. Harald, disperato, spara al sole implacabile e sfinito si accascia a fianco di Seetha.
Das Indische Grabmal Dopo un breve riassunto dell’episodio precedente, i membri di una carovana soccorrono gli amanti, che vengono ospitati in un villaggio di agricoltori, nonostante la proibizione di Chandra. Traditi da un contadino, Harald e Seetha salgono sulla montagna, rifugiandosi nella grotta consacrata a una divinità che li protegge. Braccato dagli uomini di Ramigani, l’architetto cade sul fondo di un precipizio, dove lo attende un pantano gremito di coccodrilli. Il maragià mostra ai Rhode la camicia stracciata e insanguinata di Berger, riferendo quello che gli ha detto Ramigani: il loro congiunto è morto durante la caccia alla tigre. Irene non gli crede e, aiutata dall’architetto indiano Asagara (Jochen Blume), si mette alla ricerca del fratello. Saputo che Seetha è prigioniera nel palazzo del maragià, trova il modo di incontrarla e insieme scoprono la mappa della città sotterranea e del suo labirinto, dove Harald giace incatenato in un pozzo, nelle mani di Ramigani. Seetha viene obbligata a danzare nel tempio: un cobra la ucciderà nel caso sia colpevole agli occhi degli dei. Chandra la salva in extremis, suscitando l’indignazione dei sacerdoti. In cambio della vita di Berger, Ramigani convince la danzatrice a sposare il maragià. L’architetto riesce a fuggire, mentre inizia la rivolta contro Chandra. Rhode si appresta a far saltare una parte dei sotterranei. Irene, cercando il fratello, si imbatte nei
lebbrosi e viene soccorsa da Asagara, che perisce sotto una frana. Nel corso della cerimonia nuziale irrompono Ramigani, Padhu e i sacerdoti, ma il fido generale Dagh (Guido Celano) respinge gli insorti, guidando la riscossa. Ramigani si rifugia nel sottosuolo e muore per un’esplosione che ha provocato. Il maragià affronta Harald e lo sconfigge, donandogli poi la vita e l’autorizzazione a lasciare Eschnapur con la danzatrice. Chandra rinuncia al potere, facendosi servitore di un venerabile eremita.
Nel 1956 il governo indiano si rivolge a Lang per realizzare un film ispirato alla leggenda romanticissima che circonda il celebre mausoleo Taj Mahal, fatto costruire ad Agra nel 1630-52 dall’imperatore moghul Shah Jahan in memoria della consorte Mumtaz-i-Mahal, la preferita del palazzo. Entusiasta del progetto, il regista visita l’India, compie sopralluoghi, parla con i finanziatori e infine rinuncia perché gli attori indiani, imposti dalla produzione, non corrispondono al canone di bellezza occidentale. Nell’ottobre dello stesso anno torna in Germania, dove un amico gli presenta Artur Brauner della CCC-Filmkunst. Brecht è morto da poco, Lang pensa a un film, Störtebecker, su un pirata vissuto ai tempi della Lega Anseatica, e si reca a Berlino Est. Alla fine del 1957 firma con Brauner un contratto per il remake di Das Indische Grabmal, pellicola diretta nel ’21 da Joe May, basata su un sogno di Thea von Harbou, diventato romanzo e poi sceneggiatura in collaborazione con Fritz. May, come sappiamo, si era appropriato della regia, cogliendo il successo naturalmente destinato a Lang. Nel 1938 il berlinese Richard Eichberg aveva girato, su commissione della Tobis Klang-Film, il rifacimento sonoro dell’opera. Gli attori di May – tra cui la moglie Mia, Conrad Veidt, Bernhard Goetzke nel ruolo di Ramigani, Lya de Putti – e le scenografie manierate di Eichberg sono lontani dal trionfante Eastmancolor e dalle intuizioni spettacolari di Lang. Terminato in ottantanove giorni, dall’ottobre al dicembre 1958, di cui ventisette trascorsi nella provincia del Rajasthan, a Udaipur, e i restanti in studio a Berlino, Der Tiger von Eschnapur/ Das Indische Grabmal si articola in due parti, come le versioni precedenti. Non è difficile sentirvi l’eco delle peripezie esotiche del protagonista di Der goldene See (prima delle due avventure di Die Spinnen). Se vi ricordate, Kay Hoog salva l’inca Naela, sacerdotessa del Sole, da un serpente che la minaccia durante il bagno mattutino nel Lago Dorato. La ragazza nasconde Kay nelle grotte che si aprono sotto il tempio e dopo molte emozioni li ritroviamo sposati a San Francisco. Il testo di Der goldene See, dovuto al solo Lang, curiosamente anticipa lo schema del sogno indiano di Thea. La trinità odio-assassinio-vendetta ruota quasi sempre intorno a una storia d’amore. Nel Sepolcro il nostro Harald, eroe burgundo in moderna sahariana, stringe un affilato pugnale indigeno per proteggere la dama, questa Seetha che può essere danzatrice sinuosa, truccatissima e lasciva, o fanciulla acqua e sapone, candida norna di wagneriana memoria, i capelli raccolti come una martire cristiana. Il terzo polo del triangolo d’amore è il freddo, impeccabile Chandra. La compostezza e l’eleganza del maragià evocano l’architettura poderosa e netta del Taj Mahal, forma assente che tuttavia serve da modello. Un’India così rutilante e barocca in superficie quanto il sottosuolo appare inquietante e insidioso, ospitando perfino una comunità di lebbrosi. Ricordi di Der müde Tod (l’oriente fiabesco della prima e della terza storia) si mescolano a frammenti di Metropolis. Se in quest’ultimo Freder assomiglia al principe Siddharta, in Das Indische Grabmal Chandra sceglie veramente la strada dell’ascesi, del distacco dalle apparenze, mentre ad Harald spetta l’ovvia prigione del lieto fine. Un’altra immersione nell’inconscio langhiano, che stavolta si esprime – già dai titoli di testa – in una stella a sei punte risplendente intorno a un cerchio. Passando da un episodio all’altro questo emblema diventa un labirinto, il disco solare o la grande ragnatela che, provvidenzialmente tessuta da un insetto amico, protegge la fuga degli amanti. Se Der Tiger si basa su una struttura aperta – come materna, sensuale e benevola ci appare la statua della dea – Das Grabmal rivela uno schema chiuso. Solarità, ritmo lento, scenografia sontuosa e decorativa del primo si oppongono a oscurità, dinamismo e spazio stilizzato del secondo. Tornano le coppie indivisibili sopra/sotto, razionale/irrazionale, amore/morte. Esoterismi e metafore sono parte
significativa dell’universo langhiano. Il bianco della ragnatela (come il marmo perfetto del Taj Mahal) suggerisce purezza, mentre l’aracnide in India assume una funzione purificatrice, evocando, tramite la composizione della tela, il sole e la libertà. Il piccolo insetto infatti è capace di innalzarsi grazie a un filo da lui stesso secreto, simbolo e strumento della realizzazione spirituale. La circolarità invece è associata al concetto di reclusione (i pozzi in cui “cade” Berger), alla catena della vita mortale, all’eterno ciclo del destino. Non siamo tuttavia in ambito cabalisticoespressionista, perché Lang integra l’avaro gioco dei segni con lo splendore plastico di corpi e architetture, con il fulgore dell’esotismo, donando all’insieme intensità e una notevole carica emozionale. Distribuito nel 1959 in Germania e Francia, il dittico ottiene un grande successo, ma appena un anno dopo gli episodi – di centocinque minuti ciascuno – vengono condensati per il mercato americano in un film di un’ora e mezzo, che ha comunque un bel titolo: Journey to the Lost City (t.l. Viaggio nella città perduta). Die tausend Augen des Dr. Mabuse (Il diabolico dottor Mabuse) Il cronista Peter Barter viene ucciso nella sua auto con un ago sottilissimo sparato da un’arma segreta. Cornelius (Lupo Prezzo), il veggente cieco, aveva avvertito il commissario Kraus (Gert Fröbe) di un pericolo imminente, senza essere ascoltato. La polizia collega l’omicidio a quelli commessi negli anni Venti dal dottor Mabuse e verifica tutti i casi irrisolti svoltisi all’Hotel Luxor, presso cui staziona un furgone con apparecchi di intercettazione. Nell’albergo il miliardario americano Henry B. Taylor, alias Travers (Peter Van Eyck), sta per concludere l’acquisto di un laboratorio nucleare. Una piccola folla si raduna davanti all’edificio, perché in bilico su un cornicione una ragazza minaccia di gettarsi nel vuoto. Travers riesce a dissuaderla. Poi interviene il dottor Jordan (Wolfgang Preiss), che la sta curando. Si viene a sapere che Barter le aveva parlato al bar del Luxor, albergo occupato dai nazisti durante la guerra. Cornelius predice a Travers guai seri dopo l’acquisto del laboratorio. L’americano e la fanciulla, di nome Marion Ménil (Dawn Addams), ballano insieme, osservati con discrezione dall’agente assicurativo Hieronymus P. Mistelzweig (Werner Peters), accompagnato da una bionda, e dall’impianto televisivo a circuito chiuso che controlla tutte le stanze dell’albergo, manovrato da Roberto, un uomo dal piede equino. Il laboratorio è distrutto da un’esplosione e Berg, il poliziotto del Luxor, visto che Travers si interessa a Marion, gli rivela che lo specchio tra le loro camere, adiacenti, permette all’uomo di guardare, non visto, la ragazza che ama. Cornelius invita lo scettico Kraus a una seduta spiritica, a cui partecipano anche Marion e Mistelzweig. Nell’oscurità qualcuno spara al commissario che, avvertito dall’anfitrione, si è gettato al suolo. Il colpo tuttavia era destinato al veggente, che ha scambiato con Kraus il suo posto abituale. Attraverso lo specchio l’americano vede entrare Roberto, marito di Marion, e interviene, colpendolo prima che riesca a uccidere la moglie. Jordan e Berg portano via il corpo, che nell’ambulanza resuscita per essere nuovamente abbattuto. Innamorata di Travers, Marion si svela agente di Mabuse: il tentativo di suicidio, falso, aveva lo scopo di attrarre il miliardario, per portarlo al matrimonio e quindi ucciderlo, onde convogliare le sue sostanze nelle tasche del criminale. I due decidono di fuggire insieme e prendono l’ascensore, che non si ferma al piano voluto, ma scende negli scantinati dell’Hotel, dove li attende Jordan, figlio di Mabuse, alla consolle del circuito televisivo costruito ispirandosi a un progetto per la Gestapo, in cui le telecamere erano microfoni. Ferita Marion, il dottore lascia entrambi in compagnia di un revolver, nel caso vogliano evitare l’attesa di una morte sicura. Intanto, Mistelzweig scopre che il veggente non è cieco e prosegue le indagini, notando che l’ascensore scende troppo in basso. Attraversando la hall dell’albergo Jordan è tradito dal cane di Cornelius: dottore e medium sono la stessa persona. Mabuse fugge in automobile, ma precipita da un ponte, scomparendo nel fiume. Mistelzweig ha liberato gli amanti e Marion va recuperando le forze in ospedale, affettuosamente assistita da Travers.
Nel 1959 la Cinémathèque Française organizza una rassegna delle opere di Lang e la NWRV Television di Amburgo dedica al regista un ritratto-intervista nell’ambito di una serie sugli artisti tedeschi, Künstlerporträt: Fritz Lang di Friedrich Luft e Guido Schütte. Alcuni produttori chiedono al regista di rifare Der müde Tod, I Nibelunghi, Metropolis, Die Herrin der Welt di Joe May, Nosferatu di Murnau, persino il Caligari, ma lui rifiuta, proponendo una nuova versione di Faust, già realizzato da Murnau nel 1926. I finanziatori disapprovano, suggerendo il remake del
Testamento del dottor Mabuse. Lang frattanto abbandona i progetti di due film ambientati in India (Kali Yung e Moon of Dassemra), lavorando con gli sceneggiatori Heinz Oskar Wuttig e Werner Jörg Lüddecke al soggetto di Unter Ausschluss der Öffentlichkeit (t.l. Dietro le porte chiuse), dove un magistrato ambizioso, coinvolto nel processo a una donna conosciuta in passato, comprende quanto è stata vuota e falsa la propria esistenza. L’Alfa-Film annuncia i nomi degli attori principali, ma Lang litiga e lascia cadere il progetto, accettando invece l’offerta di un terzo Mabuse fattagli da Artur Brauner della CCC-Filmkunst. Die tausend Augen des Dr. Mabuse (Il diabolico dottor Mabuse, 1960) nasce con la speranza di un grande successo commerciale. Realizzando un film che lusinghi il box-office, Lang pensa di ottenere in cambio da Brauner l’opportunità di girare senza restrizioni, come ai tempi di M. Resuscitare il mefistofelico dottore significa anche riassumere le forme, i contenuti e il significato di una vita donata al cinema. La descrizione del mondo dell’homo homini lupus, per lui abituale, si lega ancora al fascino del mago. Gli occhi di gufo della prima maschera di Mabuse, trasformati nelle orbite incavate che caratterizzano il Dottore del Testamento, diventano gli occhiali neri sul volto ascetico di Cornelius, gli stessi che rafforzano e limitano lo sguardo dell’autore. Sembra che Lang approfitti del personaggio per dirci tutta la pena e l’ansia di un regista invecchiato, gradualmente derubato della libertà e della luce. L’orbo veggente, caro anche a D’Annunzio, è senza dubbio l’artista, sempre più chiuso e solitario nello spazio simulato della sfera di cristallo (una pagina bianca, la cinepresa). Il criminale-vate, che si presume accecato, come l’Edipo di Sofocle, giustamente indica che la vita finisce dove comincia, nei plumbei recessi della materia e della psiche. Con il sembiante di Mabuse, Lang chiude infatti il primo periodo tedesco e suggella l’intera carriera. Se il genio creativo è iterazione ossessiva degli elementi costitutivi, variazione significante degli stessi e sublime ricapitolazione di uno schema immutato, Die tausend Augen des Dr. Mabuse sancisce l’appartenenza di Lang a questa categoria ristretta e non sempre privilegiata. Il film è un autentico inventario, una collezione di avatar, un iniziatico libro dei morti e dei mutamenti custodito dall’Hotel Luxor, una mappa delle metamorfosi che il vecchio edificio, maledetto dall’insediamento della Gestapo, nasconde al pari di un tesoro. L’albergo è in realtà un’architettura funebre, un sarcofago egizio ospitante la salma mummificata del faraone-regista, una cattedrale con cripta simile alla doppia città di Eschnapur. Niente sfugge allo spettro dell’autore, provvisto di tausend Augen, mille occhi sempre aperti. Questo viaggio nella necropoli perduta e ritrovata è compiuto da un ricco americano (fot. 122) che si suppone sportivo come Kay Hoog, impavido come Donald Tremaine (Spione) o Harald Berger. Travers si fa chiamare Taylor, ricordandoci l’analogo espediente usato da Frank James (The Return of Frank James), e innamorandosi salva la sfortunata Marion Ménil (in francese marionnette = burattino, ménil = fattoria, villaggio), che adombra il personaggio di Sie (Totentanz) e quello di Cara Carozza (Mabuse der Spieler). Travers/Taylor, come Frank Landov in Lilith und Ly, scopre attraverso lo specchio la doppia identità dell’amata, sposata a quell’uomo dal piede equino che evidentemente è un servo del Maligno. Roberto manovra l’impianto a circuito chiuso, i tele-specchi di Landov diventati schermi e telecamere, i mille occhi del burattinaio satanico. Jordan/Mabuse, lo scienziato criminale, si mimetizza nel guitto Cornelius, medium e hypokrites (attore), come il clown Nemo occultava l’inafferrabile Haghi (Spione).
FOT. 122
Dato il mistero, ecco apparire gli ambigui campioni dell’universo diurno, investigatori-esorcistiarcheologi pronti a calarsi e dissipare le tenebre: il commissario Kraus, che replica il simpatico Lohmann del Testamento, l’alchimistico Hieronymus P. Mistelzweig (anche agente dell’FBI), il subdolo Berg di Andrea Checchi, figure della stessa eredità poliziesca. Le “M” sembrano monumenti ai caduti di Metropolis: invece sono antenne, trasmettitori e archi trionfali dell’ipnotica dittatura multimediale. NULLA DI NUOVO SOTTO IL SOLE «La volontà di eternare ha bisogno di una duplice interpretazione. Essa può in primo luogo derivare da gratitudine e amore – un’arte che ha questa origine sarà sempre un’arte di apoteosi, forse ditirambica con Rubens, beatamente irridente con Hafis, chiara e bonaria con Goethe, e diffondente su tutte le cose un omerico raggio di luce e gloria. Ma può anche essere quella tirannica volontà di un uomo che duramente soffre, lotta, è torturato, che a ciò che è più personale, individuale, angusto, vorrebbe imprimere il sigillo dell’idiosincrasia del suo patire, come a legge e costrizione obbligatoria, e che per così dire si vendica di tutte le cose incidendovi a caratteri di fuoco la sua propria immagine, l’immagine della sua tortura. Quest’ultimo è il pessimismo romantico nella sua forma più espressiva, sia come filosofia schopenhaueriana della volontà, sia come musica wagneriana: il pessimismo romantico, l’ultimo grande avvenimento nel destino della nostra cultura. (Il fatto che ci possa anche essere un pessimismo del tutto diverso, un pessimismo classico, questo presentimento e questa visione appartengono a me, sono inseparabili da me, sono il mio proprium e ipsissimum: ma al mio orecchio ripugna la parola “classico” che è diventata di gran lunga troppo logora, troppo rotonda e irriconoscibile. Io chiamo quel pessimismo dell’avvenire – perché esso viene! io lo vedo venire! – il pessimismo dionisiaco).» Gaia scienza, F. Nietzsche
I sedici anni che separano Die tausend Augen des Dr. Mabuse dalla scomparsa del suo autore furono per Lang densi di impegni e riconoscimenti. Nel 1961 il regista lavora a un soggetto che, dopo due titoli provvisori, si chiama And Tomorrow Murder (… und Morgen: Mord!). La storia svolge una serie di casi di stupro in una tranquilla cittadina, compiuti da uno degli abitanti più rispettabili, che ha persino offerto una taglia per l’arresto del criminale. Nel 1962 si allestisce una rassegna dei suoi film al National Film Theatre di Londra. Nel ’63 Lang interpreta se stesso in Le mépris (Il disprezzo) di Jean-Luc Godard, a fianco di Brigitte Bardot, Jack Palance e Michel Piccoli, e viene premiato al festival di Berlino. Esce Begegnung mit Fritz Lang, un film-intervista realizzato da Peter Fleischmann. Nel 1964 Lang partecipa a Das War die UFA (Atlas-Retro), programma della televisione tedesca occidentale dedicato alle vicende dell’Universum-Film Aktiengesellschaft, in cui è intervistato da Erwin Leiser. Presidente della giuria di Cannes ’64, il regista stende una sceneggiatura pensata per Jeanne Moreau, Death of a Career Girl (t.l. Morte di una donna di successo), dove la protagonista «vive ma è già morta, poiché non ha alcun desiderio d’amore, alcun desiderio di una vita vera, soltanto il desiderio di una carriera». Presiede la giuria del festival del cinema documentario di Mannheim e nel 1965 è nominato Cavaliere delle Arti e delle Lettere. L’anno seguente fa parte della giuria del festival di Rio de Janeiro, riceve la Bundesverdienstkreuz, la Croce al merito della Repubblica Federale Tedesca. Si opera, senza successo, all’occhio destro. Nel 1967 il Museum of Modern Art di New York gli dedica una retrospettiva. In settembre Lang presiede il convegno sull’espressionismo organizzato dalla Mostra del cinema di Venezia, poi si reca al festival di Montreal. Nel ’68 la ZDF mette in onda Zum Beispiel Fritz Lang di Erwin Leiser, mentre il regista spedisce un telegramma, corredato delle firme di registi e produttori importanti, per sostenere Henri Langlois e la Cinémathèque Française contro André Malraux, e promuove una raccolta di fondi presso il County Museum of Art di Los Angeles. Nel 1971 il grande vecchio visita Berlino e, fermatosi a Vienna per una retrospettiva delle sue opere, riceve la Medaglia d’Onore. Lo stesso anno la WDR trasmette Drei Sendungen über Fritz Lang, serie televisiva in tre puntate
realizzata da Klaus Kreimeier. Segue Die schweren Träume des Fritz Lang (1974) di Werner Dütsch, ancora sull’emittente WDR. Il 4 dicembre 1975, intervistata dalla «Abend Zeitung» di Monaco in occasione dell’ottanta-cinquesimo compleanno del maestro, Lily Latté rivela che Lang è praticamente cieco. Dopo una lunga malattia, la morte giunge nella casa di Beverly Hills il 2 agosto 1976. Il regista viene sepolto con Peter, la sua scimmietta di peluche. Parti dell’eredità sono oggi amministrate dall’University of Southern California, dalla Sesslers Verlag di Vienna e dalla Murnau Stiftung. Grazie a Lotte Eisner la Cinémathèque Française ha avuto in dono un certo numero di documenti, fotografie e sceneggiature, mentre Lily Latté stranamente ha distrutto la maggior parte dei taccuini di Fritz, anche quelli scritti durante la prima guerra mondiale. In morte del creatore il «Los Angeles Times» recita, sulla prima pagina, Fritz Lang Perfectionist Film Director, Dies at 85. Non è molto per uno dei pochi veri talenti della storia del cinema. Eppure quel titolo sbrigativo e laconico gli rende giustizia più di qualsiasi ridondante elegia funebre. Nei suoi ultimi anni, quasi calvo, pensoso, catafratto in una maschera di filosofica asprezza, con la nota benda nera che gli copre l’occhio destro, il regista sembra un corsaro a riposo. Il suo volto è impietrito, inquietante come quello del Commendatore mozartiano e, insieme a due rughe decise agli angoli della bocca, ci fa pensare all’uomo nietzschiano che «duramente soffre, lotta, è torturato», offrendo con «la sua propria immagine», quella della «sua tortura», un formidabile ritratto del pessimismo romantico o, meglio, del pessimista dionisiaco. Il regista-profeta – malato, arroccato a Beverly Hills come il cittadino Kane a Xanadu (in Citizen Kane di Welles) – disdegna le masse e potrebbe far proprio il dandysmo cupo di Nietzsche nella Genealogia della morale (1887): «Che cosa costituisce il nostro disgusto per l’“uomo”? (…) Non il timore, piuttosto il fatto che non abbiamo più nulla da temere dall’uomo; che il verme “uomo” è alla ribalta e formicola; che l’“uomo domestico”, l’insanabilmente mediocre e sconfortevole, ha imparato già a sentirsi come scopo e culmine, come senso della storia, come “uomo superiore”. Anzi, egli ha un certo diritto a sentirsi così, in quanto si discosta dalla sovrabbondanza di malriusciti, malaticci, stanchi, esauriti, di cui oggi l’Europa comincia a puzzare, e quindi appare come qualcosa di almeno relativamente riuscito, di ancora capace di vita, che almeno dice di sì alla vita». Di quest’uomo, arrogante nella sua vitale piccolezza, Lang ha fatto buona esperienza in America, e da un malcelato fastidio per la cultura dell’everyman statunitense nascono le sue ambigue raffigurazioni di Joe Doe: dal Tracy di Fury al Dana Andrews di Beyond a Reasonable Doubt. In una lettera a Lotte Eisner del 30 dicembre 1967, il regista infatti scriveva: «Non puoi credere, cara Lotte, come qui in America, appena ho fatto un passo avanti, devo muoverne spesso due indietro e un altro ancora per poter fare, dopo molti conflitti, umiliazioni e sofferenze dell’amor proprio, di nuovo quattro passi avanti al fine di continuare l’opera della mia vita». Il lavoro della sua vita, l’affresco che Lang ha arricchito con una serie di variazioni significative su pochi temi fondamentali, è un’opera d’arte. Come insegnano i romantici, solo l’arte consente di oltrepassare l’apparenza per cogliere la sostanza delle cose. Secondo Wagner e Nietzsche, è compito dell’artista rappresentare il contrasto insanabile degli opposti primordiali in cui si manifesta l’essenza del reale. Collezionando diadi antitetiche, Lang costruisce un universo di entità divergenti e non componibili. Partendo dal contrasto basilare fra bene e male, ecco le diadi classico/romantico, razionale/irrazionale, essenza/apparenza, fino al bisturi che seziona le due metà rivali dell’uomo: la parte di Jekyll e quella di Hyde. I personaggi langhiani sovente illustrano un’opinione di Ernst Jünger, per cui «è infinitamente più desiderabile essere un criminale piuttosto che un borghese». Si trovano esattamente nel cuore della diade antitetica, camminano sul filo della lama che idealmente separa le coppie inconciliabili. Sono gli esploratori dell’artista cineasta immersi nel crogiuolo delle emozioni: perennemente lacerati e inconsapevoli, ma in qualche modo fieri dell’insoddisfazione immutabile che è il loro destino. Sono figure del pessimismo dionisiaco. Il cosmo langhiano di diadi
antitetiche giustamente non prevede la redenzione, sprezzando la medietas (che qui non è mai aurea), e come potrebbe essere altrimenti in un sistema che esclude composizioni finali? Quando esse sembrano verificarsi avvertiamo subito un senso di disagio, valga per tutte la conclusione inverosimile di Metropolis. Groth e Joh Fredersen, la mano e la mente, il lavoro e il capitale, si stringono la mano. Freder, alfiere del cuore, suggella la stretta fra suo padre e il capo operaio. C’è quindi sintesi e conciliazione degli opposti, ma nel segno di un’utopia che appare chiarissima a tutti. Il dramma dell’inconciliabilità è efficacemente simboleggiato dall’alternarsi del bianco e del nero, resi plastici dall’illuminazione accurata, nelle scenografie e nei costumi, o dagli schemi geometrici (il cerchio di bambini inscritto nel quadrato del cortile all’inizio di M), o dall’uso ossessivo della diade maschera/volto. Quando il volto è coperto da una maschera (i travestimenti di Mabuse, lo sdoppiamento Haghi/Nemo) e quest’ultima si mostra divisa in due campiture nette (l’ala oscura che scherma la faccia di Alice Reed in The Woman in the Window, il velo che nasconde la metà ustionata del viso di Emma Robey in Secret Beyond the Door, l’ustione che sfigura Debby Marsh in The Big Heat), i concetti di bene e male, che sembrano evidenziati e separati, in realtà si confondono a causa del teatro su cui sono giocati: la maschera, appunto, e l’impossibilità di cogliere il sembiante originale, di identificare la prima essenza delle cose. I personaggi, portavoce dell’autore, non fanno altro che mettere in scena, con l’effimero soccorso delle variazioni, l’irriducibile conflitto originale e un’eterna, vana ricerca di senso. I campioni di Lang sono infatti eroi pagani, senza alcun rimpianto del bene convenzionale. Superuomo e pessimista dionisiaco sono la stessa cosa. In Lang la coscienza forte di un’insanabile solitudine conduce alla superbia e da essa (A superbia initium sumpsit omnis perditio, ammonisce la Bibbia) a un altro dei peccati capitali, tanto deprecato nel basso Medioevo: l’avarizia (Radix omnium malo-rum est cupiditas, ancora nella Bibbia). La rapacità di Mabuse, Haghi e seguaci nasce dall’alveo profondo del Reno, dalla colpa di Alberico, dal furto primigenio dell’oro. La «cieca cupidigia» dantesca – istinto naturale e materiale, puramente terrestre – affliggeva secoli in cui la ricchezza non aveva assunto la spettrale elusività che la finanza moderna ha conferito al capitale. L’avarizia del criminale mabusiano è quindi antica: specula in Borsa, ma crede nel lucore del metallo fatale, anzi lo adora come una rosa mistica, come un alchemico accesso all’inconscio dei popoli e al potere. Parafrasando ancora Nietzsche, Mabuse ambisce a plasmare il mondo, a imprimervi il sigillo del suo patire, a incidervi con caratteri di fuoco la propria immagine, l’immagine della sua tortura. L’Übermensch langhiano è sempre ferinamente solo e in altera solitudine si contrappone alla folla. Questo ci porta alla diade antitetica individuo/massa, legata in molti casi a quella alto/basso. Il superuomo domina, gli omuncoli subiscono il giogo. Il supercriminale, emigrato negli USA, si trasforma in Grande Comunicatore nell’accezione di Marshall McLuhan, diventa un manipolatore di informazioni, un alchimista della società mediatica. Si nasconde dietro un paio di occhiali neri, affida la propria voce ai microfoni, è il vate oscurato, l’orbo che vede. La cecità nega lo sguardo rivolto all’esterno in favore di un approfondimento dell’interiorità, ma il veggente cieco Cornelius, alias Jordan in Die Tausend Augen des Dr. Mabuse, è soltanto un volgare ciarlatano. Ha finto di avere gli occhi dello spirito, ma è un persuasore occulto, un manipolatore audiovisuale, un probabile tiranno, un dannato del potere. L’oro, la potenza, le donne. Il gineceo langhiano pullula di ballerinette, avventuriere, femmine ciniche e fatali o brave ragazze comprensive che si ispirano a Jane Doe. La donna è comunque un altro accesso all’inconscio. Le eroine di Lang presto o tardi confluiscono nell’archetipo femminile simboleggiato dalla diade di Lilith und Ly, dal desiderio di Hilde Warren (Hilde Warren und der Tod), da Lio Sha e Naela (Die Spinnen), dal ritratto di Hel (Metropolis) e soprattutto dalla figura a cui esse si ispirano: Ayesha, la donna eterna del romanzo di Sir Henry Rider Haggard. She, edito nel 1887 (come la Genealogia della morale di Nietzsche), storia romanticissima concepita agli albori
della settima arte, ha avuto alcune versioni cinematografiche, ma anzitutto stimola riflessioni psicanalitiche. Carl Gustav Jung ritiene questo personaggio fantastico un classico esempio di anima. Per Jung l’anima del maschio è l’aggregazione di tutte le sue caratteristiche femminili, con ciò impedendogli di capire la vera psicologia della donna: è la sua idea inconscia di quello che la donna dovrebbe essere. Anima è l’immagine che l’uomo proietta sulla donna quando si innamora di lei, quindi sinonimo di urgenza vitale. Si invaghisce di un ideale e resta innamorato fino a quando la donna reale distrugge l’aura d’anima che l’uomo le ha costruito intorno. Ayesha, ovvero l’anima di Haggard, ha le tradizionali qualità ideali della femminilità: inestinguibile bellezza, eterna giovinezza, poteri soprannaturali. La teoria junghiana fa di Ayesha la proiezione dell’idea inconscia dell’amore ideale di Haggard, un’immagine che, con varianti minime, tutti gli uomini possiedono e hanno ereditato come parte dell’inconscio collettivo, la memoria della razza. Detto questo, è facile comprendere la ragione del numinoso che avvolge le eroine langhiane, quell’anima drappeggiata dagli uomini sul corpo delle amate, che li acceca e quindi indica loro le inattingibili verità del profondo. Sembra che uccidere la donna, affondare il coltello in questo sembiante ingannevole, o idealmente separare il volto dal corpo (la bestia), cioè strangolarla, possa regalare la chiave del mistero virile e più largamente umano. L’inconscio, il Grande Ambiguo, la cui solare oscurità viene evidenziata dalla spirale di carta e dalla freccia nella vetrina del negozio di giocattoli (M), appare strettamente connesso ai delitti del maniaco sessuale Becker, al sogno di Wanley(The Woman in the Window), al dipinto di Cross (Scarlet Street), ai vortici liquidi di House by the River e The Blue Gardenia, alle gesta del “killer del rossetto” in While the City Sleeps. Materia ideale per un regista che, come Lang, persegue il fascino dell’ideogramma unico, del fotogramma riassuntivo del tutto. L’intento sociale e messianico del cinema, il valore assoluto dell’immaginario collettivo si fondono proprio con questi elementi di nudità e di smascheramento forniti dall’approccio psicanalitico che, va sottolineato, non è in Lang sempre così chiaro e conseguente (soprattutto quando affronta luoghi freudiani); anzi conserva quel non so che di dilettantesco, infantile e divulgativo che lo rende ancora più conturbante. Ricordiamo, ad esempio, i racemi e le volute del “gotico californiano” protagonisti, al pari degli attori, sulla scena del manierismo alto di Secret Beyond the Door o, tornando indietro, il convulso inseguimento di Maria, da parte di Rotwang, nel labirinto e sul tetto della cattedrale gotica di Metropolis. Lang “mago” del set, edificatore di formidabili strutture simboliche, maestro di enigmi, orbo veggente, esorcista del medium cool, cantore degli eroi superni nei Nibelunghi e di un’umanità dolente, espropriata di sé, schiacciata dall’ideologia dell’uomo comune in Clash by Night (La confessione della signora Doyle). Lang fastoso e magniloquente (La tigre di Eschnapur/ Il sepolcro indiano), Lang intimo e romantico (Der müde Tod) o melanconico (Moonfleet), disinvolto frequentatore dei generi eppure sempre ostinatamente fedele a se stesso, all’idea di un cinema della testimonianza, criterio di valutazione della nostra cultura. Lang giudice e giudicato (da Goebbels, Hays, McCarthy, dai produttori di Hollywood), anima superba e solitaria, cronista impietoso, viandante pronto a non fermarsi mai, moralista gaudente, insieme dongiovanni e convitato di pietra, sincero pessimista dionisiaco. Infine anticipatore della decadenza della civiltà giudaico-cristiana. Se in Rancho Notorious la vendetta si dice, biblicamente, «un frutto amaro e cattivo», in tutti gli altri film il crimine paga, il male imperversa, il malvagio trionfa, pur morto o sconfitto, e puntualmente risorge, in quanto siamo tutti, non retoricamente, figli di Caino e Abele, disposti a sgozzare il nostro Jekyll, a venderci per meno di un anello o di una mappa del tesoro, natural born killers, assassini nati. Non per colpa del demone che ci cresce dentro, dell’Io irrisolto che ci tormenta, ma per mera volontà del fato che – ha insegnato Fritz Lang – non ci porta mai più lontano da noi.
SCENEGGIATURE 1916 | Die Peitsche | t. l.: La frusta
Regia: Adolf Gärtner; sceneggiatura: Fritz Lang. Progettato per la serie Stuart Webbs-Detektiv. 1917 | Die Hochzeit im Exzentrik Klub | t. l.: Matrimonio al Club degli Eccentrici
Regia: Joe May; sceneggiatura: Fritz Lang; fotografia: Carl Hoffmann; interpreti: Harry Liedtke (Joe Debbs), Magda Madeleine, Käte Haak, Bruno Kastner, Paul Westermeier; produzione: May-Film GmbH (per la serie Joe Debbs-Detektiv); prima proiezione: Berlino, 27 aprile 1917. 1919 | Hilde Warren und der Tod | t. l.: Hilde Warren e la Morte
Regia: Joe May;sceneggiatura: Fritz Lang; fotografia: Curt Courant; interpreti: Mia May (Hilde Warren), Hans Mierendorff, Bruno Kastner, Ernst Matray, Georg John, Fritz Lang; produzione: May-Film GmbH;prima proiezione: Berlino, 31 agosto 1917. 1919 | Die Rache ist mein | t. l.: La vendetta è mia
Regia: Alwin Neuss; sceneggiatura: Fritz Lang; interpreti: Alwin Neuss, Otto Paul, Arnold Czempin, Helga Molander, Martha Daghofer; produzione: OHG Decla-Filmgesellschaft; metri: 1450;prima proiezione:
Berlino, 28 marzo 1919. 1919 | Wolkenbau und Flimmerstern | t. l.: Composizione di nuvole e stella scintillante
Regia: sconosciuta; sceneggiatura: Fritz Lang, Wolfgang Geiger; interpreti: Ressel Orla, Margarethe Frey, Karl-Gerhard Schröder, Otto Paul; produzione: OHG Decla-Filmgesellschaft; metri: 1382. 1919 | Lilith und Ly | t. l.: Lilith e Ly
Regia: Erich Kober; sceneggiatura: Fritz Lang; interpreti: Hans Marschall (Frank Landov), Elga Beck (Lilith/Ly Delinaros), Ernst Escherich (il consigliere Delinaros), August Hartner (lo scultore Mudarra), Herr Anker (il dottor Wörrmann), Franz Kammauf; produzione: Fiat-Film, Vienna. 1919 | Die Frau mit den Orchideen | t. l.: La signora dalle orchidee
Regia: Otto Rippert; sceneggiatura: Fritz Lang; fotografia: Carl Hoffmann; interpreti: Werner Krauss, Carl de Vogt, Gilda Langer; produzione: Decla-Bioscop AG, Berlino. 1919 | Die Bettler GmbH | t. l.: I mendicanti, società anonima
Regia: Alwin Neuss; sceneggiatura: Fritz Lang; interpreti: Alwin Neuss, Fred Selva-Goebel, Fritz Achterberg, Otto Paul, Martha Daghofer; produzione: OHG Decla-Filmgesellschaft; metri: 1404. 1919 | Totentanz | t. l.: Danza macabra
Regia: Otto Rippert; sceneggiatura: Fritz Lang; fotografia: Willy Hameister; scenografia: Hermann Warm; interpreti: Sascha Gura (Sie), Werner Krauss (il dottor Sephar), Joseph Roemer (Stuart O’Connor), Richard Kirsch; produzione: Helios-Film; metri: 1733; prima proiezione: Berlino, 19 giugno 1919. 1919 | Pest in Florenz | t. l.: La peste a Firenze
Regia: Otto Rippert; sceneggiatura: Fritz Lang; fotografia: Willy Hameister, Emil Schünemann (per gli esterni); scenografia: Hermann Warm, Franz Jaffé, Walter Reimann, Walter Röhrig; musica: Bruno Gellert; interpreti: Marga Kierska (Julia), Hans Walter, Theodor Becker (l’eremita Franziskus), Otto Mannstaedt (il consigliere Cesare), Anders Wikman (suo figlio Lorenzo), Karl Bernhard (il suo confidente), Franz Knaak (il cardinale), Erner Hübsch (un monaco), Juliette Brandt (la Peste), Erich Bartels; produzione: Decla-Bioscop AG; metri: 2622; prima proiezione: Berlino, 23 ottobre 1919. 1920 | Die Herrin der Welt | La signora del mondo 8. Teil: Die Rache der Maud Ferguson | t. l.: Ottava parte: La vendetta di Maud Ferguson
Regia: Joe May; sceneggiatura: Joe May, Fritz Lang, Wilhelm Röllinghoff, da un racconto di Karl Figdor; interpreti: Mia May, Hans Mierendorff, Ernst Hoffmann, Rudolf Lettinger, Henry Bender; produzione: MayFilm GmbH; prima proiezione: Berlino, 30 gennaio 1920. 1921 | Das Indische Grabmal | Il sepolcro indiano 1. Teil: Die Sendung des Yoghi | t. l.: Prima parte: La missione dello Yogi 2. Teil: Das Indische Grabmal
Regia: Joe May; sceneggiatura: Fritz Lang, Thea von Harbou dal suo romanzo omonimo; fotografia: Werner Brandes; scenografia e costumi: Martin Jacoby-Boy, Otto Hunte, Erich Kettelhut, Karl Vollbrecht; musica: Wilhelm Löwitt; interpreti: Conrad Veidt (Ayan, maragià di Eschnapur), Erna Morena (Savitri, la maharani), Paul Richter (l’ufficiale inglese Mac Allan), Olaf Fönss (l’architetto Herbert Rowland), Mia May (la sua fidanzata Irene), Bernhard Goetzke (Ramigani, lo Yogi), Lya de Putti (la danzatrice Mirrjha), Karl Platen (il domestico di Rowland), Werner Diegelmann (il capitano), Hermann Picha (il professor Leyden, orientalista), Georg John, Wolfgang von Schwind, Lewis Brody; produzione: May-Film GmbH; metri: 2957 (prima parte), 2534 (seconda parte); prima proiezione: Berlino, 22 ottobre 1921 (prima parte), 19 novembre 1921 (seconda parte). REGIE 1919 | Halbblut | t. l.: Mezzosangue
Regia e sceneggiatura: Fritz Lang; fotografia: Carl Hoffmann; interpreti: Ressel Orla (la meticcia Juanita), Carl de Vogt (Edward), Gilda Langer, Paul Morgan, Carl Gerhard-Schröder, Axel von Straaten; produzione: OHG Decla-Filmgesellschaft.; metri: 1608; prima proiezione: Berlino, 3 aprile 1919. 1919 | Der Herr der Liebe | t. l.: Il signore dell’amore
Regia: Fritz Lang; sceneggiatura: Leo Koffler; fotografia: Emil Schünemann;scenografia: Carl Ludwig Kirmse; interpreti: Carl de Vogt (Disescu), Gilda Langer (Yvette), Erika Unruh, Max Narlinsky, Fritz Lang;
produzione: Helios-Film/ OHG Decla-Filmgesellschaft; metri: 1316; prima proiezione: Berlino, settembre 1919. 1919 | Die Spinnen – Die Abenteuer des Kay Hoog in bekannten und unbekannten Welten | t. l.: I ragni – L’avventura di Kay Hoog nei mondi conosciuti e sconosciuti 1. Abenteuer: Der goldene See | t. l.: Prima avventura: Il lago dorato
Regia e sceneggiatura: Fritz Lang; fotografia: Emil Schünemann; scenografia: Hermann Warm, Otto Hunte, Carl Ludwig Kirmse, Heinrich Umlauff; interpreti: Carl de Vogt (Kay Hoog), Ressel Orla (Lio Sha), Lil Dagover (Naela), Georg John (il dottor Telphas), Rudolf Lettinger (John Terry), Edgar Pauly (John Quattrodita), Paul Morgan, Paul Biensfeldt, Friedrich Kühne, Harry Frank; produzione: OHG DeclaFilmgesellschaft; metri: 1951; prima proiezione: Berlino, 3 ottobre 1919. 1919 | Harakiri – Die Geschichte einer jungen Japanerin | t. l.: Harakiri – La storia di una giovane giapponese
Regia: Fritz Lang; sceneggiatura: Max Jungk, dal dramma Madam Butterfly di John Luther Long e David Belasco; fotografia: Max Fassbaender; scenografia e consulenza etnografica: Heinrich Umlauff (arredamenti forniti dal I.F.G. Umlauff Museum di Amburgo); interpreti: Paul Biensfeldt (il daimyo Tokuyawa), Lil Dagover (sua figlia O-Take-San), Georg John (il bonzo), Meinhard Maur (principe Matahari), Rudolf Lettinger (Karan, servitore del tempio), Ernst Hübsch (Kin-Be-Araki, proprietario della sala da tè), Käte Küster (Hanake, domestica di O-Take-San), Niels Prien (ufficiale di marina Olaf J. Anderson), Herta Héden (Eva, la sua fidanzata), Loni Nest (il figlio di O-Take-San e Olaf J. Anderson), Harry Frank, Josef Roemer; produzione: OHG Decla-Filmgesellschaft; metri: 2238; prima proiezione: Berlino, 18 dicembre 1919. 1920 | Die Spinnen | I ragni 2. Abenteuer: Das Brillantenschiff | Seconda avventura: La nave dei diamanti
Regia e sceneggiatura: Fritz Lang; fotografia: Karl Freund; scenografia: Hermann Warm, Otto Hunte, Carl Ludwig Kirmse, Heinrich Umlauff; interpreti: gli stessi della prima parte, e Georg John (il gran maestro dei Ragni), Thea Zander (Ellen Terry), Reiner Steiner (il comandante della nave dei diamanti), Friedrich Kühne (lo yogi Al-hab-mah), Meinhard Maur (un cinese), Paul Morgan (un ebreo), Gilda Langer; produzione: OHG Decla-Filmgesellschaft; metri: 2815; prima proiezione: Berlino, 13 febbraio 1920. 1920 | Das wandernde Bild | t. l.: La statua errante o Madonna im Schnee | t. l.: La madonna della neve
Regia: Fritz Lang; sceneggiatura: Fritz Lang, Thea von Harbou; fotografia: Guido Seeber; scenografia: Otto Hunte, Erich Kettelhut; interpreti: Mia May (Irmgard Vanderheit), Hans Marr (Georg Vanderheit, John Vanderheit), Rudolf Klein-Rhoden (il cugino Will Brand), Loni Nest (il bambino), Harry Frank; produzione: May-Film GmbH; metri: 2032; prima proiezione: Berlino, 25 dicembre 1920. 1921 | Die Vier um die Frau | t. l.: Quattro intorno a una donna o Kämpfende Herzen | t. l.: Cuori in lotta
Regia: Fritz Lang; sceneggiatura: Fritz Lang, Thea von Harbou, dal dramma di Rolf E. Vanloo; fotografia: Otto Kanturek; scenografia: Ernst Meiwers, Hans Jacoby; interpreti: Carola Tölle (Florence Yquem), Hermann Böttcher (suo padre), Ludwig Hartau (suo marito Harry Yquem), Anton Edthofer (Werner Krafft, William Krafft), Rudolf Klein-Rogge (Upton), Robert Forster-Larrinaga (Meunier), Lilli Lohrer (domestica di Florence), Harry Frank (Bobby), Leonhard Haskel, Paul Rehkopf (due malviventi), Gottfried Huppertz (il maître d’hôtel), Hans Lüpschütz (un vagabondo), Lisa von Marton (Margot), Erika Unruh (una prostituta), Paul Morgan, Edgar Pauly, Gerhard Ritterband; produzione: Decla-Bioscop AG; metri: 1707; prima proiezione: Berlino, 3 febbraio 1921. 1921 | Der müde Tod | Il signore delle tenebre
Regia: Fritz Lang; sceneggiatura: Fritz Lang, Thea von Harbou; fotografia: Erich Nitzchmann, Hermann Salfrank, Fritz Arno Wagner; scenografia: Robert Herlth, Walter Röhrig, Hermann Warm; costumi: dell’Umlauff Museum di Amburgo; musica: Peter Schirman; interpreti: Lil Dagover (la fanciulla, Zobeide, Monna Fiammetta, Tiao Tsien), Walter Janssen (il giovane, l’europeo, Giovanfrancesco, Liang), Bernhard Goetzke (la Morte, El Mot, l’arciere), Hans Sternberg (il sindaco), Ernst Rückert (il pastore), Max Adalbert (il notaio, il ministro delle finanze), Erich Pabst (l’istitutore), Paul Rehkopf (il sacrestano), Wilhelm Diegelmann (il medico), Karl Platen (il farmacista), Max Pfeiffer (il guardiano notturno), Hermann Picha (il sarto), Georg John (il becchino, il mendicante), Marie Wismar (la vecchia), Grete Berger (la madre), Rudolf
Klein-Rogge (il derviscio, Girolamo), Eduard von Winterstein (il califfo), Erika Unruh (Aisha), Lewis Brody (il moro), Lothar Müthel (il confidente), Lina Paulsen (la nutrice), Paul Biensfeldt (il mago A-Hei), Karl Huszar (l’imperatore), Paul Neumann (il carnefice); produzione: Decla-Bioscop AG; metri: 2306;prima proiezione: Berlino, 6 ottobre 1921. 1922 | Dr. Mabuse, der Spieler | Il dottor Mabuse 1. Teil: Der grosse Spieler – Ein Bild der Zeit | Prima parte: Il grande giocatore – Un quadro dell’epoca 2. Teil: Inferno – Menschen der Zeit | Seconda parte: L’inferno del crimine – Uomini dell’epoca
Regia: Fritz Lang; sceneggiatura: Fritz Lang, Thea von Harbou, dal romanzo di Norbert Jacques; fotografia: Carl Hoffmann; scenografia: Carl Stahl-Urach, Otto Hunte, Erich Kettelhut, Karl Vollbrecht; costumi: Vally Reinecke; interpreti: Rudolf Klein-Rogge (il dottor Mabuse), Aud Egede Nissen (Cara Carozza), Gertrude Welcker (la contessa Told), Alfred Abel (il conte Told), Bernhard Goetzke (il procuratore von Wenk), Paul Richter (Gerhard Hull), Robert Forster-Larrinaga (Spörri), Hans Adalbert Schlettow (Georg), Georg John (Pesch), Karl Huszar (Hawasch, capo del laboratorio dei falsari), Grete Berger (Fine, domestica di Mabuse), Julius Falkenstein (Karstens), Lydia Potechina (la russa), Julius E. Herrmann (Schramm), Karl Platen (il domestico di Told), Anita Berber (la danzatrice in frac), Paul Biensfeldt, Julie Brandt, August PraschGrevenberg, Adele Sandrock, Max Adalbert, Gustav Botz, Heinrich Gotho, Leonhard Haskel, Erner Hübsch, Gottfried Huppertz, Hans Junkermann, Adolf Klein, Erich Pabst, Edgar Pauly, Hans Sternberg, Olaf Storm, Erich Walter; produzione: Erich Pommer per Uco-Film der Decla-Bioscop; metri: 3496 (prima parte), 2560 (seconda parte); prima proiezione: Berlino, 27 aprile 1922 (prima parte), 26 maggio 1922 (seconda parte). 1924 | Die Nibelungen | I Nibelunghi 1. Teil: Sigfrieds Tod | La morte di Sigfrido 2. Teil: Kriemhilds Rache | La vendetta di Crimilde
Regia: Fritz Lang; sceneggiatura: Thea von Harbou, da Die Nibelungenlied, la Saga di Norse e altre fonti; fotografia: Carl Hoffmann, Günther Rittau, Walter Ruttmann; scenografia: Otto Hunte; costruzione del drago: Karl Vollbrecht; costumi: Paul Gerd Guderian, Aenne Willkomm; armature, costumi e armi degli Unni: Heinrich Umlauff, dai laboratori del suo museo di Amburgo; musica: Gottfried Huppertz; interpreti: Gertrud Arnold (regina Ute), Margarethe Schön (Crimilde), Hanna Ralph (Brunilde), Paul Richter (Sigfrido), Theodor Loos (re Günther), Rudolf Klein-Rogge (re Etzel), Hans Carl Müller (Gerenot), Erwin Biswanger (Giselher), Bernhard Goetzke (Volker von Alzey), Hans Adalbert Schlettow (Hagen Tronje), Hardy von François (Dankwart), Georg John (Mime, Alberico, Blaodel), Frieda Richard (la serva runica), Georg Jurowski (il sacerdote), Iris Roberts (il paggio), Hubert Heinrich (il menestrello), Rudolf Rittner (Rüdiger von Bechlarn), Fritz Alberti (Dietrich von Bern), Georg August Koch (Hildebrand), Grete Berger (una donna unna); produzione: Decla-Bioscop AG/ UFA; metri: 3216 (prima parte), 3576 (seconda parte); prima proiezione: Berlino, 14 febbraio 1924 (prima parte), 26 febbraio 1924 (seconda parte). 1927 | Metropolis | Id.
Regia: Fritz Lang; sceneggiatura: Thea von Harbou; fotografia: Karl Freund, Günther Rittau; effetti speciali fotografici: Eugen Schüfftan; scenografia: Otto Hunte, Erich Kettelhut, Karl Vollbrecht; sculture e robot: Walter Schultze-Mittendorf; costumi: Aenne Willkomm; musica: Gottfried Huppertz; interpreti: Alfred Abel (Joh Fredersen), Gustav Frölich (suo figlio Freder), Brigitte Helm (Maria e il suo doppio artificiale), Rudolf Klein-Rogge (Rotwang), Fritz Rasp (lo Smilzo), Theodor Loos (Josaphat), Erwin Biswanger (l’operaio n. 11.811), Heinrich George (Groth, l’addetto alla macchina centrale), Olaf Storm (Jan), Hanns Leo Reich (Marinus), Heinrich Gotho (il maestro di cerimonie), Margarete Lanner (la donna nell’automobile), Max Dietze, Georg John, Walter Kuhle, Erwin Vater, Arthur Reinhard (operai), Grete Berger, Olly Böheim, Ellen Frey, Lisa Gray, Rose Lichtenstein, Helene Weigel (operaie), Beatrice Garga, Anny Hintze, Margarete Lanner, Helen von Münchhoffen, Hilde Woitscheff (le donne dei Giardini eterni), Fritz Alberti (l’uomo creatore, nella scena della Torre di Babele); produzione: Erich Pommer per UFA; metri: 4189; prima proiezione: Berlino, 10 gennaio 1927. 1928 | Spione | L’inafferrabile
Regia: Fritz Lang; sceneggiatura: Fritz Lang, Thea von Harbou dal suo romanzo omonimo; fotografia: Fritz Arno Wagner; scenografia: Otto Hunte, Karl Vollbrecht; musica: Werner R. Heymann; interpreti: Rudolf Klein-Rogge (Haghi, Nemo), Gerda Maurus (Sonja Baranikowa), Lien Deyers (Kitty), Louis Ralph
(Morrier), Craighall Sherry (Burton Jason), Willy Fritsch (Donald Tremaine, agente n. 326), Paul Hörbiger (l’autista Franz), Hertha von Walther (Lady Leslane), Lupu Pick (Masimoto), Fritz Rasp (colonnello Jellusic), Julius Falkenstein (direttore dell’hotel), Georg John (controllore del vagone letto), Paul Rehkopf (un teppista), Grete Berger (l’infermiera), Hermann Valentin, Hans von Twardowski (segretario di Jason), Rosa Valetti (madre di Kitty); produzione: Fritz Lang-Film GmbH; metri: 3630; prima proiezione: Berlino, 23 marzo 1928. 1929 | Die Frau im Mond | La donna nella luna
Regia: Fritz Lang; sceneggiatura: Thea von Harbou, dal suo romanzo omonimo; fotografia: Curt Courant, Oskar Fischinger, Otto Kanturek; effetti speciali: Konstantin Tschetwerikoff; scenografia: Emil Hasler, Otto Hunte, Karl Vollbrecht; fotografie dei fondali: Horst von Harbou; musica: Willy Schmidt-Gentner; consulenza artistica e scientifica: Gustav Wolff, Josef Danilowatz, Hermann Oberth, Willy Ley; interpreti: Klaus Pohl (Georg Manfeldt), Willy Fritsch (Wolf Helius), Gustav von Wangenheim (Hans Windegger), Gerda Maurus (Friede Velten), Gustl Stark-Gstettenbaur (Gustav), Fritz Rasp (Walt Turner), Tilla Durieux, Hermann Valentin, Max Zilzer, Mahmud Terja Bey, Borwin Walth (finanzieri), Margarete Kupfer (signora Hippolt, governante di Helius), Max Maximilian (Grotjan, autista di Helius), Alexa von Porembsky (una venditrice di violette), Gerhard Dammann (il caposquadra), Heinrich Gotho (l’inquilino del secondo piano), Karl Platen (uomo con il microfono), Alfred Loretto, Edgar Pauly, il topo Josephine; produzione: Fritz Lang per UFA; metri: 4365; prima proiezione: Berlino, 15 ottobre 1929. 1931 | M | M, il mostro di Düsseldorf
Regia: Fritz Lang; sceneggiatura: Fritz Lang, Thea von Harbou; fotografia: Fritz Arno Wagner; scenografia e costumi: Emil Hasler, Karl Vollbrecht; fotografie dei fondali: Horst von Harbou; suono: Adolf Jansen; montaggio: Paul Falkenberg; musica: Edvard Grieg (brani da Peer Gynt); interpreti: Peter Lorre (Franz Becker), Ellen Widmann (la signora Beckmann), Inge Landgut (Elsie Beckmann), Gustaf Gründgens (Schränker), Friedrich Gnass (il ladro), Fritz Odemar (il baro), Paul Kemp (il borsaiolo), Theo Lingen (l’imbroglione), Ernst Stahl-Nachbaur (il prefetto di polizia), Franz Stein (il ministro), Otto Wernicke (commissario Lohmann), Gerhard Bienert (segretario di Lohmann), Theodor Loos (commissario Groeber), Georg John (il venditore ambulante cieco), Rudolf Blümner (l’avvocato difensore), Karl Platen (il guardiano), Rosa Valetti (la tenutaria del “Krokodil”), Hertha von Walther (una prostituta), Josef Almas, Carl Balhaus, Hans Behal, Josef Dahmen, Hugo Döblin, J.A. Eckhoff, Else Ehser, Karl Etzer, Erwin Faber, Ilse Fürstenberg, Heinrich Gotho, Heinrich Gretler, Günther Hadank, Robert Hartberg, Ernst Paul Hempel, Oskar Höcker, Albert Hörrmann, Albert Karchow, Werner Kepich, Herrmann Krehan, Rose Lichtenstein, Lotte Löbinger, Sigurd Lohde, Alfred Loretto, Paul Meredow, Trude Moos, Hadrian M. Netto, Maja Norden, Edgar Pauly, Klaus Pohl, Franz Polland, Paul Rehkopf, Hans Ritter, Max Sablotzki, Alexander Sascha, Leonard Steckel, Karl Heinz Stroux, Wolf Trutz, Otto Waldis, Borwin Walth, Rolf Wanka, Ernst Wulf, Bruno Ziener, Gelin Wannemann, Agnes Schultz-Lichterfeld; produzione: Seymour Nebenzahl per NeroFilm AG; durata: 117’; prima proiezione: Berlino, 11 maggio 1931. 1932 | Das Testament des Dr. Mabuse | Il testamento del dottor Mabuse
Regia: Fritz Lang; sceneggiatura: Thea von Harbou, basata sul personaggio di Norbert Jacques; fotografia: Fritz Arno Wagner, Karl Vash; scenografia e costumi: Emil Hasler, Karl Vollbrecht; montaggio: Conrad von Molo; musica: Hans Erdmann; interpreti: Rudolf Klein-Rogge (il dottor Mabuse), Oskar Beregi (professor Baum), Georg John (il suo domestico), Karl Meixner (Hofmeister), Theodor Loos (il dottor Kramm), Otto Wernicke (commissario Lohmann), Klaus Pohl (Müller), Wera Liessem (Lilli), Gustav Diessl (Thomas Kent), Ludwig Stössel (funzionario dell’ufficio di collocamento), Camilla Spira (Anna dei gioielli), Rudolf Schündler (Hardy), Theo Lingen (il suo amico Karetzky), Paul Oskar Höcker (Bredow), Paul Henckels (litografo e falsario), Hadrian Maria von Netto (Nicolai Grigoriew), Paul Bernd (ricattatore), Henry Pless (un poliziotto), A.E. Licho (dottor Hauser), Gerhard Bienert (ispettore di polizia), Anna Goltz, Paul Rehkopf, Josef Dahmen, Franz Stein, Eduard Wesener, Bruno Ziener, Heinrich Gotho, Michael von Newlinski; produzione: Seymour Nebenzahl per Nero-Film AG; durata: 122’; prima proiezione: Budapest, aprile 1933; Vienna, 12 maggio 1933. 1932 | Le testament du Dr. Mabuse (versione francese girata contemporaneamente a quella tedesca)
Co-regia e adattamento della sceneggiatura originale: René Sti. Stessa équipe tecnica, salvo scenografia: Saul C. Colin e montaggio: Lothar Wolff; interpreti: Rudolf Klein-Rogge (il dottor Mabuse), Thomy
Bourdelle (professor Baum), Karl Meixner (Hofmeister), Jim Gérald (il commissario Lohmann), Monique Rolland (Lilli), Maurice Maillot (Kent), Ginette Gaubert (Anna), René Ferté (Hardy), Raymond Cordier (Karetzky), Daniel Mendaille (Bredow), Lily Rezillot, Georges Koudria, Marcel Merminod, Silvio de Pedrelli, Georges Tourreil, Georges Paulais, Jacques Ehrem; durata: 95’; prima proiezione: Parigi, aprile 1933. 1934 | Liliom | La leggenda di Liliom
Regia: Fritz Lang; sceneggiatura: Fritz Lang, Robert Liebmann, Bernard Zimmer, dalla commedia omonima di Ferenc Molnar; fotografia: Rudolf Maté, Louis Née; scenografia: Paul Colin, René Renoux; costumi: René Hubert; montaggio: Ernest Hajos; musica: Jean Lenoir (anche autore della canzone Viens, gosse de gosse), Franz Waxman; interpreti: Charles Boyer (Liliom Zadowski), Madeleine Ozeray (Julie e sua figlia), Mimi Funès (Marie), Florelle (Madame Muscat), Robert Arnoux (il forzuto), Roland Toutain (il marinaio), Alexandre Rignault (Hollinger), Henri Richard (il commissario), Raoul Marco (l’ispettore), Alcover (Alfred), Richard Barencey (il poliziotto del Purgatorio), Antonin Artaud (l’arrotino, un angelo), Léon Arvel (l’impiegato), René Stern (il cassiere), Maximilienne (Madame Menoux), Viviane Romance (la venditrice di sigarette), Mila Parély (la dattilografa celeste); produzione: Erich Pommer per Fox-Europa; durata: 120’; prima proiezione: Parigi, 13 maggio 1934. 1936 | Fury | Furia
Regia: Fritz Lang; sceneggiatura: Fritz Lang, Bartlett Cormack, dal racconto Mob Rule di Norman Krasna; fotografia: Joseph Ruttenberg; scenografia: Cedric Gibbons (collaboratori: William A. Horning, Edwin B. Willis); costumi: Dolly Tree; montaggio: Frank Sullivan; musica: Franz Waxman; interpreti: Spencer Tracy (Joe Wheeler), Sylvia Sidney (Katherine Grant), Walter Abel (il procuratore distrettuale), Bruce Cabot (Kirby Dawson), Edward Ellis (lo sceriffo), Walter Brennan (“Bugs” Mayers), Frank Albertson (Charlie), George Walcott (Tom), Arthur Stone (Durkin), Morgan Wallace (Fred Garrett), George Chandler (Milton Jackson), Roger Gray (lo straniero), Edwin Maxwell (Vickery), Howard Hickman (il governatore), Jonathan Hale (l’avvocato difensore), Leila Bennett (Edna Hooper), Esther Dale (signora Whipple), Helene Flint (Franchette), Edward Le Saint (il dottore), Frank Sully (il dinamitardo), Ben Hall (Goofy), Mira McKinney (la donna isterica), Murdock MacQuarrie, Frank Mills, Edwin J. Brady, James Quinn, Al Herman (gli amici di Dawson), Frederick Burton (il giudice Hopkins); produzione: Joseph L. Mankiewicz per MGM; durata: 94’; prima proiezione: 22 maggio 1936. 1937 | You Only Live Once | Sono innocente!
Regia: Fritz Lang; soggetto: Gene Towne; sceneggiatura: Gene Towne, Graham Baker; fotografia: Leon Shamroy; scenografia: Alexander Toluboff; costumi: Helen Taylor; montaggio: Daniel Mandell; musica: Alfred Newman (la canzone A Thousand Dreams of You è di Louis Alter e Paul Francis); interpreti: Sylvia Sidney (Joan “Jo” Graham), Henry Fonda (Eddie Taylor), Jean Dixon (Bonnie Graham), Barton MacLane (Stephen Whitney), William Gargan (padre Dolan), Warren Hymer (Mugsy), Charles “Chick” Sale (Ethan), Margaret Hamilton (Hester), Guinn Williams (Rogers), Jerome Cowan (dottor Hill), John Wray (il direttore Warden), Jonathan Hale (il procuratore distrettuale), Ward Bond (una guardia), Wade Boteler (un poliziotto), Henry Taylor (Kozderonas), Jean Stoddard (stenografa), Ben Hall (fattorino), Walter De Palma, Jack Carson; produzione: Walter Wanger per United Artists; Durata: 86’; prima proiezione: New York, 30 gennaio 1937. 1938 | You and Me| You and Me
Regia: Fritz Lang; soggetto: Norman Krasna; sceneggiatura: Virginia Van Upp; fotografia: Charles B. Lang jr.; scenografia: Hans Dreier, Ernest Fegté; montaggio: Paul Weatherwax; musica: Kurt Weill, Boris Morros (canzoni: You Can’t Get Something for Nothing, The Right Guy for Me di Kurt Weill e Sam Coslow; You and Me di Frederick Hollander e Ralph Freed); interpreti: Sylvia Sidney (Helen Roberts), George Raft (Joe Dennis), Robert Cummings (Jim), Barton MacLane (Mickey), Roscoe Karns (Cuffy), Harry Carey (il signor Morris), Warren Hymer (Gimpy), George E. Stone (Patsy), Guinn Williams (tassista), Vera Gordon (la signora Levine), Carol Paige (cantante), Bernadene Hayes (Nellie), Egon Brecher (il signor Levine), Joyce Compton (Curly Blonde), Cecil Cunningham (la signora Morris), Willard Robertson (Dayton), Roger Gray (bagnino), Adrian Morris (Knucks), Harlan Briggs (McTavish), Harriette Haddon (venditrice di sigarette), Paula De Cardo, Matt MacHugh, Paul Newlan, Jack Pennick, Kit Guard, Hal K. Dawson, Harta Lynd, Max Barwyn, Jimmie Dundee, Jack Mulhall, Sam Ash, Julia Faye, Arthur Hoyt, Harry Tenbrook, Ernie Adams, Sheila Darey, Ellen Drew, Margaret Randall; produzione: Fritz Lang per Paramount Pictures; durata: 94’;
prima proiezione: New York, 1 giugno 1938. 1940 | The Return of Frank James | Il vendicatore di Jess il bandito
Regia: Fritz Lang; sceneggiatura: Sam Hellman; fotografia: (Technicolor) George Barnes, William V. Skall; scenografia: Richard Day, Wiard B. Ihnen; costumi:Travis Banton; montaggio: Walter Thompson; musica: David Buttolph; interpreti: Henry Fonda (Frank James), Gene Tierney (Eleanor Stone), Jackie Cooper (Clem), Henry Hull (maggiore Rufus Todd), Ernest Whitman (Pinky), J. Edward Bromberg (il detective George Runyan), Donald Meek (McCoy), Eddie Collins (l’impiegato della stazione di Eldora), John Carradine (Bob Ford), George Barbier (il giudice), Charles Tannen (Charlie Ford), Lloyd Corrigan (Randolph Stone), Russell Hicks (un agente), Victor Kilian (predicatore), Edward McWade (colonnello Jackson), George Chandler (Roy), Irving Bacon (uno spettatore a teatro), Frank Shannon (sceriffo), Barbara Pepper (Nellie Blane), Louis Mason (guardiano), Stymie Beard (Mose), William Pawley, Frank Sully (attori), Davidson Clark (un ufficiale); produzione: Darryl F. Zanuck per Twentieth Century Fox; durata: 92’; prima proiezione: New York, 9 agosto 1940. 1941 | Western Union | Fred il ribelle
Regia: Fritz Lang; sceneggiatura: Robert Carson, dal romanzo omonimo di Zane Grey; fotografia: (Technicolor) Edward Cronjager, Allen M. Davey; scenografia: Richard Day, Wiard B. Ihnen, Albert Hogbett; costumi: Travis Banton; montaggio: Robert Bischoff; musica: David Buttolph; interpreti: Randolph Scott (Vance Shaw), Robert Young (Richard Blake), Dean Jagger (l’ingegnere Edward Creighton), Virginia Gilmore (Sue Creighton, sua sorella), Barton MacLane (Jack Slade), John Carradine (Doc Murdoch), Slim Summerville (il cuoco Herman), Chill Wills (Homer), Russell Hicks (il governatore), Victor Kilian (Charlie), Minor Watson (Pat Grogan), George Chandler (Herb), Chief Big Tree (capo Spotted Horse), Chief Thundercloud (capo indiano), Dick Rich (Porky), Harry Strang (un complice di Jack), Charles Middleton (postiglione), Addison Richards (capitano Harlow), Irving Bacon (il barbiere), J. Edward Bromberg; produzione: Twentieth Century Fox; durata: 95’; prima proiezione: New York, 6 febbraio 1941. 1941 | Man Hunt | Duello mortale
Regia: Fritz Lang; sceneggiatura: Dudley Nichols, dal romanzo Rogue Male di Geoffrey Household, prepubblicato a puntate sull’ «Atlantic Monthly Magazine»; fotografia: Arthur Miller; scenografia: Richard Day, Wiard B. Ihnen; costumi: Travis Banton; montaggio: Allen McNeil; musica: Alfred Newman; interpreti: Walter Pidgeon (Alan Thorndike), Joan Bennett (Jenny Stokes), George Sanders (maggiore QuiveSmith), John Carradine (Jones), Roddy McDowall (Vaner), Ludwig Stössel (il dottore), Heather Thatcher (Lady Risborough), Frederick Worlock (Lord Risborough), Roger Imhof (capitano Jensen), Egon Brecher (Whiskers), Lester Matthews (il maggiore), Holmes Herbert (il notaio Farnsworthy), Eily Malyon (impiegata dell’ufficio postale), Arno Frey (tenente di polizia), Frederick Vogeding (ambasciatore), Lucien Prival (uomo con l’ombrello), Virginia MacDowall, Keith Hitchcock, John Rogers, William Haade, Bob Stephenson; produzione: Kenneth MacGowan per Twentieth Century Fox; durata: 105’; prima proiezione: New York, 13 giugno 1941. 1943 | Hangmen Also Die! | Anche i boia muoiono
Regia: Fritz Lang; soggetto: Fritz Lang, Bertolt Brecht; sceneggiatura: Fritz Lang, Bertolt Brecht, John Wexley; fotografia: James Wong Howe; scenografia: William Darling; costumi: Julie Heron; montaggio: Gene Fowler jr.; musica: Hanns Eisler (la canzone No Surrender è di Hanns Eisler e Sam Coslow); interpreti: Brian Donlevy (Frantisek Svoboda), Walter Brennan (professor Stepan Novotny), Anna Lee (Mascha Novotny), Margaret Wycherly (zia Ludmilla Novotny), Nana Bryant (signora Novotny), Billy Roy (Beda Novotny), Dennis O’Keefe (Jan Horak), Hans von Twardowski (Reinhard Heydrich), Alexander Granach (Alois Gruber), Tonio Selwart (Hass, capo della Gestapo), Arthur Loft (generale Wotruba), Reinhold Schünzel (ispettore Ritter), Gene Lockhart (Emil Czaka), Lionel Stander (autista del taxi), Jonathan Hale (il capo della Resistenza), Sarah Padden (signora Dvorak), Byron Foulger (Bartos), Virginia Farmer (proprietaria della pensione), Louis Donath (Schirmer), Edmund MacDonald (il dottor Pilar), George Irving (il poeta Nezval), James Bush (un operaio), Arno Frey (Itnut), Lester Sharpe (Rudy), William Farnum (Viktorin), Emmett Vogan (Kvarda), Philip Merivale; produzione: Fritz Lang per Arnold Productions/ United Artists; durata: 131’; prima proiezione: Los Angeles, 26 marzo 1943. 1944 | The Woman in the Window | La donna del ritratto
Regia: Fritz Lang; sceneggiatura: Nunnally Johnson, dal romanzo Once Off Guard di J.H. Wallis; fotografia: Milton Krasner; effetti speciali: Vernon Walker; scenografia: Duncan Cramer; costumi: Muriel King; montaggio: Gene Fowler jr., Marjorie Johnson; musica: Arthur Lang; interpreti: Edward G. Robinson (professor Richard Wanley), Joan Bennett (Alice Reed), Edmond Breon (dottor Michael Barkstone), Raymond Massey (il procuratore Frank Lalor), Thomas E. Jackson (ispettore Jackson), Arthur Loft (Mazard), Dan Duryea (Heidt, la guardia del corpo), Frank Dawson (Collins), Dorothy Peterson (signora Wanley), Carol Cameron, Bobby Blake (figli di Wanley), Frank Melton, Don Brodie, Alec Craig, Frank Mills, Ralph Dunn, Fred Graham, Eddie Chandler; produzione: Nunnally Johnson per Christie Corporation/ International Pictures/ RKO Radio; durata: 99’; prima proiezione: 10 ottobre 1944. 1944 | Ministry Of Fear | Prigioniero del terrore
Regia: Fritz Lang; sceneggiatura: Seton I. Miller, dal romanzo omonimo di Graham Greene; fotografia: Henry Sharp; scenografia: Hans T. Dreier, Hal Pereira; costumi: Edith Head; montaggio: Archie Marshek; musica: Victor Young; interpreti: Ray Milland (Stephen Neale), Marjorie Reynolds (Carla Hilfe), Carl Esmond (Willi Hilfe), Dan Duryea (Travers), Alan Napier (dottor Forrester), Percy Waram (ispettore Prentice), Thomas Louden (Newland), Erskine Sanford (Rennit), Helene Grant (signora Merrick), Aminta Dyne (prima signora Bellane), Hillary Brooke (seconda signora Bellane), Mary Field (Martha Penteel), Byron Foulger (Newby), Lester Matthews (dottor Morton), Eustace Wyatt (il cieco), Connie Leon, Evelyn Beresford, Frank Dawson, Eric Wilton, Boyd Erwin, Frank Baker, Wilson Benge, Leonard Carey, Olaf Hytten; produzione: Seton I. Miller per Paramount Pictures; durata: 85’; prima proiezione: Londra, aprile 1944. 1945 | Scarlet Street | La strada scarlatta
Regia: Fritz Lang; sceneggiatura: Dudley Nichols, dal romanzo La chienne di Georges de La Fouchardière e dal dramma omonimo di Mouézy-Eon; fotografia: Milton Krasner; effetti speciali: John P. Fulton; scenografia: Alexander Golitzen; costumi: Travis Banton; montaggio: Arthur Hilton; musica: Hans J. Salter; interpreti: Edward G. Robinson (Christopher Cross), Joan Bennett (Katherine Marsh, detta Kitty “Lazy Legs”), Dan Duryea (Johnny Prince), Margaret Lindsay (Millie, l’amica di Kitty), Rosalind Ivan (Adele), Samuel S. Hinds (Charles Pringle), Jess Barker (il critico d’arte Janeway), Arthur Loft (Dellarowe), Vladimir Sokoloff (Pop Lejon), Charles Kemper (uomo con l’occhio bendato), Russell Hicks (Hogarth), Anita Bolster (signora Michaels), Cyrus W. Kendell (Nick), Fred Essler (Marchetti), Edgar Dearing, Tom Dillon (poliziotti), Chuck Hamilton (l’autista), Gus Glassmire, Howard Mitchell, Ralph Littlefield, Sherry Hall, Jack Statham (impiegati), Rodney Bell (Barney), Byron Foulger, Will Wright; produzione: Fritz Lang, Walter Wanger per Diana Productions/ Universal International; durata: 102’; prima proiezione: 28 dicembre 1945. 1946 | Cloak and Dagger | Maschere e pugnali
Regia: Fritz Lang; soggetto: Boris Ingster, John Larkin, dal romanzo omonimo di Corey Ford e Alastair MacBain; sceneggiatura: Albert Maltz, Ring Lardner jr.; fotografia: Sol Polito; effetti speciali: Harry Barndollar, Edwin B. DuPar; scenografia: Max Parker; costumi: Leah Rhodes; montaggio: Christian Nyby; musica: Max Steiner; interpreti: Gary Cooper (professor Alvah Jasper), Lilli Palmer (Gina), Robert Alda (Pinky), Vladimir Sokoloff (professor Giovanni Polda), J. Edward Bromberg (Trenk), Marjorie Hoshelle (Ann Dawson), Ludwig Stössel (il tedesco), Helene Thimig (Katarin Loder), Dan Seymour (Marsoli), Marc Lawrence (Luigi), James Flavin (colonnello Walsh), Pat O’Moore (l’inglese), Charles Marsh (Erich), Hans Schumm, Peter Michael (agenti tedeschi), Don Turner, Rosalind Lyons, Clifton Young, Ross Ford; produzione: Milton Sperling per United States Pictures/ Warner Bros.; durata: 106’; prima proiezione: 11 settembre 1946. 1948 | Secret Beyond the Door | Dietro la porta chiusa
Regia: Fritz Lang; sceneggiatura: Sylvia Richards, dal racconto Museum Piece Nb. 13 di Rufus King; fotografia: Stanley Cortez; scenografia: Max Parker; arredamenti: Russell A. Gausman, John Austin; costumi: Travis Banton; montaggio: Arthur D. Hilton; musica: Miklos Rozsa; interpreti: Joan Bennett (Celia Lamphere), Michael Redgrave (Mark Lamphere), Anne Revere (sua sorella Caroline), Mark Dennis (suo figlio David), Barbara O’Neil (Emma Robey), Natalie Schaefer (Edith Potter), Paul Cavanagh (Rick Barrett, fratello di Celia), Anabel Shaw (ragazza della buona società), Rosa Rey (Paquita), James Seay (l’avvocato Bob Dwight), Virginia Brissac (Sarah), Houseley Stevenson (Andy), Marie Harmon, Kay Morley (ragazze
della buona società), Donna Di Mario (la giovane messicana), Paul Fierro, David Cota (i duellanti messicani), Lucio Villegas (il sacerdote), Eddy C. Waller (Lem), Julian Rivero, Paul Scardon, Danny Duncan; produzione: Fritz Lang, Walter Wanger per Diana Productions/ Universal International; durata: 99’; prima proiezione: New York, 15 gennaio 1948. 1950 | House by the River | Bassa marea
Regia: Fritz Lang; sceneggiatura: Mel Dinelli, dal romanzo Floodtide di Alan P Herbert; fotografia: Edward Cronjager; effetti speciali: Howard e Theodore Lydecker; scenografia: Boris Leven; costumi: Adele Palmer; montaggio: Arthur D. Hilton; musica: George Antheil; interpreti: Louis Hayward (Stephen Byrne), Jane Wyatt (Marjorie Byrne), Lee Bowman (John Byrne), Margaret Seddon (signora Whittaker), Dorothy Patrick (Emily Gaunt), Ann Shoemaker (signora Ambrose), Jody Gilbert (Flora Bantam), Kathleen Freeman (Effie Ferguson), Sarah Padden (signora Beach), Will Wright (ispettore Sarten), Leslie Kimmel (signor Gaunt), Effie Laird (signora Gaunt), Howland Chamberlain, Peter Brocco, George Taylor; produzione: Howard Welsch per Fidelity Pictures/ Republic; durata: 88’; prima proiezione: New York, 4 aprile 1950. 1950 | American Guerrilla in the Philippines | I guerriglieri delle Filippine
Regia: Fritz Lang; sceneggiatura: Lamar Trotti, dal romanzo omonimo di Ira Wolfert; fotografia: (Technicolor) Harry Jackson; effetti speciali: Fred Sersen; scenografia: Lyle Wheeler, J. Russell Spencer; costumi: Travilla, Charles Le Maire; montaggio: Robert Simpson; musica: Cyril Mockridge; regista della seconda unità: Robert D. Webb; interpreti: Tyrone Power (Chuck Palmer), Micheline Presle (Jeanne Martinez), Juan Torena (Juan Martinez), Maria Del Val (signora Martinez), Tommy Cook (Miguel), Bob Patten (Lovejoy), Tom Ewell (Jim Mitchell), Jack Elam (Spenser), Miguel Azures (il traditore filippino), Robert H. Barrat (generale Douglas MacArthur), Eddie Infante (colonnello Dimalanta), Orlando Martin (colonnello Benson), Carleton Young (colonnello Phillips), Chris De Vera, Eduardo Rivera (ufficiali giapponesi), Fred Gonzales, Arling Gonzales (operatori radio), Sabu Camacho (Bo), Erlinda Cortez, Rosa Del Rosario, Kathy Ruby (partigiani); produzione: Lamar Trotti per Twentieth Century Fox; durata: 105’; prima proiezione: New York, 7 novembre 1950. 1952 | Rancho Notorious | Rancho Notorious
Regia: Fritz Lang; sceneggiatura: Daniel Taradash, dal racconto Gunsight Whitman di Silvia Richards; fotografia: (Technicolor) Hal Mohr; scenografia: Wiard B. Ihnen; costumi: Joe King, (per Marlene Dietrich) Don Loper; montaggio: Otto Ludwig; musica: Emil Newman (canzoni di Ken Darby: Gipsy Davey e Get Away, Young Man eseguite da Marlene Dietrich, The Legend of Chuck-A-Luck eseguita da William Lee); interpreti: Marlene Dietrich (Altar Keane), Arthur Kennedy (Vern Haskell), Mel Ferrer (Frenchy Fairmont), Gloria Henry (Beth Forbes), Lloyd Gough (Kinch), John Doucette (Whity), Fuzzy Knight (il barbiere), William Frawley (Baldy Gunder), Lisa Ferraday (Maxine), John Raven (il croupier del Chuck-A-Luck), Jack Elam (Mark Geary), Dan Seymour (Comanche Paul), George Reeves (Wilson), Rodric Redwing (Rio), Francis MacDonald (Harbin), John Kellogg (il negoziante Jen), Stuart Randall (Starr), Roger Anderson (Red), Felipe Turich (Sanchez), José Dominguez (Gonzales), Stan Jolley (lo sceriffo Warren), Charlita (ragazza messicana), Ralph Sanford (il politicante Slade), Lane Chandler (lo sceriffo Hardy), Fred Graham (Ace Maguire), Dick Elliott (il narratore), Paul Newlan, Harry Woods, William Haade (rappresentanti della legge), Dick Wessel; produzione: Howard Welsch per Fidelity Pictures Corporation/ RKO Radio; durata: 89’; prima proiezione: 7 febbraio 1952. 1952 | Clash by Night | La confessione della signora Doyle
Regia: Fritz Lang; sceneggiatura: Alfred Hayes, dal dramma omonimo di Clifford Odets (tr.it. Scontro nella notte); fotografia: Nicholas Musuraca; effetti speciali fotografici: Harold Wellman; scenografia: Albert S. D’Agostino, Carroll Clark; costumi: Michael Woulfe; montaggio: George J. Amy; musica: Roy Webb (la canzone I Hear a Rhapsody è di Dick Gasparre, Jack Baker, George Fragos, eseguita da Tony Martin); interpreti: Barbara Stanwyck (Mae Doyle), Keith Andes (Joe Doyle), Paul Douglas (Jerry D’Amato), Robert Ryan (Earl Pfeiffer), Marilyn Monroe (Peggy), J. Carroll Naish (zio Vince), Silvio Minciotti (papà D’Amato), Diane Stewart, Deborah Stewart (le gemelle), Roy D’Armour, Gilbert Frye (truffatori), Nancy Duke, Sally Yarnell, Irene Crosby, Helen Hansen, Dan Bernaducci, Dick Coe, Al Caven (invitati al matrimonio), Julius Tannen, Bert Stevens, Mario Siletti (baristi), William Norton Bailey (cameriere), Bill Slack, Art Dupuis (clienti del bar), Tony Dante (un pescatore), Frank Kreig; produzione: Harriet Parsons per Wald-Krasna Productions/ RKO Radio; durata: 105’; prima proiezione: 16 maggio 1952.
1953 | The Blue Gardenia | Gardenia blu
Regia: Fritz Lang; soggetto: Vera Caspary; sceneggiatura: Charles Hoffman; fotografia: Nicholas Musuraca; effetti speciali: Willis Cook; scenografia: Daniel Hall; costumi: Maria Donovan, Izzy Berne; montaggio: Edward Mann; musica: Raoul Kraushaar (la canzone The Blue Gardenia, di Bob Russell e Lester Lee, è arrangiata da Nelson Riddle ed eseguita da Nat “King” Cole); interpreti: Anne Baxter (Norah Larkin), Richard Conte (Casey Mayo), Ann Sothern (Crystal Carpenter), Jeff Donnell (Sally Ellis), Raymond Burr (Harry Prebble), Richard Erdman (il fotografo Al), George Reeves (ispettore Haynes), Ruth Storey (Rose Miller), Ray Walker (Homer), Nat “King” Cole (se stesso), Celia Lovsky (la fioraia cieca), Frank Ferguson (un ubriaco); produzione: Alex Gottlieb per Blue Gardenia Productions/ Gloria Films/ Warner Bros; durata: 90’; prima proiezione: 23 marzo 1953. 1953 | The Big Heat | Il grande caldo
Regia: Fritz Lang; sceneggiatura: Sidney Boehm, dal romanzo omonimo di William P. McGivern, prepubblicato a puntate sul «Saturday Evening Post»; fotografia: Charles B. Lang jr.; scenografia: Robert Peterson; costumi: Jean Louis; montaggio: Charles Nelson; musica: Daniele Amfitheatrof; interpreti: Glenn Ford (Dave Bannion), Gloria Grahame (Debby Marsh), Jocelyn Brando (Katie Bannion), Linda Bennett (Joyce), Alexander Scourby (Mike Lagana), Lee Marvin (Vince Stone), Jeannette Nolan (Bertha Duncan), Peter Whitney (Tierney), Willis Bouchey (tenente di polizia Wilkes), Robert Burton (Gus Burke), Adam Williams (Larry Gordon), Howard Wendell (commissario Higgins), Cris Alcaide (George Rose, guardia del corpo di Lagana), Michael Granger (Hugo), Dorothy Green (Lucy Chapman), Carolyn Jones (Doris), Ric Roman (Baldy), Dan Seymour (Atkins), Edith Evanson (Selma Parker), Norma Randall (Jill), Kathryn Eames (Marge), John Doucette (Mark Reiner, cognato di Dave), Sid Clute (barista), Joe Mell (dottor Kane), Herbert Lytton (Martin), Ezelle Poule (signora Tucker), Michael Ross (Segal), Ted Stanhope (Butler); produzione: Robert Arthur per Columbia Pictures Corporation; durata: 90’; prima proiezione: 6 ottobre 1953. 1954 | Human Desire | La bestia umana
Regia: Fritz Lang; sceneggiatura: Alfred Hayes, dal romanzo La bête humaine di Emile Zola; fotografia: Burnett Guffey; scenografia: Robert Peterson; costumi: Jean Louis; montaggio: Aaron Stell; musica: Daniele Amfitheatrof; interpreti: Glenn Ford (Jeff Warren), Gloria Grahame (Vicki Buckley), Broderick Crawford (Carl Buckley), Edgar Buchanan (Alec Simmons), Kathleen Case (Ellen Simmons), Diane DeLaire (Vera Simmons), Peggy Maley (Jean, amica di Vicki), Grandon Rhodes (John Owens), Dan Seymour (barista), John Pickard (Matt Henley), Paul Brinegar (un ferroviere), Dan Riss (il procuratore Gruber), Victor Hugo Greene (Davidson), John Zaremba (Russell), Carl Lee (John Thurston), Olan Soule (Lewis); produzione: Lewis J. Rachmil, Jerry Wald per Columbia Pictures Corporation; durata: 90’; prima proiezione: New York, 6 agosto 1954. 1955 | Moonfleet | Il covo dei contrabbandieri
Regia: Fritz Lang; sceneggiatura: Jan Lustig, Margaret Fitts, dal romanzo omonimo di John Meade Falkner; fotografia: (Eastmancolor, Cinemascope) Robert Planck; scenografia: Cedric Gibbons, Hans Peters; costumi: Walter Plunkett; montaggio: Albert Akst; musica: Miklos Rozsa; interpreti: Stewart Granger (Jeremy Fox), George Sanders (Lord Ashwood), Joan Greenwood (Lady Ashwood), Viveca Lindfors (Anne Minton), Jon Whiteley (John Mohune), Liliane Montevecchi (la danzatrice gitana), Sean McClory (Elzevir Block), Melville Cooper (Felix Ratsey), Alan Napier (Parson Glennie), John Hoyt (il giudice), Donna Corcoran (Grace), Jack Elam (Damen), Dan Seymour (Hull), Ian Wolfe (Tewkesbury), Lester Matthews (maggiore Hennishaw), Skelton Knaggs (Jacob), Richard Hale (Starkhill), John Alderson (Nat Greening), Ashley Cowan (Tomson), Frank Ferguson (il vetturino), Booth Colman (capitano Stanhope), Peggy Maley (affittacamere), Oliver Blake (Crispin), Lillian Kemble (Mary Hicks), Guy Kingsford (capitano Hawkins), John O’Malley (tenente Upjohn), Jean Del Val (capitano francese), Leo Britt (Ephraim); produzione: John Houseman per MGM/ Loew’s Incorporated; durata: 87’; prima proiezione: 12 maggio 1955. 1956 | While the City Sleeps | Quando la città dorme
Regia: Fritz Lang; sceneggiatura: Casey Robinson, dal romanzo The Bloody Spur di Charles Einstein; fotografia: (Superscope) Ernest Laszlo; scenografia: Carroll Clark; costumi: Bob Martien, Jackie Spitzer; montaggio: Gene Fowler jr.; musica: Herschel Burke Gilbert; interpreti: Dana Andrews (Edward Mobley), Robert Warwick (Amos Kyne), Vincent Price (Walter Kyne), Rhonda Fleming (Dorothy Kyne), Sally Forrest
(Nancy Liggett), Thomas Mitchell (John Day Griffith), Howard Duff (tenente di polizia Burt Kaufman), Ida Lupino (Mildred Donner), George Sanders (Mark Loving), James Craig (Harry Kritzer), John Barrymore jr. (Robert Manners), Mae Marsh (signora Manners, sua madre), Vladimir Sokoloff (George Pilsky), Sandy White (Judith Fenton), Ralph Peters (Gerald Meade), Larry Blake (sergente di polizia), Edward Hinton (O’Leary), Celia Lovsky (signorina Dodd), Pit Herbert (barista), David Andrews (pianista), Andrew Lupino; produzione: Bert E. Friedlob per RKO Teleradio Pictures; durata: 100’; prima proiezione: New York, 16 maggio 1956. 1956 | Beyond a Reasonable Doubt | L’alibi era perfetto
Regia: Fritz Lang; sceneggiatura: Douglas Morrow; fotografia: (RKO Scope) William Snyder; scenografia: Carroll Clark; montaggio: Gene Fowler jr.; musica: Herschel Burke Gilbert (la canzone Beyond a Reasonable Doubt, di H.B. Gilbert e Alfred Perry, è eseguita da “The Hi-Los”); interpreti: Dana Andrews (Tom Garrett), Joan Fontaine (Susan Spencer), Sidney Blackmer (Austin Spencer), Philip Bourneuf (Thompson), Barbara Nichols (Sally), Robin Raymond (Terry), Joyce Taylor (Joan), Shepperd Strudwick (Wilson), Arthur Franz (Bob Hale), Edward Binns (tenente di polizia Kennedy), William Leicester (Charlie Miller), Dan Seymour (Greco), Rusty Lane (il giudice), Carleton Young (Kirk), Trudy Wroe (guardarobiera), Joe Kirk (impiegato), Charles Evans (il governatore), Wendell Niles (annunciatore radiofonico), Joey Ray (Eddie); produzione: Bert E. Friedlob per RKO Teleradio Pictures; durata: 80’; prima proiezione: 13 settembre 1956. 1959 | Der Tiger von Eschnapur/ Das Indische Grabmal | La tigre di Eschnapur/ Il sepolcro indiano
Regia: Fritz Lang; sceneggiatura: Fritz Lang, Werner Jörg Lüddecke, dal romanzo di Thea von Harbou e dalla sceneggiatura originale di Fritz Lang e Thea von Harbou (1921); fotografia: (Eastman-color) Richard Angst; scenografia: Helmut Nentwig, Willy Schatz; costumi: Claudia Herberg (per Debra Paget), Günther Brosda; montaggio: Walter Wischniewsky; musica: Michel Michelet (La tigre), Gerhard Becker (Il sepolcro); coreografia: Robby Gay, Billy Daniel; interpreti: Debra Paget (Seetha), Paul Hubschmid (Harald Berger, Henri Mercier nella versione francese), Walther Reyer (Chandra), Claus Holm (Walter Rhode), Sabine Bethmann (Irene Rhode), Valery Inkijinoff (Yama), René Deltgen (principe Ramigani), Jochen Brockmann (Padhu), Jochen Blume (Asagara), Luciana Paoluzzi (Bahrani), Guido Celano (generale Dagh), Angela Portaluri (contadina), Richard Lauffen (Bhowana), Helmut Hildebrand (servo di Ramigani), Panos Papadopoulos (messaggero); produzione: Artur Brauner, Louise de Masure per CCC-Filmkunst, Berlino/ Regina Films e Critérion Films, Parigi/ Rizzoli Films, Roma; durata: 97’ (La tigre), 101’ (Il sepolcro); prima proiezione: Hannover, 22 gennaio 1959 (La tigre), Stoccarda, 5 marzo 1959 (Il sepolcro). 1960 | Die tausend Augen des Dr. Mabuse | Il diabolico dottor Mabuse
Regia: Fritz Lang; sceneggiatura: Fritz Lang, Heinz Oskar Wuttig, basata su un’idea di Jan Fethke e sul personaggio di Norbert Jacques; fotografia: Karl Loeb; scenografia: Erich Kettelhut, Johannes Ott; costumi: Ina Stein; montaggio: Traute e Walter Wischniewsky; musica: Bert Grund (la canzone Schau ich zum Himmelszelt è di Werner Müller); interpreti: Dawn Addams (Marion Ménil), Peter Van Eyck (Henry B. Travers), Wolfgang Preiss (dottor Jordan), Gert Fröbe (commissario Kraus), Linda Sini (Corinna), Werner Peters (Hieronymus P. Mistelzweig), Lupo Prezzo (= Wolfgang Preiss: Cornelius), Andrea Checchi (Berg), Reinhard Kolldehoff (Roberto, l’uomo dal piede equino), Howard Vernon (n. 12), Nico Pepe (il direttore dell’hotel), David Camerone (Parker), Jean-Jacques Delbo (cameriere), Marie Luise Nagel (la “Felicità Bionda”), Werner Buttler (n. 11), Rolf Möbius (ufficiale di polizia), Bruno W. Pantel (primo giornalista), Albert Bessler (ingegnere dell’hotel); produzione: Artur Brauner per CCC-Filmkunst, Berlino/ Critérion Films, Parigi/ Cei-Incom, Roma; durata: 103’; prima proiezione: Stoccarda, 14 settembre 1960.
Questa nota è una selezione delle testimonianze che riguardano il regista. Per altre indicazioni bibliografiche rimando a Fritz Lang in America di Peter Bogdanovich e a Fritz Lang. Films/ textes/ références di Georges Sturm. SCRITTI DI LANG E SCENEGGIATURE
Der goldene See/ Das Brillantenschiff (romanzo derivato dal film Die Spinnen), Buch-Film Verlag, Berlino,1920. Kontingentsverfahren und Qualitätsfilme, «Der Film», n. 30, 23 luglio 1922. Kitsch – Sensation – Kultur und Film, in E. Beyfuss, A. Kossowsky (a cura di), Das Kulturfilmbuch, Chryselius, Berlino, 1924. Arbeitsgemeinschaft im Film, «Der Kinematograph», Düsseldorf, n. 887, 17 febbraio 1924. Was lieben und hassen wir am amerikanischen Film?, «Deutsche Filmwoche», n. 23, 2 ottobre 1925. Wege des grossen Spielfilms in Deutschland, «Die Literarische Welt», n. 40, 1 ottobre 1926. Moderne Filmregie, «Die Filmbühne», Heft 1, aprile 1927. Fritz Lang über sich selbst, in Hermann Treuner (a cura di), Filmkünstler. Wir über uns selbst, Sibyllen Verlag, Berlino,1928.
Die mimische Kunst im Lichtspiel, «Der Film», n. 1, 1 gennaio 1929. Mein Film “M” – ein Tatsachenbericht, «Lichtbild-Bühne», Berlino, n. 114, 13 maggio 1931. Fury (sceneggiatura), di N. Krasna, B. Cormack, F. Lang, in J. Gassner, D. Nichols (a cura di), Twenty Best Film Plays, Crown Publ., New York, 1943. I Do Not Believe in Censorship, «Los Angeles Daily News», 15 agosto 1946. The Freedom of the Screen, «Theatre Arts», n. 31, dicembre 1947. Happily Ever After, «Penguin Film Review», n. 5, gennaio 1948. Hangmen Also Die! (parti della sceneggiatura), «Présence du cinéma», 1962. M (sceneggiatura), di F. Lang, T. von Harbou, in G. Gandert, U. Gregor, M, Marion von Schröder, Amburgo, 1963. La nuit viennoise. Une confession de Fritz Lang, G. Berg (a cura di), «Cahiers du Cinéma», n. 169, agosto 1965; n. 179, giugno 1966. Le tigre du Bengale (sceneggiatura), di F. Lang, W. J. Lüddecke, «L’Avant-Scène Cinéma», n. 339, aprile 1985. Metropolis (sceneggiatura), di F. Lang e T. von Harbou, Faber and Faber Ltd., Londra, 1989. Il colore dell’oro. Storie per il cinema, A. Rollo (a cura di), Editori Riuniti, Roma, 1990. INTERVISTE
A. Kossowsky, Türme und Katakomben, Gespräch mit Fritz Lang, «Film-Kurier», Berlino, n. 151, 30 giugno 1925. L. Spitzer, Fritz Lang über den Film der Zukunft, «Die Filmtechnik», n. 2, Halle, 15 luglio 1925. M. Tazelar, Fritz Lang Likes Hollywood, America and Social Themes, «New York Herald Tribune», 7 febbraio 1937. L. Mishkin, What’s Wrong with Films? Herès Fritz Lang’s Version, «New York Morning Telegraph», 8 giugno 1941. E. Creelman, Fritz Lang Discusses His Latest Film, “Woman in the Window”, «The New York Sun», 6 ottobre 1944. R. Jungk, Der Star, von dem Man spricht, «Stuttgarter Zeitung», 8 dicembre 1950. G. Bachmann, The Impact of Television on Motion Pictures, «Film Culture», n. 2, New York, dicembre 1957. L. Maibohm, “Tiger von Eschnapur”, Gespräch mit Fritz Lang in Rom, «Die Welt am Sonntag», Amburgo, 13 aprile 1958. J. Domarchi, J. Rivette, Entretien avec Fritz Lang, «Cahiers du Cinéma», n. 99, settembre 1959. P. Haudiquet, Rencontre avec Fritz Lang et Charles Boyer, «La Cinématographie Française», 29 aprile 1964. G. Berg, Fritz Lang, “Contempt”, «Take One», n. 2, Montreal, novembre-dicembre 1968. Sul lavoro di Lang nel Disprezzo di Godard. C. Higham, J. Greenberg, Fritz Lang, in The Celluloid Muse. Hollywood Directors Speak, Angus & Robertson, Londra,; Henry Regnery, New York, 1969. Un documento importante, dove il regista fa un bilancio della carriera da Furia al Diabolico dottor Mabuse. N. Wendevogel, Scharf und schnell: Fritz Lang, «Der Tagesspiegel», 1 luglio 1971. G.D. Phillips, Fritz Lang Gives His Last Interview, «The Village Voice», 16 agosto 1976. C. Beylie, B. Tavernier, Fritz Lang. Ordre et génie, «Écran», n. 51, ottobre 1976. S. Eyman, Fritz Lang Remembered, «Take One», n. 8, Montreal, 1977. SAGGI, ARTICOLI, MONOGRAFIE
H. Treuner, Fritz Lang, ein Meister des Deutschen Films, «Tägliche Rundschau», 6 novembre 1927. G. Franju, Le style de Fritz Lang, «Cinématographe», marzo 1939. L. Jacobs, Film Directors at Work: IV, Fritz Lang, «Theatre Arts», marzo 1941. H.G. Weinberg, An Index to the Creative Work of Fritz Lang, «Sight and Sound», n. 5, febbraio 1946. L.H. Eisner, Notes sur le style de Fritz Lang, «La Revue du Cinéma», n. 5, 1 febbraio 1947. S. Kracauer, From Caligari to Hitler. A Psychological History of the German Film, University Press, Princeton; Oxford University Press, Londra, 1947. Tr.it. Cinema tedesco, 1918-1933, Mondadori, Milano, 1954.
L.H. Eisner, The German Films of Fritz Lang, «Penguin Film Review», n. 6, aprile 1948. L.H. Eisner, L’écran démoniaque. Les influences de Max Reinhardt et de l’Expressionnisme, André Bonne Ed., Parigi, 1952. Tr.it. Lo schermo demoniaco, Editori Riuniti, Roma, 1983. G. Lambert, Fritz Lang’s America, «Sight and Sound», n. 1, estate 1955; n. 2, autunno 1955. J.-L. Godard, Le retour de Frank James, Fiche Ufoleis, 1955. J. Rivette, La main, «Cahiers du Cinéma», n. 76, novembre 1957. J. Agee, Agee on Film: Reviews and Comments, Beacon Press, New York, 1958. F. Truffaut, Fritz Lang en Amérique, 1958, ripreso in Les films de ma vie, Flammarion, Parigi, 1975. Tr.it. I film della mia vita, Marsilio, Venezia, 1978. «Cahiers du Cinéma», n. 99, settembre 1959: P. Demonsablon, La hautaine dialectique de Fritz Lang, M. Mourlet, Trajectoire de Fritz Lang, biofilmografia del regista. J. Douchet, L’étrange obsession, «Cahiers du Cinéma», n. 122, agosto 1961. F. Courtade, Fritz Lang, Le Terrain Vague, Parigi, 1963. A. Aprà, “ Cloak and Dagger”: esempi dello stile di Fritz Lang, «Filmcritica», 1963. C. Beylie, L’oeuvre allemande de Fritz Lang, «L’Avant-Scène Cinéma», n. 39, luglio-agosto 1964. W. Schütte, Kolportage, Stilisierung, Realismus, «Neue Zürcher Zeitung», 28 luglio-4 agosto 1964. A. Eibel, Fritz Lang, «Présence du Cinéma», Parigi, 1964. P.H. Schröder, Fritz Lang. Orientalischer Irrgarten und Grossberlin, «Filmkritik», n. 12, dicembre 1965. R. Bellour, Sur Fritz Lang, «Critique», n. 226, marzo 1966. E. Rhode, Fritz Lang (The German Period 1919-1933), in The Tower of Babel, Weidenfeld and Nicholson, Londra, 1966. C. Beylie, L’oeuvre américaine de Fritz Lang (1936-1956), «L’Avant-Scène Cinéma», n. 78, febbraio 1967. P. Bogdanovich, Fritz Lang in America, Movie Magazine Ltd. 1967. Tr.it. Il cinema secondo Fritz Lang, Pratiche Editrice, Parma, 1988. P. Jensen, The Cinema of Fritz Lang, Barnes & Co., New York; Zwemmer Ltd., Londra,1969. L. Buñuel, Textes (Metropolis), «Cahiers du Cinéma», n. 223, agosto-settembre 1971. U. Gregor, E. Patalas, Geschichte des Films, Verlagsgruppe Bertelsmann GmbH, Monaco-GüterslohBerlino, 1973. A. Appel jr., Film Noir: the Director Fritz Lang’s American Nightmare, «Film Comment», n. 6, novembre 1974. L.H. Eisner, Fritz Lang, Secker & Warburg, Londra, 1976. Tr.it. Fritz Lang, Mazzotta, Milano, 1978. F. Grafe, E. Patalas, H.H. Prinzler, Fritz Lang, Reihe Film 7, Carl Hanser Verlag, Monaco-Vienna, 1976. W. Wenders, Sein Tod ist keine Lösung, «Der Spiegel», 1976. Ripreso in Jahrbuch Film, Carl Hanser Verlag, Monaco, 1978. S. Brakhage, Fritz Lang, in Film Biographies, Turtle Island, Berkeley, 1977. R.A. Armour, Fritz Lang, G.K. Hall, Twayne Ed., Boston, 1978. F.W. Ott, The Films of Fritz Lang, The Citadel Press, Secaucus, 1979. P. Leguay, Fritz Lang ou la tentation du vide, «Positif», n. 228, marzo 1980. D. Willis, Fritz Lang: Only Melodrama, «Film Quarterly», n. 2, inverno 1979-1980. E.A. Kaplan, Fritz Lang. A Guide to References and Resources, G.K. Hall, Boston, 1981. L. Maibohm, Fritz Lang. Seine Filme – sein Leben, Wilhelm Heyne Verlag, Monaco, 1981. D. Dürrenmatt, Fritz Lang. Leben und Werk, Museum des Films, Basilea, 1982. «Cinéma 82», n. 282, giugno 1982, Actualité de Fritz Lang: testi di J. Magny, A. Charbonnier e D. Rabourdin, C. Chabrol, B. Jacquot, A. Techiné, J.-C. Biette, N. Simsolo, J.-L. Godard. L.H. Eisner, Ich hatte einst ein schönes Vaterland, Verlag das Wunderhorn, 1984. C. Schnauber, Fritz Lang in Hollywood, Europa Verlag, Vienna, 1986. G. Sturm, Fritz Lang. Films/ textes/ références, Presses Universitaires, Nancy, 1990. J. Garncarz, Fritz Lang’s “M”. A Case of Significant Film Variation, «Film History», n. 3, 1990. P. Bertetto, Fritz Lang Metropolis, Lindau, Torino, 1990. P. Hogue, Fritz Lang, Our Contemporary, «Film Comment», n. 6, novembre-dicembre 1990. «Positif», Le retour de Fritz Lang, n. 365-366, luglio-agosto 1991. Numero speciale dedicato al regista. P. Bertetto, B. Eisenschitz (a cura di), Fritz Lang: la messa in scena, Lindau, Torino, 1993.
Ringraziamenti
Ringrazio il personale della Mediateca Regionale Toscana e della Cineteca di Bologna per la disponibilità e la gentilezza dimostrate. Ringrazio Joseph T. Mills (N.J.), Sandro Bernardi, Guido Fink e Piero Matteini per gli utili consigli. Dedico questo libro a Elisabetta.
Indice
Segnare un pallonetto con Fritz Lang Fritz Lang Perché non scriviamo dei film insieme? Pittore, viaggiatore, soldato Sceneggiatore Joe May Erich Pommer Regista Der müde Tod (Il signore delle tenebre) Dr. Mabuse, der Spieler (Il dottor Mabuse) Die Nibelungen (I Nibelunghi) Metropolis (Id.) Spione (L’inafferrabile) Die Frau im Mond (La donna nella luna) M (M, il mostro di Düsseldorf) Das Testament des Dr. Mabuse (Il testamento del dottor Mabuse) Liliom (La leggenda di Liliom)
Solo, lontano Fury (Furia) You Only Live Once (Sono innocente!) You and Me (Id.) The Return of Frank James (Il vendicatore di Jess il bandito) Western Union (Fred il ribelle) Man Hunt (Duello mortale) Hangmen Also Die! (Anche i boia muoiono) The Woman in the Window (La donna del ritratto) Ministry of Fear (Prigioniero del terrore) Scarlet Street (La strada scarlatta) Cloak and Dagger (Maschere e pugnali) Secret Beyond the Door (Dietro la porta chiusa) House by the River (Bassa marea) American Guerrilla in the Philippines (I guerriglieri delle Filippine) Rancho Notorious (Id.) Clash by Night (La confessione della signora Doyle) The Blue Gardenia (Gardenia blu) The Big Heat (Il grande caldo) Human Desire (La bestia umana) Moonfleet (Il covo dei contrabbandieri) While the City Sleeps (Quando la città dorme) Beyond a Reasonable Doubt (L’alibi era perfetto) Der Tiger von Eschnapur/ Das Indische Grabmal (La tigre di Eschnapur/Il sepolcro indiano) Die tausend Augen des Dr. Mabuse (Il diabolico dottor Mabuse)
Nulla di nuovo sotto il sole Filmografia
Nota bibliografica
Fritz Lang (Vienna, 1890 - Beverly Hills, 1976). Uno dei maestri, regista tra due mondi. Di lui Truffaut ha detto: «Una sola parola per qualificarlo: inesorabile». Tra i suoi film: Il dottor Mabuse (1922), I Nibelunghi (1924), Metropolis (1927), M, il mostro di Düsseldorf (1931), Furia (1936), Duello mortale (1941), Il grande caldo (1953).

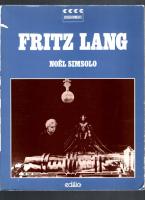




![Schattenbilder - Lichtgestalten: Das Kino von Fritz Lang und F.W. Murnau. Filmstudien [1. Aufl.]
9783839411032](https://ebin.pub/img/200x200/schattenbilder-lichtgestalten-das-kino-von-fritz-lang-und-fw-murnau-filmstudien-1-aufl-9783839411032.jpg)


