Fritz Lang 8829714399, 9788829714391
Autore di capolavori come Il dottor Mabuse, Metropolis, M, Lang persegue un’idea rigorosa di regia, definita «inesorabil
158 101 4MB
Italian Pages 240 [245] Year 2022
La regia di Fritz Lang. Forma e fascinazione di Paolo Bertetto
La fascinazione dello sguardo
America
Kitsch Sensation
La creazione della forma
Stilwille
La forma eidetico-intensiva
La configurazione differenziata
Il dottor Mabuse di Anita Trivelli
Gioco, ambienti e scenografie (del crimine)
I personaggi
Risorse formali e limiti del rispecchiamento langhiano
Metropolis di Paolo Bertetto
Kunstwollen e cinema totale
La figurazione di Lang. Geometria e eidos
La reinvenzione dell’immagine
La seduzione dello sguardo
La messa in scena e lo spazio simbolico
L’immaginario e il segreto
M di Paolo Bertetto
Le configurazioni del visibile
L’eidetico e il vuoto
L’identificazione e il soggetto parafrenico
Altri film a Berlino di Anita Trivelli, Arianna Vergari
Destino (Der müde tod, 1921)
I Nibelunghi (Die Nibelungen, 1924)
La morte di Sigfrido (Siegfried)
La vendetta di Crimilde (Kriemhilds Rache)
L’inafferrabile (Spione, 1928)
Il testamento del dottor Mabuse (Das testament des dr. Mabuse, 1933)
Duello mortale di Jacques Aumont
Dietro la porta chiusa di Silvio Alovisio
La barca e i narcisi
Oltre la porta chiusa
L’alibi era perfetto di Raymond Bellour
Il periodo americano di Matteo Pollone
Note al testo
Filmografia
Bibliografia essenziale a cura di Arianna Vergari
Recommend Papers

- Author / Uploaded
- Paolo Bertetto (editor)
File loading please wait...
Citation preview
Autore di capolavori come Il dottor Mabuse, Metropolis, M, Lang persegue un’idea rigorosa di regia, definita «inesorabile» da Truffaut, in cui l’autore programma e dirige ogni fase del lavoro compositivo. I suoi film costruiscono con straordinaria abilità le immagini come forme dinamiche, strutture geometriche in movimento. Il suo senso della visione e la capacità di costruzione plastico-architettonica contribuiscono a definire la nuova estetica del film. L’itinerario cinematografico di Lang è diviso in due parti, perché l’avvento del nazismo lo spinge prima a Parigi e poi a Hollywood: a Berlino preferisce storie e personaggi carichi di valenze simboliche e di aspetti metaforici ed esemplari; a Hollywood si misura con la macchina produttiva americana e con i generi, delineando un mondo dominato dal crimine e dall’inganno. PAOLO BERTETTO,
professore di cinema all’Università La Sapienza di Roma, ha insegnato anche nelle Università di Torino, Paris 8, Nice, Madrid Complutense, Leipzig e al Centro Sperimentale di Cinematografia. È stato direttore del Museo Nazionale del Cinema. Ha pubblicato una dozzina di monografie e curato una ventina di volumi collettanei, tra cui, per Marsilio, Microfilosofia del cinema, David Lynch e L’interpretazione dei film. È anche autore di tre romanzi, Cuore scuro, Autunno a Berlino e Odio senza fine.
Fritz Lang a cura di Paolo Bertetto Marsilio
in copertina fotogramma tratto da Metropolis (1927) di Fritz Lang Collaborazione redazionale: Arianna Vergari e Matteo Pollone © 2022 by Marsilio Editori® s.p.a. in Venezia Prima edizione digitale 2022 ISBN 978-88-297-1834-4 www.marsilioeditori.it [email protected] Quest’opera è protetta dalla Legge sul diritto d’autore. È vietata ogni duplicazione, anche parziale, non autorizzata.
Indice La regia di Fritz Lang. Forma e fascinazione di Paolo Bertetto La fascinazione dello sguardo America Kitsch Sensation La creazione della forma Stilwille La forma eidetico-intensiva La configurazione differenziata
Il dottor Mabuse di Anita Trivelli
Gioco, ambienti e scenografie (del crimine) I personaggi Risorse formali e limiti del rispecchiamento langhiano
Metropolis di Paolo Bertetto
Kunstwollen e cinema totale La figurazione di Lang. Geometria e eidos La reinvenzione dell’immagine La seduzione dello sguardo La messa in scena e lo spazio simbolico L’immaginario e il segreto
M di Paolo Bertetto
Le configurazioni del visibile L’eidetico e il vuoto L’identificazione e il soggetto parafrenico
Altri film a Berlino di Anita Trivelli, Arianna Vergari
Destino (Der müde tod, 1921) I Nibelunghi (Die Nibelungen, 1924) La morte di Sigfrido (Siegfried) La vendetta di Crimilde (Kriemhilds Rache) L’inafferrabile (Spione, 1928) Il testamento del dottor Mabuse (Das testament des dr. Mabuse, 1933)
Duello mortale di Jacques Aumont Dietro la porta chiusa di Silvio Alovisio La barca e i narcisi Oltre la porta chiusa
L’alibi era perfetto di Raymond Bellour Il periodo americano di Matteo Pollone Note al testo Filmografia Bibliografia essenziale a cura di Arianna Vergari
La regia di Fritz Lang. Forma e fascinazione di Paolo Bertetto LA FASCINAZIONE DELLO SGUARDO
L’ampiezza dell’immaginario, delle problematiche e degli stili dei film di Lang suggeriscono di approfondire in una semplice introduzione solo gli aspetti fondamentali dei modi della messa in scena e dell’arte del regista austriaco1. Si tratta cioè di cogliere le strutture fondamentali delle forme simboliche langhiane, cioè le configurazioni formali ricorrenti che definiscono la concezione estetica e l’idea di stile di Lang. Lang ha la persuasione che le forme visivo-dinamiche proprie del cinema hanno una triplice forza. Innanzitutto producono percorsi di sensazioni, itinerari emozionali che coinvolgono lo spettatore. In secondo luogo realizzano le immagini come forme e come successione di forme coordinate. Insieme hanno un potere di produzione simbolica, diventano vettori capaci di creare nuovi sensi. È una prospettiva in cui due linee estetiche fondamentali si intersecano: da un lato una creazione di effetti capaci di provocare forti sensazioni nel pubblico sino a una intenzionale cattura fascinativa; dall’altro l’attuarsi di una Stilwille, una volontà di stile rigorosa, che risente ovviamente del concetto di Kunstwollen della cultura austro-tedesca. Nei più importanti film di Lang, le dinamiche dello sguardo e la produzione del visibile acquistano una rilevanza particolare e si presentano come autentiche riflessioni sulla macchina cinema e sul suo potere di comunicazione. Nel primo Dottor Mabuse (Dr. Mabuse, der Spieler, 1922) la sequenza della partita a carte al Club Andalus di Berlino tra il procuratore von Wenck, che gli dà la caccia, e Mabuse, travestito in una foggia stravagante e inconsueta, propone alcuni segmenti dotati di una carica simbolica indubbia.
Quando von Wenck arriva al club, le prime inquadrature sono già indicative dello stile langhiano. Il procuratore giunge con la carrozza all’entrata e si ferma sotto un arco con due lampioni ai lati. Poi nella prima inquadratura nel club particolarmente animato, von Wenck fende la folla di clienti, mentre ai due lati del piano due donne di profilo sono vicine alla macchina da presa. Si tratta di due piani che realizzano un principio formale molto preciso, cioè una forma visiva simmetrica, che è uno dei modi più rilevanti della composizione filmica langhiana. Subito dopo, l’entrata nelle sale riservate del club presenta altri aspetti. Il procuratore è nell’anticamera, poi la seconda inquadratura, con uno scavalcamento di campo, mostra una nuova sala affollata con Wenck sulla porta e una serie di piani dell’uomo nella sala, inquadrato da vari punti di vista. Lang dimostra una indubbia libertà nella gestione dello spazio, mentre in genere l’organizzazione delle sue inquadrature è effettuata con grande rigore, soprattutto ne I Nibelunghi (Die Nibelungen, 1924) e in Metropolis (1927). Poi von Wenck siede a un grande tavolo affollato per giocare a carte contro l’uomo che gestisce il banco. È un personaggio maturo, con un naso accentuato, dei capelli bianco-grigi un po’ disordinati e un’aria mefistofelica: si tratta ovviamente di Mabuse con una nuova maschera, che qui appare come un giocatore professionista. Lo scontro tra Mabuse e von Wenck è mostrato secondo un altro modello compositivo, tipico del cinema muto e del cinema classico, che nell’accezione langhiana a volte non è disgiunto dalla profondità di campo, variamente usata dal cinema muto prima del cinema moderno – con buona pace di Bazin. Il campo e controcampo mostra Mabuse e von Wenck l’uno contro l’altro schierati in un palese duello che potrebbe anche essere mortale. Il campo e controcampo quindi non registra soltanto un rapporto, ma configura il fronteggiarsi dei due nemici, sottolineando lo scontro in atto, che diventa una figura di montaggio, carica di una valenza simbolica ulteriore. Le inquadrature di Mabuse e di von Wenck sono talvolta interrotte da piani di marchi o di carte, ma tutti gli elementi sono impiegati per drammatizzare la scena e
creare uno spazio di conflitto non solo tra personaggi, ma tra principi simbolici e morali. Lo scontro tra i due protagonisti si sposta rapidamente su un piano ipnotico, affidato dapprima agli occhiali magici cinesi, che Mabuse manipola e indirizza verso l’avversario, e poi alla scritta «Tsi Nan Fu» sulle carte e sul tavolo da gioco, nonché al comando ripetuto più volte in modo sempre più pressante da Mabuse. Lang usa qui la ripetizione della didascalia, che cresce gradualmente di dimensioni: una configurazione visiva che sembra anticipare le didascalie sonore di Ėjzenštejn nella Corazzata Potëmkin (Броненóсец «Потёмкин», 1925). Poi l’effetto ipnotico è affidato all’inquadratura del volto di Mabuse astratto dal contesto dell’agire, isolato sullo schermo nero e potenziato nella sua forza fascinativa perturbante: il piano si ingrandisce grazie a un movimento in avanti, che pare quasi un carrello mentale. Ma più ancora del volto sono gli occhi di Mabuse a svolgere una funzione ipnotica particolarmente forte (fig. 1). Le inquadrature degli occhi, isolati dal contesto e dallo stesso volto e mostrati sullo sfondo dello schermo nero, hanno un potere inquietante e sono proposti in tre modi diversi: a. piano degli occhi astratti dal contesto e dal viso; b. piano degli occhi resi più grandi con un movimento di macchina in avanti; c. piano degli occhi leggermente più ampio che comprende anche le folte sopracciglia e una parte del naso2. Queste inquadrature hanno una funzione diegetica, ma anche una extradiegetica e metacinematografica. L’effetto ipnotico-fascinativo che Mabuse cerca di realizzare con il procuratore è una metafora della fascinazione dello spettatore effettuata dal cinema. Come Mabuse affascina von Wenck, cerca di impadronirsi della sua mente e la sottopone a una cattura psichica (che nel film non riesce pienamente), così la macchina del cinema assorbe lo spettatore nel proprio movimento seduttivo, lo coinvolge e lo trascina, in una fascinazione che ha aspetti simili a quelli dell’ipnosi.
D’altronde, anche al di là degli effetti particolari legati al film di Mabuse, lo sguardo in macchina con la funzione di colpire psicologicamente lo spettatore e di affascinarlo è usato metodicamente da Lang in primi piani con il personaggio che guarda verso altri personaggi e insieme verso lo spettatore, con risultati seduttivi notevoli. La volontà di potenza, Wille zur Macht, concetto essenziale dell’ultimo Nietzsche3, costituisce infatti l’aspetto fondamentale dell’identità di Mabuse, personaggio nietzschiano nel tempo del caos e dell’affermarsi epocale della crisi dei valori e della morte di Dio, e viene esplicitamente enunciata attraverso una didascalia che afferma «Solo la volontà di potenza conta». Nella prima parte de Il dottor Mabuse lo sguardo ipnotico di Mabuse rivolto alla vittima prescelta invade con una forza particolare lo schermo non solo nella sequenza con von Wenck. Si tratta naturalmente di uno sguardo diegetico verso la macchina, ma la sua intenzionalità distruttiva e possessiva è così sottolineata che lo sguardo pare quasi affermarsi in forme extradiegetiche. Mabuse esercita il proprio potere attraverso la cattura della mente dell’avversario e spesso ottiene risultati significativi ipnotizzando al tavolo da gioco le vittime, dapprima Hull, poi il conte Told. Le ultime due inquadrature della sequenza della borsa, poi, mostrano in sovraimpressione sul salone vuoto due immagini di Mabuse che guarda verso lo spettatore. Lo sguardo in questo caso non ha più una funzione diegetica, ma è l’oggettivazione di una forza o forse l’esibizione di una volontà di potenza che dal personaggio – apertamente nietzschiano – si estende al cinema e diventa la visualizzazione della sua stessa logica di funzionamento. Lo sguardo in questo caso non ha più una motivazione diegetica, ma riflette un’intenzionalità ulteriore e stabilisce un rapporto diretto tra lo schermo e il pubblico: è insieme l’esibizione di una forza soggettiva e oggettiva, o forse la dichiarazione di una volontà di potenza che dal contesto narrativo si estende al cinema e
diventa la visualizzazione della sua stessa logica di funzionamento. Lo sguardo ipnotico di Mabuse realizza infatti quella sovrapposizione tra la cattura psichica dell’altro nell’orizzonte del narrato e l’esercizio e il mostrare il potere fascinativo del cinema, che ritroveremo in Metropolis nello sguardo di Maria. E lo realizza con una componente di evidenza e di esplicitazione particolari, rispetto a cui l’operazione di Metropolis appare forse più ambigua e più sottile, e quindi più complessa, ma nel medesimo tempo, meno forte e meno chiara. Lo sguardo in macchina duro e freddo di Mabuse, in ogni modo, rivive nello sguardo in macchina di un altro personaggio negativo, la falsa Maria, dominata dalla crudeltà e dalla demoniaca volontà distruttiva. È uno sguardo che non solo connota il carattere del personaggio, ma contribuisce a creare inquietudine, tensione, paura e definisce quindi la tonalità del film, o almeno delle sequenze in cui è attivo. Lang sottolinea l’anomalia dello sguardo dell’EssereMacchina Maria alterando l’occhio sinistro dell’attrice con un pesante trucco nero, che rende il volto di Brigitte Helm una maschera inquietante e perversa. L’accostamento di un occhio truccato pesantemente e di un occhio meno truccato è anche, d’altra parte, una sorta di oggettivazione simbolica della duplicità della figura fisica di Maria. Non a caso viene ripresa da Henrik Galeen ne La mandragora (Alraune, 1928), in cui Brigitte Helm interpreta ancora la parte di un personaggio doppio e demoniaco, nato da una prostituta inseminata artificialmente con lo sperma di un impiccato: nella sequenza della festa, in PPP Brigitte Helm si guarda gli occhi con uno specchietto rotondo e ne rivela la dissonanza simbolica. Nessun altro sguardo in Metropolis ha l’intensità e il demoniaco dello sguardo della falsa Maria. E la forza del suo sguardo ha una funzione diegetica immediata e precisa e produce conseguenze drammatiche ogni volta che si esercita: anche se investe lo spettatore ha tuttavia una forza orientata essenzialmente all’interno del film. Il
primo sguardo diegetico verso la macchina di tipo demoniaco della falsa Maria è infatti – in un perfetto parallelismo con il primo sguardo verso la macchina di Maria – rivolto a Freder, che l’ha sorpresa con il proprio padre, Joh Fredersen. Lo sguardo in macchina della falsa Maria sconvolge Freder come l’immagine di una scena inconscia, turbandolo profondamente e provocandogli allucinazioni visive, in cui, tra l’altro, ricompaiono la falsa Maria, Joh Fredersen e Rotwang con lo sguardo ancora rivolto verso la macchina. Nel secondo I Nibelunghi: la vendetta di Crimilde (Die Nibelungen: Kriemhilds Rache), e poi in Metropolis, lo sguardo in macchina delle protagoniste, Crimilde e Maria, interpretate dalle algide Margarete Schön e Brigitte Helm, è palesemente diretto allo spettatore e sottolinea l’intenzionalità della procedura compositiva del regista. D’altra parte, se lo sguardo verso la macchina di Mabuse esplicita la funzione ipnotica del cinema e la sua potenza di fascinante perverso, anche l’impiego dello sguardo diegetico in direzione della macchina negli altri film più significativi di Lang si rivela estremamente preciso e programmato con rigore. In primo luogo il ricorso allo sguardo diegetico verso la macchina risulta in Lang più frequente rispetto allo standard degli altri autori tedeschi contemporanei più importanti, Murnau, Pabst, Wiene. In secondo luogo è connesso a funzioni emozionali e semantiche generalmente omogenee all’interno di ogni singolo film. Il cinema di Lang, com’è noto, è un cinema rivolto non a ristrette fasce di spettatori – come poteva accadere ad esempio al cinema espressionista più radicale e all’area del Caligarismus in particolare – e si avvale di strumenti spettacolari capaci di attrarre e catturare un pubblico indifferenziato. La sua concezione del cinema come grande arte popolare della modernità lo porta nello stesso tempo a scegliere, con l’ausilio di Thea von Harbou, soggetti d’avventura melodrammatici, da feuilleton, e a ricorrere alle procedure filmiche più congeniali all’intensificazione del rapporto con lo
spettatore. Il suo cinema presenta il paradosso solo apparente di essere costruito con il massimo della razionalità e della programmazione per ottenere effetti essenzialmente fascinativi ed emozionali, per catturare il fruitore in una solida spirale di pathos. Il primo piano con la sua struttura di immagineaffezione4 gioca evidentemente una funzione fondamentale nell’economia patetica del film, e lo sguardo diegetico verso la macchina costituisce certamente una intensificazione ulteriore dell’affettività del primo piano. Ma, proprio per il suo radicamento nella narrazione, il cinema tedesco di Lang tende, nei casi più palesi e significativi, ad assumere una sorta di doppio regime e di doppia funzione, per cui, mentre potenzia la drammatizzazione di una sequenza, al tempo stesso evidenzia per forza di cose il carattere altamente seduttivo della macchina-cinema. Che lo sguardo verso la macchina debba essere considerato come un rilevante elemento di qualificazione del cinema di Lang e come una marca stilistica attentamente progettata e accuratamente realizzata, è confermato anche in Destino (Der müde Tod, 1921) e ne I Nibelunghi. In Destino, infatti, lo sguardo diegetico verso la macchina non solo è inestricabilmente connesso all’idea di morte, ma è realizzato quasi unicamente dalla Morte nell’esercizio delle sue funzioni tragiche. Il primo sguardo verso la macchina del grande cinema di Lang è uno sguardo (in PM) della Morte che ferma la carrozza su cui viaggiano gli innamorati. E gli sguardi verso la macchina successivi sono ancora sguardi della Morte che direttamente si rivolge al suo interlocutore e, scavalcando ogni mediazione dello schermo, sembra indirizzarsi altrettanto direttamente a ogni spettatore, stabilendo una comunicazione severa e inquietante. Con indubbio rigore Lang introduce gli sguardi verso la macchina soprattutto nel prologo e nell’epilogo e solo due volte nelle storie ambientate in epoche diverse e in regioni lontane, e consente uno sguardo verso la macchina solo alla Donna e al Vecchio, quando devono affrontare in qualche modo l’idea stessa della morte: come nel PP in cui – nel prologo – la Donna si accende di
speranza dopo aver letto su un libro che «l’amore è forte come la morte»; o alla fine dello splendido episodio veneziano – vera prima affermazione dell’arte langhiana –, quando Monna Fiammetta, sconvolta, si accorge di avere ucciso in duello il proprio amato; o – nell’epilogo – rispettivamente quando il Vecchio respinge la proposta di morire, o quando la Donna pensa per un attimo di offrire alla Morte il neonato imprigionato nell’edificio in fiamme in cambio del proprio innamorato. Negli altri casi è sempre la Morte a esercitare il privilegio dello sguardo verso la macchina. E sin dall’inizio, quando sulla carrozza c’è uno scambio di sguardi tra la Morte e gli innamorati, lo sguardo della Morte è in direzione della macchina da presa, mentre quello degli innamorati è obliquo. Come alla fine della prima storia, lo sguardo verso la macchina diventa possibile quando al becchino che ha sepolto l’innamorato si sostituisce in sovraimpressione l’immagine della Morte stessa. E poi ripetutamente in inquadrature con i notabili della città, o davanti al muro infinito che la Morte ha costruito, o al tavolo con gli innamorati, o nella dimora misteriosa nell’Aldilà in cui sono accesi i ceri che rappresentano simbolicamente la vita degli uomini5, nel momento della conclusione tragica delle singole storie la Morte fissa lo sguardo sulla macchina da presa e sullo spettatore, a volte con un movimento degli occhi che paiono quasi scegliere, dopo una micropanoramica, una nuova vittima. Così lo sguardo che si esercita nel cinema è direttamente connesso con la morte, diventa in qualche modo lo sguardo della morte stessa, sottolineando la dimensione inquietante e perversa della fascinazione cinematografica. E nello sguardo della Morte che si confonde con lo sguardo della camera pare quasi di vedere una sorta di figurazione simbolica di quella definizione, così suggestiva e così fortunata, del cinema come «morte al lavoro» che Cocteau avrebbe inventato diversi anni dopo. Nel film dunque l’apparizione della Morte è l’affermazione del destino come una configurazione visiva inquietante e rigorosa, che in ogni momento può
minacciare la vita dei soggetti. E l’ossessione del destino, imperscrutabile e minaccioso, attraversa poi tutto il cinema di Lang, influenzato certo da un testo importante e popolare in Germania come Il tramonto dell’Occidente (Der Untergang des Abendlandes, 1918)6, che, come dice Spengler stesso, è un libro sul destino. Nel film del 1921, dunque, lo sviluppo drammatico dell’azione approfondisce il rapporto con lo spettatore nell’orizzonte dell’inquietudine e della paura. Nell’episodio veneziano, che annuncia la nascita di un grande regista, tutto contribuisce ad affascinare e a gelare lo spettatore. Il rigore dei décors a volte simmetrici, come nei film più famosi, si intreccia con le dinamiche dell’odio e dell’inganno e la speranza di liberazione è frustrata e rovesciata dal destino e dalla astuta crudeltà del nemico. Lang realizza una scrittura dell’imaginario rigorosa e permeata dalla passione e dalla crudeltà, usando insieme lo stile e le dinamiche narrative per suscitare una fascinazione perversa e lacerante, che si conclude con l’uccisione dell’amato da parte della donna e con la disperazione dell’innamorata. Qui la drammaticità dell’evento, basato su un inganno, si fonde con una messa in scena fatta di quadri rigorosi in cui il pittorico e l’architettonico si integrano con grande efficacia. Lo stile e l’immaginario perfettamente fusi creano una forma simbolica dall’alto valore estetico, in una prospettiva che verrà sviluppata ulteriormente nei film più importanti. Anche nelle due parti dei Nibelunghi il ricorso allo sguardo diegetico verso la macchina è tendenzialmente connesso all’idea di morte. Nella prima parte de La morte di Sigfrido (Siegfried), più lineare e priva di tensioni tragiche (sin quasi alla fine), gli sguardi verso la macchina sono pochi e poco significativi (un campo e controcampo tra Sigfrido e Gunther, uno sguardo di Sigfrido mentre parla con Crimilde e uno più sottolineato di Brunilde nel duello). Ma dal momento in cui si scatena il conflitto tra Brunilde e Sigfrido, e la morte diventa l’orizzonte dell’azione, gli sguardi verso la macchina si moltiplicano e assumono un’altra intensità: Gunther guarda verso la macchina da presa quando, cedendo alle
pressioni di Brunilde, dà l’ordine di uccidere Sigfrido; Hagen guarda verso la macchina quando, ingannando Crimilde, riesce a sapere dov’è vulnerabile Sigfrido; Sigfrido guarda verso la macchina da presa mentre muore e Crimilde infine rivolge attraverso la macchina da presa uno sguardo duro e accusatore a Hagen davanti al cadavere di Sigfrido. La vendetta di Crimilde, poi, è un grande poema sullo sguardo gelido e imperturbabile, implacabile e assoluto di Crimilde (interpretata da Margarete Schön). Crimilde esige la vendetta, vuole uccidere Hagen che ha assassinato Sigfrido e il figlio che la donna ha avuto da Etzel. Per tutto il film appare come una figura ieratica, una statua che è l’immagine stessa del Fato, dell’irrevocabile. I suoi sguardi ripetutamente indirizzati verso la macchina da presa costituiscono il leitmotiv centrale del film, il segno della persistenza di una volontà indomita e di una totale penetrazione nell’universo della morte. L’occhio di Crimilde, vitreo, lontano, assente, eppure assolutamente iperdeterminato, è il massimo punto di intensità di un film che pure costruisce altre tensioni rilevanti. E prevalentemente connessi alla morte sono anche gli sguardi verso la macchina di altri personaggi: di Etzel quando minaccia i Burgundi con il figlio morto in braccio, o quando afferma la volontà di proseguire nella vendetta sino alla fine; di Volker mentre canta il Lied della morte, e ancora di Hagen, impegnato con Crimilde in un confronto di sguardi attraverso la macchina, prima di essere colpito. Ma su tutti domina la forza pura dello sguardo di Margarete Schön, che sembra quasi rappresentare una sorta di manifestazione simbolica del pathos freddo e implacabile del film: una sacralizzazione gelida e rituale, formale e intensiva, assoluta del vedere, che è forse l’essenza del cinema di Lang. America La creazione della fascinazione acquista strutture e aspetti diversi nel periodo americano, segnato da norme produttive più vincolanti. Nei film noir, che restano le prove più riuscite, Lang inscrive nello stile
hollywoodiano alcune peculiarità della sua messa in scena. Da un lato fluidifica ogni elemento inscrivendolo dentro la costruzione serrata della narrazione, dall’altro attua un percorso audiovisivo-dinamico caratterizzato dalla volontà di legare e catturare sempre più lo spettatore. Lang cioè inventa una forza attrattiva nuova che non è più opposta alla narrazione, ma è modificata per la narrazione, oltre che in funzione del rapporto spettatoriale. L’effetto fascinativo più profondo è forse ottenuto ne La donna del ritratto (Woman in the Window, 1944), in cui le dinamiche dello sguardo e la costruzione di percorsi di identificazione e di tensione negativa si fondono in modo rigoroso, più efficacemente di quanto appaia in Furia (Fury, 1936), in Sono innocente! (You Only Live Once, 1937) o ne La strada scarlatta (Scarlet Street, 1945). Insieme La donna del ritratto è nuovamente e in maniera sofisticata un’opera sull’immagine filmica. Non solo è una riflessione sugli sguardi, ma è una esibizione del carattere fittizio e assolutamente particolare dell’immagine cinematografica, lontana dalle semplificazioni realistiche e radicata nell’illusione e nell’inganno. O, per dirla più esattamente, nel simulacro. Così nel film Lang riprende in altra forma l’indagine sull’essere del cinema che aveva iniziato ne Il dottor Mabuse. Là era la macchina del cinema e la sua potenza fascinativa. Qui è il carattere complesso dell’immagine, artificiale e creata, non mimetica. La donna del ritratto è un film che senza intaccare la struttura narrativa, rivela in passaggi dalla forte valenza eidetica il meccanismo del cinema e il carattere simulacrale dell’immagine. Nel film Lang ci presenta il protagonista che guarda in una vetrina il ritratto di una donna e poi trova la stessa donna viva accanto a sé. Lang articola la visualizzazione del rapporto complesso tra le diverse configurazioni della donna del ritratto, elaborando immagini a valenza multipla che giocano sul raddoppiamento della figura femminile e sulle potenzialità di rifrazione della vetrina. Nel film la moltiplicazione dell’immagine della donna in tre figure diverse, il corpo concreto, il ritratto e la rifrazione nella
vetrina, crea un effetto di ambiguità radicale e di sovrapposizione di percezione e allucinazione, di reale e di immaginario. Le inquadrature successive sono costituite prevalentemente da campi e controcampi dell’uomo e della donna (Alice), realizzati in modi diversi, tranne l’inquadratura 9, che mostra insieme Alice, il ritratto e Wanley di profilo, e l’inquadratura conclusiva (n. 21), che riprende Wanley e Alice che parlano ancora e poi si allontanano. Nella visualizzazione e nei dinamismi di luce e di colore (i neri e le variazioni di grigio), non si gioca solo una partita legata all’estetica, si gioca anche una questione che investe la complessità e lo statuto dell’immaginario filmico. Il protagonista, il professor Wanley, sta guardando il ritratto di una donna in una vetrina. L’immagine del ritratto è anche riflessa nel vetro. A un certo punto, con grande stupore di Wanley, compare riflessa sulla superficie trasparente del vetro, oltre all’immagine del ritratto, anche l’immagine di una donna che è la stessa donna del dipinto. La rifrazione del vetro mostra la donna che sta guardando il proprio ritratto e il ritratto stesso in un doppio raddoppiamento dell’immagine. Wanley, attraverso l’immagine riflessa nel vetro, scopre con stupore la donna in carne e ossa vicino a sé. Quello che si realizza, attraverso le immagini moltiplicate della donna, è un duplice riconoscimento in cui il sé e l’altro sono variamente implicati. Da un lato l’uomo vede nell’immagine riflessa della donna un inveramento dell’immagine della donna vista nel ritratto. L’uomo vede il ritratto e l’immagine riflessa nella vetrina e l’immagine della donna viva sempre riflessa nella vetrina. L’immagine rifratta nel vetro è dunque la donna viva e la donna del ritratto. Cioè è una duplice duplicazione, un doppio raddoppiamento. L’immagine duplicata riflessa nella vetrina è alternativamente, cioè in inquadrature successive, l’immagine del ritratto e l’immagine della donna vera. È insomma un effetto di duplicazione che rifigura e visualizza la donna del ritratto nel vetro e la
donna (viva) ancora nel vetro7. Il vetro si pone come spazio impalpabile, in cui ombre fantasmatiche appaiono in rapporto con il soggetto, il suo ritratto e le loro rispettive duplicazioni. L’immagine riflessa diventa segno, traccia della riflessività del vedere in una duplice accezione: come visione attraverso il riflesso e come oggettivazione del vedere stesso. Questo lavoro doppio e complesso di duplicazione visibile/invisibile, di riflessività del vedere e di immagine raddoppiata produce uno spazio in cui la rappresentazione diventa visualizzazione e si lega all’immaginario e al fantasmatico. Lang è impegnato qui a visualizzare il fantasma, cioè a evocare e a mostrare qualcosa che si pone come sintesi di percezione e allucinazione, che si palesa all’inizio come percezione impregnata di fantasmaticità e alla fine del film si rivela come fantasma onirico mascherato da percezione. Ma nella visualizzazione dei doppi della donna e del ritratto nella vetrina si opera anche un altro meccanismo, che riguarda l’orizzonte dell’immaginario. La donna infatti nella scena degli sguardi alla vetrina scopre se stessa in un duplice movimento di identificazione con il sé doppiato del ritratto e con la percezione dello sguardo ammirato dell’uomo, cioè dell’altro. Attraverso lo sguardo dell’altro la donna riscopre la propria identità di bellezza e di attrazione. Quello che le dinamiche degli sguardi e delle immagini illusive sulla vetrina producono è la visualizzazione palese dell’immaginario e del suo meccanismo costitutivo (si pensi all’analisi di Lacan sulla formazione dell’immaginario)8. Non a caso tutto l’episodio della donna del ritratto si rivela alla fine del film come un sogno, come una produzione, una visualizzazione di fantasmi onirici. E la rifrazione del ritratto integrato dall’immagine della donna concreta riflessa nel vetro costituisce non solo un incontro di grande suggestione tra figura dipinta e figura vivente, ma assume una valenza più complessa di immagine eidetica, attraversata da più determinazioni simboliche, da più idee.
Nel periodo americano un secondo modello è invece costituito dalla elaborazione di percorsi narrativi complessi e labirintici in cui alla fine tutti i pezzi si collocano al proprio posto e le dinamiche rivelano la precisione del meccanismo. Ne L’alibi era perfetto (Beyond a Reasonable Doubt, 1956) in particolare l’itinerario labirintico è giocato sulla dinamica sapere/non sapere del pubblico e costituisce anche una implicita teoria dello spettatore. Tra gli appunti per il film Lang ha elaborato anche un piccolo foglietto che indica «Quello che il pubblico sa» e «Quello che è accaduto e il pubblico non sa»9. È una traccia che non attesta solo il carattere “inesorabile” della regia di Lang, come scriveva Truffaut, ma le differenti modalità di costruzione dell’intensità e della fascinazione. Il film infatti articola un mosaico di sapere/non-sapere che è insieme un’esibizione di come funziona l’intrigo del racconto e un’analisi dell’illusione di sapere il vero nell’esistenza. Infine un film come Il grande caldo (The Big Heat, 1953) – ma anche La bestia umana (Human Desire, 1954), ad esempio, – elabora una scrittura dell’arbitrio e della violenza che ha nella bruciatura del volto della donna (interpretata da una splendida Gloria Graham) il momento di massima crudeltà (fig. 3). Il getto del caffè bollente sul volto della donna, infatti, non oggettiva soltanto il sadismo di Lang, ma mostra la crudeltà, la violenza insensata e improvvisa come uno degli elementi della forza del cinema, che nell’oltrepassare il limite, nel mostrare l’irrappresentabile trova una intensità fondamentale e perversa. E la crudeltà qui implica tensione-aggressione allo spettatore e alle sue simpatie affettive verso alcuni personaggi. Implica una tensione interna che Lang dissemina nel testo per tenere stretto il pubblico. Questa volontà di affascinare e non di intrattenere il pubblico è d’altronde sottolineata da Lang in scritti e interviste che legano il periodo tedesco a quello americano e che vale la pena di ripercorrere. Kitsch Sensation
La fascinazione e l’intensità appaiono dunque come i vettori di punta della messa in scena di Lang, che è pensata proprio per creare sensazioni, emozioni. E questa finalità programmatica è attestata consapevolmente già in un articolo pubblicato nel 1924, dedicato a Il dottor Mabuse e I Nibelunghi. Si tratta di un testo dal titolo significativo, Kitsch Sensation Kultur und Film, in cui Lang definisce alcuni caratteri peculiari del suo cinema10. Lang contesta l’opposizione tra grande cinema e cinema per le masse, sottolineando come la sensazione sia un elemento essenziale nel cinema e non solo nei film popolari. «Assecondare la fame di sensazione delle masse» non è un’opzione corriva e kitsch, ma riflette un aspetto essenziale del cinema e del suo rapporto con il pubblico. Inoltre il cinema popolare riprende le strutture narrative delle fiabe, delle tradizioni e quindi affonda nell’immaginario collettivo. Produrre un effetto di sensazione forte è quindi una componente strutturale del cinema, non un cedimento al kitsch. La centralità della sensazione nell’arte e non solo nel cinema è d’altronde una tendenza significativa dell’estetica contemporanea e non è un caso che due pensatori come Deleuze e Guattari considerino la sensazione come un elemento costitutivo dell’opera d’arte e dell’estetica11. Lang definisce il cinema di sensazione come «film d’effetto», ma sottolinea anche come altri film non di effetto abbiano raggiunto livelli artistici e successo di pubblico (ad esempio Il gabinetto del dottor Caligari, Das Cabinet des Dr. Caligari, 1920, di Robert Wiene, o Il Golem, Der Golem, 1920, di Paul Wegener e Carl Boese). Ma per Lang, Il dottor Mabuse costituisce un modello di particolare valore, in quanto è «un film d’effetto e un successo», ed è insieme un film che potenzia la sensazione e cerca di cogliere lo “spirito del tempo”. Quello che conta per Lang è la possibilità «dell’uso del film come immagine del suo tempo o meglio della valorizzazione del film come elemento della sua epoca». «Il segreto del suo successo (del Mabuse) non stava nel sensazionale, che è rimasto ancora sostanzialmente in seconda linea». Il sensazionale è insieme la sensazione e
lo spettacolo, cioè la capacità di produrre emozioni forti ed effetti spettacolari che colpiscono lo spettatore. Gli effetti spettacolari non sono qualcosa di facile o di volgare, ma al contrario valorizzano un aspetto fondamentale del cinema. Insieme Lang insiste sul film come espressione dello spirito del tempo. Non si tratta per Lang solo di mostrare la contemporaneità, che già è un obiettivo significativo, ma di cogliere quello che la cultura tedesca chiama Zeitgeist, spirito del tempo, che non è certo un insieme di oggetti o di personaggi dell’oggi, ma un insieme di aspetti, immaginari e simbolici, che definiscono un momento storico. Il dottor Mabuse è l’affermazione di un’epoca, del suo stile e dei suoi simboli. Non a caso qualche pagina prima Lang aveva scritto: «Lo spirito di un film […] è valido solo se riflette lo spirito dell’epoca in cui è nato. È del tutto indifferente quello che un film propone, ma i contemporanei lo devono percepire in modo immediato e con la stessa velocità delle immagini che scorrono davanti ai suoi occhi»12. La velocità delle immagini, cioè delle azioni, delle scene evocate e il ritmo creato sono fondamentali come elemento di affermazione della specificità e della epocalità dei film. La difesa di un cinema di sensazione da parte di Lang non riflette dunque un’opzione facile e popolare, ma al contrario cerca di trovare una nuova sintesi tra estetica e spettacolo, tra efficacia delle attrazioni filmiche e ricerca formale. Non a caso riflettendo sull’estetica e sulla sensazione Deleuze e Guattari parlano di «percetto, affetto e concetto»13 come elementi essenziali dell’opera d’arte. La sensazione, l’affezione, l’emozione sono componenti rilevanti che possono realizzare una fusione efficace nella produzione simbolica. E il cinema di Lang, spettacolare e simbolico, mostra proprio questa sintesi. D’altronde Lang, in incontri con studenti e con critici in America, sottolinea la sua esplicita intenzione di operare una fascinazione dello spettatore, proponendosi quasi di ipnotizzarlo. Lang dice: «Sono qui per affascinare lo spettatore, forse per creare in lui una certa inquietudine. È il mio modo di scuoterlo davanti alla realtà»14. Lang ha acquisito la consapevolezza teorica non solo della
necessità di creare forti sensazioni nel pubblico, ma di realizzare una fascinazione radicale, cioè di catturare lo spettatore e di coinvolgerlo in una spirale seduttiva. La produzione di sensazioni è diventata progetto di fascinazione. Abbiamo già visto come i film tedeschi di Lang puntino alla fascinazione dello spettatore. Ma Lang dichiara anche di voler «creare una certa inquietudine». La sua fascinazione non è lineare o semplicemente seduttiva. È finalizzata a creare inquietudine, a turbare lo spettatore. Lang punta a incrinare le certezze e l’equilibrio del fruitore, a frantumare la sua tranquillità. La fascinazione che Lang determina dissolve la condizione normale del percettore e gli insinua l’incertezza, la fragilità, la paura, davanti al male o al destino drammatico. Lo spettatore langhiano non è mai tranquillizzato. Al contrario è affascinato, inquietato ed è portato ad affrontare la realtà con meno certezze e più turbamenti e insicurezze. Ancora in America in un altro incontro, Lang spiega come la sua costruzione delle inquadrature e delle sequenze rifletta questa ricerca della fascinazione in forme ora più evidenti, ora più indirette. «Voi non sapete come io zerlege [sic] una scena, al fine di prendere in trappola lo spettatore, di obbligarlo a non lasciarmi sino alla fine della storia. Sapete cosa vuol dire zerlegen? È un gioco di domino che si deve praticare a una tavola rotonda, un po’ come a una seduta di spiritismo»15. Invero già nel Mabuse, che è una vera summa dei temi e delle figure langhiane più importanti, lo spiritismo e l’ipnosi giocano un ruolo assolutamente rilevante. In una sequenza, infatti, Mabuse partecipa a una seduta spiritica e naturalmente la guida. I partecipanti sono collocati in cerchio legati attraverso le mani aperte sul tavolo e Mabuse ricorre allo stato di trance per influenzare il comportamento degli altri. In altre due occasioni, attraverso la potenza della sua capacità ipnotica a distanza, dapprima sconfigge il miliardario Hull alle carte e poi ipnotizza il conte Told, spingendolo a barare e quindi a compiere un’azione infamante. In entrambi i casi, Lang utilizza scenografie di grande efficacia visiva, in stile floreale nel primo caso, in un
generico Espressionismo nel secondo e racconta l’ipnosi con effetti di profondità di campo e montaggi per contrasto di indubbia efficacia. E d’altronde l’importanza centrale dell’ipnosi nel cinema e nel personaggio di Mabuse è sottolineata da un’ampia sequenza della seconda parte del film (Il dottor Mabuse. Nell’inferno del crimine. Uomini dell’epoca, Dr. Mabuse, der Spieler. Inferno. Ein Spiel von Menschen unserer Zeit)16. Il macro-segmento dello spettacolo teatrale di ipnosi collettiva riprende insieme la riflessione visiva e narrativa sul potere della macchina cinema, ampliandola esplicitamente all’ipnosi e ai poteri della regia e del metteur en scène. L’illusionista Weltmann (cioè Mabuse travestito) allestisce infatti in un teatro un doppio spettacolo di ipnosi, che investe insieme il pubblico e alcuni spettatori particolari come von Wenck. Weltmann compie un gesto misterioso, poi chiude gli occhi e produce un effetto di ipnosi generale. Il teatro diventa una sala cinematografica immersa nel buio, e sullo sfondo appare un paesaggio di dune di sabbia e di palme. Poi torna la luce e sul palcoscenico compare e poi scende in mezzo al pubblico una carovana di cammelli e di arabi che attraversa la sala, sino a sparire di colpo a un ordine di Weltmann. Con l’invasione dello spazio del pubblico, l’illusione è andata al di là del cinema e quasi sembra avere prefigurato aspetti del teatro sperimentale e soprattutto degli esperimenti di realtà virtuale, sottolineando in ogni caso la forza di coinvolgimento psichico che il film può determinare nello spettatore. Il potere della regia cinematografica sopravanza il teatro e la tradizione dello spettacolo e crea un effetto di straordinaria e sconosciuta potenza. E Lang ne ha piena consapevolezza e costruisce Il dottor Mabuse e poi i suoi film più significativi come un’esperienza radicale del potere del cinema: dall’intensità dello sguardo in macchina all’allucinazione della messa in scena. LA CREAZIONE DELLA FORMA
Stilwille
Un ideale di perfezione assoluta ispira tutta la grande avventura creativa di Fritz Lang e il suo concreto lavoro di messa in scena. Non solo Lang costruisce macchine realizzative di grande forza fascinativa e di estremo rigore, ma elabora anche una sintesi nuova tra l’applicazione sistematica delle più innovative tecnologie dell’immagine e della scena e una profonda attitudine creativa segnata da un deliberativo e metodico Kunstwollen. L’operare cinematografico di Lang in tutto il periodo tedesco riflette una complessità particolare, caratterizzata dalla capacità di far confluire tutti gli elementi tecnici, linguistici e pragmatici inerenti al cinema in una visione sintetica nuova, fortemente strutturata e artisticamente legittimata. Nessun altro autore lavora nei primi anni venti con una simile volontà d’arte, puntando alla creazione di un Gesamtkunstwerk dai caratteri sintetici e complessi. Lang è consapevole di porsi in un’intersecazione difficile e necessaria tra il vecchio e il nuovo, tra l’aspirazione profonda a uno stile legato alla grande tradizione dell’arte e la necessità di costruire le nuove forme comunicative della società di massa. E insieme Lang ha anche la consapevolezza di dover piegare e sfruttare le grandi risorse della tecnologia all’elaborazione di un linguaggio che deve insieme sedurre il pubblico e garantirsi una legittimazione artistica piena. La macchina realizzativa di Lang è quindi una sorta di grande scena tecnica estremamente perfezionata, che riproduce in sé, nella propria struttura o nel proprio operare, lo stesso ideale ispiratore del Kunstwollen langhiano. Ma al tempo stesso l’enorme e sofisticata macchina realizzativa langhiana, che tende ad avvalersi, com’è noto, dei medesimi tecnici e dei medesimi attori, è anche un grande meccanismo di produzione di figure e di insiemi che solo la particolarità assoluta di un’inesorabile e definitiva Stilwille17 trasforma infine in una forma totale. Proprio la grande complessità e qualità del meccanismo produttivo del cinema di Lang richiede, per lo stesso ideale di perfezione che l’ha concepito, di essere trasfigurato e ridisegnato da un’attitudine creativa
ulteriore e singolare che solo la volontà di stile di un autore può garantire. Paradossalmente quanto più i tecnici, i collaboratori rappresentano il meglio, o quasi, della produzione tedesca, tanto più si rende necessaria la funzione compositiva e trasfigurante dell’artista, che coordina in termini di formalità interiore i vari elementi realizzati. Proprio lo studio del prezioso fondo Fritz Lang della Cinémathèque française conferma questo paradosso relativo alla creatività di Lang, mostrandoci al tempo stesso, e soprattutto per il cinema del periodo della Repubblica di Weimar che qui analizzerò, la grande qualità del materiale di preparazione della mise en scène e la differenza stilizzante garantita dall’intervento formale di Lang. È nella differenza sottile ma radicale tra il progetto scenografico e il testo visivo che si colloca il lavoro essenziale di Lang. Perché Lang costruisce forme e meccanismi di stilizzazione eidetica a forte figurazione, muovendo da un materiale di base ricco di determinazioni e di supporti, ma differente nella qualità e nei caratteri intrinseci dal risultato finale. E come le sceneggiature di Thea von Harbou – conservate alla Stiftung Deutsche Kinemathek – sono estremamente articolate e assai feconde di suggerimenti relativi alla messa in scena e allo stesso montaggio, ma restano un supporto operativo che definisce temi e strutture narrative senza far presagire lo stile e la forma dinamica langhiana, così lo stesso apparato dei bozzetti per le scenografie definisce il quadro del visibile, ma non ancora la struttura profonda e assolutamente particolare dello stile visivo-dinamico di Lang. È su questa differenza che si tratta di concentrare lo sguardo per tentare di cogliere la qualità specifica del Kunstwollen langhiano, l’essenza della sua arte della messa in scena. Oggetto di questo discorso sono dunque la processualità, i modi e la qualità di una differenza, che verranno analizzati in rapporto a due film fondamentali, profondamente diversi l’uno dall’altro, e che definiscono i modelli essenziali della scrittura langhiana. Sono I Nibelunghi e Il testamento del dottor Mabuse (Das Testament des Dr. Mabuse, 1933) che si avvalgono rispettivamente delle scenografie di Otto Hunte e di Erich Kettelhut e di Emil Hasler, e delineano forse al più
alto grado di intensità i modelli formali del cinema langhiano nel periodo di Weimar. Due film che testimoniano della complessità linguistica di una mise en scène che elabora, attraverso l’eterogeneo, complesse e affascinanti forme eidetiche. La forma eidetico-intensiva Nel fondo Fritz Lang della Cinémathèque française sono conservati diciotto bozzetti di Otto Hunte destinati alle due parti de I Nibelunghi. Si tratta soprattutto di guazzi (o di guazzi a penna) su cartoncino, del formato prevalente di 33 × 49 centimetri18. La predisposizione delle scenografie per il tournage segue in maniera abbastanza precisa i disegni di Hunte, discostandosene soltanto in pochi casi, forse per l’insorgere di difficoltà concrete di realizzazione. La ricostruzione degli spazi e degli ambienti, com’è noto, è totale. La stessa foresta in cui avverrà l’omicidio di Sigfrido è integralmente costruita presso gli studi di Neubabelsberg. Tutta la spazialità e il visibile sono realizzati in funzione di un progetto di messa in scena e di un programma visivodinamico e sono dunque segnati in profondità dal marchio compositivo, dalla volontà di stile. Ma tra i bozzetti di Hunte, le costruzioni per la scenografia e le immagini corrispettive del film realizzato ci sono differenze legate non solo alla specificità dei linguaggi rispettivamente impiegati, ma a intenzionali scelte di scrittura e di composizione. In queste differenze si racchiudono le tracce e i segni significativi di un progetto creativo. Esse sono lo spazio non tanto di un miglioramento dei bozzetti originari, fondato su dettagli, quanto dell’esercitarsi di un’attitudine compositiva rigorosa che rielabora e ripianifica ogni elemento in un quadro di formalizzazione assoluta. Le immagini create hanno una bellezza e una forza intrinseca. E insieme sono configurazioni che si caricano di significazioni, di idee, senza perdere l’intensità visiva. Sono immagini eidetico-intensive. Vediamone dunque alcuni esempi analiticamente.
Gang in der Burg zu Worms. La prima apparizione della reggia e del mondo dei Burgundi – contrapposto al mondo degli gnomi, di esseri leggendari, di magia e di destini divini di Sigfrido – è affidata una breve sequenza che ha nella particolare inquadratura di apertura il suo momento di massima suggestione visiva. Il guazzo di Hunte presenta un interno caratterizzato da un pavimento in parte a losanghe bianche e nere, in parte grigio e da una parete grigia in cui si disegna un arco più illuminato. Contro la parete sono disposti quattro soldati immobili che reggono scudi molto grandi e variamente decorati. Al centro avanzano il re e i dignitari burgundi in fila, indossando mantelli ricchi e ornati. È la rappresentazione di un mondo ordinato in cui i motivi ornamentali giocano un ruolo significativo di qualificazione dello spirito del mondo delineato. L’inquadratura corrispondente di Lang ripete il taglio laterale e i caratteri dell’ambiente, ma modifica alcuni elementi sostanziali. Da un lato elimina il chiaroscuro e illumina in maniera diretta e omogenea la parete; insieme costruisce un pavimento con una decorazione più ricca e ornata in bianco, grigio e nero. Dall’altro, e soprattutto, modifica la posizione dei soldati schierandoli non sullo sfondo ma davanti alla macchina da presa mentre il re, i nobili e dignitari sfilano lentamente (in gruppi in nero, in bianco, in grigio) apparendo e scomparendo dietro i profili scuri dei guerrieri. La collocazione dei guerrieri in primo piano e la loro riduzione a una sorta di colonne buie, che hanno la funzione di compartimentare lo spazio, aumentano la ieraticità dell’insieme, limitano il decorativismo e realizzano una prima pietrificazione dell’antropologico, ridotto, in parte, a una funzione di quinta di un palco immaginario19. Il trattamento del materiale visivo si arricchisce dunque subito di una determinazione intellettuale e simbolica ulteriore. L’elemento umano è sottoposto da Lang a due differenti modalità di struttura visiva e formale che implicano differenti articolazioni simboliche. I soldati, sottratti all’ornato di Hunte, sono diventati meri supporti d’ombra, della scena e per quella via esprimono
una profonda riduzione dell’antropologico, una sua sostanziale minimalizzazione. I nobili che sfilano tra le colonne d’ombra dei soldati esprimono invece nel rituale, nel movimento lento, nell’abbigliamento, un altro e complementare modello di organizzazione dell’antropologico: un antropologico totalmente formalizzato, gelato nella cerimonialità dell’essente, che sembra avere ridotto la mutevolezza e la vitalità dell’umano a rito disincarnato. L’animato è trasformato in disanimato, attraverso il lavoro di composizione formale, cioè di messa in scena, e al rituale disanimato è affidato il compito di esprimere l’ordine schematico di una civilizzazione senza più forza e senza più programmi di sviluppo. Landung der Burgunden. L’arrivo di Brunilde in nave al paese dei Burgundi costituisce un altro momento particolarmente significativo. Nel bozzetto di Hunte due elementi visivi giocano un ruolo determinante. In alto, la grande vela dispiegata della nave, che occupa quasi tutta la parte superiore del quadro, presenta su un fondo grigio due motivi ornamentali neri formati da grosse linee convergenti. Sotto, il gruppo dei personaggi, da Gunther a Brunilde, e i soldati schierati sulla nave. In basso, il mare scuro e sul fianco della nave regolari losanghe ornamentali. Nel film l’inquadratura della nave segue un’altra inquadratura ripresa con angolazione opposta, in cui due lunghe file di soldati con l’elmo, immersi nell’acqua e disposti a quinta, reggono un ponte di legno. L’ampio piano dei soldati nell’acqua prepara la grande inquadratura della nave sistemata accanto all’improvvisato ponte. Lang procede ancora una volta, rispetto al bozzetto di Hunte, per semplificazione e purificazione, puntando all’individuazione di strutture visive essenziali (fig. 2). Innanzitutto elimina la vela dispiegata, che assorbiva l’attenzione con il suo ampio motivo ornamentale, e la presenta arrotolata attorno all’albero. In questo modo sostituisce un tema decorativo con due linee rette che si incontrano formando un angolo leggermente ottuso. Sullo sfondo, il cielo illumina in maniera differente tutta la scena, mentre sulla nave appaiono riconoscibili i personaggi. Più ampia del
bozzetto, l’inquadratura ingloba nella visione anche i soldati immersi nell’acqua, con gli elmi ben visibili, che reggono il ponte di barche. E la traccia chiara del ponte in diagonale crea un quadro di linee di forza particolari che introducono un dinamismo controllato nell’inquadratura. Il singolare elmo con le ali di Hagen poi, sullo sfondo chiaro, introduce un ulteriore elemento di arbitrarietà figurativa. Nello spazio si integrano componenti diverse che Lang scandisce con una logica spaziale coordinata a un progetto formale. In questo caso Lang non vuole costruire una simmetria perfetta, ma al contrario dinamizzare elementi differenti. L’inquadratura della discesa di Brunilde e Gunther a terra, infatti, è collocata tra due inquadrature in controcampo e crea quindi con le diagonali del ponte sostenuto dai soldati una doppia dinamica di linee di forza divergenti. L’operazione di Lang presenta dunque una duplice ricomposizione degli elementi visivi. In primo luogo, una semplificazione delle componenti nello spazio e nella figuratività dell’immagine per far apparire le strutture essenziali. Insieme, un impiego delle potenzialità dell’angolazione delle riprese e del montaggio per realizzare uno sviluppo di dinamismi capaci di garantire al tempo stesso la geometria delle forme e la loro modificabilità e di delineare una tipologia specifica di rapporti tra forma statica e forma dinamica. Insieme estremamente significativa è l’dea del ponte di legno retto dai soldati burgundi e delimitato dalle doppie linee degli elmi che escono appena dall’acqua. È un’innovazione spaziale che il bozzetto non possedeva e che sottolinea ulteriormente la reificazione dell’umano e al tempo stesso la sua trasformazione in elemento microarchitettonico e insieme visivo-formale. La vendetta di Crimilde è un altro film, concepito con il medesimo rigore formale ed eidetico, ma articolato prospetticamente in una direzione assolutamente diversa. La rappresentazione del mondo barbarico degli Unni, infatti, è pensata come simmetricamente opposta alla rappresentazione del mondo ordinato e civile dei Burgundi e la sequenza del massacro di questi ultimi nella Saal der Knechte è certamente uno degli esempi più
significativi. La prima inquadratura dedicata alla Saal der Knechte è un’immagine d’insieme, in cui dominano a un tempo in alto le volte arcuate dell’ampia caverna e in basso le grandi masse dei Burgundi e degli Unni che si agitano e si muovono forsennatamente. In parallelo, il pranzo di apparente pacificazione dei nobiliari unni con i nobiliari burgundi è invece organizzato con disposizione geometrica dei personaggi e ritmi lentamente scanditi, in uno spazio che è tuttavia segnato da elementi scenografici e da decorazioni primitivi, elementari e arbitrari. Nella Saal der Knechte il grande numero di persone che si agitano senza nessuna direzione e senza nessuna finalità ragionevole dà il segno di un caos diffuso, in cui si perde ogni determinazione antropologica. L’umano è schiacciato dal magma bestiale degli uomini che saltano, ballano, lottano e si mescolano l’un l’altro in un groviglio senza forme. La massa occupa tutto lo spazio calpestabile del sotterraneo ed è solo parzialmente illuminata dalla luce. Gli uomini sono ridotti a macchie mobili, nere, grigie, grigie chiare, con poche macchie bianche in corrispondenza dei volti. Le macchie si muovono in continuazione, come un brulicare di formiche o di un alveare di api o il mescolarsi di granelli di colore diverso (con il medesimo modello rappresentativo Lang descriverà gli operai in rivolta in Metropolis). Le tracce dell’umano sembrano perdersi di fronte all’affermarsi del magma, della mobilità caotica. Nessuna struttura, nessun particolare, nessun elemento scenografico emerge dominante: solo il formicolare di una massa disumanizzata. E questa massa si rivela contraddittoriamente disanimata proprio mentre appare per converso in perenne mobilità. Il movimento caotico è privato di ogni logica, di ogni finalità, non ha forma, non ha anima. Eppure proprio questo caos, questo formicolare sfrenato ha una finalità semantica profonda, è il segno del caos barbarico, della mancanza di ordine, di razionalità del mondo primitivo e in particolare delle sue classi subalterne: un mondo che non è inscritto nell’orizzonte del valore e dello spirituale e non accede al simbolico, un mondo che non ha ancora raggiunto la sanzione della civiltà. E proprio l’organizzazione del caotico, del disordine e dell’informe, elevati alla massima
potenza, garantisce nell’orizzonte visivo-dinamico stesso la realizzazione di una rappresentazione che è anche idea, e quindi è una figurazione eidetica. Il bozzetto corrispondente di Hunte, al contrario, disegna sì il grande spazio sotterraneo con le volte ricurve e le caverne laterali, volte a sottolineare la primitività dell’ambiente, ma, insieme, dispone i Burgundi e gli Unni, per quanto numerosi, attorno a grandi tavole e colloca un grande spiedo con il fuoco acceso quasi al centro, catalizzando e ordinando l’attenzione dello spettatore. Hunte delinea insomma uno spazio primitivo, ma segnato pur sempre da principi di micro-funzionalità e di micro-organizzazione degli spazi e della disposizione degli uomini: la sua è la rappresentazione di una grande caverna in cui si raccolgono popolazioni primitive, non la figurazione di un magma. L’intervento di Lang costituisce dunque una riorganizzazione sistematica degli elementi nella prospettiva della figurazione del caos, una visualizzazione dell’idea stessa di disordine, e si configura anche come rappresentazione eidetica di popoli barbarici e di comportamenti e riti acefali e al limite dell’umano. È una rappresentazione che coinvolge nella figurazione del barbarico anche le classi subalterne dei Burgundi, che nella prima parte dei Nibelunghi erano invece delineate secondo le strutture dell’ordine e della civiltà. Le masse dei Burgundi sono qui spostate nell’orizzonte del caos, assumono dall’impianto generale del film una nuova e specifica qualificazione. Fondamentale, nell’opzione figurativa di Lang, è la volontà di caratterizzare tutto il mondo degli Unni rappresentato nella seconda parte dei Nibelunghi come mondo del caos e della barbarie. La scelta stilistica guida le determinazioni rappresentative e formali, l’idea di forma condiziona la stessa logica della rappresentazione. La realizzazione nel lavoro di messa in scena di una duplice transcodificazione della sceneggiatura di Thea von Harbou e dei bozzetti e delle scenografie di Hunte (nonché del lavoro di architetto e di tecnico di Kettelhut e di Vollbrecht) in immagini filmiche implica in primo luogo una visualizzazione dinamica, coordinata di un insieme di elementi spaziali e di un insieme di movimenti e di gesti estremamente eterogenei. Inoltre
questa visualizzazione dev’essere elaborata e scandita in termini di linguaggio cinematografico e quindi innanzitutto attraverso la discontinuità delle riprese, poi montate secondo una logica strutturante. Ma, all’interno e insieme al di là di questi passaggi che costituiscono il concreto del fare cinema, Lang opera alcune specifiche rielaborazioni che portano non solo il segno di una Stilwille, ma attestano anche l’idea di forma che Lang si proponeva di attuare. Una considerazione analitica del film di Lang, integrata dall’analisi delle differenze tra i bozzetti di Hunte e le immagini filmiche, consente di proporre alcune ipotesi relative alla formalizzazione langhiana. Sono insieme criteri operativi e opzioni estetiche che si integrano reciprocamente e che delineano le direttrici dell’attitudine stilizzante di Lang. E sono insieme percorsi di intensità che si realizzano grazie a una particolare sapienza compositiva, cioè a una particolare volontà di stile: a. una figurazione forte del visibile realizzata in un quadro di sistematica interazione di tutti gli elementi del profilmico e del filmico, sempre totalmente programmati e interagenti; b. la riduzione agli aspetti essenziali delle determinazioni visivo-scenografiche di Hunte, al fine di costituire uno spazio di strutture rigorose: lo spazio deve infatti apparire non come un insieme caotico di elementi, ma come una dimensione strutturata su linee di fondo riconoscibili; c. un’opzione compositiva specifica per la costruzione di strutture geometriche e simmetriche, pensate da Lang come scelte formali più rigorose e armoniche e come attestazioni più precise della sua particolare figurazione estetica; d. la trasformazione coordinata delle strutture geometriche statiche in dinamismi che riarticolano le geometrie formali: una delle caratteristiche fondamentali della mise en scène langhiana è proprio fondata sulla capacità di dinamizzare le strutture geometriche nella figurazione e di concepire quindi il movimento dentro linee e volumi geometrico-formali;
e. l’elaborazione della formalizzazione dello spazio in diretto rapporto con l’esigenza di produrre idee e inscrivere le idee nel visibile; è l’opzione per una composizione eidetica che intende potenziare e sviluppare la possibilità dell’immagine di essere idea, è una concezione del cinema che punta alla realizzazione di una visione intellettuale, di un sistema di composizione dell’immagine fondato sull’integrazione di pensiero e immagine: una concezione del cinema come Eidos, immagineforma-idea fuse in un’unità rigorosa e produttiva; f. la realizzazione dinamica, nel concreto-astratto della banda visiva di una sintesi tra spazio rappresentato, spazio formale e spazio eidetico. In tutti gli anni venti la mise in scène di Lang lavora dunque alla costruzione di una forma dinamica che integra in sé l’idea. La forma dinamica langhiana è tuttavia diversa dalla forma dinamica di Ėjzenštejn. Ėjzenštejn concepisce il dinamismo come movimento intensificato che potenzia le linee e le contrapposizioni di conflittualità: la forma dinamica di Ėjzenštejn è una forma conflittuale che utilizza il montaggio come intensificazione e acceleratore del contrasto. Per Ėjzenštejn la forma visiva deve essere posta al servizio del contrasto e del dinamismo, che alla fine diventano l’elemento prevalente e qualificante. In Lang invece il lavoro di messa in scena riflette la volontà di inscrivere il movimento nella forma, di creare una dimensione compositiva nuova che realizza un equilibrio assoluto tra forma e movimento, dinamismo e geometria strutturale. E mentre in Ėjzenštejn l’idea è il prodotto del contrasto del montaggio conflittuale, il «non figurabile prodotto da due figurabili»20, in Lang emerge dalla composizione, è nella strutturazione del visibile, nell’interrelazione geometrico-dinamica delle componenti. L’idea-forma di Ėjzenštejn è nell’organizzazione del movimento-contrasto programmato degli elementi, trasformati in vettori ideologici. L’idea-forma di Lang è invece nell’organizzazione astratto-monumentale,
figurativo-geometrica del visibile, elevato dal Kunstwollen all’orizzonte superiore dello stile. È un modello di scrittura-composizione che riflette esigenze diverse e nuove sul filo della contraddizione: è figurazione rappresentativa ma tende a potenziare le componenti geometriche del figurale e a risolvere in tensioni micro e macro-astratte determinazioni che non perdono il rapporto con il visibile fenomenico. L’idea è nella figurazione stilizzata e geometrica, nel rigore della forma visiva. E in Lang come in Ėjzenštejn la figurazione è Eidos, forma-idea-visione, purezza del vedere e complessità intellettuale del figurabile. Lang ed Ėjzenštejn sono non a caso i più grandi creatori di forme linguistiche e di figure eidetiche di tutto il cinema muto. E lo stile di Lang è insieme l’impostazione del lavoro linguistico che produce la forma eidetica e le linee di composizione degli elementi configurativi e visivi racchiusi nella forma cinetica. La configurazione differenziata Non è un caso che Lang concepisca i suoi film sulla Germania come film noir. Tra i suoi film muti solo Kämpfende Herzen (1921), Il dottor Mabuse e L’inafferrabile (Spione, 1928) sono film contemporanei. Anche nei primi anni trenta il noir sembra essere per Lang la chiave per capire il XX secolo. Ma nei film noir dei primi anni trenta Lang opera con la consapevolezza di dover affrontare un nuovo grande problema di stilizzazione linguistica e mediologica. Lang sa di dover inventare le forme di stilizzazione della contemporaneità nella scatola vivente prodotta dal sonoro, e quindi le forme di stilizzazione possibile del cinema sonoro attraverso le immagini della contemporaneità. In M (1931) come ne Il testamento del dottor Mabuse Lang delinea un insieme di figure complessive legate al movimento e al tempo, all’immagine e allo spazio, con il fine di inscrivere la scatola mobile vivente sonora nell’orizzonte della forma attraverso una rappresentazione che deve essere scritta dallo stile. La
sua operazione è duplice e si articola in una serie di specifiche interazioni tra il simbolico e il visibile sonoro, che è qualcosa di profondamente diverso dal quadro visivo eidetico e potenzialmente astratto-astraente del muto. Lang non parte certo dal presupposto che la contemporaneità e il sonoro siano dimensioni inferiori che è difficile elevare allo stile. Ma evidentemente Lang si pone il problema della stilizzazione della contemporaneità e del sonoro con la consapevolezza di una Stilwille che si è già pienamente esercitata nella realizzazione di macroforme di figurazione polivalente e simbolica. L’operazione di Lang, realizzata attraverso M e Il testamento del dottor Mabuse, è quindi complessa e articolata su più livelli, e investe modalità diverse di scrittura e di rappresentazione. Le procedure inventate da Lang possono essere interpretate innanzitutto proprio mediante un’analisi comparata dei bozzetti per la scenografia di Hasler, conservati alla Cinémathèque française, e delle immagini del film. Nel fondo Fritz Lang della Cinémathèque française sono raccolte le maquettes formato 37 × 52 centimetri per M e quelle per Il testamento del dottor Mabuse dello stesso formato. Nella preparazione di M e del Testamento del dottor Mabuse, Hasler ha elaborato per le scenografie bozzetti di grande interesse, disegnando interni ed esterni estremamente ricchi di particolari e di determinazioni oggettuali e visive. Il suo disegno a carboncino, raramente integrato dal colore, tende ad affastellare una molteplicità di elementi dentro il quadro, per garantire al tempo stesso un surplus di informazioni e di materiali. Lang interviene sui bozzetti di Hasler con una volontà di stile assolutamente particolare, che non si discosta nell’impegno da quella già esercitata verso i bozzetti di Hunte, ma si configura ovviamente in termini del tutto diversi. Lang parte da bozzetti che descrivono in maniera omogenea un ambiente omogeneo sul piano degli oggetti e dello stile degli oggetti, e punta alla costruzione del disomogeneo.
L’inserimento della persona e dell’azione introduce una prima differenziazione nel quadro del rappresentato, creando una dinamica differenziante tra i gruppi di elementi. Ma è soprattutto il lavoro sull’insieme del visibile a creare articolazioni e segni diversificati. Non sono evidentemente il gusto o, all’opposto, il realismo del décor a definire una qualità particolare della rappresentazione, ma l’interazione tra due disomogeneità, la creazione di una condizione di differenzialità tra gli insiemi che sono in relazione. I bozzetti di Hasler sono certo piuttosto elaborati e mostrano una compattezza stilistica non inferiore a quelli di Hunte. Presentano una ricchezza di particolari anche superiore alle maquettes di Hunte e caratteri nettamente diversi. Hunte vuole evocare e strutturare lo spazio e i segni esemplari di un’altra epoca e lavora apertamente sul singolare, sul geometrico e sul monumentale. Hasler punta piuttosto sulla coerenza interna degli elementi disposti nel quadro e ovviamente sull’esemplarità. Ma mentre Hunte ricorre al monumentale e al geometrico, Hasler fornisce un’omogeneità d’insieme centrata sull’esemplarità figurativo-rappresentativa. Il lavoro di messa in scena di Lang deve quindi figurare all’interno dello spazio filmico altre articolazioni visive e strutturali per realizzare uno scarto di stile rispetto alla mera riproduzione del visibile contemporaneo. Ed è quello che Lang fa scrivendo linearità e strutturalità differenti all’interno dei sistemi omogenei (oggettuali, antropologici, cinetici) che entrano nella rappresentazione. Vale la pena di vedere analiticamente due aspetti significativi del film, in rapporto a due bozzetti particolari di Hasler. La prima inquadratura de Il testamento del dottor Mabuse rivela l’interno di un magazzino disordinato di un’officina. Dapprima la macchina da presa inquadra una porta scura inserita in una parete altrettanto scura, poi, scivolando verso destra, mostra alcuni scaffali su cui sono appoggiati caoticamente ferraglie e apparecchi in disuso, cerchioni di ruote e bottiglie.
Il movimento di macchina procede ancora, da panoramica diventa travelling in avanti che rivela e si impossessa progressivamente dello spazio. Una sensazione di instabilità è prodotta al tempo stesso dal movimento di macchina, rapido e penetrante, piuttosto inconsueto nel cinema dei primi anni trenta, e dallo stesso precario equilibrio degli oggetti sugli scaffali: lo spazio sembra squassato dall’attività del misterioso macchinario posto probabilmente in uno spazio adiacente che produce un rumore molto forte. Poi la macchina si sposta più velocemente non solo verso destra, ma anche in avanti, mescolando due spostamenti che danno l’impressione di un dinamismo particolare della visione. Il movimento di macchina ha evidentemente un effetto al tempo stesso inclusivo ed esclusivo, man mano che rivela nuove porzioni di spazio. Al termine dell’avanzamento nello spazio, la macchina da presa si ferma per un attimo sulla parete grezza, sotto una lucerna, inglobando nel quadro anche un cappio un po’ inquietante per poi scendere rapidamente a inquadrare un uomo spaventato, accovacciato in un angolo. L’uomo si asciuga il sudore sul volto, poi d’improvviso si volta e guarda verso sinistra. Con un raccordo classico la macchina da presa ci rivela subito il settore di spazio osservato e i due uomini che sono entrati nel deposito. Il rumore è talmente forte da dominare non solo la dimensione sonora e auditiva, ma tutto l’orizzonte del configurato. È come se tutto lo spazio fosse segnato e semanticamente riqualificato dall’invasione di un sonoro non umano, prodotto da un oggetto fuori campi. Una funzione meno palese ma, certo, fondamentale, è poi svolta dall’illuminazione che assume caratteri particolari. L’illuminazione curata dal più grande direttore della fotografia tedesco, Fritz Arno Wagner, realizza effetti visivi nuovi che vanno al di là sia del modello della luce diffusa, sia del modello opposto della luce contrastata e della contrapposizione tra settori di tenebra e zone di luce. La luce infatti sembra scrivere gli oggetti e lo spazio, creando su ogni superficie giochi e variazioni di intensità e di luminosità. È
È una pratica che tende a considerare l’insieme del profilmico, e degli spazi e degli oggetti del mondo, non come una realtà indifferenziata e omogenea, ma come uno spazio da scrivere e da comporre con la luce. La luce infatti sembra incaricarsi non solo di diversificare il colore e il carattere visivo degli oggetti, ma di creare in un certo senso una differenziazione particolare tra gli oggetti, una gerarchia di rilevanza e di funzionalità spaziale e semantica. Ma, più in profondità, il lavoro dell’illuminazione realizza una composizione visiva attraverso la distribuzione della luce, trasformando lo spazio e la scatola sonora mobile del cinema sonoro in un orizzonte di scrittura, in un tessuto di differenze. Proprio questa operazione consente di riscattare il tendenziale abbassamento del cinema a una dimensione di realismo riproduttivo, provocato dall’avvento del sonoro, riaffermando la possibilità per il cinema di scrivere il visibile invece di subirne una più facile immediatezza. La luce non opera più contrasti tra settori del visibile, scivola sugli oggetti e lo spazio, ma al tempo stesso differenzia, dipinge, perché sa passare da un elemento all’altro con un’intensificazione morbida, attaccata alle cose, capace di qualificare e diversificare non solo ogni elemento, ma, all’interno degli elementi, anche singoli spazi di superficie. Il bozzetto di Hasler che illustra lo spazio prevede il locale povero e inospitale, con attrezzature obsolete, pulegge e strutture meccaniche, pavimento e pareti grezze che preparano efficacemente la scenografia per la messa in scena di Lang. Le differenze tra il bozzetto e lo spazio della sequenza langhiana non sono evidenti eppure sono profonde. Lang insiste sul disordine del locale contribuendo a rendere palese ed esplicito il caos dello spazio. Insieme, mentre nel bozzetto di Hasler la luce è diffusa in modo omogeneo, nel film il gioco delle luci crea agglomerati di visibilità intrecciati ad agglomerati di invisibilità, facendo della scatola vivente mobile sonora non il terreno della riproduzione, ma lo spazio del “non-indifferente” – per usare una formula di Ėjzenštejn –, prodotto dalla mise en scène. L’ultima essenziale determinazione nella creazione della non
indifferenza del rappresentato è poi legata naturalmente all’uso di quel codice specificamente filmico che è il movimento di macchina. Lang rivela lo spazio dell’accadere per parzialità successive, strutturate e contrapposte insieme, e poi mediante un’ulteriore qualificazione che perfeziona la differenziazione del rappresentato. Al contrario, quello che colpisce nei bozzetti precisi e articolati di Hasler è proprio l’omogeneità del rappresentato, l’organizzazione funzionale degli elementi ispirata ai dettami della riproduzione realistica. Se nella prima sequenza definisce subito una modalità particolare di trattamento del materiale visivo, con la presentazione del dottor Mabuse Lang inaugura un’ulteriore forma di visualizzazione, del tutto particolare proprio in rapporto all’eccezionalità del personaggio. Mabuse compare dapprima in una diapositiva durante una lezione del professor Baum in un’aula ad anfiteatro. È a un tavolo, fotografato di profilo, con un’espressione di grande concentrazione. Altre due diapositive mostrano la sua attività grafica. Su fogli volanti Mabuse ha tracciato strani segni mescolati a parole e disposti sulla carta senza nessun ordine. Poi il nome di Mabuse compare misteriosamente sul graffito inciso a rovescio su un vetro dall’investigatore Hoffmeister prima di impazzire. Dopo l’inquadratura del commissario Lohmann che osserva l’ambigua incisione sul vetro, il film cambia spazio e persona e ci presenta improvvisamente Mabuse nella sua cella all’interno dell’ospedale psichiatrico. Mabuse appare ancora di profilo, ma ha un’aria molto più dissennata, folle e invecchiata. L’inquadratura lo coglie in una stanza totalmente disadorna e il suo profilo si staglia contro la parete. Ha i capelli ritti, quasi irrigiditi, e scrive forsennatamente in una sorta di raptus creativo illimitato. Poi la macchina da presa rivela a terra innumerevoli fogli vergati ossessivamente da Mabuse. Baum entra in seguito nella cella e si avvicina a Mabuse, mentre un inserviente raccoglie a terra i fogli. D’improvviso compare sullo schermo l’immagine
controluce di un’inferriata parzialmente deteriorata: la luce penetra violenta dal retro mentre tutto attorno domina il buio. Baum è accanto a Mabuse che continua a scrivere, quando d’improvviso passa sul suo corpo la traccia veloce ed enigmatica di un’ombra: Baum si volta di colpo e la macchina da presa segue la direzione del suo sguardo per cogliere l’immagine fantasmatica di Mabuse in piedi al fondo della stanza, minaccioso e inquietante. La macchina da presa si sposta ancora senza stacco a osservare l’infermiere che a terra raccoglie i fogli e poi si sposta nel punto dove Mabuse è intanto scomparso. L’apparizione di Mabuse sdoppiato rappresenta non solo l’inizio della cattura psichica di Baum da parte di Mabuse, ma anche l’inserimento del film dentro il meccanismo delle fissazioni paranoidi di Mabuse. Il professor Baum appare insieme come un uomo che esercita il suo potere psichiatrico, come una vittima di Mabuse e come un grande criminale, figura sostitutiva di Mabuse, e proprio nelle inquadrature con Mabuse le ambiguità della sua funzione sono sottolineate. Questo processo è realizzato mediante la costituzione di una qualità particolare della rappresentazione, che la successiva inquadratura dedicata a Mabuse contribuisce ulteriormente a definire. Mabuse compare ancora un’ultima volta prima di morire in due inquadrature, solo, immobile come “un morto vivente”, ma con gli occhi di qualcuno che ha conservato la ragione. Nella prima inquadratura Mabuse è a letto, in un décor essenziale, appoggiato alle mani, ritto, con lo sguardo fisso. Nella seconda appare invece in primissimo piano con gli occhi infossati parzialmente in ombra, che emanano tuttavia una particolare e inquietante intensità. La luce colpisce direttamente le guance, mentre il naso adunco determina un’ulteriore zona d’ombra. Un punto di luce sembra irradiarsi dall’occhio destro, come il segno di una forza demoniaca interiore che va al di là dell’ombra. Mabuse ricompare cadavere in un’inquadratura che sottolinea anche puntualmente la fine del corpo del grande criminale. Di Mabuse, infatti, appaiono i piedi
nudi di un cadavere coperto da un lenzuolo, mentre due mani legano alla caviglia un biglietto con la scritta «Mabuse». La rappresentazione langhiana di Mabuse punta nel Testamento a una sistematica rarefazione degli elementi per costruire dentro il visibile un’essenzialità particolare, capace di inscrivere l’idea nel visibile. Poco dopo, la visita di controllo dell’ispettore Lohmann si svolge in una stanza assolutamente asettica in cui Mabuse è solo un corpo coperto da un lenzuolo. L’inquadratura mostra dapprima una forma indefinita sotto il bianco del lenzuolo, appena individuata sullo sfondo del bianco del muro. Una mano solleva il lenzuolo e rivela la testa di profilo di Mabuse. Poi la macchina da presa si sposta sino a inglobare il professor Baum, mantenendo nel quadro al tempo stesso il volto di Mabuse. Tra Baum e Lohmann inizia un dialogo che Lang realizza con una misura stilistica estremamente precisa. I personaggi sono inquadrati sempre singolarmente uno di fronte all’altro, ciascuno davanti a un muro bianco, isolati e separati come entità radicalmente divise, immerse in una contrapposizione totale. È un montaggio per contrapposizione che giustappone due polarità opposte, con una procedura che ha valenze simboliche (solo 1’ultima inquadratura riunisce insieme Lohmann e Baum). Di particolare interesse è poi la sequenza dello studio, da parte del professor Baum, degli scritti di Mabuse, e della cattura psichica di Baum da parte dello stesso fantasma di Mabuse. L’interesse interpretativo è accresciuto dall’esistenza di un bozzetto di Hasler dedicato all’elegante ufficio di Baum. Il décor disegnato da Hasler è un ambiente caldo ed elegante con mobili antichi, suppellettili, oggetti e lampade, e ampie librerie alle pareti: uno studio ampiamente arredato, curato in ogni particolare, che va proprio nella direzione opposta alla riduzione essenziale dello spazio che caratterizza le scene con Mabuse.
La differenza tra il bozzetto e il film è insieme limitata e radicale. Dopo due inquadrature dedicate ai manoscritti di Mabuse, la macchina da presa leggermente dall’alto e in diagonale inquadra l’ampio ufficio di Baum, che è seduto alla scrivania. È un’inquadratura che dà un quadro articolato dell’ufficio ed è realizzata con un taglio di ripresa nettamente diverso da quello previsto da Hasler e ritagliato poi in rosso da Lang stesso sul bozzetto. Le inquadrature seguenti vanno invece progressivamente nella direzione della rarefazione degli elementi, della scomparsa dello spazio e dell’affermarsi di una dimensione fantasmatica e parapsichica. Ma prima di palesare in sovraimpressione Mabuse come un fantasma malvagio, Lang aveva isolato, sugli scaffali dello studio, una serie di maschere, materiali o disegnate, e di teschi, per qualificare lo spazio dell’agire nell’orizzonte della morte. Sono una serie di inquadrature che trasformano lo spazio diegetico in uno spazio formale e simbolico a un tempo. La serie di primi piani e di piani ravvicinati sulle maschere e i teschi realizza una frammentazione metodica dello spazio che è evidentemente una tecnica per modificare la qualità e la finalità del visibile e del discorso stesso. Prima ancora di sviluppare la rappresentazione del rapporto BaumMabuse, c’è da parte di Lang uno smembramento dell’unità spaziale e diegetica, perché oltre l’immediatezza del narrato si affermi la mediatezza del simbolico. Ma poi, man mano che Baum procede nella lettura dei testi di Mabuse (Aufzeichnungen des Dr. Mabuse, Herrschaft des Verbrechens), le procedure di visualizzazione dell’azione drammatica si modificano ancora. E mentre il testo di Mabuse affascina e cattura Baum, Mabuse appare in sovraimpressione come un lemure bianco semitrasparente, che si siede di fronte a Baum come per parlargli e poi riappare dietro di lui per penetrarlo e introdursi nella sua mente e nella sua volontà. Tutto questo segmento dall’alto potenziale metapsichico e simbolico è invero realizzato in un décor che ha perduto tutte le connotazioni di arredo e si è trasformato in uno spazio mentale: uno spazio interiore in cui si gioca una fascinazione radicale, una cattura psichica perversa che ha risonanze infinite.
Nel film tutto quello che riguarda Mabuse è ricondotto attraverso la rappresentazione a un’essenzialità particolare. L’apparizione di Mabuse è sempre legata alla realizzazione di un orizzonte ulteriore del rappresentato, a una dimensione in cui l’essere e 1’“oltre essere” si intrecciano enigmaticamente. Mabuse appare nella sua miseria di malato e di prigioniero, ma è insieme il sembiante di un’ulteriorità assoluta. La sua immagine invecchiata, la sua figura di folle sono ancora domiate da una forza psichica sconvolgente e la rappresentazione di Lang mostra il puro carattere ulteriore del suo essere. Proprio il décor essenziale, il dominio del bianco, l’eliminazione di quasi tutti gli elementi concreti della vita quotidiana e degli ambienti abituali attestano subito sul piano visivo l’eccezionalità del personaggio e la sua esemplarità nel male. La scrittura langhiana afferma con una serie di marche enunciative, di determinazioni stilistiche precise, l’esistenza di un piano del vivente che è radicalmente diverso dal piano delle interrelazioni quotidiane. La scelta per un décor essenziale quasi nullificato ci dà il segno del rapporto con il male, con la morte, con il nulla e con le forze misteriose della psiche, che Mabuse implica. Lang dimostra ancora che nella scatola sonora mobile del cinema parlato c’è la possibilità di elaborare una scrittura complessa, ancora eidetica, capace di qualificare semanticamente e simbolicamente l’orizzonte del visibile e di sfuggire alla mera accumulazione dell’indifferenziato che caratterizza il cinema sonoro più diffuso. La scrittura degli episodi dedicati a Mabuse costituisce dunque un altro modello di rappresentazione, una scrittura della differenza che compone l’eccezionalità e gli estremi in una dimensione eidetica. Non è un caso che non vi siano disegni preparatori di Hasler per la cella di Mabuse. La cella di Mabuse è tutta nella testa di Lang, ed è ispirata a una rarefazione assoluta che è una formalizzazione pura. Il contributo dello scenografo non poteva che essere superfluo. La rarefazione assoluta è la persistenza, nell’ambito del cinema sonoro, della figurazione langhiana più radicale
dei tempi del muto: un’opzione di confronto con l’estremo e di figurazione intellettuale. L’analisi complessiva del film e la comparazione tra i bozzetti di Hasler e le immagini filmiche permettono dunque di rilevare non solo la complessità del lavoro di messa in scena di Lang, ma anche la sua capacita di rispondere al problema dell’invenzione della nuova forma estetica del cinema sonoro attraverso una differenziazione delle procedure configurative. Potremmo quindi dire, in sintesi, che sono tre i modelli di configurazione del visibile sonoro attraverso la stilizzazione realizzati da Lang. 1. Un primo livello di restituzione del visibile come insieme strutturato e reinquadrato (come dimostrano gli interventi a matita rossa di Lang sui bozzetti di Hasler e, ovviamente, i piani del film stesso). Si tratta di segmenti di rappresentazione che attestano palesemente il lavoro di messa in scena, ma che sono tuttavia privi di forti elementi di stilizzazione. 2. Un secondo livello di configurazione attraverso la rivelazione di uno spazio di elementi nonindifferenziati, resi non omogenei, ma designati e disegnati diversamente e quindi realizzati dalla composizione, dalla messa in scena e attivati e qualificati attraverso la luce e i parametri filmici. 3. Un terzo livello inerente essenzialmente alla configurazione di Mabuse. Qui la scrittura punta a una rarefazione radicale degli elementi, privilegiando la dimensione dell’essenzialità e dell’eidetico e palesando l’insufficienza del mero visibile a semantizzare gli orizzonti estremi. Sono procedure che cercano di produrre un’intensità visiva attraverso la differenziazione delle configurazioni e la scelta per tipologie di immagini diversificate. La forza delle immagini costruite secondo modelli visivi molteplici assicura la creazione di vettori intensivi di indubbia rilevanza. Inoltre l’insieme di procedure configurative e stilizzanti costituisce una risposta particolare e meditata alla
questione fondamentale del cinema dei primi anni trenta: come salvaguardare la forma specifica del film e la sua struttura di legittimazione artistica nella scatola mobile del sonoro. La scelta di Lang è subito, in M come nel Testamento, estremamente matura e va nella direzione della rielaborazione differenziata del visibile. Per il Lang degli anni trenta solo l’impegno a diversificare l’orizzonte audiovisivo attraverso la molteplicità degli stili di messa in scena potrà garantire la sottrazione dell’universo filmico del sonoro alla mera riproduzione del visibile. Lo stile nel cinema sonoro è per Lang, insieme, il complesso delle differenziazioni e la sua ricomposizione configurativa: un nuovo modo di pensare la forma filmica. E nel cinema di Lang la forma è legata all’intensità, è uno dei modi, il più raffinato senza dubbio, di creare l’intensità. Quindi nel cinema di Lang del periodo tedesco è fondamentale la produzione della sensazione e la ricerca dell’intensità. E l’intensità assume due tipologie dominanti, legata la prima alla forza e alla novità delle situazioni narrative e la seconda alla costruzione della forma visivo-dinamica. La prima è una tipologia diretta e capace di coinvolgere e di guidare lo spettatore. La seconda è un vettore più rilevante sotto il profilo filmico, più sofisticato, meno diretto, e capace di valorizzare il carattere più profondo dell’intensità e la sua dimensione fluida e configurativa, cioè formale.
[1.]
[2.]
[3.]
Il dottor Mabuse di Anita Trivelli Dr. Mabuse presenta errori, lungaggini, inverosimiglianze, ma lascia intravedere la strada in salita che il cinema della nostra epoca deve percorrere. KURT PINTHUS1
Il dottor Mabuse (Dr. Mabuse, der Spieler, 1922) presenta un personaggio archetipico per il cinema di Fritz Lang e coordinate tematiche e stilistiche che il regista non abbandonerà mai. Non a caso il suo ultimo film sarà Il diabolico dottor Mabuse (Die 1000 Augen des Dr. Mabuse, 1960): tutto si ripete, ci dice Lang a quarant’anni di distanza, confermando l’iscrizione del film in una serialità da classico à suivre e to be continued di tanto cinema francese e americano di inizio Novecento2. Nel 1924 Lang osserva che «lo spirito di un film è valido soltanto se riflette lo spirito dell’epoca in cui è nato»3: in perfetta sintonia con queste parole, il suo Mabuse esplora i vizi della borghesia cui il regista appartiene, e la decadenza della società tedesca contemporanea, in una acuta premonizione del nazismo. E nell’introduzione del fascicolo-programma pubblicato in occasione della première del film nel 1922 si legge: «L’umanità, offesa e calpestata dalla guerra e dalla rivoluzione, si vendica di anni di angoscia abbandonandosi all’incontinenza. […] E arrendendosi passivamente o attivamente al delitto»4. GIOCO, AMBIENTI E SCENOGRAFIE (DEL CRIMINE)
Dalla fine della prima guerra mondiale la Germania è funestata da sanguinose lotte interne seguite da una devastante iperinflazione, con la crisi della produzione industriale, l’aumento vertiginoso della disoccupazione, la forte diminuzione dei salari operai e profondi sommovimenti internazionali che culmineranno con l’occupazione-franco belga della Ruhr dal 1923 al 19255:
L’iperinflazione provocò una sostanziale disumanizzazione delle persone […]. «I vecchi valori – onestà, sobrietà, intelligenza imprenditoriale – erano stati brutalmente sostituiti dalla fortuna del giocatore d’azzardo. E il valore – della vita, del denaro – era stato ridotto a una mera addizione di zeri». […] L’iperinflazione […] metteva a rischio le fondamenta stesse del vivere collettivo6.
Nel 1922 uscì a Berlino il roman-feuilleton di Norbert Jacques Dr. Mabuse, der Spieler, originariamente pubblicato a puntate sul settimanale «Berliner Illustrierte Zeitung» a partire dal 1921. Con la collaborazione di Thea von Harbou, Lang aveva iniziato a scriverne l’adattamento prima che venisse pubblicato l’ultimo capitolo sulla rivista. Per diversi episodi il regista dichiarò di aver tratto ispirazione da articoli di giornali7. In un articolo del 1946 (The Frog and I) il regista osservava che «Ogni regista mira alla spontaneità; forse è perché ho imparato a fare film in un paese dove i particolari furono sempre giudicati importanti […] dico che la spontaneità deriva da una minuta attenzione al particolare e dall’esercitazione costante»8. Esemplare di questa estetica del dettaglio è appunto il suo primo Mabuse, che con i successivi Metropolis (1927) e M (1931), compone una trilogia del potere e del crimine, che delinea «i nodi più significativi della Germania weimeriana, dal disadattamento del dopoguerra all’affermazione della Rationalisierung, alla contro-rivoluzione preventiva, alla hitlerizzazione ideologico-culturale»9. Anche alla luce della sua esperienza nella Grande Guerra (fu al fronte e vi rimase gravemente ferito), Lang analizza così la drammatica situazione tedesca postbellica: «Dopo la sconfitta della I guerra mondiale e il conseguente sconvolgimento sociale […], seguito da una controrivoluzione reazionaria […], la Germania entrò in un periodo di fermento e confusione, […] di disperazione e vizio sfrenato, segnato dagli eccessi di un paese in preda all’inflazione»10. Mabuse esplora una varietà di ambienti sociali, in un composito Bild der Zeit capace di far luce sulle componenti culturali nascoste che si riveleranno fatali per l’intera Europa: le meticolose finiture scenografiche
(dai salotti agli hotel, dai teatri ai club privati e alle bische) esaltano oscurità e inquietudine, espandendo una entropica atmosfera esistenziale e sociale11. La regia langhiana si concentra sulla combinazione tra l’elemento realistico – affidato agli ambienti e ai personaggi colti nelle loro relazioni sociali – e quello più propriamente illusorio, assegnato allo Spieler Mabuse, che con i suoi schizofrenici travestimenti (s)maschera il non detto e non dicibile della società. Del resto, la locuzione der Spieler del titolo originale ha un significato poliedrico di attore, giocatore e giocatore d’azzardo: una poliedricità consona al protagonista. Il gioco è dunque, anzitutto, quello del cinema, che Lang esibisce innestando il suo poliziesco in un topos del cinema delle origini: il treno in corsa. Ne vediamo l’interno, con un omicidio a scopo di rapina, e l’esterno, che corre su un ponte per incrociare con precisione cronometrica un’auto che vi passa sotto e che riceve la borsa rapinata. Gli ambienti dello Spiel sono centrali in tutto il film, dalla sequenza della borsa agli accaniti gamblers drogati dal gioco d’azzardo: è la società dei Golden Twenties tedeschi, una società «confusa, isterica e disperata», dedita al «vizio sfrenato» (per riprendere le parole del regista), facile preda di ambizioni tiranniche12 e che anticipa il grigiore invasivo della fabbrica di Metropolis, su cui possono proiettarsi retrospettivamente le lugubri immagini dei campi di concentramento nazisti13. Altro ambiente sinistro del primo atto è il laboratorio in cui Hawash, membro della banda di Mabuse, fabbrica banconote false che vengono impacchettate da un gruppetto di ciechi. Si tratta di una sorta di sottoscalascantinato senza particolari connotati, in cui però operano delle macchine, tra cui la pressa per stampare, che nell’ultima scena del film si animeranno come mostri terrorizzando Mabuse sconvolto per la sua sconfitta: una delle poche scenografie espressioniste del film. Del resto, come sottolinea Paolo Bertetto, nell’atteggiamento verso il visibile c’è una differenza strutturale tra Lang e l’espressionismo. Diversamente dal Caligarismus e dal cinema espressionista, il cinema di
«figurazione eidetica» langhiano non trasmette idee deformando e alterando i materiali del profilmico, bensì «geometrizzandolo» attraverso la struttura architettonica delle immagini e del loro spazio interno14. L’ambiente della borsa, che dal punto di vista simbolico è la sintesi degli altri, quasi la summa discorsiva del film, è sovrastato da un gigantesco orologio inquadrato tra alte colonne doriche: ed è qui che Mabuse sfoggia la sua prima prova camaleontica, esibendosi come Spieler (attore-giocatore d’azzardo-manovratore) d’eccellenza della nuova economia che muove il mondo. Dopo aver iscritto il film nel genere poliziesco, Lang inizia dunque la riflessione sulla sua epoca proprio sul palcoscenico della borsa, dove Mabuse si erge come una statua a dirigere le sue manovre speculative. L’economia mondiale è in mano a giocatori senza scrupoli: la Germania è ridotta allo stremo, mentre i suoi borghesi si accalcano dimenando i loro lucidi cilindri di seta nera e la gente comune è metaforizzata dai ciechi del laboratorio di contraffazione15. Dopo la scena della borsa Mabuse recita di nuovo su un palcoscenico, quello di una filarmonica (la cui sede non è identificabile)16. Ma questa volta è presentato nel ruolo che si è dato in società: tiene una conferenza come psicanalista e famoso professore, e appare con il suo nome e il volto senza trucco, diversamente dalle eclettiche mascherate da Spieler consumato. Ruolo sociale confermato nel quarto atto della seconda parte, quando von Wenk va a casa di Mabuse dove c’è la targa «Dr. Mabuse - Psychoanalyse». Questo ruolo sociale dialogherà significativamente con un’altra mascherata, quando Mabuse vestirà i panni di un illusionista, sotto un nome diverso e con una marcata truccatura, e ipnotizzerà il pubblico facendolo assistere a un illusorio gigantesco e invasivo spettacolo. Da un lato la psicanalisi come ipnotico dirigismo delle menti altrui, e dall’altro la riflessione di Lang sull’ipnosi come pratica i cui poteri e procedimenti appaiono imparentarsi con quelli del dispositivo cinematografico e della proiezione dei film in sala. Una consapevolezza, questa del regista
viennese, che è stata più volte sottolineata dagli studiosi che all’interpretazione del Mabuse hanno dedicato la loro attenzione17. Ricordiamo che nella Vienna in cui Lang vive i primi vent’anni della sua vita Freud è un personaggio centrale, cui si richiamano direttamente e indirettamente altre personalità che costituiscono l’humus culturale in cui il regista si forma, espresso nelle arti dalle Secessioni di Monaco (1892), Vienna (1897) e Berlino (1898), che si diffondono in tutta Europa assumendo i nomi di Art Nouveau, Modern Style, Liberty, Jugendstil, Modernismo18. Un humus che coltiva l’ideale della Gesamtkunstwerk e che innova rispetto all’accademismo tradizionalista, venendo presto affiancato e superato dalle avanguardie futurista, dadaista, surrealista, espressionista, cubista, costruttivista che nel Dr. Mabuse si mescolano tra loro e con altre correnti, come quella francese dei Fauves, che proprio con l’Espressionismo dialogò nel primo decennio del Novecento. Dopo l’inquadratura della conferenza inizia la serie degli ambienti borghesi che accoglieranno il prosieguo della narrazione: il teatro Folies Bergères, dove si esibisce la danzatrice Cara Carozza su un fondale di ascendenza fauve, difendendosi dall’assalto di due gallinacci dal becco a forma di giganteschi nasi fallici che ricordano i personaggi di George Grosz; il Club 17+4, in una scenografia relativamente tradizionale; l’hotel Excelsior, dove figura una riproduzione plastica del David di Michelangelo19. Da questi ambienti pubblici si passa a quello privato della residenza dell’alto-borghese Hull, ispirata a un misurato stile Liberty nella scala e nella vetrata (nella quale si vedono influssi dell’espressionismo di Die Brücke), arredata in modo anonimo con un tappeto persiano che invade il pavimento, un grande camino e una libreria. Un ulteriore spazio privato è la sala da gioco dello Schramm’s Palais, in cui la scena è dominata da un Mabuse quasi irriconoscibile che al gioco, cui partecipano anche Carozza e Hull, vince la collana che una grassa signora russa ha acquistato a New York da
Tiffany. Le pareti di questo ambiente sono occupate da dipinti che ricordano la Scuola di Parigi, in particolare Léger, Matisse e Chagall, oltre a Kandinskij e ai quadri più astratti dell’espressionista Franz Marc. La sala da pranzo è in una scenografia che ricorda Kandinskij e Marc ma anche il futurismo e i motivi costruttivisti dell’opera di Lyonel Feininger; la vicina sala spettacolo è circolare, con tavoli su un gradone tondeggiante, sullo sfondo dei quali giganteggiano immagini di foglie e alberi che ricordano Matisse; nella cavea centrale si esibisce una ballerina vestita da uomo al suono di una jazz band. L’atmosfera generale fa pensare alla capitale francese. La borghesia tedesca viene dunque presentata da Lang come moderatamente in sintonia con le correnti più vive del periodo, che si intrecciano tra loro non di rado negli stessi artisti, ciascuno dei quali coglie gli stimoli che ritiene più adatti al momento artistico che sta vivendo. Scambi che sono spesso accompagnati da viaggi, frequentazione di scuole e di gruppi, in cui è centrale – ma nient’affatto sola – la città di Parigi. Così, per esempio, il Petit Casino del Palais Haydnstrasse 11, presentato come «modernissimo ambiente» in cui gli ospiti «potranno tornare all’età dell’oro» e dove vige il «motto: tutto ciò che vi piace vi è permesso!», è un ambiente elegante con séparé in stile Liberty viennese che circondano una gigantesca roulette20. Nella normalità alto-borghese ottocentesca è iscritto il salotto della veggente, privo di connotazioni moderniste (il «ritorno all’età dell’oro») e abitato da signore di mezza età, probabili amiche o sorelle della veggente, e come lei zitelle. La casa dei conti Told è invece una sorta di museo dell’espressionismo, edificato dal conte e mal sopportato dalla contessa, la quale proprio per la tristezza che il luogo le trasmette frequenta luoghi equivoci come i club/case da gioco. Le pareti di casa Told sono occupate da quadri espressionisti, accompagnati da numerose opere di scultura africana e più generalmente esotica, secondo un gusto che negli espressionisti aveva certamente un punto di riferimento (in particolare in Die Brücke, con Kirchner e Pechstein), ma che aveva origine anche in altre avanguardie, anzitutto nel contesto
postimpressionista (dal Giappone di Van Gogh e dalla Tahiti di Gauguin alle opere di Picasso, Braque, Matisse, Modigliani)21. E sarà in quell’ambiente che il conte alla fine vagherà di notte con un candelabro in mano, prima di uccidersi per disperazione, immerso in un gioco di luci e ombre memore dell’arte espressionista. In quel salone, pochi giorni prima, si era tenuta una festa poi conclusasi al tavolo da gioco (dove peraltro il conte non giocava mai) con l’ipnosi di Mabuse e la conseguente accusa di baro che avrebbe spinto al suicidio l’ignaro padrone di casa. Prima del gioco, dopo essere stato inquadrato accanto a un grande camino con la fiamma accesa, sovrastato da un altrettanto grande quadro espressionista raffigurante il diavolo, Mabuse si era avvicinato al conte e ai suoi amici e aveva risposto a Told che gli aveva chiesto che cosa pensasse dell’Espressionismo dicendo: «l’Espressionismo è solo un giochino [Spielerei]… ma perché non giocare? oggigiorno ogni cosa è solo un giochino». Al che il conte: «Visto che ogni cosa è solo un giochino, Signor Dottore, spero che a voi non dispiaccia se noi proprio adesso ci dirigiamo al tavolo da gioco». Mabuse non si unisce al gruppo e va a scortare la contessa: percorrono un corridoio che ha l’aspetto di una galleria d’arte e si siedono in un séparé ornato da due giganteschi cactus. Ed è da lì che Mabuse ipnotizzerà il conte facendolo barare, per poi rapire la contessa. Le vie della città di notte sono l’occasione per Lang di lavorare sulle luci in profondità di campo, e di giocare con la sovrimpressione nell’inquadratura di un cavalcavia su cui passa un treno in corsa. E le strade di campagna ripropongono brevemente l’inseguimento tipico di tanto cinema muto statunitense, con l’aggiunta delle scritte che in sovrimpressione rincarano l’umore sonnambolico del film. Gli ultimi ambienti di riferimento che annoto confermano la ricercata atmosfera Kammerspiel della messa in scena langhiana. La cella della prigione in cui viene condotta Carozza mostra un’ulteriore riduzione e congestionamento degli spazi. E il bar dei lavoratori, in
cui si nota il volto di un giovane intellettuale, è antitetico ai predominanti ambienti borghesi: è un luogo ordinario piuttosto povero e senza particolari connotazioni, salvo il fumo delle sigarette che lo invade. La sala della filarmonica, in cui Mabuse mascherato da illusionista tiene l’ultimo dei suoi spettacoli, ha un grande palcoscenico analogo a quello iniziale della borsa. Su di esso avanzeranno dal fondo della scena cavalli e cammelli con i loro proprietari mediorientali, risultato dell’ultima riuscita ipnosi di gruppo (la vastissima platea borghese) cui il protagonista darà vita sotto il nome di Sandor Weltmann22. Il canale delle fogne, infine, al di là del valore simbolico, consente giochi luministici e, collegato con la grottascantinato in cui vivono i ciechi e in cui finirà l’avventura di Mabuse, richiama l’opera teatrale di Maksim Gor’kij Bassifondi, scritta tra il 1901 e il 1902 e rappresentata nei teatri di tutto il mondo con grande successo. I PERSONAGGI
Fin dalla prima inquadratura del film, con le mani di Mabuse che sfogliano le foto/cartes des visites23, appaiono i diversi travestimenti da Spieler che lo caratterizzano come personaggio. Questa apertura (di mani-foto-carte) è «un’immagine di controllo e potere», che si articolerà nelle impeccabili performance del protagonista, nei suoi vari (ruoli) avatar24: di grande capitalista, venditore ambulante e illusionista. E quando utilizzerà il gioco delle carte, esibendosi anche come giocatore d’azzardo, lo farà soprattutto per ipnotizzare le sue vittime, per manipolarle a suo profitto nell’ennesimo trasformismo attoriale-illusionistico da infallibile «(Puppen)spieler» (burattinaio)25. La sequenza della borsa in Mabuse pullula di turgidi cappelli a cilindro e volti frenetici, signoreggiata dall’ubiquo Doktor, esplicito riferimento all’esplosione della crisi economica tedesca: alla fine, restano nella sala silenziosa e vuota un cimitero di cartacce bianche e il presentimento di una minaccia incombente.
Nel suo delirio passionale, la danzatrice Carozza ha idealizzato la figura di Mabuse e la colloca estensivamente al di là di tutto e al di sopra della massa, composta da «miserabili creature». A fronte dell’amore incondizionato di lei, Mabuse nega ogni forma di coinvolgimento emotivo. Dice alla contessa, poco prima di ipnotizzare il conte: «Non esiste l’amore, esiste solo il desiderio. Non esiste la felicità, esiste solo la volontà di potenza». E dopo aver rapito la contessa e averla portata sul divano-letto che era stato di Carozza, esclama: «Mia». Infine, ordina a Carozza di suicidarsi. Le parole di Mabuse si accordano bene con gli slogan di un’epoca, inquietante premonizione del “trionfo della volontà” del Terzo Reich. Le tante facce del protagonista – dispiegate nelle foto/cartes des visites d’apertura e poi agite nelle sue avventure – sono maschere dietro le quali si rivela una sola cosa: la volontà di potenza («Es gibt nur Willen zur Macht»), come dice lui stesso alla contessa. Un «ritratto del potere», quello del dottor Mabuse, «ma di un potere molto particolare, individuale e impersonale al tempo stesso, simile a quello che Adorno chiamava la “maschera del carattere” tipica dell’esercizio del potere politico ed economico moderno (capitalistico)»26. La deriva e la maladie di un tempo senza orizzonti hanno l’esito più immediato nella tragedia del nazismo ma per Lang sono la condizione esistenziale di base, come preciserà sempre di più nella sua opera futura. La fisionomia narrativa del suo protagonista, che convoglia in sé la minaccia di un pericolo incombente, è sintetizzata nel finale da Mabuse con un’ossessione dichiarata: «Mi sento come uno Stato dentro uno Stato con cui sono sempre stato in guerra». Non è certo un caso che il suo avversario sia il procuratore di Stato, «il campione della legge e dell’ordine» von Wenk27, e che questi decida alla fine di far intervenire l’esercito per sconfiggere l’Anti-Stato. Un Anti-Stato che Mabuse incarna in preda al delirio di onnipotenza e che precipita in pazzia quando realizza di essere stato sconfitto28.
Von Wenk è riflessivo ma deciso, non esita a utilizzare il suo amico Karsten per poter entrare nelle bische segrete e neppure a truccarsi per non farsi riconoscere, in fondo subendo anche lui il fascino di Mabuse. È un personaggio disegnato a tutto tondo, con i suoi sospetti, le premonizioni, l’innamoramento per la contessa. Incarna l’idea di uno Stato intento a ripristinare l’ordine, a sconfiggere il caos e l’anarchia sociale, a fronte di una modesta prontezza nel cogliere la realtà. Un coté comportamentale, il suo, funzionale alla suspense del genere poliziesco29. Non manca un carnet femminile, che il film declina secondo schemi aderenti alla tradizione del genere e agli stereotipi del gender, capitanati da Cara Carozza, una danzatrice di rango, che è stata l’amante di Mabuse, di cui è ancora follemente innamorata anche se lui ora la rifiuta. Ciò che la attrae dello Spieler è che lui gioca molto meglio degli altri, in un modo che lo rende superiore a tutti. Nel colloquio in carcere in cui la contessa, convinta da Wenk, cerca la sua collaborazione nell’individuare Mabuse, Carozza esclama con trasporto: «Chi lui sia nessuno lo sa! Lui è qui! Lui è vivo! Vive al di sopra della città, grande come una torre, è la dannazione e la salvezza! È il più grande uomo vivente! E mi ama! […] Come puoi pensare che io tradisca quest’uomo speciale per voi miserabili creature!». Una profusione amorosa che stupisce la contessa, che le chiede perdono e la chiama Fräulein Carozza. La contessa Told è la nobile annoiata dalla vita e intristita da un marito che non è in grado di gratificarne la femminilità. Non ha mai conosciuto il vero amore e in prigione, dopo aver capito il sentimento che Carozza prova per Mabuse, confida a se stessa: «Questo esiste nel mondo?». Allo psicanalista Mabuse la contessa riserva in apparenza un netto rifiuto, ma in fondo anche lei ne subisce intimamente il fascino: ancora l’ambiguità di Lang nel rapporto con la psicanalisi. Alla fine gli resiste, impedendogli di portarla via con lui dalla casa in cui ormai sta entrando l’esercito, e appare frastornata quando Wenk la salva definitivamente e avanza un approccio affettivo, che lei rifiuta (si direbbe: per il
momento). Un rifiuto che suggerisce uno scompiglio emozionale che va oltre la prigionia e riguarda altresì il suo rapporto profondo con Mabuse. Su queste due figure femminili, «fra loro contrapposte, una il riflesso dell’altra, in modo quasi troppo semplicistico», osserva Raymond Bellour: Da un lato la Carozza, la sola donna della banda […], che riassume in un’apparizione sulla scena il tipico feticismo voyeuristico nei confronti della donna. […] Al contrario, la contessa Told, la «voyeuse», [è] come estraniata da se stessa a tutto profitto dello sguardo che si diverte a fare indugiare sulle cose […]. L’eccesso di desiderio e la sua mancanza si alternano in questa storia, mito e matrice – dove la donna, anche se è un po’ marginale, è doppiamente sottoposta al male30.
Il conte Told “gioca all’espressionista”, tagliato fuori dal mondo, collezionando opere d’arte terribili di cui certamente conosce il senso – riassunto nel diavolo sul camino – ma che assume come qualcosa che non deve turbarlo. La sua terapia è il collezionarle, quelle opere che scavano nell’ignoto, come per gli artisti la terapia è realizzarle: «un giochetto» (Spielerei) lo definisce Mabuse, poco prima di rovinare per sempre il conte, suo rivale in amore. Hull è il giovane borghese moderatamente entusiasta e capace di slanci e di innamoramento. Vive in una casa molto confortevole e non aspetta altro che di innamorarsi, ricambiato, di una donna che sia fiera della sua femminilità e che la esibisca ricevendone applausi: la danzatrice Carozza, di cui si è invaghito allo spettacolo nel cabaret. E lei, di mala voglia, obbligata da Mabuse, lo circuirà. Un entusiasmo che lo porterà alla morte insieme con l’altro alto-borghese Karsten, anche lui individuato in pochi tratti gentili come ricco frequentatore di club privati e bische semi-clandestine. L’altro lato della società è inquadrato da Lang nei seguaci di Mabuse: Spoerri, il cocainomane terrorizzato da tutto e attaccato a Mabuse in un rapporto di dipendenza assoluta; Hawasch, il grassone che stampa le banconote false e all’occorrenza non esita a uccidere; Pesch, irrilevante servo di Mabuse; Georg, l’autista convinto sostenitore (non si capisce bene perché) del suo padrone, di cui esegue gli ordini più sanguinari e che alla fine si
impiccherà in cella scrivendo sulla parete: «baciatemi il culo». RISORSE FORMALI E LIMITI DEL RISPECCHIAMENTO LANGHIANO
Il film si svolge quasi tutto in interni, e in spazi per lo più grandi, in sequenze che hanno spesso l’unitarietà della scena e iniziano o contengono generalmente totali di grande efficacia, ripresi in profondità di campo. Ciò accade in particolare nella borsa, nella sala della conferenza di psicanalisi, alle Folies Bergères, al Club 17+4, all’hotel Excelsior, nella casa di Hull, allo Schramm’s Palais, nella casa dei conti Told, al club di Haydnstrasse 11, nel salotto della veggente, alla filarmonica. Alla estrema cura degli ambienti, che contribuisce al Bild der Zeit, si associa la qualità dell’immagine, sia nelle luci sia nella diffusa profondità di campo, che dilata lo spazio visivo, spesso oltre l’uso abituale nel Kammerspielfilm, e che ha in Mabuse una chiara funzionalità (raf)figurativa dell’epoca: è la società intera che viene fotografata fin nei dettagli, e il film costituisce uno specchio preciso per la parte borghese degli spettatori che negli ambienti e nei personaggi può riconoscersi. La meticolosità dei dettagli è abbinata a quella dei dialoghi, che fanno sì che il montaggio equivalga talora a un piano sequenza: delle 4 ore e mezza di film 43 minuti sono costituiti dai 342 cartelli che riportano le frasi di dialogo (esclusi tutti gli altri); un’evidente aspirazione al cinema sonoro, che arriverà solo pochi anni dopo31. A questa sorta di montaggio in continuità sono abbinati alcuni flashback e il montaggio alternato di scene che si svolgono contemporaneamente, fin dalla prima sequenza della rapina sul treno, con una precisione che com’è noto interessò anche Ėjzenstejn, che studiò il film con grande attenzione. Questo dialogo tra tipologie di montaggio rende efficaci i dettagli di scenografia e costumi, il gioco delle luci, le psicologie dei personaggi, l’iter diegetico dalla rapina sul
treno alla sparatoria finale in strada. Inoltre, l’uso diffuso dell’iride (non solo nel passaggio da una scena all’altra) è del tutto coerente con il tipo di montaggio scelto, come pure con la focalizzazione su un personaggio o su un particolare dialogo. Un’altra risorsa formale costante nel film è la sovrimpressione, per lo più utilizzata da Lang in momenti allucinatori e fantasmatici, come nella scena in cui il conte Told rivede il tavolo da gioco in cui ha involontariamente barato popolato da suoi cloni, o il finale in cui i ciechi della stamperia clandestina si trasformano nei personaggi di cui Mabuse ha causato la morte: Hull, Told, Pesch, Carozza. Il potere di Mabuse – scrive Tom Gunning – è stato il potere dello sguardo, i suoi poteri visivi occulti volti a costringere gli altri a focalizzarsi sul suo sguardo fisso e la sua abilità di attrarre lo sguardo degli altri, di affascinarli come un performer. […] Mentre precedentemente tutto il mondo sembrava rispondere alla sua volontà, ora il suo ultimo dominio si popola degli spettri della sua propria immaginazione32.
Il Bild der Zeit, che appare efficace per quanto riguarda la borghesia tedesca, non lo è altrettanto per i personaggi e le comparse che borghesi non sono. Il gremito bar degli operai, infervorati dagli slogan di Mabuse-capopopolo, è scenario di un confuso populismo (pseudo)rivoluzionario, utile alla mobilitazione di massa e all’uccisione di Pesch da parte di Georg. Siamo negli anni della Repubblica di Weimar, eppure la società è dipinta come se questo non contasse. Certo si può capire che Lang non potesse prendere posizione in questi anni di durissimi conflitti interni agli stessi repubblicani, ma ciò non toglie che il suo “ritratto del tempo” ne risulti parziale. Tuttavia va riconosciuto, alla luce dell’ascesa hitleriana, che il quadro d’epoca langhiano centrava due questioni cruciali: il ruolo del capitale e dell’economia e l’indifferenza di una borghesia ignava. Quello che maggiormente colpisce nel plot è piuttosto l’incongruenza che c’è tra le ambizioni di Mabuse e le scarse energie umane su cui può contare. I suoi accoliti, per quanto ottimamente caratterizzati per un poliziesco,
sono improbabili come effettivo aiuto alla… conquista del mondo! Non solo: il predominio che esercita sulla contessa si risolve presto nella decisione di abbandonare la città portandola con sé e dimenticando, si direbbe, la sua ansia di conquista di un potere che tutto faceva pensare avesse una dimensione ben più ampia. La sua sarà una sconfitta totale, considerando l’esito della fuga: qualcosa che ha il sapore di una nemesi, anche per il minaccioso animarsi espressionista delle sue macchine. Queste macchine di contraffazione, ora animate da una costellazione di occhi e artigli che Mabuse non può più governare, suggellano l’apoteosi allucinatoria del sistema di falsificazione e manipolazione che ha perpetrato, un «apparato che ha creduto di dominare in tutte le sue forme», dal «destino delle persone con cui ha giocato […] alle illusioni visive che sembrava suscitare negli altri»: Il potere nei suoi occhi si è spento e la sua identità finale mima quella della maggior parte dei suoi abbietti lavoratori, il cieco, con le mani tremanti, lo sguardo sfocato e i movimenti ripetitivi. L’uomo che poteva manipolare e trasformare la sua identità finisce senza averne una – l’uomo che era stato Mabuse. Ora è ridotto alla tabula rasa che soggiaceva a tutte le sue identità, la carta bianca in attesa del timbro contraffatto. Il suo potere è finito, il film finisce precipitosamente. L’iride conclusiva non esprime più lo sguardo o il potere dell’enunciazione di Mabuse. Viene condotto esitante fuori dal film33.
[1.]
[2.]
[3.]
Metropolis di Paolo Bertetto La storia di Metropolis non è un percorso lineare. È un processo articolato che sviluppa itinerari molteplici e contraddittori. È la storia della sua realizzazione, innanzitutto. Poi è la cronaca della sua diffusione, a cominciare dalla prima a Berlino. Ma subito dopo è anche il processo, paradossale ma non incredibile, della sua distruzione. E infine è la cronaca della sua ricostruzione. Un percorso in quattro movimenti che raccontano la storia di un testo e di una pellicola, di un sistema significante e di un corpo materiale. È la sera del 10 gennaio 1927. All’UFA-Palast, alla presenza di personalità del mondo della finanza e dello spettacolo e di autorità dello Stato come il cancelliere del Reich, Wilhelm Marx, e i ministri Stresemann e Gessler, l’industria cinematografica tedesca realizza uno dei suoi riti più importanti: la proiezione del film a più alto budget mai prodotto in Germania, un film capace di competere con i kolossal americani sul piano della spettacolarità e di superarli per la ricchezza del messaggio e la forza delle immagini. Un film volto a coinvolgere il pubblico in un intreccio popolare di amore e di morte, di schiavitù e di rivolta, di vendette e di inganni, e impegnato a elaborare un modello complesso di strutture architettoniche e di visioni del futuro (e forse del medioevo prossimo venturo), destinato a durare nel tempo e a diventare quasi una figura dell’immaginario popolare del XX secolo. Quel film a lungo non è più esistito. Enno Patalas e il Filmmuseum - Münchner Stadtmuseum hanno iniziato una difficile ricostruzione, finché più recentemente nel Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken di Buenos Aires è stata ritrovata una copia a 16 mm del film nella prima versione (che nell’originale a 35 mm era di 4189 metri) completa. Successivamente l’UFA aveva distribuito una versione più corta di circa 3200 metri e con la distruzione degli archivi di Berlino le copie erano andate perdute. Ora finalmente si può vedere la versione quasi
completa, ma non virata, predisposta dalla FriedrichWilhelm-Murnau-Stiftung, anche se, per il momento, le parti tratte dalla versione a 16 mm sono di qualità visiva inferiore1. «KUNSTWOLLEN» E CINEMA TOTALE
Grazie al lavoro di restauro, dunque, Metropolis si presenta nella sua completezza come una grande esperienza di messa in scena che riflette la volontà di realizzare un cinema totale. Come in pochi altri film della storia del cinema, il progetto langhiano punta alla costruzione di una complessità capace di raccogliere e di sviluppare tutta le potenzialità del cinema. Così da un lato Lang elabora immagini di una spettacolarità estrema caratterizzate da una ricerca della monumentalità. E dall’altro crea forme visivo-dinamiche complesse finalizzate alla rivelazione della psiche e dell’inconscio e segnate da una reinvenzione dell’immagine di grande intensità formale. È l’opzione di raccogliere in una sintesi avanzata l’infinitamente grande e l’infinitamente piccolo, in un’operazione che implica l’allargamento sistematico e intenzionale dell’orizzonte del cinema. Innanzitutto la realizzazione di una forma di cinema totale è effettuata da Lang attraverso un’affermazione della centralità e della polivocità della messa in scena come grande progetto di creazione artistica, come oggettivazione di un’idea forte di Kunstwollen, di volontà d’arte. Per tradizione il cinema di Lang è considerato un cinema di messa in scena rigorosa. E il progetto formativo di Lang comincia proprio dalla strutturazione tecnica del concreto e dal dominio formale su tutti gli elementi materiali: l’allestimento della scena e la direzione degli attori, l’illuminazione e i movimenti nel profilmico, l’architettura e l’occhio della macchina da presa. Vediamo. L’apertura del film, dopo il passaggio da un’immagine disegnata a un’immagine analogica, mostra un universo di macchine produttive attraverso una serie di immagini variabili, sovrapposte, diversamente
montate, che si modificano in continuazione, trasformandosi l’una nell’altra con un effetto di mobilità e di pluralizzazione estremamente suggestivo, che viene registrato sostanzialmente senza modificare il punto di ripresa. Le grandi ruote di metallo in movimento, gli stantuffi, le bielle, gli ingranaggi variamente combinati occupano lo schermo con la loro imponenza, coordinati attraverso sovraimpressioni, dissolvenze incrociate, mutamenti di illuminazione, creando una sorta di poema delle macchine, legato all’iconografia della civilisation machiniste. La fluidificazione dell’immagine mediante l’uso di tecniche raffinate realizza una sorta di spazio virtuale e concettuale, che costituisce certo una delle più rilevanti linee di costruzione del film. La prima determinazione del film è quindi essenzialmente visiva e, insieme, intellettuale: prima di costruire e descrivere uno spazio d’azione, cioè uno spazio in cui l’architettura (o il paesaggio urbano) e l’azione dei personaggi si fondono, Lang preferisce fornire il “correlativo oggettivo” (per usare una formula di Eliot) del quadro, della dimensione in cui si sviluppa il film. L’orizzonte della meccanizzazione, della produzione industriale è quindi subito evocato e configurato come l’elemento distintivo primario dell’universo diegetico del film, e come il fondamento stesso dell’organizzazione della vita associata nella città di Metropolis, cioè di Metropolis come società formata. E la scelta di macchine produttive contemporanee a Lang e non futuribili attesta subito come la rappresentazione di Lang si proponga di essere un discorso sul problema stesso del lavoro e della società industriale, facendo apertamente di Metropolis il primo grande film sulla complessità dei problemi del mondo produttivo contemporaneo. A uno spazio determinato, organizzato da diversi punti di vista, si passa invece con il secondo segmento del film, che, pur senza mettere in gioco ancora nessun personaggio riconoscibile, comincia a delineare la realtà di Metropolis e i modelli di comportamento imposti dall’organizzazione rigida della vita associata. La sequenza è costruita da un lato attraverso il
coordinamento grazie al montaggio di spazi diversi, dall’altro mediante l’accumulo di piani omogenei, ripresi da punti di vista differenti. La configurazione punta subito a una costruzione dialettica, ossia alla produzione di insiemi capaci di garantire se non l’idea immediata di una totalità in atto, almeno il riferimento tendenziale a una complessità in cui ogni elemento rimanda agli altri. Gli spostamenti molto lenti, quasi automatici dei lavoratori uniscono spazi diversi, dai corridoi illuminati negli inferi, ai grandi elevatori, alla città-dormitorio, con i tipici casermoni operai, organizzati attorno alla grande piazza con al centro il gong colossale. Le macchine, il tempo, gli operai disanimati sono coordinati in un circuito reattivo particolare di tipo concettuale. Le immagini appaiono impregnate di un messaggio intellettuale, sono portatrici di idee. Sono immagini eidetiche2. Il dittico iniziale, infatti, racchiude alcuni nodi essenziali, a cominciare da una determinazione complementare, di natura eidetica, che, riprendendo e rielaborando una significativa formula di Worringer, potremmo definire animazione dell’inorganico e in opposizione disanimazione dell’organico. Il primo segmento, la sequenza delle macchine, è infatti una costruzione del dinamismo della macchina realizzata con tecniche sofisticate che producono un effetto palesemente artificiale e insieme estremamente concreto. Le immagini delle macchine non sono lontane dalle sinfonie meccaniche dell’avanguardia, dal Ballet mécanique (1924) di Léger, che forse Lang conosceva (era stato proiettato a Berlino all’UFA-Palast il 3 maggio 1925), a Photogénie (1925) di Epstein, a Photogénie mécanique (1924) di Grémillon, che probabilmente Lang non aveva visto. Sono invece posteriori a Metropolis le altre significative sinfonie meccaniche dell’avanguardia, da La Marche des machines (1929) di Deslaw a Thèmes et variations (1928) di Germaine Dulac a Forges (1931) di Tedesco. Ma figurazioni significative del meccanico sono anche presenti nei film sovietici influenzati dal costruttivismo e in particolare in Ėjzenštejn e in Vertov. Le riprese ravvicinate delle macchine, la scelta di oggetti
meccanici grossi, ingombranti e solidi – a differenza ad esempio delle macchine di Léger o di Deslaw che sono più piccole e più leggere, o delle macchine del segmento finale di Futurismo (L’inhumaine, 1924) di L’Herbier, meno complesse e più stilizzate –, l’attenzione visiva alla potenza, oltre che alla mobilità dei meccanismi inquadrati, producono un effetto di gigantismo visivo, di amplificazione innaturale dell’oggetto che non a caso ricorda le teorie di Léger, sul potere assolutamente particolare del primo piano. Ma questa forte presentificazione degli oggetti meccanici in movimento insieme invera l’oggetto e gli attribuisce una sorta di vitalità, di animazione artificiale. Non si tratta soltanto di un processo compositivo che sottolinea la mobilità dell’oggetto, ma di una più profonda operazione di trasformazione del non-vivente in vivente, dell’inorganico in organico. È una sorta di metamorfosi quella che Lang realizza con l’apertura di Metropolis, che tuttavia si attua senza nessun passaggio da un oggetto o da una figura o persona a un’altra. È una trasformazione realizzata non mediante uno stacco, ma, al contrario, con un lavoro interno all’inquadratura, e certamente più complesso e pienamente filmico. È una metamorfosi che investe la struttura interiore dell’oggetto, e, animando la macchina, la predispone a un ruolo di dominio, di subordinazione dell’umano, cominciando quasi a sottolinearne la potenziale pericolosità. Questo modo di simbolizzazione produce un effetto di spiazzamento che la seconda sequenza del film conferma e raddoppia con un procedimento assolutamente opposto. La composizione visiva e la coreografia delle disposizioni e dei caratteri dei lavoratori di Metropolis al cambio turno puntano a una vera e propria metamorfosi del materiale per ottenere un effetto di totale pietrificazione. Il lavoro di messa in scena di Lang si esercita soprattutto sulle masse operaie, che vengono sottoposte a una precisa operazione di riqualificazione visiva. In primo luogo tutti i lavoratori sono vestiti di tute scure,
procedono in file ordinate che formano rettangoli compatti di persone, camminano con le spalle chine, la testa bassa e un passo lento e scandito. In tutta la sequenza le masse operaie aderiscono in forma sempre più precisa allo spazio in cui si trovano, e si integrano alle strutture architettoniche in modo così radicale che in fondo non vi si appiattiscono, ma addirittura vi si identificano. Le masse operaie sono esse stesse architetture, solidi pietrificati, elementi solo apparentemente mobili di un paesaggio urbano quanto mai funzionale e pesante. Non sono statue, suggestivi ornamenti decorativi, come erano ad esempio i guerrieri burgundi ne I Nibelunghi (Die Nibelungen, 1924) dove l’insieme dei soldati con armature e tuniche decorate secondo i modelli delle miniature medievali manteneva pur sempre un carattere di ornamento fuso nell’ambiente architettonico e paesaggistico, ma distaccato da questo. Nella sequenza di Metropolis, invece, non vi sono persone né individualità identificabili, né ancora statue che si ergono nello spazio, ma solo strutture architettoniche che si dispongono le une accanto alle altre per disegnare un ambito di totale pietrificazione. Se la prima sequenza di Metropolis è dominata dal senso plastico e dal dinamismo, la seconda sequenza mostra una sorta di “architetturizzazione” dello spazio filmico, di riduzione a pietra di ogni elemento destinato allo schermo. È un’operazione opposta e complementare a quella realizzata nella prima sequenza: all’animazione dell’inorganico si sostituisce qui una disanimazione dell’organico. La messa in scena di Lang sottrae apertamente agli operai ogni componente individualizzante, ogni carattere di soggettività, riducendoli a mera sostanza, li priva dell’organico, quasi li mineralizza. Lang non ricorre né a didascalie né a componenti narrative forti. Si affida totalmente al lavoro della messa in scena, alla spazializzazione e alla visualizzazione del materiale. L’organizzazione visiva degli elementi produce una significazione precisa e ricca di valenze a un tempo. Le immagini diventano pensiero. La mineralizzazione visiva degli operai non è soltanto una soluzione registica
di indubbia suggestione: è un concetto espresso con grande forza visiva. Questa riduzione degli operai a presenza disumanizzata, a cosa, costituisce una sorta di oggettivazione della reificazione degli operai, della loro disumanizzazione nel processo di produzione capitalistico teorizzata da Marx e poi negli anni venti in Germania da Lukács. I lavoratori sono privati dell’antropologico e sono mostrati come oggetti, cose. Più efficacemente di quanto abbia fatto il cinema di sinistra sovietico e tedesco – che insistono sulla miseria delle classi subalterne –, Lang ci mostra l’effetto disumanizzante e reificante del lavoro industriale e investe l’orizzonte stesso del modo di produzione capitalistico e non alcuni suoi effetti collaterali. Le immagini di Lang costituiscono la più approfondita oggettivazione del mondo industriale e della sua riduzione del lavoratore a cosa. Più ancora di quanto accade in Tempi moderni (Modern Times, 1936) di Chaplin, ad esempio, o in A me la libertà! (À nous la liberté, 1931) di Clair, o nella figurazione di una civiltà aliena in Aėlita (Аэлита, 1924) di Protazanov. Attraverso la disanimazione dell’organico Lang costruisce un’anomalia, una formalizzazione visiva del materiale che, proprio per la sua particolarità, per il suo carattere di violazione della norma visiva, ha una immediata rilevanza concettuale. Come sottolinea Arnheim ne Il pensiero visivo (Visual Thinking, 1969) sono proprio l’allontanamento dalla norma visiva e la stilizzazione a consentire al linguaggio visivo una più completa produzione di idee. Il lavoro di Lang punta a cogliere visivamente la struttura fondamentale di un’idea, a costruire cioè una figurazione simbolica. Il suo è un cinema di figurazione eidetica. Mentre Wiene e Martin e il modello scritturale del Caligarismus realizzano una stilizzazione intellettuale operando una comunicazione di idee attraverso la deformazione del visibile, Lang non altera il mondo fenomenico, ma lo figura attraverso raffinate procedure di geometrizzazione, che si integrano perfettamente con l’altra grande opzione del suo lavoro
compositivo: la produzione del gigantismo, la monumentalizzazione degli elementi. Lang opera intenzionalmente nella prospettiva della costruzione di macrostrutture visive, della trasposizione di ogni componente del quadro in una scala moltiplicata. È la tecnica del «monumentalisieren» di cui parla Lotte Eisner ne Lo schermo demoniaco (L’écran démoniaque, 1952) rievocando una linea di pensiero che va da Langbehn a Worringer a Spengler, nel sottolineare la tendenza dello spirito tedesco a costruire forme monumentali. Ma per Lang non si tratta soltanto di costruire in proporzioni monumentali per un mero gusto decorativo magniloquente, peraltro perfettamente legittimo. Per Lang, invece, ne I Nibelunghi e ancora più in Metropolis, il lavoro di monumentalizzazione riflette la volontà di inscrivere il contingente nell’essenziale, di trasformare il leggendario o il futuribile in epocale, l’epocale in metastorico. Riflette cioè il progetto di trascendere sistematicamente l’elemento e il dato concreto, l’individualità specifica di un’azione narrativa, di una situazione, per evidenziarne l’aspetto universale, la rilevanza epocale, come se fosse una forma sovrastorica di mito. La monumentalizzazione è una sorta di inscrizione degli elementi nel valore, di affermazione di un regime di ipersignificazione dei segni filmici prodotti. Come ricorda ancora Eisner, questa monumentalizzazione della scena riflette, d’altra parte, l’influenza del lavoro grandioso di organizzazione dinamica della scena propria delle regie di Reinhardt al Grosses Schauspielhaus e al Deutsches Theater, o di Piscator. LA FIGURAZIONE DI LANG. GEOMETRIA E «EIDOS»
Quello che ci interessa qui sottolineare è come tutti questi elementi vengano ripianificati linguisticamente da Lang in una prospettiva di figurazione eminentemente intellettuale, che attesta una precisa potenzialità del linguaggio filmico. Questa singolarità produttiva di
procedure è ulteriormente sviluppata nel corso del film attraverso un programma di messa in scena che punta alla realizzazione di una figurazione complessa, articolata tra l’orizzonte della geometria e l’orizzonte delle idee. La scrittura di Lang infatti elabora un modello compositivo di estremo rigore, caratterizzato insieme da criteri operativi e opzioni estetiche, che abbiamo già delineato più ampiamente nel saggio introduttivo. Lang realizza una figurazione forte del visibile attraverso un quadro di sistematica interazione di tutti gli elementi; una riduzione agli aspetti essenziali delle determinazioni visivo-scenografiche di Hunte e Kettelhut, al fine di costruire uno spazio di strutture rigorose; un’opzione compositiva specifica per la costruzione di strutture geometriche e simmetriche; una trasformazione coordinata delle strutture geometriche statiche in dinamismi che riarticolano le geometrie formali; una formalizzazione dello spazio in diretto rapporto con l’esigenza di inscrivere le idee nel visibile: è una concezione del cinema che punta alla realizzazione di una visione intellettuale, forma-idea fuse in un’unità rigorosa e produttiva; una fusione dinamica di una sintesi tra spazio rappresentato, spazio formale e spazio eidetico. In tutti gli anni venti la mise en scène di Lang lavora dunque alla costruzione di una forma dinamica che integra in sé l’idea. La forma dinamica langhiana è tuttavia diversa dalla forma dinamica di Ėzenštejn. In Lang il lavoro di messa in scena riflette la volontà di inscrivere il movimento nella forma, di creare una dimensione compositiva nuova, che realizzi un equilibrio assoluto tra forma e movimento, dinamismo e geometria strutturale. In Lang l’Eidos, come fusione di forma e idea, emerge dalla composizione e dall’interrelazione geometrico-dinamica delle componenti. In Ėjzenštejn l’idea è il risultato del conflitto tra le immagini: «Con la combinazione di due figurabili si riesce a delineare ciò che graficamente figurabile non è»3. L’idea-forma di Ėjzenštejn è nell’organizzazione del movimentocontrasto programmato degli elementi, trasformati in vettori ideologici.
LA REINVENZIONE DELL’IMMAGINE
Di estremo interesse è poi il lavoro di reinvenzione dell’immagine che Lang sviluppa per accrescere le potenzialità del visivo. Molte inquadrature langhiane infatti si presentano come uno spazio visivo-dinamico immaginario costituito attraverso un insieme di sovraimpressioni di grande impatto. Nella sequenza nelle catacombe che scatena la rivolta, le immagini della falsa Maria (Maschinen-Mensch Maria nella sceneggiatura) che arringa la folla sono infatti racchiuse esemplarmente in una serie di sovraimpressioni che vedono in basso i volti degli operai coinvolti dal comizio dell’automa e in alto a destra il volto della falsa Maria che parla con un atteggiamento esagitato. Sono immagini che creano un orizzonte irreale in cui la dimensione simbolica dell’evento è racchiusa in una configurazione artificiale esemplare. Nella medesima prospettiva vanno le immagini del piacere e della seduzione a Yoshiwara, legate allo spostamento in auto dell’operaio Georgy. Le immagini – recuperate grazie alla copia lunga trovata in Argentina – mostrano la vivacità e la varietà delle notti nel quartiere del divertimento di Metropolis. In inquadrature successive o in sovraimpressioni sofisticate si accumulano nell’immagine volti di donna, luci, corpi, immagini di locali notturni, insegne luminose, volantini gettati sulla folla. È un pot-pourri di elementi eterogenei che ricreano l’universo della città dei divertimenti come una fantasmagoria visiva, una féerie che celebra l’apoteosi della merce e del piacere offerto, dei corpi femminili e degli oggetti dell’abbondanza: una struttura fondamentale della città moderna, come hanno teorizzato prima Simmel e poi Benjamin. Una polivisione che crea effetti di suggestione e di coinvolgimento dello spettatore di grande forza ed eleganza. Una delle immagini più significative del film, poi, legata alla visione febbrile di Freder della danza erotica della falsa Maria durante la festa di Rotwang, è costituita da un insieme di occhi svincolati dai volti (o dai musi), che si dispongono in sovraimpressione nell’inquadratura,
palesando in primo luogo l’atteggiamento voyeuristico degli spettatori e contemporaneamente il carattere animalesco del desiderio che trasforma le persone in bestie. La prima inquadratura degli occhi bestiali moltiplicati è collegata metonimicamente a un’inquadratura degli spettatori in preda al desiderio, ma la travalica nettamente, inscrivendosi in un nuovo ordine di tipo metaforico ed eidetico. Gli occhi animaleschi appaiono subito in sovraimpressione su un’inquadratura dei volti infoiati degli spettatori, poi si accampano pienamente sullo schermo mentre l’immagine degli spettatori svanisce. Si tratta di un’aperta visualizzazione sintetica di un’idea. Le immagini degli occhi moltiplicati, animaleschi, trasformati in un frammento del volto, sono quattro e si alternano con piani del Maschinen-Mensch Maria che danza. L’ultima inquadratura, la quinta, è dedicata a un unico occhio, privo di connotati bestiali, che fissa l’immagine del vedere e la consacra simbolicamente per poi raddoppiarla con l’immagine di Freder nel letto che guarda davanti a sé allucinato. Lo sguardo animalesco che i trucchi filmici disegnano così bene, dunque, non è solo lo sguardo degli spettatori presenti in sala, ma è lo sguardo stesso di Freder, che produce tutte le immagini nella propria fantasticheria delirante e attribuisce ai partecipanti alla festa di Rotwang la qualità e le ossessioni del proprio sguardo. Non solo è Freder a inventare la performance erotica della falsa Maria e a guardarla con un trasporto particolare, ma è lo stesso Freder a oggettivare il proprio atteggiamento desiderante e, insieme, a censurarlo, paragonandolo a un desiderio animalesco. Così le immagini visualizzano non soltanto l’attività psichica di Freder, ma addirittura il conflitto nell’io tra un’istanza desiderante e un’istanza repressiva, tra Es e Super-io. Il segmento del trauma di Freder alla vista del padre e della falsa Maria (che lui crede essere la vera Maria) abbracciati, è poi organizzato con una scrittura vicina allo stile del cinema d’avanguardia. Le inquadrature dei volti dei personaggi che ossessionano la mente di Freder sono inscritte in una sorta di cornice geometrica di luce.
Le immagini della falsa Maria, di Fredersen, di Rotwang, di Freder stesso si susseguono e si mescolano a un’immagine della statua della morte che incombe. Ma insieme altre inquadrature astratte sono realizzate con effetti di luce “gettati” sull’immagine, che visualizzano lo shock del protagonista. Poi, alla fine, la figura di Freder, che sembra crollare e cadere giù nel profondo della propria psiche, segna il chiudersi di una esperienza del trauma. Così l’invenzione di nuove immagini, l’elaborazione di configurazioni visive di grande suggestione, liberamente create in una composizione irreale e complessa, mostrano al tempo stesso la volontà di Lang di costituire immagini innovative, segnate da un desiderio di mostrare le profondità dell’inconscio e insieme da una volontà di produzione diretta di idee nell’immagine. Sono immagini eidetiche e immagini figurali che si mescolano e si intrecciano, oggettivando strati profondi della psiche. Le stesse immagini del delirio di Freder nel suo letto mescolano insieme figure oggettive e ossessioni psichiche, delineando una configurazione complessa di elementi in cui la storia personale di Freder si mescola non solo alla storia della città di Metropolis, ma alla tradizione mitologica antica, in un singolare intreccio di simbologia cristiana e figure ossessive dalla indubbia valenza sessuale. Anche i segmenti dell’allucinazione di Freder e del racconto di Josaphat presentano una struttura di montaggio complessa, con combinazioni apertamente intellettuali. Il montaggio infatti deve coordinare spazi e inquadrature diversi per costruire il percorso difficile di un’allucinazione che procede per analogie e accostamenti certamente non razionali, ma caratterizzati da un preciso percorso del senso. È un montaggio che definisce esattamente la presenza e il dinamismo di fantasmi psichici determinati, elaborando non solo una registrazione, ma una scrittura in progress dell’inconscio. Non cura tanto i raccordi o la fluidità del
tessuto visivo, ma piuttosto costruisce accostamenti anomali, inattesi, avvicinamenti fantasmatici. Opera quindi nuovi coordinamenti e nuove integrazioni: ma nella realizzazione visiva di ossessioni particolari del soggetto che immagina, il montaggio definisce anche una concezione particolare dello status simbolico di Metropolis. Così in questi segmenti Lang elabora una struttura del delirio, un concatenamento di fantasmi psichici, e insieme un discorso di idee, un’articolazione intellettuale. L’accostamento di Metropolis a Babilonia, l’evocazione della città del peccato e dell’Apocalisse, la Morte che incombe sulla città e su Freder stesso, sono figure simboliche fondate nel delirio di Freder, ma volte a delineare in profondità l’essenza della città di Metropolis. Nel secondo segmento dedicato alle performance della falsa Maria a Yoshiwara, invece, ci si trova di fronte a esempi di montaggio produttivo dalla valenza ulteriore. Il suicidio di uno dei figli dei milionari, Marinus, reo di avere ucciso in duello Jan a causa della falsa Maria, è infatti mostrato attraverso un tipico procedimento di montaggio produttivo eisensteiniano, realizzato prima della teorizzazione di Ėjzenštejn. Lang infatti risolve narrativamente il suicidio di Marinus con due sole inquadrature: nella prima sono visibili una lettera, una pistola, un portacenere e una mano che schiaccia una sigaretta; nella seconda solo del fumo. L’azione è omessa, ma il senso è prodotto. Come scriveva Ėjzenštejn nel saggio già citato. Un modello diverso di scrittura filmica realizzato attraverso il montaggio raffinato della luce e del movimento è invece rappresentato dalla sequenza del rapimento di Maria nelle catacombe. Si tratta di una lunga sequenza senza didascalie che costituisce in fondo una forma singolare, una variante anomala e imperfetta, ma affascinante, di cinema assoluto, in cui la mobilità della luce prodotta dalla pila di Rotwang si mescola alle tenebre dello spazio e alle immagini nell’oscurità di Maria, in un dinamismo visivo di grande suggestione.
Il fascino più profondo del progetto compositivo di Metropolis risiede proprio nella dialettica che il film realizza tra un cinema di organizzazione geometrica di macroelementi visivi, di strutture architettoniche e di forme antropologiche complesse e monumentali, e un cinema di ricerca linguistica sofisticata, non aliena da segmenti di montaggio non narrativo e da sperimentazioni visivo-dinamiche mutuate dall’Absolute Film. Influenze e procedure dell’Espressionismo come della sinfonia visiva o del cinema astratto si mescolano a opzioni per un montaggio complesso ed estremamente elaborato, capace di costruire tessuti e pattern nuovi non legati a una dimensione rappresentativa, ma affondati ora nella logica dell’allucinazione, dell’incubo soggettivo, e quindi della scrittura della psiche e dei suoi traumi, ora nella strutturazione formale autonoma ed extrarappresentativa delle intensità visive, ora nella trasformazione di idee in immagini. Dalla deviazione dalla norma visiva alla stilizzazione geometrica, dal montaggio produttivo e intellettuale alla simbolizzazione diretta, sino alle composizioni visive multiple e all’uso dei trucchi in funzione concettuale, Lang realizza una ricerca radicale per spingere il cinema al di là dei confini, nell’orizzonte stesso del pensiero. Pathos e monumentalità, immagini eidetiche e ricerca sperimentale, spazialità e simbolismo, scenari dell’inconscio e simulacri, geometria e simultaneità ritmiche: il cinema totale di Lang è una razionale programmazione dell’eterogeneo, un coordinamento del differente che rifiuta l’organicità, il naturale, per realizzare la visione come complesso artificio formale. LA SEDUZIONE DELLO SGUARDO
L’incontro tra Freder e Maria nei Giardini Eterni spezza l’equilibrio funzionale su cui è basata la città di Metropolis e che ha il suo fulcro nella separazione radicale del mondo dei milionari dal mondo dei lavoratori. È quindi un passaggio diegetico che – secondo la più classica tradizione narrativa – disgrega
una condizione di stabilità per determinare una nuova tensione e uno sviluppo drammatico. Lo sguardo stupefatto di Freder nel momento in cui vede Maria e i bambini è nello stesso tempo lo sguardo di chi scopre qualcosa di nuovo, e quindi esercita un’attività precisa di conoscenza, e lo sguardo di chi si inserisce in una dinamica (narrativa) di colpi di scena, di sorprese, cioè nella situazione specifica e particolare del film d’avventura, fondato sull’azione e sull’imprevisto, o del romanzo feuilleton fondato sulla iterazione periodica delle sorprese. Contrapposto allo sguardo di Freder è quello di Maria, intensivo, diretto, volto ad affascinare. C’è infatti una differenza radicale di statuto e di struttura tra lo sguardo di Freder e lo sguardo di Maria. Lo sguardo di Freder è uno sguardo per vedere, quello di Maria è invece uno sguardo per essere vista. Il primo è uno sguardo rivolto in direzione della macchina da presa per vedere qualcosa nell’universo del film. Il secondo è uno sguardo verso la macchina, apertamente seduttivo che si propone insieme di catturare Freder nell’universo diegetico e lo spettatore attraverso lo schermo. Il primo è uno sguardo diegetico, che non ha come obiettivo lo spettatore. Il secondo è uno sguardo diegeticamente motivato, ma di fatto extradiegetico, enunciazionale, che è fatto per “lavorare” il pubblico. L’uno è pienamente filmico, cioè interno alla logica narrativa del film. L’altro è certamente filmico e quindi organico alla logica testuale di Metropolis, ma insieme è metafilmico e mediologico, perché esibisce una funzione essenziale del cinema in quanto tale, cioè la funzione fascinativa. È uno sguardo che si appropria dell’altro e lo abbacina. Lo fa diventare spellbound – per usare una parola hitchcockiana. È uno sguardo meduseo. In Metropolis ci sono sostanzialmente due tipi di sguardo verso la macchina. Uno sguardo diegetico verso la macchina di tipo forte in cui l’attore fissa la macchina da presa, la attraversa e mediante lo schermo guarda lo spettatore con tutta la forza perturbante dei propri occhi. È un semplice sguardo diegetico verso la macchina, generalmente inscritto in un sistema di campi e controcampi, che attraversa la macchina da presa e lo
schermo per oltrepassare lo stesso spettatore e accompagnarlo a vedere qualcosa di particolare. Il numero molto elevato di sguardi diegetici verso la macchina da presa in Metropolis riflette evidentemente il progetto deliberato della regia di produrre un’intensificazione emozionale per realizzare profondi processi di coinvolgimento dello spettatore. L’esercizio di fascinazione più forte è naturalmente realizzato da Brigitte Helm nel duplice ruolo della vera e della falsa Maria. Si tratta evidentemente di due forme diverse di fascinazione: la prima fondata apertamente sulle più tradizionali qualità del femminile, dalla bellezza alla dolcezza; la seconda basata all’opposto su meccanismi perversi di seduzione e di cattura psichica dell’altro. Lo sguardo dell’Essere-Macchina Maria infatti opera palesemente una fascinazione demoniaca, finalizzata ad annullare la volontà dell’altro e a coinvolgerlo in avventure pericolose e distruttive. Lang sottolinea l’anomalia dello sguardo dell’EssereMacchina Maria, alterando l’occhio sinistro dell’attrice con un pesante trucco nero che rende il volto di Brigitte Helm una maschera inquietante e perversa. L’accostamento di un occhio truccato pesantemente e di un occhio meno truccato è anche, d’altra parte, una sorta di oggettivazione simbolica della duplicità della figura fisica di Maria. Il cinema di Lang, com’è noto, è un cinema rivolto non a ristrette fasce di spettatori e si avvale di strumenti spettacolari capaci di attrarre e catturare un pubblico indifferenziato, dagli spettatori più colti a quelli meno colti. E nel potenziamento degli effetti spettacolari e drammatici delle sequenze, Lang oggettiva anche il carattere altamente seduttivo della macchina-cinema. In Metropolis lo sguardo verso la macchina compare soprattutto in sequenze con pochi personaggi impegnati in rapporti psichici molto tesi, segnati ora dal contrasto, dalla volontà di sopraffazione, ora dall’intento seduttivo, ma è presente talvolta anche in alcune sequenze di massa. Si tratta in genere di sequenze dal livello emozionale particolarmente alto (ma bisognerebbe
aggiungere che quasi tutto il film è caratterizzato da una forte produzione di emozionalità), in cui i personaggi realizzano comportamenti precisamente finalizzati, che paiono quasi richiedere un surplus di determinazione e di aggressività, o, a volte, di seduzione. Ed è lo sguardo verso la macchina a costituire il segno dell’intensità e la qualità dell’emozione, quasi a guidare, e quindi a produrre, nella sua particolarità determinata e aggiuntiva, la tonalità della sequenza e della fruizione stessa. Una serie di sguardi verso la macchina caratterizza ad esempio l’insieme delle sequenze che si svolgono nella casa di Rotwang, prima con Rotwang e Joh Fredersen, poi con Rotwang, Joh Fredersen e la falsa Maria, e infine anche con Freder. Sono sequenze centrali dal punto di vista dello sviluppo diegetico del film, le quali, anche sotto il profilo delle dinamiche dello sguardo, presentano determinazioni di grande interesse. L’incontro di Rotwang e di Fredersen, antichi amici, diventati rivali e nemici per amore di Hel, madre di Freder, è subito segnato come un incontro carico di tensione. Dopo l’annuncio a Rotwang della sua visita, Fredersen è inquadrato mentre sta per entrare nello studio dell’inventore e guarda verso la macchina. Il suo sguardo non ha in questo caso né una funzione percettiva né una funzione fascinativa: costituisce una semplice e diretta intensificazione della tensione, quasi una marca per annunciare un segmento testuale caratterizzato da particolari contrasti interpersonali. Ma non è lo sguardo verso la macchina, riservato e in fondo circospetto di Fredersen a dare il tono alla sequenza, quanto lo sguardo alterato di Rotwang che dopo un PM in cui è di profilo accanto a Fredersen, appare in PPP mentre esalta il proprio lavoro finalmente compiuto con un’espressione delirante e uno sguardo folle. Gli occhi dilatati quasi senza pupille di Rotwang, più ancora della sua gestualità e del dinamismo esagitato del suo viso e della sua bocca, segnano la tonalità emozionale della sequenza e preparano il rincontro con l’inatteso assoluto dell’automa metallico. Prima che appaia l’EssereMacchina Hel e che si dispieghino sullo schermo le conseguenze tragiche del suo impiego immorale e
illegittimo, lo sguardo allucinato di Rotwang predispone già lo spettatore, preparandone l’emotività e orientandone l’atteggiamento mentale. Secondo il suo metodo consueto Lang costruisce gli effetti e le tensioni dei suoi film non per piccoli segni, ma attraverso un’accumulazione sistematica di segnali palesi, non solo per guidare lo spettatore, ma più sottilmente per produrre nella sua psiche una serie calibrata di attese drammatiche e spettacolari, cui il film puntualmente risponderà. È un procedimento che riflette la volontà di far sperimentare ogni situazione e ogni esperienza emozionale a più livelli, e in rapporto a differenti tipi di messaggi e di sollecitazioni visive. La tonalità delirante introdotta da Rotwang mediante lo sguardo, l’espressione e la gestualità, è tuttavia in qualche modo corretta in primo luogo da una nuova inquadratura di Fredersen che guarda verso la macchina da presa in atteggiamento riflessivo, contrapponendo la propria razionalità finalizzata al dominio alla ragione anomala di Rotwang. È l’ultimo sguardo diegetico verso la macchina della sequenza; poi, nella sua insensatezza e imprevedibilità – e a un tempo nel suo assoluto distacco – introduce un ulteriore elemento di ambiguità nel testo, arricchendo la dialettica di razionalità e irrazionalità perverse di cui sono portatori Fredersen e Rotwang di un altro aspetto misterioso. Il soggetto dello sguardo diegetico verso la macchina è infatti l’Essere-Macchina Hel medesimo, che dopo essere avanzato verso i due uomini ed essersi rivolto prima all’uno e poi all’altro, si ferma in un atteggiamento frontale e viene ripreso e quasi gelato in un PPP che fissa necessariamente sullo spettatore il suo sguardo vuoto e illeggibile, chiaro e oscuro a un tempo. Lo sguardo vuoto dell’EssereMacchina Hel è insieme il segno della sua flessibilità, della sua disponibilità a essere guidato, e il segno della sua impenetrabilità, del suo essere in fondo al di là della comprensione e del controllo umano, come una forza determinata, strutturata sulla base di un’alterità e di una differenza che l’uomo non può possedere e dirigere. Il suo sguardo vuoto, se non è l’esercizio di una cattura anomala del meccanico sull’umano, è però la sua
minaccia, la presentificazione di un possibile negativo senza limiti e senza fondo, la forma di un segreto. Lo sguardo vuoto verso la macchina da presa dell’EssereMacchina Hel, ripetuto in un breve inserto diegetico spostato, durante la sequenza di Maria prigioniera di Rotwang, è invero ripreso, esaltato e superato nell’inquadratura della metamorfosi dell’EssereMacchina Hel nell’Essere-Macchina Maria. Si tratta di un processo indubbiamente complesso, in quanto attesta non già un passaggio, peraltro problematico, dal meccanico all’umano, ma un più ambiguo e perverso sviluppo dal meccanico all’apparenza dell’umano, al suo sembiante illusivo, alla sua copia ingannevole. Il Maschinenmensch Maria è evidentemente un simulacro, cioè «una vana immagine» che si oppone alla realtà, o «una rappresentazione di qualche cosa», o ancora «una menzogna che fa scambiare un segno per un altro», per citare alcune definizioni di Foucault, o «un’immagine demoniaca» che «ha posto la somiglianza all’esterno e vive di differenza», per riprendere la suggestiva definizione di Deleuze4. Se l’oggetto – e la matrice della sua immagine – è nel mondo reale, la sua radice è nel demoniaco. L’EssereMacchina Maria non è soltanto la mediazione tra il meccanico e l’umano. È l’incontro tra il meccanico e l’umano realizzato attraverso la mediazione del demoniaco. È il risultato di un incontro perverso in cui la tecnologia diventa patto con il diavolo, e dal fondo della scienza emerge una pericolosa potenzialità di creazione del disumano. Il personaggio della falsa Maria si ricollega naturalmente a quella tradizione letteraria del prodotto artificiale della scienza che si ribella al suo creatore, che, com’è noto, ha nel Frankenstein di Mary Shelley il modello essenziale. Ma, in questo orizzonte di discorso, l’aspetto più pertinente è relativo allo sguardo e alla visione del demoniaco e del simulacro. Perché lo spettatore nello stesso momento guarda ed è guardato dalla produzione del demoniaco e del simulacro e coglie il momento in cui il demoniaco si afferma e il simulacro si concretizza. Il passaggio dall’Essere-Macchina Hel all’androide Maria è
in primo luogo seguito dall’analisi del volto e degli occhi senza pupille e senza cornee, vuoti, traslucidi e quasi indistinti dell’androide, che diventano vivi, mobili e differenziati. E proprio gli occhi – questa ossessione langhiana, affondata nella sua stessa esistenza – sono il punto di incandescenza del simulacro e il segno che rappresenta visivamente il demoniaco. L’unica differenza tra la vera Maria e la falsa Maria è infatti racchiusa negli occhi. Gli occhi dell’Essere-Macchina Maria sono pesantemente truccati e danno un’impressione di corruzione, palesando subito la natura perversa del simulacro. Così la trasformazione che il cinema coglie e descrive non è un passaggio dal meccanico all’umano, ma dal meccanico al simulacro dell’umano, e la metamorfosi e la mobilizzazione dell’occhio che la macchina da presa registra non corrisponde a una sua umanizzazione ma semmai a una demonizzazione. E nello sguardo del simulacro prodotto da una macchina, artificiale, pesantemente truccato, e potenzialmente perverso, si sarebbe tentati di vedere la rappresentazione simbolica dello sguardo del cinema, anch’esso prodotto da una macchina impegnata a doppiare e poi a mostrare copie illusive del reale, cioè simulacri, e simulacro esso stesso dello sguardo antropologico e di questo infinitamente più potente. Ma, nell’insieme delle inquadrature dell’incontro con Fredersen, lo sguardo perverso della falsa Maria incontra un altro sguardo meno palesemente connotato sul piano visivo, ma non meno carico di volontà di potenza. Qui, dallo scambio di inquadrature in campo e controcampo, che sono anche sguardi diegetici verso la macchina, l’occhio che palesa la propria perversità è invero l’occhio meno perverso, o, meglio, l’occhio che sta subendo un tentativo di controllo ipnotico e di comando. E nel suo spessore la dinamica dello sguardo pare quasi introdurre una complessità di lettura, rivelando una sorta di ambiguità nella perversione, di oscurità che non si rivela. LA MESSA IN SCENA E LO SPAZIO SIMBOLICO
Il lavoro di regia di Lang punta alla costruzione di una molteplice e complessa operatività dello spazio, articolata in forme e funzioni diverse. Lo spazio di Lang è infatti, in primo luogo, una costruzione in relazione con l’universo, una dimensione dialettica innervata da un’interazione contenente-contenuto. Le sue superfici sono piani che si prolungano oltre i limiti del quadro. Lo spazio del film implica una sorta di fuoricampo totale, supera i limiti dell’inquadratura, è un luogo di intersezione di piani che vanno al di là del veduto. Lo spazio diventa il centro di un vasto sistema di relazioni immaginarie la cui chiave è la geometria. Nel cinema di Lang del periodo tedesco gli elementi sono disposti nello spazio non secondo un principio naturale od organico, ma secondo un principio geometrico. E la forma privilegiata della geometrizzazione dell’essente è la simmetria, la disposizione ordinata dei segni attorno a un asse centrale. La loro logica di funzionamento non risponde a una esigenza di organicità al tessuto dell’essente, ma di ridefinizione geometrica e formale del mondo. Detto altrimenti, l’identità di spazio e cosa non è sostanziale, ma razionale, non è funzionale, ma formale. Questo non vuol dire che lo spazio non sia unitario, anzi. Lo spazio è del tutto unitario perché è razionale e retto da un’idea di forma. Lo spazio formale di Lang è diverso da quello di Murnau. In Murnau infatti prevale uno spazio pittorico, segnato non da strutture forti, ma da una distribuzione atmosferica ed estetica della luce. Murnau crea luminosità, chiaroscuri, intrecci visivi, lavora come un pittore che delinea un quadro, disseminando punti di luce e di ombra. Lang invece costruisce strutture forti in cui gli elementi si inscrivono in un quadro geometrico, invece di scivolare l’uno nell’altro. Le strutture architettoniche nel film riflettono un sincretismo estremamente interessante – già sperimentato ne I Nibelunghi, in cui Lang aveva intrecciato i modelli del duecentesco Castel del Monte con l’espressionista Einsteinturm di Mendelsohn. E mentre nella città sotterranea le case dei lavoratori riprendono i modelli delle Mietcasernen dell’architettura
operaia austro-tedesca, sostenuta dalla sinistra, la cosiddetta “Moloch-Maschine” guarda ai progetti di architettura industriale del futurismo italiano e in particolare di Chiattone e di Sant’Elia. La città dei milionari, invece, è un intreccio di suggestioni differenti. Guarda certo allo skyline di New York, come afferma Lang: ma la Babelturm, il grattacielo più importante, riprende il progetto di Bruno Taut per il Monument des Neuen Gesetzes. E altre configurazioni scenografiche sottolineano ancora l’eclettismo di Lang, di Hunte e di Kettelhut. La scenografia per i Giardini Eterni riflette lo stile e l’iconografia della Secessione viennese e di un artista come Fidus, mentre il robot e la scena della sua trasformazione nella falsa Maria riprende i modelli di Schlemmer per il Triadische Ballett, progettato all’interno del teatro della Bauhaus, e oggi esposto nella Staatsgalerie Stuttgart. Altre configurazioni guardano alla struttura e soprattutto alle decorazioni della Schauspielhaus di Berlino e ai progetti per Saulen di Ulm. L’evocazione della Torre di Babele è condotta innanzitutto sul quadro di Pieter Brueghel, ma risente anche della Einsteinturm espressionista di Mendelsohn, secondo esempio di eclettismo già sperimentato ne I Nibelunghi. E i palazzi di Metropolis risentono certo dell’architettura radicale degli anni dieci-inizio anni venti in Germania, da Behrens a Scharoun, da Mies van der Rohe, a Gropius, a Poelzig, a Bruno Taut. Lang opera cioè una sintesi complessa, sincretica di modelli artistici diversi e li sa fondere in una forma sempre efficace e rigorosa. Ma, al di là dei modelli iconici – possibili o evidenti –, lo spazio langhiano è il luogo di una simbolizzazione complessa, articolata in forme diverse, un orizzonte che si carica di determinazioni spirituali, diventa quasi uno spazio faustiano, per citare un filosofo come Spengler che negli anni venti godeva di grande stima in Germania. Innanzitutto c’è un livello esplicito di simbolizzazione che si manifesta con la massima evidenza attraverso il ricorso alla dimensione della metafora (è ad esempio il caso della macchina che diventa Moloch, o della
machinérie scenica della falsa Maria che è la bestia dell’Apocalisse, o della statua gotica della Morte). C’è poi un secondo livello di simbolizzazione, meno esplicito, ma non meno intenzionale: è quel tessuto di elementi ambigui, plurisignificanti, quei segni in cui ora è inscritto il destino dei personaggi, ora è amplificato, raddoppiato l’orizzonte delle relazioni interpersonali, l’universo esistenziale. Sono tracciati visivi che evocano percorsi semantici e immagini che rafforzano il messaggio: i costanti riferimenti all’iconografia religiosa, le mani sul cuore di Freder, i simboli che collegano realtà diverse, la spirale conica nell’immagine di Babele (ripresa da Brueghel) e sulla scrivania di Rotwang, le ombre che intervengono a doppiare i personaggi e a scriverne l’essenza psichica o fatidica. Un livello differente è invece costituito dalle figurazioni intenzionalmente concettuali dello spazio. Dalla distribuzione verticale dell’universo metropolitano ad aspetti particolari dell’organizzazione degli elementi nello spazio e della stessa presenza antropologica; dai più elementari connotati abissi-inferno-subalternità, alto-libertà-dominio, alla più complessa e rilevante geometrizzazione dello spazio e della vita di Metropolis. C’è infine un livello di simbolizzazione estremo nel film, in cui nulla è esplicitato, le tracce sono nascoste, ma le dinamiche della significazione sono particolarmente forti. È l’orizzonte del segreto, il territorio in cui gli elementi sono dissimulati per non rivelarsi immediatamente ed emergere poi in forme occulte. È un livello virtuale, quello del segreto, un orizzonte verso cui slittano i significati e che li comprende tutti. È la forma in cui il detto sfiora il non detto e trova una via per essere senza palesarsi, per vibrare senza cadere nell’ovvietà della presenza. I simboli esoterici del pentacolo astrale e del pentacolo infernale (le stelle con il vertice rivolto verso l’altro o verso il basso) nella casa e nel laboratorio di Rotwang. Ma anche la presenza della stella a cinque punte sulla Babelturm di Metropolis, l’edificio più importante, che attesta il legame strutturale tra lo sviluppo tecnocratico e la tradizione magico-alchemica (e
guarda insieme all’architettura americana e alla ricerca di progettisti come Bruno Taut). L’IMMAGINARIO E IL SEGRETO
La fase conclusiva di Metropolis si presenta come un sistema di grandi sintesi, che ricompongono in una struttura nuova tutte le opposizioni, i conflitti e le tensioni che hanno attraversato il film e ne hanno garantito il dinamismo interno. La sintesi simbolica e politica, sottolineata anche dall’epigrafe posta all’inizio del film da Thea von Harbou, è naturalmente quella più evidente. Ma insieme si realizza una sintesi simbolica più complessa, basata sulla ricomposizione degli opposti, sul superamento del contrasto, e sulla concentrazione della tensione e dei conflitti sul capro espiatorio. Il capro espiatorio è l’elemento fondamentale della sintesi sociale e simbolica realizzata. Non solo capitale e lavoro possono incontrarsi mediante l’individuazione di un responsabile (reale o presunto) della negatività esistente, ma tutte le ricomposizioni dopo un conflitto riflettono l’indicazione di un’alterità definita come colpevole. Esemplare a questo proposito sono la rapidità e la facilità con cui Grot, gli operai e le donne proletarie che si erano violentemente contrapposti l’uno agli altri, ritrovano una saldissima unità operativa nella caccia comune alla falsa Maria, subito definita la “strega”, con perfetto stile medievale. Lang costruisce la spirale di tensione e di scatenamento dell’odio e della violenza, proseguendo nella caratterizzazione dell’azione della massa come azione irrazionale e dissennata. Ma, in fondo, sembra in qualche modo trovare maggiori ragioni e giustificazioni allo scatenamento primitivo contro l’Essere-Macchina Maria di quante ne avesse voluto trovare nel momento più acuto della ribellione e nella distruzione della Herzmaschine. Il montaggio collega strettamente i due capri espiatori nel momento stesso in cui l’Essere-Macchina Maria si trasforma nel robot, nell’Essere-Macchina Hel: con una
soluzione suggestiva che il romanzo non prevede, appare sul cornicione del tetto della cattedrale l’altro capro espiatorio, Rotwang, mentre ormai impazzito insegue forsennatamente la vera Maria. Naturalmente è Freder, che dopo lo shock e la morte simbolica della malattia è diventato un protagonista lucido e attivo, il primo a vedere Rotwang e Maria, ed è lui che corre per liberare la donna. La punizione finale di Rotwang e il riscatto di Joh Fredersen infatti risultano, sotto il profilo dell’etica interna al narrato, parzialmente incongrui. Fredersen non solo è responsabile delle ingiustizie sociali e della dura organizzazione del lavoro di Metropolis, ma è anche l’ispiratore delle azioni e degli inganni a più alta valenza distruttiva di tutto il racconto. La conclusione del film ha in ogni modo un carattere fortemente simbolico. Lo spazio degli eventi finali è naturalmente lo spazio attorno alla cattedrale e la cattedrale stessa. Lo scontro tra Freder, il Mediatore (der Mittler), e Rotwang, il mago-scienziato demoniaco, avviene sul tetto della cattedrale. L’incontro finale tra il rappresentante dei lavoratori e Fredersen, il capo di Metropolis, auspici Freder e Maria, è situato sulla scalinata davanti al portale della cattedrale. La cattedrale è lo spazio spirituale in cui si delineano le valenze e le figure simboliche definitive di Metropolis, come tesori spirituali a futura memoria. Il tessuto ideologico di una siffatta strutturazione simbolica delle componenti e delle funzioni sociali rinvia a una società cristiana guidata da un capo e sostenuta dalla legittimazione della fede. Ma quel “cuore” enfatizzato dall’aforisma di apertura ha forse rilevanze ulteriori. C’è da chiedersi infatti se il cuore non sia anche il biologico, l’unità o l’omogeneità antropologica, e dunque razziale. E Rotwang, il capro espiatorio eliminato, presenta anche elementi semitici, confermati dal romanzo, che parla di un sapiente venuto dall’Oriente. Alla fine del film le masse operaie, inquadrate secondo una struttura triangolare compatta, simbolo del loro
organizzarsi sensato come forza sociale dialogante, vanno a stringere un contratto simbolico con il capo di Metropolis, Joh Fredersen, il tecnocrate, il cervello più lucido di Metropolis5. E l’accordo è favorito e sancito da Freder, aiutato ancora da Maria. Ma in questa struttura di relazioni simboliche che si stabiliscono, chi pacifica, chi legittima, e insieme chi è il capo e chi è il promotore della rifondazione, chi è l’auctor? Qual è il segreto che si delinea? È plausibile ipotizzare che l’ambiguità strutturale del film si estenda allo stesso pattern ideologico, che non va considerato né come un sistema di pensiero né come un enunciato ideologico, ma come un meccanismo di funzionamento, un’operatività ideologico-emozionale, una macchina da usare o un percorso simbolico da cui essere agito. È in questa chiave che può essere letto il presunto favore di Hitler per Metropolis: perché il film gli offriva alcuni meccanismi ideologici, simbolici e inconsci che rispondevano ad alcune sue esperienze ideologiche, simboliche e inconsce. Questo non significa che il film fosse soltanto questi meccanismi, perché il film è anche qualcos’altro, che certamente oltrepassa e in parte smentisce il processo di identificazione di Hitler. Ma significa che nel film c’erano anche quei meccanismi oscuri. L’ambiguità testuale di Metropolis presenta spessori e meccanismi assolutamente particolari. Non è soltanto una molteplicità di significazioni emergenti dal testo. È un sovrapporsi di regimi di significazione, un intrecciarsi di aperture e di chiusure del senso, di rivelazioni e di occultamenti. Al regime del detto sembra aggiungersi occultato un altro regime simbolico, che si dispone proprio sotto la soglia del dire, stabilendo una dialettica perversa con l’orizzonte del detto. Non c’è un vero segreto di Metropolis. Ci sono possibili implicazioni segrete, cioè nascoste, occultate del testo, che si dispongono una accanto all’altra o una dentro l’altra e che è possibile leggere a più livelli e in più forme. Conosciamo l’aforisma posto in epigrafe del film: «Mediatore tra il cervello e le mani deve essere il cuore».
Freder è il mediatore, è colui che rigenera Metropolis e insieme il suo stesso padre, Fredersen, riscattato in una sorta di palingenesi religiosa. Solo così si può spiegare il suo nome, Fredersen che sembra Freder-son, figlio di Freder. Perché è Freder alla fine del film che lo ri-genera e lo fa rinascere a nuova vita6. Ma nel film ci sono zone di oscurità, intrecci segreti che si nascondono in particolare dietro la figura della donna, Maria e Hel, la vera Maria e la falsa Maria. La donna della seduzione, che Freder vede nella propria allucinazione come l’immagine del peccato, della grande prostituta di Babilonia, è anche, ai suoi occhi, la donna che lo ha sedotto con un’immagine cristiana nei Giardini Eterni, avviando il suo processo di graduale autocoscienza, ed è la donna che Freder stesso ha scoperto allacciata ambiguamente con il proprio padre, il capo di Metropolis. Questi vertiginosi slittamenti di identità, questi rovesciamenti totali tra una figura identificata con il bene e una figura identificata con il male, assumono poi un’intensità traumatica ulteriore, perché Maria (e, automaticamente, la falsa Maria) diventa rapidamente la figura della Madre di Freder, di Hel, quella Madre perduta, che muore mettendolo al mondo, dà la sua vita all’Eletto e gli consegna insieme il suo sangue e la sua natura7. E Hel, nell’orizzonte segreto del film, appare come un personaggio enigmatico, a più facce. Hel è la madre di Freder, ma è stata anche la donna di Rotwang prima di sposare Fredersen. È una donna fondata a un tempo sulla relazione con il divino – poiché ha generato l’Eletto – e con il demoniaco – poiché ha amato Rotwang. È una Madre ambigua che intreccia in profondità il bene e il male, e rivela nella propria identità una duplicità misteriosa. Questa ambiguità del personaggio di Hel è assolutamente fondamentale nell’economia simbolica di Metropolis. In primo luogo perché riverbera una catena di polarità dialettiche, di slittamenti e di rovesciamenti simbolici che si riarticola e si trasforma lungo tutto l’arco del film, a partire in primo luogo, e nella forma più
palese, dal suo doppio, Maria, e nella forma più nascosta da Freder stesso. Gli slittamenti e le sovrapposizioni tra Hel e Maria sono invero diffusi per tutto il testo. Non solo Maria si pone subito, fin dalla sua prima apparizione a Freder, come la Madre perduta, l’immagine e l’affetto che manca all’io di Freder, e agisce come la Madre buona che lo orienta sulla via dell’autocoscienza e della scoperta del proprio destino. Ma ancora di più, proprio nel rapporto con Rotwang, Maria diventa l’oggetto dell’esperimento di riproduzione bio-tecnologica di Rotwang sostituendo Hel, e, prigioniera, diventa l’oggetto dell’interesse dell’inventore. Mentre la falsa Maria è incaricata di realizzare la vendetta di Rotwang contro Joh Fredersen, motivata ancora dal conflitto tra Fredersen e Rotwang relativo a Hel. E alla fine Maria è finalmente scambiata apertamente per Hel da Rotwang, impazzito, cioè finalmente del tutto preda del proprio inconscio, che palesa chiaramente quanto prima era rimasto soltanto implicito nel gioco delle relazioni simboliche. E allora anche l’accettazione immediata da parte di Rotwang della proposta di Fredersen di fare dell’automa un doppio di Maria diventa più comprensibile. Così la Maria buona e la Maria cattiva sono entrambe proiezioni di Hel, enti simbolici connessi alla Madre Hel, articolazioni visibili della sua doppia natura. E Freder, l’Eletto, è dunque subalterno alla Madre buona, è una sua estrinsecazione, una sua figura vicaria? Forse Metropolis, la Città della Madre secondo l’etimo, non può che essere salvata da una donna, da un’altra Madre divina, che agisce per interposta persona, attraverso una figura incarnata. E come lo sguardo meduseo della Madre demoniaca aveva ipnotizzato gli abitanti di Metropolis in un delirio di distruzione e di autodistruzione, così lo sguardo seduttivo della Madre buona può, attraverso una figura designata, riattivare le funzioni umane, simbolicamente ri-legittimate di Metropolis. Il demoniaco e il peccato come negatività assolute da schiacciare sono inscritti nel destino di Metropolis e radicalmente contrapposti alle forze simboliche positive, rappresentate da Maria e da Freder
e investite di un ruolo provvidenziale, cioè storico e religioso. In questo bilanciamento di modelli simbolici differenti si gioca tutta l’ambiguità di Metropolis, il funzionamento molteplice e contraddittorio del suo regime segreto. Ed è proprio questa ambiguità profonda che costituisce sul piano dell’immaginario l’aspetto essenziale di Metropolis: una struttura immaginaria in cui ogni figura è inserita in un processo di slittamento continuo che la sdoppia, la fonde con l’altro e la fa scivolare nel suo contrario. Tutto in Metropolis tende a produrre una infinita moltiplicazione del senso.
[1.]
[2.]
[3.]
M di Paolo Bertetto LE CONFIGURAZIONI DEL VISIBILE
Innanzitutto in M1 la scrittura langhiana elabora una composizione del visibile che privilegia le componenti di figurazione rappresentativa che l’invenzione del sonoro permette. La ricostruzione dei quartieri della vita metropolitana, gli interni della sede della polizia, dei bassifondi e dei locali dove si trova la malavita hanno una immediatezza apparente che rinvia al mondo urbano dei primi anni trenta in Germania. Le scenografie di Hasler, i costumi, tutti gli elementi del profilmico rafforzano l’effetto rappresentativo. Ma questa opzione non è solo effettuata come una necessità imposta dal cinema sonoro. Riflette anche una ripresa da parte di Lang di aspetti della configurazione del mondo delle classi subalterne in Germania elaborate dal cinema di impegno sociale degli ultimi anni venti e in particolare da Jutzi e da Junghans. Resta significativo peraltro il fatto che Lang concepisca i suoi film sulla Germania contemporanea come film noir. Tra i suoi film muti solo Kämpfende Herzen (1921), Il dottor Mabuse (Dr. Mabuse, der Spieler, 1922) e L’inafferrabile (Spione, 1928) sono film contemporanei e sono crime stories o spy stories. Anche nei primi anni trenta il noir sembra essere per Lang la chiave per capire il XX secolo. Tutti i film di Lang d’altronde sono film di genere. Lang sa bene, da un lato, che la capacità di un regista – quella che poi si sarebbe chiamata autorialità – non è in contrasto con la realizzazione di film di genere. Anzi. Quasi tutti i grandi autori fanno film di genere. Insieme è consapevole della forza del genere come meccanismo narrativo e spettacolare che garantisce il rapporto con il pubblico e sa sfruttare le potenzialità della costruzione dell’intreccio e della produzione di processi identificativi: e quindi la produzione di intensità forti, anche se, a volte, un po’ facili o standardizzate.
Lang tuttavia non si limita a modificare l’orizzonte di riferimento sociale. Ha la consapevolezza di dover reinventare la scrittura filmica, davanti ai problemi linguistici e mediologici che il sonoro e gli anni trenta gli pongono. Sa bene che l’opzione di ridurre la produzione del mondo filmico a una sorta di mera fotografia del visibile o di semplice ricostruzione fedele in studio degli spazi metropolitani sarebbe una scelta che impoverirebbe il linguaggio e le potenzialità del cinema. Decide dunque di non uniformare i modi della messa in scena, ma di inscrivere ripetutamente nella scrittura filmica una serie di determinazioni e di procedure di stilizzazione, capaci di arricchire la visione e di riservare al linguaggio filmico una esplicita funzione rilevante nella riconfigurazione del visibile. Abbiamo già sottolineato nel saggio introduttivo come Lang elabori tre livelli formali (morfo-simbolici) di configurazione del visibile. Innanzitutto una dimensione di registrazione dell’immagine che effettua una figurazione rappresentativa, che attesta il lavoro di regia, ma evita marche di stilizzazione. In secondo luogo un livello di figurazione per contrasto, formato da spazi ed elementi non indifferenziati, non omogenei, in cui il lavoro della messa in scena e della luce giocano un ruolo forte. Infine una terza dimensione legata alla configurazione del vuoto e dell’idea, fondata su una scrittura che privilegia l’eidetico e il negativo. È un insieme di procedure figurative e stilizzanti che costituisce una risposta particolare e meditata alla questione fondamentale del cinema dei primi anni trenta: come salvaguardare la forma specifica del film e la sua struttura di legittimazione artistica nella scatola mobile del sonoro. Vediamo ora attraverso un’analisi morfo-simbolica alcune procedure di messa in scena. Il primo segmento del film è dedicato sostanzialmente alla vana attesa di Elsie Beckmann da parte della madre e all’uccisione della bambina. In questo segmento vediamo tipi diversi di immagine e di costruzione del visibile.
Innanzitutto abbiamo una serie di immagini legate a una dimensione eminentemente rappresentativa, e quindi con uno scarso livello di rielaborazione linguistica, che segnano il primo livello di configurazione del visibile. Sono ad esempio le immagini della madre di Elsie che prepara il pranzo e che attende l’arrivo della bambina: si tratta di inquadrature che delineano una sostanziale omogeneità degli elementi visivi disposti nello spazio, senza forti differenziazioni interne. Accanto a queste, Lang introduce una serie di altre immagini, caratterizzate dal disegno di uno spazio non omogeneo, ma costruito secondo logiche di molteplicità e di differenziazione degli elementi. Questa diversificazione avviene attraverso varie procedure: in primo luogo la collocazione degli elementi nel visibile secondo un principio configurativo specifico, diverso dalla mera rappresentazione, in funzione di un effetto visivo controllato e programmato. Nella prima immagine, ad esempio, vediamo una serie di bambini collocati in cerchio attorno a una bambina situata al centro. La bambina recita una filastrocca che evoca la presenza del mostro, del serial killer. I ragazzi sono disposti in maniera non casuale, ma a una certa distanza l’uno dall’altro, in modo da coprire adeguatamente tutto lo spazio visivo. Al tempo stesso non sono uniti e quindi sembrano lasciati anche visivamente ciascuno alla propria singolarità e alla propria solitudine, come un insieme che può essere disgregato e colpito. Poi, l’altro elemento forte di differenziazione di questo secondo livello dell’immagine è dato da una procedura che Lang utilizza in maniera sistematica nell’ambito di M. Tale procedura è costituita dalla ripresa dall’alto di molte inquadrature, che grazie a questa particolare opzione di messa in scena, acquistano una configurazione assolutamente particolare. Un uso così sistematico di immagini dall’alto è indubbiamente innovativo, in quanto prevede l’utilizzo di una macchina da presa gestibile in maniera semplificata e al tempo stesso l’uso di una serie di particolari invenzioni di nuove ottiche. Vi sono molte immagini del
tournage di M, in cui noi vediamo come Lang abbia fatto costruire piattaforme sopraelevate per effettuare le riprese. Le immagini colte dall’alto tendono a proporre un punto di vista differente sul visibile e a presentare l’orizzonte delle interrelazioni intersoggettive come uno spazio percepito e conosciuto con un’ottica anomala, quasi uno spazio sottoposto a un’analisi entomologica, insieme distanziato e reso subalterno alla macchina da presa. È come se Lang volesse oggettivare un’impressione di potere dello sguardo del cinema, che subordina il campo visivo e pare dominarlo, percepirlo e interpretarlo dall’alto, riconfigurando l’orizzonte del visibile. E questa forza delle riprese dall’alto garantisce una differenza di punto di vista che produce una intensità sottile ma non irrilevante. Nelle riprese standard, come è noto, la macchina da presa è generalmente collocata in modo da situare la testa del personaggio ai tre quarti dell’inquadratura vicino al bordo superiore. Le variazioni rispetto a tale standard costituiscono evidentemente una scelta singolare, una opzione personale, enunciazionale del regista, legata a una volontà espressiva specifica. Lang in M adopera quindi inquadrature anomale, che fanno sentire la presenza della macchina da presa e la volontà di scrittura del regista, valorizzandone l’intervento formalizzante. Dopo la prima inquadratura in cui compaiono i bambini che giocano, noi vediamo una madre che interviene esortando la bambina a smettere di cantare la filastrocca che evoca l’assassino. L’inquadratura della madre è un’inquadratura effettuata dal basso, con un’opzione complementare alla precedente, ma ancora anomala. Lang avrebbe potuto utilizzare il punto di vista che aveva assunto per inquadrare i bambini. Invece sceglie intenzionalmente un’inquadratura rovesciata e cioè effettuata in contre-plongée. L’opzione per la ripresa dal basso rinvia evidentemente alla posizione dei bambini, cioè delle vittime nell’orizzonte del film, e costituisce un significativo contraltare delle inquadrature dall’alto. E l’alternanza delle inquadrature dall’alto e di quelle (meno frequenti) dal basso richiama naturalmente il grande
esperimento di scrittura eidetica di La passione di Giovanna d’Arco (La passion de Jeanne d’Arc, 1928) di Dreyer, in cui il conflitto tra il potere dei giudici e la subordinazione di Jeanne d’Arc, processata e perseguitata, è risolto anche in termini visivi, acquisendo, grazie all’alternanza dei punti di vista, una intensità ulteriore. Le due inquadrature potrebbero sembrare delle soggettive, ma verificando più esattamente la configurazione spaziale delle riprese ci si accorge che non si tratta di soggettive, bensì di inquadrature in cui la macchina da presa viene collocata vicino ai personaggi, ma non esattamente dal loro punto di vista, poiché l’angolazione di ripresa risulta diversa. Un ulteriore elemento importante nell’uso della macchina da presa è costituito da una procedura che Lang utilizza in parte anche all’interno di questo primo segmento, ovvero la progettazione e l’organizzazione di una mobilità estrema e del tutto particolare della camera. La mobilizzazione della macchina da presa è, come è noto, uno dei passaggi attraverso cui il cinema si afferma come linguaggio autonomo. Un esempio famoso ed estremo è il film di Murnau del 1924, L’ultima risata (Der Letzte Mann), in cui c’è addirittura una ripresa a 360°, in cui Murnau vuole mostrare il punto di vista gravemente alterato del personaggio ubriaco che vede tutta la stanza girargli attorno. Il cinema tedesco degli anni venti è un cinema estremamente avanzato dal punto di vista della sperimentazione tecnica. Karl Freund realizza una mobilità estrema della macchina da presa, «die entfesselte Kamera», ovvero «la camera scatenata»2 e usa attrezzature molto particolari per dinamizzare la cinepresa. In M, Lang lavora con Fritz Arno Wagner, che è forse, tra i direttori tedeschi della fotografia, il più abile a costruire immagini immerse nell’oscurità e in cui la dinamica di luce e ombra è più suggestiva e più sofisticata. Ma qui in M come poi nel Testamento del dottor Mabuse (Das Testament des Dr. Mabuse, 1933),
Wagner realizza un dinamismo della macchina da presa non solo di grande efficacia, ma capace di riconfigurare il visibile sul piano della mobilità estrema. Nulla appare come qualcosa di statico. Tutti gli elementi del mondo sono sottoposti a un turbinio di mobilità che oggettiva esemplarmente il carattere dinamico intrinseco del cinema. Alcuni di questi movimenti di macchina sono talmente sperimentali che sembrano effettuati quasi con la macchina a mano e determinano ancora una leggera, significativa intensità della visione. Non sembrano realizzati mediante un carrello, ma forse con l’ausilio di piccole piattaforme mobili, perché spesso l’immagine risulta leggermente incerta, non fissa, riuscendo a garantire un effetto di mobilità aggiuntiva di grandissima efficacia. In questa direzione, il film presenta un numero di bravura assolutamente particolare realizzato da Wagner nella sequenza che si svolge all’interno della sede dell’organizzazione dei mendicanti. Si tratta di un movimento in avanti della macchina da presa che attraversa una stanza, poi sale sino all’altezza di una finestra-lucernario con una grata, per montare ulteriormente sino a scavalcare la grata stessa, sfociando nella stanza accanto e continuando a muoversi in avanti alla conquista del nuovo spazio. Un movimento di macchina di grande bravura tecnica che attesta una nuova capacità del cinema di impadronirsi di luoghi molteplici e di creare un nuovo spazio mobile assolutamente innovativo e in fondo aperto sull’apparentemente impossibile. Il dinamismo della macchina da presa sorprende e colpisce lo spettatore e accende un’intensità improvvisa all’interno di un episodio narrativo abbastanza piatto. È un movimento di macchina che assume anche un carattere di singolare anticipazione di altri famosi movimenti di macchina estremamente elaborati che hanno segnato la storia del cinema, da Quarto potere (Citizen Kane, 1941) di Orson Welles a Professione: reporter (The Passenger, 1975) di Michelangelo Antonioni. La macchina da presa passa al di là del vetro, prosegue nell’altro spazio e non inquadra solo i
personaggi più vicini alla finestra, ma avanza ancora fino a riprendere il capo della malavita che si è recato a trovare i mendicanti. Questo estremo dinamismo della cinepresa, questa sorta di esibizione delle potenzialità della macchina cinema, è una scelta forte di regia di Lang, che caratterizza la sua scrittura filmica. Ed è un ulteriore elemento di qualificazione del visibile che Lang realizza per allontanarsi dalla mera riproduzione dell’oggetto, dalla banalità della rappresentazione. Lang costruisce le sue inquadrature con una sistematica dialettica di luce e ombra privilegiando intenzionalmente il buio, le tenebre, l’oscurità come elementi strutturali di un mondo dominato dalla presenza del crimine e della morte. L’oscurità prodotta da Lang e Wagner è insieme visibile e simbolica, descrittiva e legata all’oggettivazione eidetica della presenza del male e delle tenebre. È un’oscurità che rende più suggestiva e inquietante l’immagine e le trasmette un’intensità forte e ulteriore. Un’immagine dominata dall’ombra o dal contrasto tra luce e buio ha una forza e un’intensità intrinseca, e produce un’inquietudine particolare nello spettatore. Inoltre porta in sé una visione dello spazio e degli oggetti che crea una suggestione e una bellezza assolutamente singolari. Questo modello di scrittura sottolinea ulteriormente la rilevanza del lavoro sui codici cinematografici e la capacità straordinaria di elaborazione di una messa in scena che sviluppa e valorizza le grandi potenzialità della regia cinematografica. Le immagini del protagonista che viene inseguito e controllato dalla malavita organizzata e scappa di notte hanno una indubbia forza espressiva e intensiva: ad esempio quella in cui noi vediamo una ripresa notturna di una strada di Berlino, inquadrata dall’alto, assolutamente deserta, se non per la presenza dell’assassino che scappa terrorizzato. È un’immagine che, indirettamente, sembra mostrarci la solitudine del soggetto, emblematica della condizione dell’uomo nella grande città, ma anche il carattere di minaccia che l’esperienza della metropoli può determinare.
Il lavoro di Lang per M tende poi a fondere e sviluppare influenze provenienti dall’esperienza dell’Espressionismo artistico e influenze che vengono dal movimento più diffuso nella seconda metà degli anni venti in Germania, la Neue Sachlichkeit. La Nuova Oggettività è una pittura in cui prevale l’elemento di documentazione della contemporaneità, la volontà di mostrare il mondo sociale, di testimoniare le configurazioni del visibile contemporaneo. È quindi un tipo di arte che punta alla riscoperta dell’oggettività dei fenomeni, mettendo in luce i contorni della vita metropolitana: una prospettiva estremamente diversa da quella su cui lavora l’espressionismo, che invece intendeva recuperare una dimensione di irrealtà, di immaginario, di fantastico, di soggettivo. Lang nell’ambito di M rielabora influenze e logiche che appartengono da un lato alla ricerca defigurante espressionista, come l’uso intensivo della luce e la configurazione di una scrittura simbolica-eidetica (di cui parleremo più avanti), e dall’altro lato alla volontà di documentazione precisa del mondo del crimine e delle tecniche d’indagine della Kriminalpolizei di Berlino, che sembrano invece rinviare al gusto della nuova oggettività. Non c’è qui lo spazio per una lettura del film in rapporto alla storia tedesca, ma è importante sottolineare come le immagini di impronte digitali o altre inquadrature prese dalle schede della polizia di Berlino contribuiscano a creare una visualità filmica assolutamente nuova: il dettaglio dell’impronta digitale mostrata sul grande schermo costituisce un’immagine che allarga l’orizzonte del visibile non solo nella prospettiva dell’infinitamente piccolo, ma anche nella direzione degli effetti visivi inattesi e certo non leggibili secondo gli schemi percettivi tradizionali. La possibilità di creare sullo schermo delle immagini assolutamente nuove, segna in profondità l’esperienza del cinema tedesco degli anni venti da Von Morgens bis Mitternacht (1920) di Martin a Ombre ammonitrici (Schatten - Eine nächtliche Halluzination, 1923) di Robison, da Varieté (1925) di Dupont a Metropolis (1927) e si estende sino ai primi anni trenta.
Le immagini del cinema trattate attraverso dettagli e particolari inusuali possono creare una visibilità radicalmente nuova che produce forme e configurazioni visive dal forte carattere inventivo. Uno degli aspetti che caratterizza la messa in scena di M è anche la valorizzazione dell’oggetto come elemento visivo e narrativo di forte pregnanza. Per tutto il film il mondo dell’oggetto è investito di una nuova forza significante. La cosa s’impone sullo schermo e diviene una componente centrale del nuovo orizzonte dell’immagine. Uno studioso come Slavoj Zižek3 ha sottolineato l’importanza della Cosa nel cinema di Hitchcock. Ma questa importanza della Cosa è in fondo anticipata dall’iperdeterminazione dell’oggetto nel cinema di Lang e in particolare in M: ancora una volta il rapporto Lang-Hitchcock appare come una relazione di grande intensità. Un’ulteriore qualificazione del visibile è poi garantita dalle immagini allo specchio presenti nel film, che si caricano insieme di un potere significante assolutamente particolare e di una suggestiva intensità visiva. Una delle due sequenze davanti alla vetrina di un negozio articola una serie di inquadrature riflesse di grande rilevanza simbolica – e naturalmente di forte tensione narrativa e di indubbia inquietudine. I piani alla vetrina dei coltelli – tutti molto nitidi – sono dieci e sono dedicati non solo a Beckert (Peter Lorre) (6 inq.), ma anche a una bambina (3 inq.), vittima potenziale, e alla merce esposta nella vetrina stessa (1 inq.). Sia le inquadrature dedicate all’assassino, sia quelle riservate alla bambina sono incastonate in uno spazio specchiante all’interno di una sorta di rombo con un vertice verso il basso e formato da un insieme ordinato di coltelli. Questa composizione ritaglia le immagini del carnefice e della vittima potenziale, isolandole dal contesto e realizzando un effettivo recadrage, cioè un quadro nel quadro. In un’inquadratura nel rombo appare riflessa anche l’immagine della strada, mentre la rifrazione di Beckert è a volte meno nitida nella vetrina stessa. È un insieme di immagini che, al di là della connessione simbolica con i coltelli, mostra invero una dialettica estremamente
significativa tra un soggetto che guarda e un personaggio che è guardato. La bambina appare solo come oggetto dello sguardo turbato di Beckert, mentre l’uomo è riflesso dalla superficie specchiante nelle evidenti modificazioni psichiche che la visione della possibile preda suscita in lui. L’immagine riflessa appare qui come il luogo di una rivelazione della natura e delle pulsioni omicide del soggetto e si carica quindi di una potenzialità interpretativa particolare. L’immagine in ogni modo non mostra un soggetto che si guarda allo specchio, ma un personaggio riflesso che attiva un esercizio particolare di sguardi. Inoltre l’inserimento della figura del serial killer, come di quella della bambina, all’interno di una composizione visiva complessa, costituita dalle merci in vetrina oltre che dal rombo dei coltelli, rende l’immagine dell’uomo strettamente correlata con lo spazio circostante. Prima, nel segmento inserito nell’indagine di polizia, l’immagine del protagonista-assassino raddoppiata dallo specchio riflette insieme la volontà di Beckert di scoprire le fattezze del proprio volto e l’impossibilità di farlo se non attraverso lo specchio. Lo sguardo che Beckert rivolge a se stesso è un’interrogazione sulla propria natura e sul volto-specchio-dell’anima, come si diceva. È una domanda sulla propria soggettività e sugli abissi nascosti che l’assassino rivolge al proprio viso e alla propria superficie facciale, non potendo penetrare nelle profondità del suo inconscio. Beckert altera l’espressione del volto, con le dita piega la bocca verso il basso, cerca di scoprire i segni di una mostruosità che non vede. La voce over, intanto enuncia il testo di un’analisi psicologica dell’assassino fatta da uno specialista e sembra spingere Beckert a investigare ancora di più su di sé. Lo specchio è quindi insieme lo spazio della duplicazione e lo spazio dell’autorivelazione: cioè uno spazio intensivo. E insieme è lo spazio in cui lo sguardo del soggetto può vedere il proprio volto che è proprio quello che abitualmente si sottrae allo sguardo. Lo specchio è
anche quello che ci rivela il nostro stesso volto, abitualmente visibile a tutti e per noi così misterioso. Nel lavoro di messa in scena un’importanza particolare è poi attribuita al sonoro. Non a caso il film comincia con un’immagine in nero in cui si ascoltano delle voci, per sottolineare l’importanza che la dimensione del suono acquista nell’economia narrativa di M e nel cinema. La seconda macrosequenza, dedicata al diffondersi della paura del serial killer e al racconto dell’attività investigativa, è strutturata attorno al dialogo telefonico tra il presidente della polizia di Berlino e il ministro degli Interni, che è l’asse che guida il montaggio delle inquadrature. Non sono le immagini a delineare il percorso dello sviluppo narrativo, ma è il sonoro, l’enunciazione verbale a legare, selezionare e proporre il visibile. Poi, nel grande sintagma di montaggio alternato costituito dalle due riunioni contemporanee della criminalità organizzata e della polizia dedicate all’organizzazione delle indagini, a volte un personaggio dell’altro ambito risponde a una domanda posta da un personaggio del precedente spazio, con un effetto di “rima” e di montaggio estremamente significativo: un dirigente della polizia, ad esempio, risponde a una domanda enunciata dal capo della malavita organizzata e viceversa. Anche sotto il profilo dell’avanzamento della narrazione, il sonoro si rivela determinante: la persona che individua il serial killer è un mendicante cieco che lo riconosce, perché lo sente fischiettare un’aria del Peer Gynt di Grieg. La soluzione che Fritz Lang e Thea von Harbou individuano nell’elaborazione della sceneggiatura, quindi, valorizza la centralità del sonoro nella scrittura cinematografica, senza però implicare una semplificazione delle strutture della messa in scena, un appiattimento della scrittura filmica alla mera riproduzione del mondo visibile sonoro. L’EIDETICO E IL VUOTO
Nel primo macrosegmento, precedentemente analizzato, vanno sottolineati altri due elementi, che contribuiscono a definire un terzo livello più complesso e concettuale, di configurazione del visibile nella messa in scena langhiana. In alcune immagini la composizione visiva acquista una rilevanza simbolica, nel senso che l’immagine esprime un’idea – e per questa via produce un’intensità eidetica. Troviamo questo effetto in una delle immagini più famose del film, il manifesto con la taglia sull’assassino, che vediamo mentre la piccola Elsie Beckmann lancia una palla per giocare. La palla entra in campo, rimbalza contro il manifesto e sull’immagine compare un’ombra minacciosa e misteriosa, l’ombra dell’assassino, un’immagine tipica non solo del cinema espressionista, ma del muto tedesco – va rammentato infatti che Lang non è un autore espressionista, anche se a volte assorbe alcuni stilemi dell’Espressionismo. Le immagini delle ombre che sostituiscono i corpi appaiono come una sorta di ossessione o di leitmotiv nel cinema tedesco, dall’immagine dell’assassino che uccide Alan ne Il gabinetto del dottor Caligari (Das Cabinet des Dr. Caligari, 1920) di Wiene, all’ombra sul muro di Nosferatu, che entra nella casa di Ellen, nel film di Murnau (Nosferatu - Il vampiro, Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, 1922), o all’immagine dell’ombra della falsa Maria in Metropolis, mentre sale la scala del grande contenitore dell’acqua durante l’inondazione, un’ombra che ha quasi la forma di un insetto, sino alla moltiplicazione delle ombre nell’ipnosi di Ombre ammonitrici, per citare solo le più significative. L’immagine dell’ombra cancella il corpo e costituisce il visibile: l’assassino ci appare sullo schermo per la prima volta semplicemente come ombra e non come personaggio concreto. È un’immagine che da un lato punta a non rivelare immediatamente il volto dell’assassino, ma dall’altro collega l’incubo dell’ombra al male e diventa una sorta di correlativo oggettivo del male che incombe, acquistando una forza e un’intensità indubbiamene particolari. Questa procedura di riduzione dei corpi all’ombra ricompare nella sequenza in cui i
rappresentanti delle organizzazioni gangsteristiche si ritrovano per decidere un’azione contro il serial killer. Un’altra immagine che riflette una configurazione eidetica4 è l’inquadratura del palloncino che scappa di mano a Elsie quando viene uccisa e sale verso il cielo fino a impigliarsi tra i fili elettrici. Anche questa è un’immagine dotata di una forte rilevanza simbolica, che sostituisce la presentazione dell’accadimento e implica un montaggio ellittico, poiché noi non vediamo l’uccisione di Elsie, ma solo la conseguenza dell’assassinio. L’uccisione da parte di un serial killer di una bambina era considerata un’immagine troppo violenta per un film del 1931, ma il procedimento compositivo di Lang è indubbiamente sofisticato e di grande forza. D’altronde Lang aveva già usato effetti di montaggio ellittico anche in Metropolis, omettendo magari un gesto, ma mostrandone l’immagine che precede l’atto e quella successiva. Nel film del 1927, ad esempio, c’è una sequenza in cui un personaggio si uccide: noi non vediamo il gesto, ma dapprima il biglietto d’addio che scrive e poi la pistola fumante. È una scrittura ellittica ed eidetica che anticipa le procedure di montaggio intellettuale dell’Ėjzenštejn di Ottobre (Октябрь, 1928), e de Il vecchio e il nuovo (Старое и новое, 1929). Un altro modello di messinscena elaborato da Lang in M è costituito dalle ripetute immagini di spazi vuoti che compaiono in passaggi diversi del film e realizzano ancora un’intensità eidetica. Generalmente il cinema non mostra immagini di spazi vuoti, che nella logica della consequenzialità narrativa sono considerate inutili, non funzionali. Invece Lang mostra l’immagine della tromba delle scale e del lavatoio della casa povera in cui vive Elsie Beckmann, come spazi vuoti. Così l’immagine della tavola con i piatti, le posate, la sedia, pronti per Elsie, ma mostrati in assenza del personaggio, si configurano come immagini di un’assenza e di un vuoto. Le immagini del vuoto ritornano d’altronde anche nella sequenza di maggiore tensione narrativa, il processo al serial killer, in cui l’interno di una vecchia fabbrica abbandonata è mostrato attraverso una serie di
immagini di ampi spazi desolatamente vuoti, volti a segnare il radicale vuoto esistenziale in cui si trova a operare Beckert, l’assassino. Un vuoto profondo e totale che è insieme prima dell’assassinio e dopo e che investe insieme il carnefice, le vittime e i parenti delle vittime, unificati da un destino di sofferenza. D’altronde, anche nella lunga sequenza all’interno del palazzo di uffici in cui l’assassino si nasconde, molte inquadrature si limitano a registrare uno spazio vuoto, uno spazio segnato dall’assenza, dalla mancanza dell’elemento antropomorfico. E in fondo nel film è possibile rilevare due tipologie di spazi vuoti, tutti connotati sul piano dell’Eidos e dell’intensità: da un lato un insieme di immagini senza presenze antropomorfiche che hanno una rilevanza assoluta, vanno quindi al di là dell’immediato collegamento con la diegesi e si pongono come dimensione stessa dell’angoscia e del negativo; dall’altro spazi fortemente correlati allo sviluppo dell’azione, in cui il vuoto segna la presenza del male e del dolore nel contesto stesso dell’operare concreto dei personaggi. Questa procedura di oggettivazione del nulla e della morte, che il film evoca drammaticamente, ritorna nel Testamento del dottor Mabuse, in cui sono presenti immagini dalla forte valenza significante, legate alla dimensione simbolico-eidetica del fantasma e della morte, e dedicate all’apparizione angosciante del vecchio Mabuse impazzito e destinato alla morte. L’IDENTIFICAZIONE E IL SOGGETTO PARAFRENICO
La struttura narrativa di M è in sostanza il racconto di un processo investigativo. Non è tanto l’azione o l’intensificazione dell’attività omicida e criminale del protagonista a essere al centro del film, anche se questa è una componente importante che ispira alcune delle sequenze più efficaci, quanto lo sviluppo parallelo delle ricerche investigative della polizia e della malavita, impegnate nella difficile individuazione del colpevole5. Anche per questo motivo il film ha un andamento
caratterizzato da un montaggio di scene autonome, elaborate in relazione al percorso d’indagine. Non è costruito su un asse di causa-effetto, o su una somma di elementi consequenziali (post hoc ergo propter hoc), ma su una processualità diversa, in cui il concatenamento tra le sequenze è piuttosto libero e gli elementi narrati sono collegati alle logiche delle diverse detections. Questa procedura consente una maggiore libertà di selezione dei segmenti da un lato e una costruzione che assembla elementi diversi, realizzando un’unità processuale attraverso le eterogeneità. Nell’ultima parte del film, invece, quando il colpevole è braccato dalla malavita, il racconto acquista una dinamica diversa e un ritmo intensivo forte, direttamente correlato con la caccia all’assassino. Le molteplici suggestioni narrative e visive determinano un particolare coinvolgimento dello spettatore, anche in riferimento alla notevole interpretazione del protagonista, Peter Lorre, che è indubbiamente un attore di un’abilità recitativa assolutamente straordinaria6. Lorre è alla sua prima interpretazione cinematografica, ma non è un “uomo nuovo” dello spettacolo. Al contrario, è un attore di teatro che ha lavorato in alcune messe in scena di Brecht, tra cui Un uomo è un uomo, e viene quindi da una delle grandi esperienze del teatro tedesco degli anni venti e trenta. Lang lo sceglie innanzitutto per le sue caratteristiche fisiognomiche. Indubbiamente uno degli elementi che subito colpisce nel personaggio dell’assassino di M è proprio il suo aspetto fisico, segnato da un’altezza limitata, da una certa pinguedine e da un volto dotato di un’espressività e di caratteri indubbiamente peculiari. È un volto rotondo, leggermente grasso, con labbra pronunciate, naso piccolo e soprattutto due grandi occhi, sicuramente difformi rispetto alla norma abituale. Il volto ha naturalmente nel cinema una funzione di grande importanza ed è uno straordinario vettore d’intensità, quando è legato alla bellezza, ma soprattutto quando è legato all’espressività. Béla Balázs7 considera la valorizzazione del volto, con il primo piano, come una
delle componenti essenziali del nuovo linguaggio cinematografico. Nel cinema delle star la valorizzazione del volto è sempre un elemento assolutamente centrale: basti pensare ai visi di Rodolfo Valentino, di Greta Garbo, di Marlene Dietrich. In particolare, una delle componenti essenziali nella valorizzazione del volto è costituita sicuramente dalla funzione dell’occhio e dello sguardo. Come nel ritratto, nel primo piano lo sguardo catalizza l’attenzione dello spettatore e diventa il punto di più alta produttività significante. Il fatto che Peter Lorre presenti un volto e uno sguardo così singolari contribuisce a sottolineare l’anomalia del personaggio, la sua peculiarità. Le immagini di Lorre sono quindi impregnate di intensità, proprio per la sua singolarità inquietante. Hans Beckert non è assolutamente un personaggio che ci incute paura. Spesso chi ha una particolare aggressività nel viso o possiede un viso duro e crudele interpreta il ruolo di un criminale. Peter Lorre invece non ha un viso di questo tipo. Le ricerche sulla criminalità e sui serial killer hanno rilevato il fatto che molte persone che presentano caratteri psicopatologici sono contraddistinte da un’anomalia genetica, consistente nella presenza di un cromosoma in più. Quindi lo sguardo e gli occhi anomali di Peter Lorre potrebbero farci pensare a una sorta di oggettivazione visiva di un’anomalia genetica, sottolineata ulteriormente da un’insolita configurazione della bocca, in cui il labbro superiore sale in maniera singolare. Nonostante la sua esperienza teatrale con Brecht, la recitazione di Lorre non è affatto brechtiana e il film di Lang è assolutamente opposto ai principi del teatro brechtiano (i film brechtiani sono in genere fallimenti totali). Nel suo cinema Lang potenzia le forme dell’identificazione cinematografica secondaria, correlata alla storia che viene raccontata e ai personaggi che noi vediamo. All’ interno di M il meccanismo che viene posto in atto è indubbiamente complicato e sofisticato e crea una tensione e un’intensità del tutto singolari. Lang è un
autore che spesso configura lo sguardo del personaggio come una componente importante nella definizione del rapporto tra l’immagine e lo spettatore. I personaggi del cinema muto langhiano – da Destino (Der müde Tod, 1921) al Dr. Mabuse, da I Nibelunghi (Die Nibelungen, 1924) a Metropolis – guardano spesso in macchina e attraverso lo sguardo diegeticamente motivato, verso la macchina da presa, intensificano il rapporto tra lo schermo e lo spettatore8. Come abbiamo argomentato in M la situazione è diversa e indubbiamente nuova, perché il protagonista del film è un serial killer, e quindi un personaggio con cui lo spettatore ha ovviamente delle difficoltà a identificarsi9. Quando Beckert diventa oggetto della caccia della malavita organizzata, Lang utilizza questa disponibilità dello spettatore a schierarsi dalla parte delle vittime e opera un rovesciamento quanto mai significativo delle dinamiche psichiche. L’assassino, pur senza diventare evidentemente un personaggio positivo, determina una sorta di processo singolare di identificazione nello spettatore, ulteriormente sviluppato nella parte finale, durante il drammatico processo organizzato dalla malavita. In questa macrosequenza di grande forza l’esigenza di giustizia si mescola con la evidente debolezza di Beckert, creando nel fruitore un effetto psichico del tutto contraddittorio. Lo spettatore, che prima era assolutamente schierato con le indagini e aspettava che l’assassino venisse colpito e distrutto, è condotto dalla messa in scena ad assumere un atteggiamento estremamente ambiguo: pur senza identificarsi in modo preciso con l’assassino, partecipa anche alla sua condizione di oggetto di persecuzione e ne vive psichicamente il dramma. E alla fine del percorso, l’enigma del male e della colpa sembra diventare il centro simbolico del film. D’altronde in tutto il suo cinema, Lang riflette ossessivamente sull’orizzonte della colpa, che è sicuramente una delle dimensioni psichiche fondamentali, probabilmente legata alla sua esperienza vissuta e alla morte della sua prima moglie10.
Il personaggio del serial killer è quindi un personaggio di indubbia ricchezza psicologica11. Nella sua autodifesa pubblica l’assassino dichiara di essere una vittima di se stesso. È un soggetto profondamente diviso, spinto verso la distruzione e l’omicidio da una impellente istanza dell’io, mentre un’altra componente della soggettività tende inutilmente a sfuggire all’impulso criminale. L’ idea che il serial killer sia al tempo stesso carnefice e vittima di se stesso e quindi presenti una struttura palesemente schizoide è l’asse fondamentale su cui è costruito il personaggio. Il serial killer dice di essere inseguito da una voce, da una volontà, da un desiderio oscuro, che vengono dal profondo e che lo spingono a cercare di compiere degli omicidi, a uccidere, per calmare la condizione di angoscia in cui si trova. Insieme Beckert dice di essere sempre ossessionato dalle immagini delle bambine, delle madri e degli assassinii compiuti, e di non riuscire a liberarsi da questa presenza da incubo, se non nel momento in cui compie un altro omicidio. Lo status psichico che il serial killer propone è costituito da una compresenza di componenti diverse: da un lato l’ossessione delle immagini fantasmatiche legate agli assassinii, alle responsabilità, e quindi alle colpe del serial killer stesso; dall’altro la presenza ossessiva di una voce, di un desiderio o di una volontà che lo spingono nuovamente a compiere dei delitti; e, dall’altro ancora, la subalternità di una componente dell’io che tenderebbe a comportarsi normalmente, ma è dominata invece dalla voce che proviene dall’oscuro e lo costringe a colpire, ad agire, a uccidere. Sono elementi di caratterizzazione della psiche di un omicida seriale che la criminologia recente ha spesso ripreso e confermato. Quindi l’immagine della soggettività che il protagonista prospetta è l’immagine di un io diviso, in cui una determinazione profonda, oscura, di origine inconscia, emerge per produrre azioni violente che l’altra componente della sua soggettività vorrebbe evitare. Si tratta dunque di una struttura psichica caratterizzata da una separazione schizoide all’interno dell’io, con la
presenza di una istanza aggressiva, sadica, distruttiva, che diventa periodicamente dominante. Questa immagine di un io radicalmente diviso, naturalmente, riflette in fondo l’interpretazione del soggetto elaborata da Freud e dalla psicanalisi, con l’idea di una struttura frammentata dell’io – articolata, com’è noto, in coscienza, preconscio e inconscio e in Io, Es e Super-Io –, attestando tra l’altro l’indubbia modernità dell’immaginario elaborato da Lang e dalla sua sceneggiatrice Thea von Harbou.
[1.]
[2.]
[3.]
Altri film a Berlino di Anita Trivelli, Arianna Vergari 1 «DESTINO» («DER MÜDE TOD», 1921)
Sinossi Delle sei Strofe in cui il film è diviso le prime due e l’ultima appartengono alla storia principale e le altre tre raccontano tre diverse vicende che alla prima sono collegate. La storia principale si svolge, dicono i titoli di testa, «in qualche tempo in qualche luogo»; ma la scenografia e i costumi mostrano che siamo nella Mitteleuropa tra XVIII e XIX secolo. La Morte arriva in un paese e prende il giovane innamorato che con la sua amata si è fermato nella locanda. Contrattando con i notabili del luogo, la Morte affitta per novantanove anni un terreno accanto al cimitero e lo circonda di un muro impenetrabile del cui ingresso invisibile lei sola è padrona. La giovane innamorata cerca disperatamente il suo fidanzato e, dopo averne visto l’ombra entrare nel muro con quelle di altri defunti, riesce a farsi accettare all’interno di quel terreno dalla Morte, che le mostra una quantità di candele accese: sono i viventi che morranno allo spegnersi della loro fiamma. Cedendo alle preghiere della giovane, la Morte le indica tre candele che stanno per spegnersi: se riuscirà a salvare almeno una delle tre persone riavrà il suo amato. Qui inizia il «Racconto della prima fiamma», che si svolge in una città piena di moschee che viene chiamata «la nostra città della fede». Dopo varie peripezie, il Califfo fa uccidere il giovane francese innamorato di sua sorella, che lei non deve sposare perché “infedele”. Segue il «Racconto della seconda fiamma», che ha luogo in una Venezia quattrocentesca apparentemente gaia per il Carnevale, dove tra omicidi e scambi di persona un nobile fa uccidere il suo rivale in amore. Il «Racconto della terza fiamma», infine, si svolge in Cina, ed è anch’esso imperniato su una storia d’amore contrastato, con l’Imperatore che fa uccidere dal proprio arciere – la
Morte – il giovane innamorato della figlia del Mago, al termine di una vicenda che ha il suo fulcro proprio nella magia e negli incantesimi. Gli innamorati dei tre racconti sono la stessa attrice (Lil Dagover) e lo stesso attore (Walter Janssen) che interpretano questi ruoli nella storia principale. Quando questa riprende con la sesta e ultima Strofa, la Morte dapprima invita la giovane ad «amare la vita con gioia», a «tornare tra i viventi e a vivere», poi, vista l’insistenza della ragazza, le concede un’ultima possibilità: se troverà qualcuno disposto a dare la sua vita in cambio, lei riavrà il suo fidanzato. Ma nessuno è disposto a morire: dall’anziano farmacista al povero mendicante, ai vecchi dell’ospizio che a parole dicono di desiderare la morte. Alla fine un incendio divampa nell’ospizio, e l’unico che non può salvarsi è un bimbo in fasce nella culla. La giovane entra per prenderlo e consegnarlo alla Morte ma quando lo ha tra le braccia si rifiuta, dicendole: «Non posso sconfiggerti a questo prezzo. Ora prendi anche la mia vita, perché senza il mio amato per me essa significa meno di niente!». La Morte ha un dolce sorriso e, dopo che l’ospizio è crollato, la conduce dal suo amato. Poi avvolge entrambi con il suo mantello e li accompagna su una collina fiorita, inquadrata nell’iride e contro un cielo vuoto. Sulla cima la Morte svanisce: i due si danno la mano e proseguono dandoci le spalle. Note Nel film sono presenti molti dei motivi che caratterizzeranno l’opera futura del regista, non meno che la cultura austriaca e tedesca del suo tempo. Anzitutto quella che egli stesso chiama «l’intimità con la morte» che è propria della cultura del suo paese e che «si ritrova in molte canzoni viennesi». È il romanticismo che lo stesso Lang sottolinea nelle sue conversazioni, in primis quelle con Lotte Eisner, e che motiva il titolo stesso del film: Der müde Tod. Ein Deutsches Volkslied in sechs Versen, cioè “La Morte stanca. Una ballata popolare tedesca in sei Strofe”. Il Volkslied è una antica forma di canzone tedesca che il Romanticismo a partire
dalla fine del Settecento (con lo Sturm und Drang e con Goethe e Lessing) rilanciò come voce del popolo, espressione dell’anima popolare. Ed è il Romanticismo di Lang che Eisner contrappone alla lettura in chiave espressionista che alcuni critici davano dell’opera e che lo stesso regista rifiutava, sostenendo che soltanto un’inquadratura del film derivava direttamente dallo stile espressionista. Eisner peraltro considera le magie del «Racconto della terza fiamma» come una parodia dell’Espressionismo, e avvicina l’atmosfera generale del film all’opera del pittore romantico Caspar David Friedrich. Alla fine del film, Lang ci mostra la differenza che c’è tra le parole e i fatti nella ricerca di un donatore perché il fidanzato torni in vita. E ci mostra anche il trionfo della vita nel gesto finale della giovane che salva il bambino. Quando i due innamorati saranno ricongiunti, però, ciò avverrà tristemente senza che loro si guardino, sotto il mantello della Morte, e quando quest’ultima sarà sparita, si daranno la mano guardandosi e allontanandosi dallo spettatore in un finale assai poco rassicurante, in dissolvenza di chiusura. Subito dopo vediamo l’orologio del campanile che segna la mezzanotte. L’ultima inquadratura del film è per il guardiano notturno che esclama: «Ascoltate quello che dico, brava gente! L’orologio ha appena battuto la mezzanotte, difendetevi dai fantasmi e dagli spiriti, affinché nessun male affligga le vostre anime!». Il gioco della cultura popolare è concluso, ma Lang ci dice che esso è ancora profondamente attuale. «I NIBELUNGHI» («DIE NIBELUNGEN», 1924)
La morte di Sigfrido (Siegfried) I sette canti Il primo canto: «Come Sigfrido uccise il drago»; «Così finisce il primo canto». Il secondo canto: «Come Voker, il
bardo, cantò di Sigfrido davanti a Crimilde e come Sigfrido venne a Worms»; «Così finisce il secondo canto». Il terzo canto: «Come Sigfrido vinse Brunilde per Gunther»; «Così finisce il terzo canto». Il quarto canto: «Come Brunilde si recò a Worms e come i reali celebrarono le nozze»; «Così finisce il quarto canto». Il quinto canto: «Come sei lune dopo, la dote di Sigfrido, il tesoro dei Nibelunghi, arrivò a Worms e come le due regine ebbero una lite»; «Così finisce il quinto canto». Il sesto canto: «Come Gunther ruppe la fedeltà a Sigfrido»; «Così finisce il sesto canto». Il settimo canto: «Come Crimilde giurò vendetta a Hagen Tronje»; «Così finisce la storia di Sigfrido». Sinossi del primo film L’eroe Sigfrido – la cui dimora è Xanten, nella Renania Settentrionale-Vestfalia – lascia i nani che lo hanno allevato per raggiungere Worms, sulle rive del Reno, e chiedere la mano della bella Crimilde, sorella di Gunther re dei Burgundi. Sulla sua strada incontra e uccide il Drago che custodisce il tesoro dei Nibelunghi, sconfigge il nano Alberico che vorrebbe impedirgli di conquistarlo, si impadronisce della sua rete-cappuccio che può renderlo invisibile e della spada invincibile, che è parte del tesoro. Tutto ciò, ci dice a questo punto il film, è cantato dal bardo alla corte dei Burgundi, raccontando anche che Sigfrido, padrone del tesoro dei Nibelunghi, ha poi conquistato dodici regni i cui dodici re sono diventati i suoi vassalli. Arrivato Sigfrido a Worms con i dodici, Gunther gli concede la mano di Crimilde, ma gli chiede di aiutarlo a ottenere in sposa Brunilde, regina d’Islanda, che vive in un castello difeso da un “mare di fiamme” che si levano spontanee dal suolo e che si spengono all’arrivo dell’eroe, di Gunther e dei suoi guerrieri. Invisibile grazie al cappuccio-rete, Sigfrido aiuta il debole Gunther a battere Brunilde nelle tre prove di forza che lei impone a chi voglia la sua mano. Una volta tornati a Worms, sempre grazie al cappuccio Sigfrido si sostituisce a Gunther nel vincere le resistenze di Brunilde ad accettare il letto
matrimoniale. E Sigfrido e Gunther stipulano il patto di sangue tra fratelli. Dopo i due matrimoni viene portato a Worms il tesoro dei Nibelunghi, che Sigfrido offre in dote a Gunther. Un equivoco che può rivelarsi fatale obbliga però Sigfrido a rivelare in segreto alla moglie la verità sulla conquista di Brunilde. E poco tempo dopo, una lite provocata da quest’ultima – che del rapporto tra Crimilde e Sigfrido è gelosa – spinge Crimilde a rivendicare la nobiltà di Sigfrido rivelandole a sua volta il segreto. Brunilde allora pretende da Gunther la morte di Sigfrido. Rompendo il patto di sangue, il debole Gunther lascia che il suo braccio destro Hagen Tronje uccida l’eroe alla fine di una partita di caccia colpendolo sulla spalla, nell’unico punto – saputo con l’inganno da Crimilde – in cui il sangue del Drago non lo aveva reso invulnerabile. Davanti alla bara di Sigfrido, con accanto il corpo di Brunilde che si è uccisa, Crimilde giura vendetta: Hagen Tronje dovrà morire. La vendetta di Crimilde (Kriemhilds Rache) I sette canti Il primo canto: «Come Crimilde pianse Sigfrido e come re Etzel tramite Rüdiger von Bechlarn la chiese in sposa»; «Così finisce il primo canto». Il secondo canto: «Come Crimilde si congedò dalla sua terra, e come fu accolta da Etzel»; «Così finisce il secondo canto». Il terzo canto: «Come re Etzel stava davanti a Roma, e come Crimilde fece chiamare i suoi fratelli»; «Così finisce il terzo canto». Il quarto canto: «Come Crimilde accolse i suoi fratelli»; «Così finisce il quarto canto». Il quinto canto: «Come gli Unni celebrarono con i Nibelunghi la festa del solstizio»; «Così finisce il quinto canto». Il sesto canto: «Le pene dei Nibelunghi»; «Così finisce il sesto canto». Il settimo canto: «La fine dei Nibelunghi»; «Così finisce la storia». Sinossi del secondo film Etzel (Attila) re degli Unni chiede la mano di Crimilde attraverso il Margravio (cioè governatore di una
provincia di confine) Rüdiger von Bechlarn (oggi Pöchlarn, comune austriaco a 98 chilometri a ovest di Vienna). Crimilde accetta e parte per raggiungere Attila rifiutandosi di salutare i suoi fratelli e la sua corte. Hagen Tronje, che cinge la spada di Sigfrido, getta in acqua il tesoro dei Nibelunghi per nasconderlo, dicendo a se stesso che ora si devono proteggere i Burgundi. Attila, orribile e scimmiesco, sposa Crimilde, che gli dà un figlio e gli chiede di far venire a corte i suoi fratelli. Questi arrivano, insieme con Hagen Tronje e una parte delle loro truppe e l’incontro viene festeggiato con un grande pranzo e la presenza a tavola del piccolo erede unno. Crimilde, che aveva chiesto invano ad Attila di uccidere Hagen, offre di nascosto un lauto compenso agli Unni che stanno banchettando nei sotterranei del palazzo perché siano loro a ucciderlo. Quando la battaglia si scatena, Hagen uccide il bambino. Segue una serie di scontri con i Nibelunghi-Burgundi che appaiono invincibili e Crimilde determinata a vendicare Sigfrido. Alla fine gli Unni danno fuoco al palazzo, in un angolo del quale il bardo non smette di cantare commuovendo sia i suoi sia gli stessi Unni, finché il palazzo crolla uccidendo tutti tranne Hagen e Gunther. Crimilde fa tagliare la testa a suo fratello e uccide Hagen lei stessa, dopo aver avuto da lui l’ultimo scherno nel rifiuto di rivelarle dove ha nascosto il tesoro dei Nibelunghi. Subito dopo Hildebrand la uccide per aver messo fine alla dinastia dei Nibelunghi-Burgundi. Attila disperato griderà: «Portatela a casa di Sigfrido, il suo marito morto! A nessun altro uomo lei apparteneva!». Note Il film è dedicato al popolo tedesco ed è diviso in due parti (Sigfried, la prima, e Kriemhilds Rache, la seconda), per la durata totale di 247 minuti (287 nella versione estesa), entrambe uscite nel 1924. La prima parte fu sonorizzata dall’UFA nel 1933. Ogni parte è composta da sette canti intervallati da relativi titoli. Come ha dichiarato lo stesso regista, ne I Nibelunghi la Morte assume forme simboliche: una scelta che si
estende a tutta l’opera e la rende schematica, sia nella trama che nei personaggi e nelle scenografie. Queste ultime sono firmate da Otto Hunte, che aveva già lavorato con Lang in tre film, tra i quali Il dottor Mabuse (Dr. Mabuse, der Spieler, 1922), e che firmerà la scenografia di Metropolis (1927). Le riprese si svolsero interamente nel territorio berlinese, negli studi dell’UFA a Tempelhof, a Potsdam e a Spandau, dove Hunte disegnò una scenografia con strutture multifunzionali che potevano essere agilmente addobbate e ornate per l’utilizzo sia nel primo che nel secondo film (segnatamente nelle regge di Gunther e di Attila). La dedica al popolo tedesco inaugura quattro motivi dominanti dell’opera: il discorso sulla morte che permea il lavoro langhiano; il motivo dell’eroe; quello dell’onore (rispetto del giuramento, rispetto dell’ospitalità) e della vendetta; la cultura “germanica”, le sue origini, la sua condivisione nella Grande Germania (problematica del XIX secolo centrata sull’Austria, ripresa poi dal nazismo). «L’INAFFERRABILE» («SPIONE», 1928)
Sinossi Il film è imperniato sul personaggio del banchiere Haghi, che, irraggiungibile nel suo ufficio, con la sua rete criminale cerca di mettere le mani su un trattato segreto tra Germania e Giappone che impedirà lo scoppio di una guerra. Contro le sue manovre si muovono i servizi segreti tedesco e giapponese, rappresentati rispettivamente dall’agente Donald Tremaine, che opera sotto il nome No. 326, e dal dottor Akira Matsumoto. Al servizio di Haghi vi sono tra gli altri tre donne: la russa Sonja Baralnikova, la nobildonna Lady Laslane e Kitty la giovane e bella complice priva di scrupoli. Sonja è convinta da Haghi a collaborare per vendicare l’esecuzione del fratello e del padre avvenuta per opera della polizia zarista, dal momento che anche la Russia è coinvolta nel trattato, il cui documento dovrà passare nel suo territorio; Lady Laslane è ricattata perché Haghi ha le fotografie della sua dipendenza dalla droga; Kitty sembra da sempre complice di Haghi e per nulla
imbarazzata dalle missioni di adescatrice che il suo capo le affida: sedurrà Matsumoto e gli sottrarrà il documento, cosa che indurrà l’irreprensibile capo dei servizi giapponesi a pagare il suo involontario tradimento facendo harakiri. Sonja si innamorerà di Donald, e la contemporanea voluttà di Haghi farà intrecciare il motivo amoroso a quello poliziesco. Tra le spie che Haghi paga c’è anche il colonnello Jellusic’, appartenente all’esercito di uno Stato non precisato ma certamente dell’Est Europa, considerato il nome e il fatto che per tornare a casa viaggerà sull’Orient Express. Anche lui, denunciato dallo stesso Haghi all’esercito cui appartiene, chiederà di potersi uccidere e otterrà per questo una pistola. Alla fine Haghi, che si è sottratto all’invasione dei suoi uffici da parte dei poliziotti, si rivelerà avere anche un travestimento da clown che ufficialmente dovrebbe coprire la sua attività di agente tedesco No. 719, e, scoperto e accerchiato durante uno spettacolo, si suiciderà platealmente in scena con l’ultima parola: «Sipario!», dopo la quale apparirà il cartello «Fine» con cui il film si chiuderà. Note Fin dall’inizio de L’inafferrabile il telefono è centrale, ritornando continuamente in scena, tanto da poter essere considerato come uno dei protagonisti del film. Ad esso si accompagnano gli altoparlanti, la posta, il telegrafo con – proprio in apertura – un palo telegrafico che emette lampi realizzati in truka, e da ultimo il treno. Nella consueta cura di ogni particolare che caratterizza il lavoro di Fritz Lang, il film mostra talune consonanze con il Dottor Mabuse del 1922, in particolare per il motivo del travestimento (il banchiere/clown, il mendicante/detective), la funzione dell’amore, le risorse del mezzo cinematografico. Oltre al riferimento politico e culturale al Giappone, presente peraltro nello stesso plot del film, il personaggio del capo dei servizi segreti giapponesi in Germania, il dottor Akira Matsumoto, interessa anche perché a interpretarlo, con grande finezza, è l’attore e regista Lupu Pick. Il personaggio di
Matsumoto conferma il rilievo che la cultura orientale aveva nella Germania di allora e che avrà anche una connotazione politica e militare non molti anni più tardi. Si ricordi, del resto, che Lang aveva girato nel 1919 Harakiri, dalla pièce teatrale Madame Butterfly di John Luther Long e David Belasco del 1900. Inoltre, la mimica di Willy Fritsch (il detective, agente No. 326), la sua bombetta e l’insieme del suo travestimento alla prima apparizione sembrano rinviare a diversi personaggi di Sciopero! (Стачка) di Ėjzenštejn, uscito nel 1924. Come pure al film ejzenstejniano fanno pensare i primissimi piani dei funzionari governativi nel caos all’inizio del film, e l’intreccio di scale di ferro che vanno da un piano all’altro e da una parete all’altra nei grandi uffici. Il travestimento da mendicante ricorda anche L’opera da tre soldi (Die Dreigroschenoper) di Brecht, rappresentata per la prima volta il 31 agosto 1928 a Berlino, rielaborazione della famosa L’opera del mendicante (Beggar’s Opera) di John Gay. «IL TESTAMENTO DEL DOTTOR MABUSE» («DAS TESTAMENT DES DR. MABUSE», 1933)
Sinossi Scoperto il covo di un’organizzazione criminale, l’ex poliziotto Hofmeister (Karl Meixner) è intento a rivelare all’ispettore Karl Lohmann (Otto Wernicke) il nome a capo della banda. Ma la telefonata viene interrotta, la luce va via, e dopo dei colpi di pistola Hofmeister sembra essere impazzito. Nel frattempo in un’aula universitaria, il professor Baum (Oscar Beregi) spiega il caso clinico del dottor Mabuse (Rudolf Klein-Rogge), che con «doti quasi sovrumane di logica» si era servito dell’ipnosi per commettere crimini efferati. Ma anche Mabuse era finito per impazzire. Rinchiuso nella cella dell’ospedale psichiatrico gestito da Baum, ora trascorre le sue giornate senza proferire parola, riempiendo pagine di appunti apparentemente incomprensibili. Pian piano si fa strada l’idea che qualcuno nel mondo esterno possa eseguire i folli ordini di Mabuse. Nonostante sopraggiunga la notizia della sua morte, la banda
criminale continua a eseguire gli ordini del misterioso “dottore”, che si rivelerà essere in realtà Baum, posseduto dallo spettro demoniaco di Mabuse. Alla fine Lohmann, grazie all’aiuto di Thomas Kent (Gustav Diessl) – intento ad abbandonare il mondo della criminalità per amore di Lilli (Wera Liessem) –, riuscirà ad arrestare gli scagnozzi di Mabuse e a smascherare Baum. Sventato anche l’ultimo piano, ovvero la distruzione di un impianto chimico, Lohmann e Kent inseguono Baum, diretto all’ospedale psichiatrico. Qui il professore, entrato nella cella dove intanto è stato ricoverato Hofmeister, si presenta come il Dr. Mabuse. Immediatamente il maleficio ipnotico a cui era sottoposto Hofmeister svanisce. La cella adesso può ritornare a essere la dimora del professor Baum/Mabuse. Note Sono trascorsi undici anni, un’ellissi che trasforma il dottor Mabuse, trasforma Fritz Lang e tutto il cinema, trasforma la Germania che nel 1933, proprio mentre Il testamento prende forma nella sala di montaggio, assiste all’ascesa di Hitler. Succede allora che un altro Doktor, con la passione per il cinema e, a quanto pare, un grande estimatore di Lang, assuma il controllo del Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda. Nonostante le ambiguità dei rapporti di Joseph Goebbels con Lang sconfinino nella leggenda, come si intuisce ad esempio dalle molteplici versioni di un fatidico incontro tra i due che presumibilmente avvenne alla fine del marzo del 1933, Il testamento del dottor Mabuse viene stroncato dalla censura, che ne vieta la distribuzione in Germania. È a Budapest, nell’aprile del 1933, che il film ottiene la sua prima proiezione pubblica, per poi fare ritorno a casa solo dopo la seconda guerra mondiale, nel 1951. Il testamento è una cesura – invero mai definitiva – di due cicli, il primo inerente al personaggio di Mabuse, il secondo alla produzione tedesca di Lang. Questo capitolo sancisce delle rotture significative con il film del 1922, così come rilancia la potenza di alcuni dispositivi formali
in virtù dell’emergenza di nuovi regimi percettivi, intensificandone anche i significati metacinematografici. In Il dottor Mabuse la prima apparizione di Mabuse avviene tramite un’immagine, o meglio più immagini, attraverso le carte che lo stesso protagonista ha in mano e che rappresentano i diversi travestimenti che caratterizzano, come sottolinea Paolo Bertetto, la personalità ambigua e proteiforme di Mabuse. Anche nel Testamento la prima apparizione del protagonista è veicolata da un’immagine, questa volta però un’immagine fotografica, una diapositiva proiettata per un pubblico di studenti nell’aula universitaria in cui il professor Baum sta tenendo la sua lezione. Le differenze sono evidenti. Ma soprattutto sono sintomatiche di un passaggio che dalla rifrazione del soggetto passa a una sua rarefazione. Ovvero, se prima Mabuse esercitava il suo controllo e manifestava la sua onnipresenza in un gioco di moltiplicazioni identitarie, qui si smaterializza. Libero dai limiti del corpo umano, dopo la morte, accresce senz’altro il suo potere: adesso sembra penetrare non solo le menti – quella di Baum in primis – ma ogni superficie del visibile (e del non-visibile), si insinua tra le pieghe dei fogli scritti, permea lo spazio come voce acusmatica e presenza fantasmatica. La morte di Mabuse rimane fuori campo, come luogoaltro e indicibile di una metempsicosi spettrale che alimenta ancora – anzi con maggior insistenza – quell’interrogativo che guidava anche il primo film: chi si nasconde dietro tutto questo? Mabuse, certamente, ma anche Lang stesso, come più volte notato. Questa volta invece la risposta a una simile domanda implica, seguendo Tom Gunning, una regressione all’infinito. Regressione che, nella messa in scena langhiana, sembra condurci oltre lo schermo, oltre il sipario, dritti al cuore dell’apparato cinematografico. Per ben due volte nel film viene strappato il velo di Maya. La prima volta quando Kent, uno dei componenti della banda di Mabuse, – fermo però ad abbandonare la vita criminale per amore di Lilli – fatto ostaggio e condannato a morte dal capo per il suo tradimento, decide di oltrepassare la tenda/sipario, intento a scoprire l’identità del misterioso
“dottore”. Lo spettatore a questo punto ipotizza la presenza del professor Baum, per ritrovarsi invece di fronte a una pura finzione: una sagoma in cartone, un microfono e un altoparlante. La stessa cosa accade più avanti, quando Kent e il commissario Lohmann, ormai convinti degli intenti criminali del professor Baum, sfondano la porta del suo ufficio, per ritrovarsi nuovamente davanti a un giradischi che riproduce meccanicamente la sua voce. Lang qui non ripropone solo quell’idea che permea tutto il film secondo cui il male può dimorare nell’invisibilità, ma innesta un grande momento di autoriflessività in cui la seduzione del crimine incontra la fascinazione per il cinema come grande macchina generatrice di illusioni fantasmagoriche. Mabuse, come ricorda Jonathan Crary, non è semplicemente un personaggio di fantasia. È un sistema di potere spettacolare. Un sistema che trova nello sguardo la fonte della sua attrazione. Nel Testamento, però, rispetto al Dr. Mabuse, una sola inquadratura incornicia il volto in PP di Mabuse (se si esclude il PP del suo volto demoniaco), con lo sguardo penetrante rivolto in camera, enfatizzato dalla voce fuori campo di un medico del manicomio che sottolinea l’incantesimo meduseo di «occhi che ti lasciano praticamente paralizzato». Peculiare è il fatto che Mabuse sfrutti i suoi poteri ipnotici e seduttivi non solo tramite lo sguardo, ma materializzandosi prima nelle pagine del suo “testamento” e in seguito in una voce che si fa mezzo di trasmissione potentissimo. Nella straordinaria sequenza della possessione/allucinazione nell’ufficio del professor Baum, infatti, il primo “passaggio” dal professore a Mabuse avviene proprio tramite la voce. Mentre il professore legge i diktat dell’“impero del crimine” stilati da Mabuse, un carrello ci conduce verso il PP del professore, che smette di parlare, chiudendo gli occhi. La lettura del manoscritto, però, continua poiché la voce di Baum viene sostituita da quella oltretombale di Mabuse. Solo successivamente, dallo sguardo attonito del professore che riapre gli occhi, Lang stacca sul fantasma agghiacciante di Mabuse seduto proprio di fronte a
Baum. Chiaramente questa esaltazione del suono rivela da un lato la capacità di Lang, già manifestatasi nel suo precedente film, M (1931), di integrare e sfruttare tutte le potenzialità offerte dal film sonoro. Dall’altra aggiunge un grado di complessità nel riflettere sui meccanismi di assoggettamento della modernità industriale, che non si basano più esclusivamente sul primato della vista. Basti pensare al clima di terrore e claustrofobia realizzato nella sequenza di apertura del film, non solo tramite un sorprendente movimento di macchina che sembra già presagire uno sguardo non-umano, ma anche attraverso un boato ritmico e sinistro che penetra l’immagine in una sintesi magistrale. Se Il testamento suggella il periodo tedesco, nel 1960 Lang ritorna ancora a Mabuse, per chiudere un altro cerchio, questa volta quello della sua carriera, attraverso un testamento personale, un labirinto di rimandi filmici che mentre guarda al passato e si perde in una memoria visiva, viene permeato però da profondi mutamenti storici. Ne Il diabolico dottor Mabuse (Die 1000 Augen des Dr. Mabuse, 1960) il controllo ipnotico si fa sguardo catodico che passa attraverso la moltiplicazione degli schermi delle telecamere di sorveglianza. I “mille occhi” del titolo originale tradiscono un’atavica ossessione langhiana e, allo stesso tempo, rivelano una preoccupazione attuale, come ricorda Lotte Eisner, per la dipendenza dalla tecnologia, per i lati oscuri del progresso scientifico. Il film si apre con l’omicidio del telecronista Barter. L’arma (americana) del delitto, un sottile ago di acciaio sparato da un fucile ad aria compressa, è il piccolo dettaglio che crea il primo ponte con il passato. Riflettendo sulle circostanze dell’omicidio, un investigatore commenta: «A voi dice niente il nome dottor Mabuse?». Si apre così la prima voragine in un passato che principalmente è un rimando alla cinematografia di Lang e che ci conduce ancora una volta nella mente criminale che si è ora reincarnata in un erede contemporaneo.
La narrazione intreccia indizi, a volte in modo fuorviante, frammentando le coordinate spaziotemporali, costringendo lo spettatore a credere ancora una volta a una finzione, a quella che si rivela essere solo una messa in scena. Pian piano tutto sembra confluire al Luxor Hotel, ennesima personificazione del male, rifrazione di Mabuse/dottor Jordan/Cornelius. Questo edificio panottico, come spiega Gunning, incorpora nei nuovi sistemi di videosorveglianza quelle che un tempo erano le doti ipnotiche e sovrannaturali del malefico dottore. Come a dire che Mabuse, vivo o morto, continua a sopravvivere nel nostro intimo desiderio di visione e conoscenza, in quella avidità degli occhi che il cinema riesce a soddisfare così pienamente.
Duello mortale* di Jacques Aumont Che cosa poteva sperare, agli inizi del 1941, un tedesco cacciato dal suo paese a causa del nazismo e stabilitosi negli Stati Uniti? Naturalmente che il suo paese d’adozione uscisse dall’immobilismo e dall’indecisione, e mettesse d’accordo le parole ufficiali (appoggio all’Inghilterra, condanna del nazismo) e la politica reale. E come poteva contribuirvi, lui, in qualità di cineasta? Facendo un film, chiaramente. Prevedere il passato è sempre piuttosto facile. Non fingiamo dunque di credere che tutto, fino ai minimi dettagli di questo film, fosse già in fieri in quel semplice programma. Molti film, allora, erano prevedibili: molte sceneggiature, e molti modi per realizzarle. E poi, si sa che, nel sistema hollywoodiano, è lo studio che decide sul film da farsi, non colui che lo realizza. Tuttavia, una volta poste tali premesse, nulla appare più logico della genesi di questo film. È Darryl F. Zanuck o in ogni caso la 20th Century Fox che, dietro sua indicazione, acquista nel 1940 i diritti del romanzo Rogue Male1, oggi dimenticato, ma che, al tempo della sua pubblicazione nel 1937, aveva fatto scalpore. L’adattamento dell’opera viene affidato prima a Jules Furthman, poi a Dudley Nichols2; il film dovrebbe essere realizzato dal duo John Ford-Kenneth Macgowan, che ha appena terminato Alba di gloria (Young Mr. Lincoln, 1939). A quanto pare, è per via dell’indisponibilità di Ford che Macgowan suggerisce il nome di Fritz Lang. Ma il caso (che non sbaglia) non ha che una piccola parte in questa proposta, poiché i documenti reperibili danno la sensazione di un’adesione senza riserve del cineasta al progetto, al suo peso politico e, inscindibilmente, al suo aspetto di “film d’avventura”3. Fritz Lang, che è ancora impegnato fino alla fine del dicembre 1940 con il suo film precedente (Fred il ribelle, Western Union, 1941), si occupa di Duello Mortale (Man Hunt, 1941) allorquando la sceneggiatura, già molto elaborata da Dudley Nichols, ha raggiunto a grandi linee
la propria forma definitiva. Tale sceneggiatura sarà ancora rielaborata da Nichols e da Lang per due mesi, e si è conservato il verbale di un incontro con Zanuck che testimonia un grandissimo accordo fra i tre uomini, in particolare su alcuni punti essenziali riguardanti la portata politica del film. Un dettaglio sarà sufficiente a dare la misura di tale accordo: mentre la sequenza finale verrà più volte rifatta (a film terminato è ulteriormente sfrondata rispetto a quella già depurata dello shooting final script), un elemento non cambierà più dopo l’incontro del 4 febbraio 1941: l’esordio finale. Come figura nel verbale dell’incontro, così appare nel film, senza che gli si cambi nemmeno una virgola – in particolare le ultime parole, che varrebbe la pena di sottolineare una per una: «this time he clearly knows his purpose, and, unflinching, faces his destiny». A quel punto è già stato ampiamente superato, alla 20th Century Fox, lo stadio della preparedness; si tratta adesso di perorare la causa dell’entrata in guerra. Due argomenti sono al centro dell’arringa: l’espansionismo germanico, la barbarie nazista. Il primo argomento, più razionale, più tecnicamente politico, è essenzialmente affidato ai dialoghi, raggiunge il suo apogeo emotivo nella scena della caverna, dove si viene a sapere che la Germania ha invaso la Polonia. Il secondo argomento, preponderante, è anch’esso molto presente nei dialoghi, ma è anche oggetto di una gran parte del lavoro di messa in scena. Il film mostra una collezione di nazisti di tutti i generi, dal politologo di alto livello spietato ed esaltato nel personaggio di Quive-Smith (George Sanders) fino al più anonimo e volgare degli esecutori londinesi, passando per il dottore, per lo scaltro bavarese amante della birra, fino all’assassino dal volto acuminato e feroce come la lama della sua arma (interpretato dal meraviglioso John Carradine). Probabilmente Lang aveva ancora in mente questo gruppo di criminali, quando diresse, due anni dopo, Anche i boia muoiono (Hangmen Also Die!, 1943). In Duello Mortale si può notare come la prima lezione del film passi proprio attraverso questi personaggi: che siano educati o villani, tedeschi o inglesi, qualunque sia il loro aspetto, tutti i
nazisti sono assassini, carnefici, torturatori, tanto più terribili quanto più perfetta è la loro organizzazione. Bruti primitivi o eredi caricaturalmente rigidi del militarismo prussiano, nazisti sono inoltre gli esecutori di un temibile piano strategico, il cui scopo è nientemeno che la dominazione del mondo intero («Today, Europe, tomorrow, the world!», grida Quive-Smith, con un impeto indubbiamente sincero). È proprio così – temibili e strateghi – che vengono presentati fin da principio. Quive-Smith e il dottore, infatti, giocano a scacchi mentre gli uomini delle SS torturano l’eroe, l’inglese Thorndike (Walter Pidgeon), che durante la ritirata di Berchtesgaden era riuscito ad avvicinarsi al Führer a tal punto da poterlo uccidere se solo ne avesse avuto l’intenzione – cosa che invece nega. Naturalmente non c’è nulla di inverosimile in questo, ma la presenza così insistente del gioco degli scacchi durante la lunga scena dell’interrogatorio eccede il semplice realismo o la mera funzione decorativa: si tratta di un gioco in cui a trionfare è il più furbo e spregiudicato (un gioco, inoltre, il cui unico scopo è quello di vincere: non un semplice passatempo)4. L’inquadratura che inaugura questa scena si apre su un panorama montano, un panorama dipinto che non vuole affatto dissimularsi e che la cinepresa abbandona subito per scendere sulla scacchiera, rivelando fin dall’inizio che il realismo del film non verrà declinato come accuratezza documentaristica, e che i luoghi saranno sempre connotati metaforicamente o addirittura ideologicamente. La partita è già avviata: i bianchi sono arroccati e il dottore, che li gioca, riflette sulla prossima mossa. Nel frattempo, Quive-Smith, da intenditore, esamina il fucile, il binocolo e il passaporto di Thorndike, da cui trae le sue conclusioni: è un fine conoscitore del mondo bellico. Nella grande stanza, dove avranno luogo due lunghe conversazioni ideologicamente impegnate tra l’inglese che crede nella democrazia e il tedesco che disprezza tutto ciò che percepisce come debolezza, abbondano gli oggetti, tutti potenzialmente simbolici. Una statua di San Sebastiano crivellato da frecce, visibile nella maggior parte delle inquadrature, evoca
chiaramente le torture inflitte al prigioniero, mentre un San Cristoforo sembra indicare la possibilità di una via d’uscita. Sul paralume in pergamena di un abat-jour, posto accanto al tavolo con gli scacchi, vi è un frammento di spartito in neumi su cui è chiaramente leggibile la frase: «Nur deine Güth hilft / Mir aus den Nöthen» (Solo la tua bontà mi sottrarrà alle pene). L’ironia è evidente, soprattutto se proviene da un regista per il quale “nulla è dettaglio”. Un’aquila sopra un globo e una biga romana aggiogata a tre cavalli esprimono più banalmente il gusto nazista per i simboli pagani. Ma senza alcun dubbio, oltre all’onnipresente San Sebastiano, è la scacchiera che, posta al centro della messa in scena e comparendo in quasi tutte le inquadrature, ne focalizza e ne emana tutti i significati. Come già detto, è il gioco strategico per eccellenza, in cui trionfa chi ha una capacità logica e intellettuale superiore; è anche un gioco brutale, in quanto prevede un solo vincitore e un solo sconfitto. All’inizio della prima conversazione tra i due uomini separati dalla scacchiera, il dialogo insiste sull’equivoco tra game/gioco e game/cacciagione – un gioco di parole già utilizzato in un film che Lang e Nichols conoscevano, Pericolosa partita (The Most Dangerous Game, 1932) di Irving Pichel e Ernest B. Schoedsack5. Inoltre, gli scacchi rappresentano il gioco che oppone i bianchi ai neri, elemento particolarmente appropriato per un film in bianco e nero. Nella partita in corso, è il dottore a muovere i bianchi, quindi Quive-Smith prende i neri: discreto tocco di verosimiglianza, dato che in una partita amichevole, chi accetta i neri è di norma il più forte; ma è anche un’inversione rispetto ai colori dei loro vestiti – scambio che anticipa un’altra inversione ben più significativa, tra il bianco immacolato dell’uniforme del nazista che gioca con i neri e il grigio scuro e sporco dei vestiti da caccia del candido cittadino britannico. Come in quasi tutto il film, la preparazione (in gran parte dovuta al regista) della messa in scena, del set e dell’abbigliamento ha funzionato nel doppio senso della verosimiglianza (non parliamo di realismo, poiché tutto nel film è rimaneggiato) e del significato. Chi frequenta il
cinema di Lang si accorgerà di quel tocco riconoscibile tra centinaia. Lang conferiva un’importanza tale alla metafora degli scacchi in questo film che aveva previsto di utilizzarla come figura generale e generatrice. Una serie di foto scattate durante la preparazione del film conserva traccia di tutto ciò: lo spostamento da Berchtesgaden a Londra sarebbe avvenuto mediante una dissolvenza fissata su un’inquadratura generale della scacchiera, sostituita poi da un modellino di Londra, con veicoli bianchi e neri disposti in un quadrato, ovvero un’altra scacchiera, stavolta a grandezza naturale, dove si sarebbe giocata la vera “partita”. L’idea fu rifiutata da Nichols e da Zanuck, tuttavia nel film permane visibilmente l’idea che Thorndike e Quive-Smith siano due avversari in un gioco che richiede intelligenza e mancanza di scrupoli. Non è quindi un caso che Lang, sin dal primo incontro tra i due uomini, abbia insistito così tanto sull’inversione del bianco e del nero. Inversione senz’altro provocatoria, mirata a suscitare una reazione nello spettatore con la propria ironia (in modo analogo all’accento british troppo marcato e all’elocuzione melliflua di Sanders). Ma non la si può forse anche leggere letteralmente? Nella partita a scacchi, sono i bianchi che avviano il gioco e che per questo mantengono sempre il vantaggio di una mossa. Per quanto accorte siano le sue mosse, Thorndike non farà altro che rispondere – soprattutto perché, fino alla fine della partita, sembra non abbia un vero e proprio piano strategico da opporre a quello di ferro messo in atto da Quive-Smith. Possiamo così vedere, nel complesso, come ogni elemento – ovvero lo stile personale di Lang, la sua preparazione meticolosa, l’accordo con il produttore e lo sceneggiatore, la pregnanza visiva della partita a scacchi – concorra a sostenere il progetto del film. Si tratta di inscenare un confronto tra due termini, e due soltanto: il bene e il male, la democrazia e la barbarie nazista. Oltre ai due protagonisti, tutti gli altri personaggi non sono altro che comparse in questo duello, lo è persino Jerry, la piccola e affascinante prostituta (ben travestita da sarta per aggirare la censura6) innamoratasi del bel
gentleman, e il cui ruolo è chiaramente il risultato dell’aggiunta di un elemento romantico, ritenuto necessario da molti produttori dell’epoca. E, in modo ancora più radicale, tutte le situazioni devono essere epurate, ricondotte allo schema più trasparente possibile del confronto tra due termini antagonisti. Il risultato è, così, un lavoro costante di ellissi e soppressione, al quale nulla sfugge (come non sfugge allo spettatore). Fra i documenti visivi che sono serviti a preparare questo film (foto, storyboard), una buona parte è dedicata, talvolta con molta insistenza e una grande cura del dettaglio, a una delle scene che il genere “film d’avventura” sembrava richiedere: l’evasione di Thorndike. I disegni raccontano, in modo pletorico, la fuga attraverso le paludi, il furto di un’imbarcazione, fino all’approdo in un grande porto industriale tedesco. Alcune foto, senz’altro commissionate da Lang al Research Department della 20th Century Fox, ritraggono determinate atmosfere: «idea for type of undergrowth»: numerose foto di sottoboschi; «idea for night shot in German harbour»: ciminiere contro un cielo scuro, effetti di luce riflessa sull’acqua7… Alcune di queste «idee per» sono state realmente girate (le scene del furto della barca e della fuga lungo il fiume sono attestate da alcune foto scattate durante le riprese), sebbene non siano mai state montate. Lo spettatore non conoscerà mai i dettagli, e non si può nemmeno dire che spetterà a lui immaginarli, poiché tali dettagli, non solo non vengono mostrati, ma non devono essere mostrati: non devono essere mai esistiti. È necessario che l’astrazione sostituisca il racconto illustrato, che l’idea di fuga sostituisca la fuga come concatenazione di episodi drammatici o comici. È necessario che Thorndike scompaia e poi inspiegabilmente ricompaia. È necessario che il film abbandoni il racconto d’avventura per divenire parabola logica. La logica non è il verosimile, e si sa che Lang sceglie sempre il primo dei due termini, a costo di sacrificare l’altro. L’ellisse, l’eliminazione pura e semplice dei momenti problematici del racconto, è la manifestazione più vistosa di tale scelta, ma non l’unica. Talvolta, invece,
è con l’aggiunta, apparentemente destinata a conferire verosimiglianza, che Lang ottiene astrazione e forza logica. Mentre Thorndike viene torturato dietro la porta (in modo totalmente astratto, per cui non vedremo alcun effetto se non un cerotto [!] e poi una piccola cicatrice sulla guancia destra), Quive-Smith avanza di una casella. Telefona a un ufficio della Gestapo chiedendo di preparare a nome di Thorndike una confessione falsa, assolutamente identica – ordina – a quella utilizzata dianzi per il caso Roszicky. Tutto ciò sarebbe chiaro se gli ordini, trasmessi in tedesco, fossero tradotti. Ma non lo sono mai, e se va bene lo spettatore dovrà ricostruire quanto è accaduto o, alla peggio, non capirlo mai8. Risultato di tutto questo lavoro di epurazione della sceneggiatura: un’impressione, soffocante (ed era lo scopo perseguito), di potere. Come Thorndike e prima ancora di lui, lo spettatore è nelle mani di qualcosa che lo domina, costantemente preceduto di una mossa e manipolato da un’entità invisibile, onnipresente, magistrale e di superiore intelligenza. Naturalmente, per tutto il racconto, il narratore possiede un grado di conoscenza maggiore rispetto allo spettatore. L’elemento eccezionale in Duello mortale è che questa posizione privilegiata dell’enunciatore si concretizza sia nella trama che nella messa in scena, per cui lo spettatore assiste sempre al fatto già compiuto: esso viene trascinato dalla narrazione, volens nolens. I nazisti, a Londra, sono ovunque9, vi saranno sempre prima di tutti gli altri (prima di Thorndike, prima di Jerry, prima della polizia), non li si vedrà mai arrivare, ma sempre già presenti. Come l’eroe, lo spettatore dovrà presto riconoscere questo dono dell’ubiquità, che il film non si cura di spiegare salvo che per l’indizio, improbabile e disinvolto, della scena del piccione viaggiatore – (all’epoca del telefono!). Come l’eroe, sarà presto anche lui in preda all’angoscia da incubo provocata da tali apparizioni. E tutto studiato appositamente affinché lo spettatore si metta nei panni dell’eroe (fino alla penultima scena filmata lo si vedrà empaticamente dal punto di vista del braccato, dell’assediato).
Qui, chiaramente, la pura logica astratta che Lang amava tanto nei suoi film americani si unisce all’intenzione ideologica. Si tratta di portare le metafore alle loro estreme conseguenze, di mostrare concretamente, fisicamente, quasi, che l’oppressione e la barbarie nazista non sono un’idea che riguarda solamente popoli lontani, foreigners, ma che possono, al contrario, aspettarti al varco, soffocarti da un momento all’altro, in modo potente: senza dubbio, di rado sono stati utilizzati dispositivi narrativi e di messa in scena talmente consapevoli da coinvolgere lo spettatore in processi identificativi così forti con l’eroe. Come uscirne fuori? O, visto che si tratta di un film narrativo di stampo militante, come soddisfare questo doppio programma: fare in modo che l’eroe riesca a cavarsela senza che, a sua volta, lo spettatore ne esca indenne? In altre parole: che cosa opporre a questo potere assoluto di cui gode fama il nazismo? Le soluzioni immaginate dalla sceneggiatura di Lang e di Nichols sono di due tipi. La prima si gioca sul versante della verosimiglianza psicologica o, meglio, di quel misto più accettabile di psicologia e di verosimiglianza che è la tipizzazione. I primi stadi della sceneggiatura (e poi ancora lo shooting script), generalmente più espliciti del film terminato, tenevano a mettere in rilievo il rapporto di cugini nemici (come si dice “fratelli nemici”) che unisce Quive-Smith e Thorndike, nazisti e britannici. Se l’apparenza, le maniere, il linguaggio di un gentleman celano in Quive-Smith una natura bestiale, selvaggia, ciò è dovuto al fatto che egli è un ibrido, un meticcio10; nato da padre inglese e da madre tedesca, ha ricevuto in eredità certi valori barbari rivisitati dall’ipocrita civiltà britannica – che pertanto egli conosce perfettamente e dall’interno. Ibrido transfuga, Quive-Smith calcola, è freddo e astrattamente intelligente. Di fronte a lui, il prototipo del britannico, onesto, coraggioso, leale, energico, longanime, ma anche, bisogna dirlo, un po’ meno intelligente del suo avversario. La sceneggiatura su questo punto è particolarmente sottile, nel suggerire, ad esempio per la scena del confronto a Berchtesgaden, che
Quive-Smith commetta un errore di valutazione per eccesso d’intelligenza; minacciando Thorndike di consegnarlo nuovamente ai torturatori, lo avverte: «You think it is easy to throw away your life, yes, it is, but, how well do you stand pain?». O, più precisamente, è alla prova concreta, fisica del dolore, senz’altro più che a quella astratta della morte, che Thorndike è in grado di far fronte (e di resistere, vittoriosamente). In un’inquadratura, non girata, della scena in cui i nazisti vanno alla ricerca di Thorndike, l’indomani mattina, Quive-Smith domandava al Scharführer che comandava i torturatori: «Habt Ihr ihn denn auch richtig in die Kandare genommen?» (gli avete messo i morsi, il freno?), una metafora tratta dalla lingua tedesca, che fa letteralmente di Thorndike un cavallo da domare e da vessare. La figura del cavallo, l’animale nobile, libero, più istintivo che intelligente, ritorna in un’altra replica suggerita da questa medesima scena, in forma ammirativa («Eine Natur muss der haben – wie ein Pferd», deve avere un temperamento da cavallo). E in essa dev’esserci qualcosa di vero riguardo al carattere dell’eroe. Accanto alla soluzione psicologica (e talvolta in conflitto con essa), c’è poi la soluzione logica: alla logica, impareggiabile sul suo stesso terreno, del giocatore di scacchi, non si può ovviare se non cambiando terreno, o gioco. Thorndike, lo si è detto, è colui che lungo il racconto subisce l’iniziativa del campo avversario, e questo rimane vero fino al penultimo momento, fino a quella mossa magistrale di Quive-Smith, la lettera falsa depositata fermo posta, che sembra dover sferrare lo scaccomatto mortale. Ora, è nel decidere di non giocare più, e anche nel ricorso a un’arma magica finora vietatagli, che Thorndike riesce a sfuggire all’insidia. È questa la posta in gioco della scena della caverna. Tale sequenza, posta prima dell’esordio finale, fa eco alla seconda scena del film, ovvero quella dello scontro verbale tra i due protagonisti in Germania, alla quale si cerca di fornire una soluzione in termini ideologici (quelli del film “militante”). Bisogna protestare contro la barbarie nazista o deriderla, come fa l’eroe nella prima
scena (tramite la parodia del saluto nazista), o ancora bisogna, più efficacemente, armarsi per distruggerla? Tutto il film è votato a far passare lo spettatore, insieme all’eroe, dal primo al secondo termine dell’alternativa, perciò è comprensibile che questa scena sia lunga, ridondante, enfatizzata. Una simile inversione attraverso cui la scena di Berchtesgaden viene specularmente rievocata dalla scena nella caverna (compresa la loro relazione con il bosco) è solo la comparazione più evidente di un gioco di ripetizioni e inversioni che attraversa tutto il film. Come avviene, ad esempio, tra la sala di rappresentanza a Berchtesgaden e il salotto aristocratico del fratello di Thorndike. In entrambi i casi vediamo dei quadri appesi alle pareti (tra cui, nell’antro nazista, una Danae in una delle versioni di Tiziano: dettaglio, questo, difficile da spiegare). Tutto il resto, però, contrasta: poltrone medievali in un caso, morbidi divani nell’altro (morbidezza enfatizzata dal gesto infantile di Jerry che rimbalza sui cuscini); gli scacchi nella prima scena, una partita a carte nella seconda (se non perfino un banale solitario). L’amante dei dettagli, Fritz Lang, si è divertito a rimarcare con ironia la distanza tra i due mondi, uno radicale, brutale e spaventosamente logico, l’altro sereno, rassicurante, ma debole. Ritorniamo alla caverna. I documenti conservati nel fondo Lang non contengono nulla (nulla di visivo, almeno) relativo a tale caverna. Nessuna foto di documentazione, nessuno storyboard, solo una descrizione, sulla quale torneremo. In compenso, è preziosa un’indicazione emersa dal verbale stenografato della discussione con Zanuck del 4 febbraio 1941. Mister Lang, vi si dice, pensa che la scena della caverna debba essere incentrata su Thorndike, con la voce di QuiveSmith in off, e questo per creare l’effetto di un animale preso in trappola11. Questa caverna è dunque innanzitutto una tana, il che è confermato dalla sua disposizione interna: un giaciglio, del cibo, una presa d’aria, una protezione contro i predatori. Essa conclude così, a modo suo, il tema del big game, della grande battuta di caccia, e del dangerous game, del pericoloso
gioco della caccia, esplicitando finalmente quanto il film aveva suggerito fin dalle prime inquadrature, ossia che il cacciatore può diventare preda. Ecco come viene descritta la caverna nella sceneggiatura finale: «the floor of this cave, which is not much bigger than a coffin (though about four feet to the uneven, rocky surface of the ceiling), is sandy like the bed of the gully». Inutile dire che la caverna, così come appare nel film, non si conforma strettamente a questa definizione, perlomeno in termini di dimensioni; il soffitto, infatti, è alto più di un metro e mezzo, dato che ci si può stare in piedi al suo interno, e inoltre è molto più ampia di una bara; per quanto riguarda il pavimento sabbioso, invece, non si riesce quasi mai a vederlo. Tale descrizione, tuttavia, rivela due elementi essenziali a livello figurativo (il che è rilevante nell’economia visiva dell’intero film). Il primo è subito evidente (e reso esplicito da Quive-Smith quando dice: «You are sealed up as in a grave»): ovvero, si tratta di uno spazio destinato a un cadavere (una tomba). Altrettanto significativo è il secondo elemento: vengono palesati i tratti di uno spazio che seppur disumanizzato, rimane in contatto con la natura circostante12. Del resto, il suo funzionamento all’interno del film è abbastanza chiaro, come si evince anche dalla sua simmetria con la scena della fortezza, dove la reclusione e la minaccia di morte hanno però un aspetto differente. La fortezza di Hitler è, se ne vanta Quive-Smith all’inizio del film, «the most closely guarded house in the worlds»; la caverna è forse un po’ meno piantonata, ma meglio chiusa (closed). Questa è la molla del ricatto esercitato da Quive-Smith, il cui obiettivo principale fin dall’inizio, è bene ricordarlo, non è quello di uccidere Thorndike, ma di ottenere la sua firma sulla falsa confessione della sua premeditazione13. Basandoci solo su quello che vediamo, però, la forza di questo ricatto non è assolutamente comprensibile. In questo spazio ben areato, munito di provviste, Thorndike può certamente sopravvivere per diversi giorni, e non è da escludere che, con il tempo e la pazienza, possa anche spostare la lastra che chiude la caverna. Ci viene quindi chiesto di credere non a ciò che
vediamo, ma a ciò che viene detto («you may last a few hours») e a ciò che è stato scritto nella sceneggiatura (la caverna è una bara). Questa modifica è nata, lo si deduce immediatamente, da considerazioni pratiche. Per esempio, l’attore doveva avere lo spazio necessario per compiere delle azioni, per la finzione scenica, in particolare per la costruzione dell’arco da una delle doghe di una rete che non ha nulla a che fare con la tana di un animale. Ma il più significativo di questi cambiamenti riguarda la presa d’aria della caverna. La sceneggiatura ne menziona l’esistenza, ma nulla sta a indicare dove è situata precisamente. Nel film tale presa è ad altezza d’occhio: permettendo, così, non solo la circolazione dell’aria, ma anche altri tipi di circolazione. Ad esempio quella degli oggetti materiali che simboleggiano il confronto fra i due uomini: la confessione, la stilografica, la freccia, il bastone. Del pari e soprattutto, la circolazione di qualcosa d’immateriale che assumerà via via su di sé tutto il peso di tale confronto, della scena e del film: lo sguardo. Un’inquadratura, qui, è particolarmente significativa: quella in cui Quive-Smith, che ha finalmente ricevuto il documento e attende Thorndike revolver alla mano, viene guardato dall’interno della caverna dall’avversario che si prepara a scoccare la freccia. Il volto di QuiveSmith si vede di tre quarti da sinistra, esattamente come predisposto dal finale dello shooting script. Ma quello che la sceneggiatura non diceva e che occupa tutto lo schermo, è la forma che assume in quel momento – e soltanto in quello – la presa d’aria: esattamente la forma di un occhio. Le due inquadrature seguenti (in cui si scinde quella che la sceneggiatura prevedeva come una sola), dove Thorndike tende l’arco e scocca, saranno improvvisamente quasi ridondanti: infatti, tutto ruota attorno all’iscrizione, perfettamente al centro dell’occhio della caverna, della testa di Quive-Smith. Lampante la rima che intercorre tra quest’inquadratura e quella dell’inizio del film, dove Hitler viene puntato attraverso il mirino del fucile del cacciatore. Questa volta, però, il
bersaglio è la testa, non solo un distintivo, e il colpo partirà davvero. Questa fessura in una parete, attraverso la quale passa uno sguardo, questa fessura a forma d’occhio arriva al culmine della scena. D’altra parte, Lang non ha esitato a sopprimere un’inquadratura della sceneggiatura per accrescere la vigorosa subitaneità della sua apparizione: si tratta di sorprendere e di sbalordire visivamente uno spettatore che è stato comunque preparato a quanto accadrà. La natura rudimentale dell’arma, assemblata con pezzi di spago e la cui parte letale è un pezzo di bigiotteria, intensifica la forza di questo omicidio (il proiettile del fucile è uno strumento di morte molto più astratto, quasi privo di un’esistenza fisica, persino difficile da immaginare). In ogni caso, è senza dubbio lo sguardo mortale, incarnato da questo inquietante occhio di pietra, a conferire all’azione tutta la sua violenza. Impossibile non vedere un tocco specificatamente langhiano in quella fessura oculare aperta nella roccia, che trova i suoi corrispondenti tanto in Metropolis (1927) quanto in La tigre di Eschnapur (Der Tiger von Eschnapur, 1959). Se, dunque, si segue la metafora dell’occhio, aggiungendovi quanto si desume da questi due film, risulta chiaro come la caverna in cui è rinchiuso l’eroe altro non è che un’amplificazione del suo cervello. La caverna è un cranio: il luogo dove la cosa viene concepita, dove la cosa viene architettata. Thorndike sta per subire lo scaccomatto dell’intelligenza logica superiore del suo avversario: è a questo punto che decide di cambiare gioco, registro e armi. Evita lo scaccomatto con la propria abilità manuale e la sicurezza dei propri riflessi di cacciatore, ma anche con la forza letteralmente giaculatoria del proprio sguardo. Da dove proviene questa forza? Lo si è suggerito diverse volte: è di natura meno intellettuale, più bruta, più istintiva di quella del nazista. Nessun animale selvaggio si batte tanto ferocemente come quando è nella propria tana (Quive-Smith lo sa: «I’ve no desire to enter a cave after a trapped animal»), perché in tal caso non difende solo la propria vita, ma la propria stessa ragione d’essere, il proprio luogo di appartenenza. Si parla, in genere,
riferendosi all’uomo, di difesa del “suolo natale”. Lo scontro verbale in Germania era ambientato in un luogo posizionato più in alto, in una stanza con vista panoramica sulle Alpi ricreate artificialmente. Il combattimento finale si svolge invece a livello terreno, quasi dentro il terreno. La forza e l’astuzia di Thorndike hanno quella qualità ctonia che deriva da un contatto più profondo con la terra natale, con la sua terra. «I film di guerra di Lang sono tutti film di “sotterranei”»14: non solo i film di guerra, ma è vero che forse in questi il “sottosuolo” acquista il suo pieno valore. Underground è il termine che designa un certo tipo di clandestinità, quella che hanno conosciuto i protagonisti della resistenza europea di cui Thorndike è il prototipo. A giudicare dalla quantità di documentazione preparatoria che ha originato, la scena che ha dato più lavoro a Lang è stata quella dell’underground, della metropolitana londinese. Una scena di sottosuolo e, proprio durante la lotta e l’uccisione del torvo nazista, già quasi una scena di caverna, dove l’eroe lotterà una prima volta spalle al muro, contrapponendo il proprio coraggio e il proprio istinto al freddo sapere dell’assassino, ed evitando, anche in questo caso, di usare un’arma tradizionale (il revolver)15. Come molti film di Lang, anche questo deriva da una duplice intenzione, da un duplice progetto, ideologico e formale, quest’ultimo altrettanto incisivo e percepibile quanto il primo16. Ho già accennato allo schema dicotomico bianco/nero. È chiaramente leggibile nella scacchiera e nelle sue ramificazioni simboliche, in particolare nell’abbigliamento, ed è inscritto anche, in modo meno insolito, nel gioco delle ombre e dei chiaroscuri che il genere poliziesco (e, tendenzialmente, tutto il cinema hollywoodiano) metteva ampiamente in pratica all’epoca. Le due inquadrature che mostrano Thorndike uscire dalla camera di tortura, svenuto e trascinato via da due guardie, fanno ampio uso del potere del chiaroscuro e della retro-illuminazione. L’intera scena dello sbarco di Thorndike a Londra sembra concepita come un catalogo di effetti visivi, in cui non potevano mancare anche i “pearly kings and queens”
che con i loro costumi scintillanti emergono dalla nebbia e permettono all’eroe di intravedere in tempo il suo cacciatore/inseguitore, e contemporaneamente propongono un classico cliché british. C’è un altro schema visivo che attraversa il film con altrettanta insistenza e ricorsività: il cerchio. Nella sua forma più pura, è il cerchio creato dal mirino iniziale puntato su Hitler, quello dell’apertura del nascondiglio dell’eroe sul transatlantico e, naturalmente, il cerchio del tunnel sotterraneo londinese, ampiamente rimarcato. Questi cerchi non hanno lo scopo di circondare qualcosa: sono transiti, aperture, di cui si sottolinea il ruolo funzionale. Permettono il passaggio della metropolitana o l’ingresso di un fuggitivo in cerca di un nascondiglio; soprattutto, sono permeati da echi sinistri, motivo per cui possiamo tranquillamente includere anche l’occhio informe della caverna nel bosco17 (o ancora l’apertura nel sottobosco durante la fuga iniziale del protagonista, che ha anch’essa la forma di un occhio). Queste forme e questi schemi sottintendono una funzione ideologica assolutamente chiara. Della partizione quasi araldica in bianco e nero si è sottolineata la pregnanza nel racconto e nel suo significato simbolico. Quanto al cerchio, è creato, né più né meno, affinché qualcosa di mortale ne sgorghi: uno sguardo, in particolare, la cui forza giaculatoria, alla fine, è rappresentata dalla freccia che, la piccola Jerry, suo malgrado, lascia in eredità. Nella scena della metropolitana, l’idea si ripropone, in maniera ancora più evidente, anche fin troppo lampante, attraverso la lama del bastone animato che Carradine estrae dalla guaina mentre varca la soglia buia18. Perfino la più anonima delle botole della stiva di una nave viene espressamente equiparata, attraverso il dialogo, a un feretro19. L’ultima parola del film, «destiny», è anche quella mediante la quale, dopo che venne scelto il titolo inglese di Destino (Der müde Tod, 1921), la critica ha voluto troppo spesso riassumere il cinema di Lang: un cinema in cui l’uomo sarebbe una mera pedina in mano agli dei, la preda del destino. Ci vuole una forte vena metafisica
per trarre questa conclusione, considerando il cinismo che permea le storie langhiane (a patto che Lang non fosse costretto a fare diversamente). Ciò che Duello mortale dimostra, infatti, è esattamente il contrario: l’uomo non deve subire il proprio destino ma, al prezzo di una lunga, difficile e dolorosa presa di coscienza, compierlo, anche a costo di affrontarlo senza esitazioni, unflinching, senza sottrarvisi. L’arsenale figurativo straordinariamente efficace del film (senza alcun dubbio uno dei più elaborati del cinema americano di Lang) non ha altra funzione se non dare sostanza simbolica, ossia non enunciativa ma figurativa, a questa traiettoria, enfatizzando il valore del suo compimento. Si può anche simpatizzare con le dichiarazioni antinaziste dell’eroe (sicuramente, nel 1941, molti spettatori ne furono scossi) – ma Fritz Lang continua ad affidarsi alle immagini per conquistare il suo pubblico.
[1.]
[2.]
[3.]
* Traduzione di Vittoria Martinetto, per la prima versione, e Arianna Vergari, per le integrazioni e i cambiamenti. Si ringrazia Vittoria Martinetto per aver concesso la riproduzione della sua traduzione.
Dietro la porta chiusa di Silvio Alovisio «Detesto il film, per diversi motivi»1. Così Lang, in una corrispondenza del 19 febbraio 1969 con Lotte Eisner, liquida Dietro la porta chiusa (Secret Beyond the Door, 1947). Pochi anni prima, conversando con Bogdanovich, era stato meno perentorio ma non più indulgente2. È probabile, però, che questo disamore di Lang per il suo dodicesimo film hollywoodiano sia motivato più da ragioni produttive e personali che artistiche, legate a uno dei momenti più difficili del suo lungo periodo americano. Nella primavera del 1945 la fondazione, con il produttore Walter Wanger e l’attrice Joan Bennett, moglie di quest’ultimo e musa di Lang, della Diana Productions (società legata per la distribuzione all’Universal ma, almeno in teoria, indipendente) aveva alimentato nel regista la speranza di poter realizzare film in autonomia, con un team rodato e rispettoso della sua autorità. La prima produzione della casa, La strada scarlatta (Scarlett Street, 1945), aveva riscosso un incoraggiante successo. Purtroppo le difficoltà emerse con il fallimento del progetto Winchester 73 e il flop di Dietro la porta chiusa portarono presto la Diana all’inattività. A posteriori Lang ribadì che il film era un vecchio progetto di Wanger, ansioso di produrre un film che eguagliasse, per qualità e, soprattutto, successo, il seminale Rebecca, la prima moglie (Rebecca, 1940, di Alfred Hitchcock). Le numerose fonti sulla sofferta lavorazione di Dietro la porta chiusa3, tuttavia, rivelano una realtà diversa. In primo luogo, il progetto era tutt’altro che vecchio: i diritti di adattamento della fonte letteraria, l’omonimo romanzo di Rufus King, erano stati acquistati da Wanger subito dopo la pubblicazione del racconto, nel dicembre 1945, sulla rivista «Redbook»4. In secondo luogo, Lang partecipò attivamente a tutte le fasi della lavorazione, confermando quella cura quasi maniacale dei dettagli e quel controllo direttivo votato al perfezionismo che erano
al tempo stesso garanzia del suo eccezionale talento e fonte di pessima fama presso i produttori hollywoodiani. Particolarmente intenso fu il suo lavoro sull’adattamento, condotto con la giovane sceneggiatrice Silvia Richards, da lui stesso imposta a Wanger nonostante la scarsa esperienza (aveva però già all’attivo un interessante script per il woman movie a tema psichiatrico Anime in delirio, Possessed, 1947, di Curtis Bernhardt). Sua la scelta anche del partner di Joan Bennett, l’attore britannico Michael Redgrave, di cui Lang aveva apprezzato l’interpretazione del ventriloquo pazzo in The Ventriloquist’s Dummy, episodio diretto da Alberto Cavalcanti nel film Incubi notturni (Dead of Night, 1945). Anche la collaborazione con Miklos Rosza fu fortemente voluta e seguita dal regista. Non fu invece scelto da lui ma da Joan Bennett il raffinato direttore della fotografia Stanley Cortez, noto per le sue luci contrastate e per la sua abilità nell’illuminare le star. Il fatto che Cortez gli fosse stato imposto e che fosse molto lento alimentò tra i due continui scontri, malgrado la fotografia di Dietro la porta chiusa sia tra le più riuscite del periodo hollywoodiano di Lang. Molte tensioni ci furono anche con il costumista Travis Banton, mentre a rendere ancora più nervoso il regista intervenne la rinuncia, a lavorazione avviata, dell’amico Oskar Fischinger, geniale sperimentatore del cinema d’animazione astratto, a realizzare la sequenza paraonirica di apertura5, sulla quale torneremo a breve. A fronte del più elevato budget di cui il regista aveva potuto godere sino ad allora a Hollywood, le difficoltà di produzione, gravate anche da ritardi nelle riprese, peggiorarono quando l’Universal, dopo l’esito disastroso della prima preview, volle imporre drastici rimaneggiamenti e tagli. Lang si oppose, minacciando per la prima volta nella sua carriera di togliere il proprio nome, segno del fatto che credeva nel film e lo sentiva suo. Alla fine ne uscì un compromesso che salvò l’integrità dell’opera, ma non evitò la catastrofica accoglienza da parte di critica e pubblico. Si è detto della volontà di Wanger di produrre un film che sfruttasse l’onda lunga del successo di Rebecca. La
sfida a Hitchcock, però, vedeva coinvolto anche Lang, come egli stesso riconosce nel suo dialogo con Bogdanovich, parlando di un vero e proprio “furto” nei confronti del precedente hitchcockiano6. Tra i debiti contratti con Rebecca, i più manifesti sono due: da un lato, una seconda moglie che sospetta del marito, possibile omicida della prima moglie, dall’altro lato l’incendio che distrugge l’antica dimora di famiglia del marito, innescato da una governante (segretaria nel caso di Dietro la porta chiusa) pazza e gelosa. Al di là dei prestiti da Rebecca, Dietro la porta chiusa integra con originalità due tendenze del woman movie hollywoodiano degli anni quaranta: il cosiddetto female gothic romance7 e il dramma a tema psicanalitico. In entrambe le tendenze, la protagonista femminile svolge un ruolo centrale. Nel primo caso la donna patisce un marito autoritario e minaccioso: si pensi non solo a Rebecca ma a film come Angoscia (Gaslight, 1944, di George Cukor), Il castello di Dragonwyck (Dragonwyck, 1946, di Joseph L. Mankiewicz), Tragico segreto (Undercurrent, 1946, di Vincente Minnelli). Nel secondo invece si batte per scoprire e risolvere il trauma che affligge l’uomo amato (come avviene in Io ti salverò, Spellbound, 1945, di Alfred Hitchcock). Pur aderendo, in modo non sempre convincente, alle convenzioni tipiche di queste due tendenze, Dietro la porta chiusa offre al regista un terreno di sperimentazione su almeno due direttrici di ricerca. La prima investe i legami tra pensiero e immagine, ed è attivata dalla scelta di sostituire la focalizzazione zero che strutturava il racconto di King con una focalizzazione interna sulla protagonista, supportata dagli interventi della sua voce fuori campo. Anche se ci si aspetterebbe il contrario, i woman movie gotici o psicanalitici che negli anni quaranta ricorrono alla voce fuori campo della protagonista sono, come ricorda Karen Hollinger, pochissimi8. Forse perché, ipotizza la studiosa, optando per una soggettivazione del punto di vista femminile vi era il rischio di emarginare il principale oggetto di indagine di questi film, che non era la donna ma il
protagonista maschile sospettato di comportamenti illeciti9. Dietro la porta chiusa rappresenta quindi un’eccezione, ed è un caso unico nella filmografia langhiana. Ancora più eccezionale è il fatto che, come vedremo, la voce di Celia risulta impegnata non tanto a raccontare ciò che sta accadendo ma a verbalizzare i propri pensieri. La seconda linea di ricerca è invece conseguente alla scelta di mantenere l’idea più forte del romanzo di King: la passione del protagonista per la collezione di stanze in cui è stato commesso un omicidio. La presenza di questo elemento costituisce per Lang una sfida su uno dei suoi terreni creativi privilegiati: la messa in scena di micromondi programmati nei minimi dettagli attraverso complesse strategie intensive e ipersignificanti di formalizzazione. Il regime infrapsichico (evocato in primo luogo dalla voce di Celia) e le implicazioni simboliche della messa in scena (chiamate in causa dal perverso collezionismo di Mark) sono quindi i due poli sui quali il film costruisce le proprie forme. A intrecciarli contribuisce il legame narrativo (l’amore, sia pure tormentato, che unisce i due protagonisti) e la loro appartenenza a un orizzonte di riflessione, tipicamente langhiano, tra pensiero e forma, tra geografie psichiche e messa in scena. I due paragrafi che seguono saranno dedicati all’analisi di queste due fondamentali componenti testuali. LA BARCA E I NARCISI
Nella prima versione del film, Lang, con una decisione che non sembra avere precedenti nel cinema hollywoodiano, aveva affidato la voce interiore della protagonista a un’altra attrice (Colleen Collins), ma poi l’Universal, preoccupata che il pubblico fosse disorientato, ne aveva imposto la sostituzione con la voce della Bennett. Questa scelta, secondo Gunning, avrebbe rafforzato lo statuto di Celia come personaggio diviso, enfatizzando la separazione tra la voce mentale e le simultanee azioni della donna sulla scena, e conferendo
maggiore autonomia all’inconscio femminile (di cui la voce off è un tentativo di rielaborazione) come dimensione radicalmente altra10. Lang consegna alla voce interiore di Celia poteri eccezionali sul piano spaziale e temporale. Spesso infatti non è chiaro in quale temporalità essa si collochi rispetto alle immagini che le sono associate, come se i pensieri di Celia avessero la capacità di muoversi tra passato e presente, tra ricordo e simultaneità. Altrettanto libero è il rapporto con lo spazio filmico. Come ha acutamente osservato Steven Rybin, i pensieri di Celia sono «il primo motore dell’inquadratura»11. In più di un’occasione la voce di Celia, peraltro, dimostra di essere autonoma rispetto al personaggio, arrivando a indirizzare le scelte della macchina da presa. È quanto accade nella prima micro-sequenza della chiesa, quando, in assenza di Celia (deve ancora entrare), la sua voce interiore intenta a descrivere l’edificio è supportata da un sorprendente dolly che attraversa le navate («Marienbad avant la lettre», scrive Gunning12). Un caso analogo si trova all’inizio della sequenza nel chiostro, durante la luna di miele in Messico, quando la cinepresa seguendo la voce di Celia, accarezza con un movimento obliquo la fontana degli amanti, la statua di un idolo arcaico, un pappagallo e, infine, la stessa Celia e Mark addormentati. È significativo notare, però, come tali poteri non si traducano anche in una prevalenza della soggettiva. In altri termini, alla dominante focalizzazione interna sulla protagonista non corrisponde il ricorso a una sistematica ocularizzazione interna. Anche se per Lang la soggettiva è una strategia formale importante, nel suo cinema egli predilige l’oggettiva, espressione di un punto di vista demiurgico che è quello del regista stesso, funzionale all’edificazione di universi chiusi capaci di inglobare e controllare i personaggi al proprio interno. L’aspetto interessante, e per certi aspetti anomalo, di Dietro la porta chiusa è che Celia spesso sfugge a questo inglobamento. Ciò avviene, in primo luogo grazie alla sua voce interiore, responsabile di un costante sdoppiamento del personaggio. Celia, insomma, non è solo contenuta nello spazio e nel tempo del film ma a volte è essa stessa
un contenitore, o l’origine del contenuto delle immagini13. Una figurazione visiva di questa strategia finalizzata al decentramento del personaggio femminile rispetto all’autorità del tempo e dello spazio filmici è ravvisabile nell’inquadratura di una sequenza del viaggio di nozze in Messico. Celia soffre della fuga improvvisa di Mark (la prima di una lunga serie) e si guarda allo specchio. Lang incornicia il suo volto in una composizione centripeta simmetrica, fortemente chiusa: al centro del campo primeggia uno specchio dalla spessa cornice, sul quale si riflette il volto della donna, confinato ai lati da due statue e due candele assolutamente identiche (fig. 1). L’immagine di Celia appare incastonata dentro questa sorta di altare laico, quasi fosse prigioniera di un rituale (questo dolore ritornerà altre volte, così come il suo volto nello specchio). In campo però si vede anche, in mezza figura, il suo corpo “reale”, di spalle, decentrato sulla destra nel buio, indizio di un’oscurità esistenziale ma anche di un desiderio di smarcamento rispetto alle costrizioni centripete dell’inquadratura. La voce di Celia interviene già nella sequenza di apertura, a ribadire da subito che se – come si rivelerà nelle sequenze successive – a soffrire di disturbi psichici è Mark, il paesaggio mentale esplorato per quasi tutto il film sarà quello della protagonista. Un lento travelling filma, in soft focus, uno specchio d’acqua, increspato da misteriosi punti scintillanti simili a stelle e da cerchi concentrici prodotti dalla caduta di un piccolo corpo estraneo (ma il momento dell’impatto non si vede, forse prefigura la moneta che Celia getterà nel pozzo dei desideri in Messico). La cinepresa inquadra poi una barchetta di carta e infine, mentre l’acqua si è fatta scura, un intreccio di fiori e radici dalle forme sinistre. Il travelling è accompagnato dalla suadente voce di Celia, quasi un sussurro, che ricorda di aver letto in un libro che se una giovane donna sogna «a boat or a ship», ciò significa che arriverà in un posto sicuro, mentre se sogna «daffodils» (narcisi), vuol dire che è in pericolo. Anche se la psicanalisi è evocata nel film, sia pure in una versione che è eufemistico definire “banalizzata”, è
importante osservare come il libro ricordato da Celia non sia L’interpretazione dei sogni ma uno di quei tanti libri di onirologia non scientifica fondati su determinismi allegorici (dunque su associazioni arbitrarie ma culturalmente connotate) tra le immagini e la loro simbolizzazione. Tutta la sequenza è pervasa da una forte ambiguità. Noi sentiamo la voce della protagonista, ma Celia sta parlando con se stessa, in un monologo interiore, dove le parole sono diretta espressione del pensiero. Le immagini potrebbero essere i ricordi di un sogno della donna. Celia però non si limita a rievocare immagini oniriche ma prova a interpretarle. L’emergere di immagini fantasmatiche legate all’inconscio (richiamato, con accenti quasi magrittiani o bunueliani, anche dalle nuvole riflesse nell’acqua) si intreccia quindi con il tentativo, più razionale a sempre mentale, di dare ad esse un significato, con l’aiuto del simbolico (il libro di onirologia). Questo nesso tra figure dell’inconscio e loro contestuale interpretazione è fondamentale per comprendere lo stato mentale di Celia. Qui la sua voce è calma, evocativa, pacata, ma anche sicura. In quasi tutti i suoi interventi successivi, invece, essa è più emotiva, perché immersa in quella torbida mescolanza di sicurezza e pericolo, di desiderio e paura, così ben descritta nella sequenza di apertura. Già nel prosieguo del primo intervento, la voce cambia registro, in particolare quando si sposta dal passato («I remember, long ago…») al presente del suo imminente matrimonio («this is my wedding day») con il quasi sconosciuto Mark. Nel tentativo di descrivere uno stato di ansia, la voce confessa di sentirsi come una persona che sta per annegare (evidente nesso con l’acqua e con il “danger” del sogno precedente) e di vedere tutta la vita scorrerle nella mente «like in a fast movie», un’espressione metacinematografica che il doppiaggio italiano, traducendo con «come in una visione», rimuove del tutto. A queste parole segue il “fast movie” della mente di Celia, ossia un flashback di dieci minuti nel quale la protagonista visualizza il passato più recente: la sua vita di donna ricca e in apparenza sicura, assediata
da pretendenti; il forte affetto, quasi filiale, per il fratello e il dolore per la sua morte; il corteggiamento di Bob, un onesto avvocato; il viaggio in Messico, dove s’innamorerà, ricambiata, di Mark. Gli interventi della voce off a commento del flashback delineano un autoritratto interiore di Celia sempre più complesso e problematico14. Il primo elemento critico si coglie quando la voce ricorda il fratello Rick: «When you died, Rick, life was lonely». Come ha osservato Karen Hollinger, il forte rapporto della donna con il fratello più anziano, scatena nella protagonista un «dilemma edipico»15: da un lato, infatti, il fratello-padre gli offriva un “porto sicuro”, così come adesso potrebbe offrirglielo Bob, eletto da Rick a suo “successore”; dall’altro lato, però, la solitudine («lonely life») di questa orfananza edipica potrebbe essere superata accogliendo le istanze più oscure e profonde del desiderio. Ed è proprio questo che accade nella seconda parte del flashback, in un Messico che Lang costruisce come uno spazio palesemente artificiale, quasi una figurazione dell’immaginario della donna, uno scenario totalmente “altro”, arcaico e pulsionale. In questa sorta di teatro del desiderio (duplicato, verso la fine del flashback, dalla scenografia altrettanto allegorica del pozzo dei desideri), Celia assiste a un duello tra due uomini che si contendono una donna. Come rivelato dalla sua voce, questa scena che intreccia Eros e Thanatos slatentizza le contraddizioni del suo desiderio erotico. Celia comprende che per eccitarsi deve muoversi lungo quel crinale che nel sogno divideva la barca dai narcisi, ossia la sicurezza (guardare da fuori la scena) dal pericolo (identificarsi con la donna-preda oggetto sessuale della contesa tra i duellanti). Il coltello fallico che si conficca a pochi centimetri da lei è il simbolo, fin troppo palese, del desiderio di Celia di essere “aggredita” e violata dal desiderio dell’altro. Non a caso proprio in quell’istante di pericolo Celia avverte su di sé (sta sempre parlando la sua voce) un’altra sensazione di eccitante paura, prodotta dallo sguardo di un uomo sconosciuto tra la folla. Gli occhi di quell’uomo, dice la voce, la stanno toccando, rivelandole – «behind my make-up» – cose su
di sé che lei stessa ignorava. Questo la spaventa e l’attira, al punto che sarà lei stessa, poco dopo, a propiziare un incontro con Mark, lo sconosciuto che l’aveva guardata e “spogliata”. «I’d planned my strategy, I wanted to meet him on my own grounds», dice la voce di Celia: la donna vuole rischiare ma fa in modo di controllare la situazione. La protagonista vive quindi una mescolanza ambigua e contraddittoria di emozioni che l’accompagna anche sull’altare, e il cui lato rischioso (sta sposando uno sconosciuto) non è una criticità ma la sostanza del legame erotico, il motore primo del suo desiderio. Grazie all’incontro con Mark e quindi all’esperienza dell’altro, la protagonista inizia un percorso di autoconoscenza che la porterà a superare le sue allegoresi deterministiche, per aprirsi allo squilibrio, al rischio, alla piena accettazione della paura. Appare evidente, allora, come sostiene acutamente Noël Simsolo, che il caso di Celia sia meno leggibile e schematico di quello di Mark, e che il film vuole raccontare non solo la guarigione di un uomo ma anche e soprattutto la “presa di coscienza”16 di una donna. Nella prima parte della sua sofferta relazione con Mark, la freddezza dell’uomo genera in Celia, donna dalla libido risvegliata, una grave frustrazione del desiderio e nutre nella sua voce interiore dubbi e domande, una trama di possibili interpretazioni sui sentimenti di Mark che di fatto paralizzano le sue azioni. La svolta si determina quando la mente di Celia comprende che non basta essere un soggetto desiderante ma occorre assumere un ruolo attivo: invece di limitarsi a patire la mente di Mark, bisogna aprirla ed entrarvi dentro. La convinzione – espressa dalla sua voce dopo il rito nuziale – che amare Mark significa l’immediata apertura di una porta oltre la quale «wind was there, and space and sun and storm» ora le sembra incauta o ingenua. Ben altre sono le porte, fisiche e mentali, che Celia deve aprire, nell’ultima parte del film, per salvare Mark e anche se stessa. La distanza che divide questa prima apertura illusoria dall’apertura ben più incisiva della stanza n. 7 (inaccessibile per volere di Mark, qui nel ruolo di un
moderno Barbablù) è rimarcata dalle diverse ma in fondo complementari scelte di messa in scena. Nel primo caso, Celia avanza con passo solenne ma determinato verso la macchina da presa, coincidente con il punto di vista dell’altare. Il suo corpo occupa stabilmente il centro dell’inquadratura, la key light di Stanley Cortez lo stacca dall’oscurità dello sfondo e ne valorizza il candore, esaltato dal bianco del vestito e delle rose che tiene in mano. Segue una soggettiva di Celia dell’altare, controcampo speculare che conferma la composizione centripeta e simmetrica dell’inquadratura precedente. Quasi subito però Celia rompe questa rassicurante specularità del rituale, smarcandosi dalla stabile visione frontale per spostarsi verso destra, verso una zona più scura, dove si trova Mark. È da questo scarto asimmetrico dello sguardo che prende forma la paura dell’altro evocata dalla voce della donna, sostanziata dall’inquietante visione di Mark che, entrando in una zona d’ombra della chiesa, diventa completamente nero (fig. 2). Una paura che accompagnerà la protagonista sin quasi alla fine del film. Nel secondo caso (l’apertura della stanza n. 7) Celia, sempre inquadrata frontalmente, deve invece avanzare in un corridoio oscuro, che non ha più nulla di rassicurante e di centrato e dove l’unica luce che le concede Cortez è quella della torcia elettrica che la donna tiene in mano. Davanti a lei c’è solo il buio, e per uscirne l’unica soluzione è, di nuovo, scartare lo sguardo verso destra e aprire, questa volta realmente, una porta sull’ignoto. OLTRE LA PORTA CHIUSA
Dietro la porta chiusa, osserva Hollinger, è prima di tutto una «battaglia narrativa per il controllo della storia»17. I due contendenti, ovviamente, sono Celia e Mark. Quest’ultimo all’inizio sembra porsi come soggetto attivo, non solo desiderante ma anche autorevole e maieutico nei confronti della sua quasi sconosciuta partner. Nel loro primo incontro, dopo averla definita una moderna Bella addormentata, Mark si assegna il compito – gravido d’implicazioni sessuali – di
“risvegliarla”, ma al primo intoppo (Celia che per scherzo, prima della notte nozze, chiude la porta della stanza per non farlo entrare) l’uomo tornerà subito prigioniero dei propri fantasmi. Anche Mark, come Celia, soffre di un problema edipico, ma il suo squilibrio è più grave, ai limiti della psicosi. Nel suo vissuto traumatico, riemergente solo nel finale del film, l’amore totale per la madre era stato tradito quando lei l’aveva chiuso in una stanza, a dieci anni, per uscire con un uomo. Dalla finestra di quella camera, il piccolo Mark aveva guardato impotente sua madre mentre si allontanava con il “rivale”. È proprio in quella stanza chiusa che Mark inizia a provare l’incontenibile desiderio di uccidere la madre, un desiderio che cerca di controllare, confinandolo a quella stanza, e attribuendo alla stanza stessa la responsabilità di quest’odio (proprio come nel daydream del processo, Mark cercherà di scagionarsi attribuendo la responsabilità dei suoi istinti omicidi all’inconscio). Da questa terribile scena primaria l’uomo sviluppa la sua teoria sulle «felicitous structures», ossia spazi non felici (come erroneamente inteso da Celia) ma adeguati, strutture la cui conformazione è funzionale all’influenza che esercitano su chi le abita. La sua collezione di stanze nelle quali avvennero omicidi di mogli, amanti o madri è per lui una sorta di singolare difesa dalla pressione pulsionale: prima di tutto perché può guardare una stanza dall’esterno, non essendone più prigioniero ma per certi aspetti creatore, e in secondo luogo perché quelle stanze dimostrano, nella loro “felice” adeguatezza, la bontà della sua tesi auto-assolutoria. Grazie a queste stanze, Mark può mettere a distanza l’inconfessabile pulsione omicida verso la madre, spostandola in un passato che non lo coinvolge, ma soprattutto trasferendola in una scena, ossia in una configurazione capace di rendere visibile qualcosa che, albergando nel suo inconscio, resta non rappresentabile. Il protagonista sublima le sue pulsioni sessuali (e omicide) attraverso un’attività per molti versi creativa e riconducibile alla pratica artistica (ritenuta non a caso da
Lacan una delle possibili forme, appunto, della sublimazione18). Il lavoro di Mark sulle stanze ricorda, inevitabilmente, quello del regista sul set, perché la (ri)costruzione di una stanza «felicitous» esige una progettazione rigorosa e un talento compositivo, proprio come la realizzazione di un film. La cura maniacale per i dettagli, l’ossessione per la simmetria (si ricordi il fastidio che prova Mark quando nota la diversa altezza delle due candele nella stanza di Celia), l’attenta disposizione degli oggetti, la più generale tendenza a costruire spazi claustrofili19 e centripeti sono tutte strategie della sua attività creativa che rievocano aspetti peculiari della stessa messa in scena langhiana. Mark è un regista di mondi chiusi che cercano di resistere alla pressione centrifuga delle pulsioni e del desiderio perverso: le stanze di cui fa collezione sono reazioni d’ordine e di controllo di fronte al concreto pericolo di un’irreversibile deriva psichica ma anche di fronte al disordine oscuro del mondo (le stanze “felici” sono perfettamente illuminate, al contrario degli altri spazi di Blaze Creek, labirintici e sempre dominati dalle tensioni chiaroscurali cesellate da Cortez). Quando fa vedere agli ospiti le sue stanze “felici”, Mark si muove con sicurezza, come un regista davanti al suo set (e al pubblico dei suoi film), occupando il centro dell’inquadratura. Celia invece è confinata in un altro campo, e non a caso vicina a Bob, l’ex fidanzato vicario del ruolo paterno. La voce di Mark conquista provvisoriamente lo stesso potere sulle immagini concesso alla voce di Celia: i movimenti di macchina che raccordano in continuità gli oggetti delle stanze, a rievocare la dinamica degli omicidi, sono la risposta della cinepresa alle “indicazioni di regia” impartite dalla voce del protagonista. Malgrado la perfezione funzionale di queste stanze e la piena armonia con il volere del “regista” che le ha realizzate, in esse si coglie un’inquietante diversità rispetto alle caratteristiche tipiche di un set cinematografico. Gli spazi di queste stanze così accortamente strutturate e allestite sono infatti saturi di oggetti ma evidenziano l’assenza dei corpi di cui Mark racconta il tragico destino. È come se
Mark, condannato dall’età di dieci anni a usare principalmente lo sguardo voyeuristico nei suoi rapporti con le donne (si ricordino le circostanze del suo primo incontro con Celia), volesse rimuovere del tutto l’eventualità di una performance fisica all’interno di questi “set” mai abitati, pena la perdita del controllo su di essi. Il regista-Mark lavora solo sugli spazi immobili e non sui corpi, quindi, e l’unica forma di dinamismo, al loro interno, è quella della macchina da presa, traduzione letterale del suo sguardo. Se Mark si limitasse a quest’attività, in fondo innocua, di sublimazione, forse potrebbe convivere con le sue angosce ancora per qualche tempo. A rendere insostenibile il suo disturbo, così come il rapporto con Celia, è però la presenza di una stanza segreta e proibita a tutti, soprattutto alla moglie. Quella stanza è l’espressione scenica di un desiderio perverso che non cerca più la sublimazione ma la morte. Il set privato e interdetto che Mark sta minuziosamente allestendo nella stanza n. 7 prevede infatti, a differenza delle altre stanze, la presenza di corpi, il suo e quello di Celia. E ciò che in essa deve avvenire per la prima volta, finalmente, è un vero omicidio, l’eliminazione della moglie. Per riprendere un’efficace espressione proposta da Gunning per accomunare questo film ai due thriller precedenti di Lang sempre interpretati dalla Bennett, Mark, in quanto soggetto sessualmente debole, è animato, in questo delirante progetto, da un «framed desire»20 che aspira ad assoggettare la donna, “inquadrandola” in una scena artificiale predisposta allo scopo. Mark tenta una prima volta di uccidere Celia subito dopo che quest’ultima ha violato il divieto, introducendosi furtivamente nella stanza n. 7. Celia reagisce d’istinto e fugge all’esterno di Blaze Creek, entrando in un bosco notturno espressionista intagliato dalla nebbia e dai rami spogli contorti. Qui intravede in lontananza una figura che sembra avvicinarsi minacciosamente. Segue il suo grido e lo schermo nero, prolungato per alcuni secondi. Subito dopo vediamo Mark nella sua stanza e ascoltiamo, per la prima volta, la sua voce interiore come a voler
ribadire che il cinema è il luogo elettivo per l’espressione del mentale, e che se una voce interiore viene meno ce n’è subito un’altra pronta ad affiorare e a mettere in scena i suoi fantasmi. Di Celia e della sua voce non vi è più traccia. La donna, come vedremo, ritornerà di lì a poco (l’uomo nella nebbia non era il suo assassino ma Bob), ma non altrettanto farà la sua voce interiore, sparita per sempre. Questa cesura forte, tipica di Lang21, è da tempo al centro di un animato dibattito critico. Secondo alcune interpretazioni autorevoli (come quelle di Stephen Jenkins e Mary Ann Doane22) la sparizione della voce di Celia e la contestuale emersione di quella di Mark rappresentano una vittoria del potere discorsivo maschile sulla soggettività femminile. Alla luce di un’attenta analisi del film, tuttavia, paiono più convincenti e approfondite altre interpretazioni, come quelle di Hollinger o Gunning23. Secondo quest’ultimo, in particolare, la voce di Celia sparisce non perché la voce di Mark (presente solo per pochi minuti) ne prende il posto ma perché non è più necessaria alla donna, visto che ora ha imparato a parlare direttamente al marito. Una volta che ha vinto la paura, o meglio, una volta che ha accettato la paura stessa come linfa del suo desiderio, Celia sceglie di rigettare il teorema di Mark, per dimostrare che a determinare le azioni (violente) non sono gli spazi che le ospitano ma la soggettività (disturbata) di che le compie. Questa scelta implica per Celia un passaggio dalla riflessione introspettiva all’azione, e quindi uno scontro diretto con Mark nel cuore stesso della sua scena fantasmatica. Celia attraversa nuovamente la casa per entrare nella stanza n. 7 ma questa volta lo fa con disinvoltura, dentro uno spazio non più divorato dal buio ma illuminato. Ora non è più osservatrice, come la notte precedente, ma attrice e, soprattutto, regista: accomoda i lillà, tanto odiati dal marito, in un vaso e si siede in attesa del suo carnefice, di nuovo mescolando paura ed eccitazione. Il duello finale tra i due si esprime attraverso un’alternanza serrata di campi/controcampi: l’unica arma di cui beneficia Celia per fermare l’inesorabile avanzata del suo potenziale
assassino è la parola, l’interrogatorio, l’interpretazione e infine la rivelazione (a chiudere la porta non fu la madre ma la sorella Caroline). Qui Celia conduce un’azione logoterapeutica che recupera il rimosso di Mark e ne risolve il disturbo con una rapidità e un semplicismo che già all’epoca non convinsero. Ma la forza di quest’ultima parte finale del film si regge non sulle allusioni a una psicanalisi trivializzata e posticcia ma a una visione fortemente allegorica della composizione scenica. La stanza n. 7, da figura segreta dell’inconscio disturbato di Mark e copia simulacrale di un originale (la vera stanza delle due mogli) che non è mai stato realmente vissuto, diventa uno spazio finalmente agito dalla coppia. La successiva distruzione di Blaze Creek, in apparenza così simile all’incendio di Manderley in Rebecca, è l’allegoria della distruzione non solo di un passato che non voleva passare ma anche di un disturbo mentale che aveva concretizzato la sua perversione in una dimensione prima di tutto spaziale. L’inquadratura finale coglie i due sposi di nuovo nel chiostro della Villa degli incanti in Messico, a simboleggiare il rinnovarsi di una più autentica luna di miele. La postura della coppia però è cambiata: ora Celia tiene sul grembo la testa di Mark e gli accarezza teneramente i capelli (fig. 3). «I still have a long way to go», dice l’uomo. «We have a long way to go», lo corregge Celia. Lo scontro io/tu si è risolto in un noi, i pensieri individuali di Celia non possono quindi più trovare una collocazione nel film. Tutto sembra risolto, ma questo idillio così ostenato, dislocato dentro uno scenario pseudo-fiabesco, con questa anomala alterazione dei ruoli (Celia sembra una madre premurosa mentre Mark un bambino) e il fatto di rimandare il compimento definitivo della guarigione a un lontano futuro, conserva non pochi margini di ambiguità24. Forse ci saranno altre porte da aprire, e altre ancora si chiuderanno. Forse Celia sognerà di nuovo i narcisi.
[1.]
[2.]
[3.]
L’alibi era perfetto* di Raymond Bellour Il district attorney Thompson si trova davanti alla finestra che mostra sullo sfondo le facciate degli edifici di fronte. Questi si stagliano su livelli di profondità diseguale, che mutano a seconda degli spostamenti di Thompson nell’ufficio, delle diverse angolazioni della cinepresa e della distanza con cui essa lo segue per tutta la durata del dialogo con l’assistente. Si tratta di mutamenti irrilevanti, ma se si prende in considerazione quel che fanno apparire o sparire dalla finestra diventano profondamente significativi. Le facciate orizzontali di questi edifici, che appaiono sia sovrapposte una sull’altra, sia in prospettiva, sono interrotte da innumerevoli finestre che delineano altrettanti quadrati e rettangoli neri, più o meno scuri, su uno sfondo bianco e grigio. Il procuratore distrettuale Thompson deplora che Susan Spencer, dopo l’improvvisa morte del padre Austin Spencer, stia approfittando dell’influenza del suo giornale, suscitando nell’opinione pubblica sensazioni “artificiose”, per cercare di rimettere in discussione la decisione della giuria che ha condannato a morte Tom Garrett per l’assassinio di Patty Gray, come richiesto dall’accusa. Davanti alla finestra Thompson sta parlando al suo assistente e accenna a muoversi verso di lui. Ecco per la seconda volta, ancor più ravvicinata, la vista dalla finestra. Ed è proprio adesso che lo spettatore può credere di vedere ciò che non può aver visto: gli spazi scuri negli edifici di fronte come tanti fotogrammi. Lo spettatore attento e ipercritico capirà ben presto qual è l’origine dell’allucinazione che gli è rimasta così impressa. Quella scena la conosce già. E tutte le volte è stato colpito da quel che ha intravisto dalla finestra. Soprattutto sa che due scene prima ha visto Susan Spencer, in quella stessa stanza e quasi contro la finestra, mostrare due pezzi di vetro su cui stanno, come delle macchie, i resti anneriti delle foto prese a Garrett da Spencer (prove irrefutabili dell’innocenza di Garrett, le
foto sono andate bruciate con il corpo di Spencer nell’incidente d’auto in cui questi ha trovato la morte). Lo spettatore è sicuro di aver solo avuto l’impressione di vedere qualcosa, ma non per questo ha avuto una sensazione meno violenta. Sa poi che questo film ha in comune con pochi altri la particolarità di condensare due film in uno. O, meglio, di fare del film che si vede il doppio ingannevole dell’altro che si va costruendo celatamente al suo interno e che si scopre alla fine, rimanendo di sasso e con l’impellente desiderio di rivedere al più presto il film appena visto, per riuscire, questa volta, ad afferrare i due film contemporaneamente e a chiarire, una volta per tutte, uno attraverso l’altro. Su questo doppio film e sulle impressioni che suscita è già stato detto tutto1. Ma a ogni proiezione lo stupore è così profondo che non si può fare a meno di considerarne nuovamente l’eccezionalità e di provare a vedere se è ancora possibile aggiungere qualcosa al già detto. Tom Garrett, un giornalista diventato scrittore di successo dopo il suo primo libro, è costretto a sbarazzarsi di una moglie scomoda per sposare la ragazza che ama, la ricca figlia dell’amico e datore di lavoro Austin Spencer, direttore di un grande quotidiano; è una storia credibile. Ma che questi elementi tanto semplici diventino strumento (occulto) di una macchinazione (esplicita) escogitata dal protagonista e dal suo futuro suocero, al fine di dimostrare a tutti (e innanzitutto al procuratore Thompson) l’inaccettabilità della pena di morte, perché c’è sempre il rischio che un innocente venga condannato; che Garrett, il colpevole, faccia così la parte dell’innocente che si finge colpevole per potersi meglio discolpare; e che, ciononostante, si ritrovi colpevole per via di un misterioso incidente e per essersi lasciato sfuggire all’ultimo momento un nome che troppo a lungo gli è bruciato sulle labbra: questa è una storia impossibile, davvero difficile da credere. Ma il punto non è tanto crederci o meno, quanto vedere gli effetti che ne derivano, non appena si fanno combaciare le due storie, secondo il gioco di pieni e di vuoti di cui a malapena si riesce a valutare il grado di realtà – come Lang aveva
previsto, elencando dettagliatamente su due colonne (nei suoi appunti preparatori) quello che il pubblico sa e quello che ignora. Si tratta di un gioco che, ancor prima dello scioglimento finale, è fatto per coinvolgere al massimo lo spettatore, vittima designata del fascino che si suppone subisca, in quanto complice e testimone di questa messinscena. Ma visto che ci siamo, è bene sapere a che cosa si va incontro, in cambio di quel brivido sottile – e spaventoso – che presuppone anche una facoltà visionaria assai sviluppata, ma attenta. Infatti, secondo la logica della sentenza obbligata (formula consacrata, ricordata dal procuratore alla giuria), il trionfo “al di là di ogni ragionevole dubbio” della vertigine delle apparenze, dapprima incontrollabile (a meno di concedercela, come in questo caso, quale oggetto, mediante un secondo artificio), si muove tuttavia attorno a un centro. Un punto fisso dotato di estrema mobilità. Tale centro è duplice, e uno dei due elementi che lo compongono si divide subito in due. Esso mette di fronte un matrimonio e due omicidi, quello vero e quello finto, laddove quest’ultimo implica che tra i due uomini si stabilisca una complicità che ben si accorda con un soggetto in cui le tre donne rimandano l’una all’altra, legate come sono tra loro a due a due. Il matrimonio tra Susan Spencer e Tom Garrett si profila sin dall’inizio del film, e verrà differito per dare spazio a quanto accadrà al suo posto. Il vero omicidio è quello (eluso/eliso) di Patty Gray-Emma Blooker per mano di Tom Garrett. Il finto (preparato/simulato) è quello di Dolly Moore (una collega di Patty Gray) a opera di Garrett. Istigatore dell’omicidio virtuale sarà non solo Austin Spencer, ma anche il suo futuro genero, destinato a diventarne il finto esecutore. È solo Garrett (l’immancabile Dana Andrews, perfettamente impenetrabile e ambiguo) a rappresentare il punto di incontro tra i due film: quello che si vede e quello nascosto, dove il primo funge da giustificazione retrospettiva e da copertura al secondo. È sufficiente dare una rapida occhiata al contenuto delle prime scene (aggiungendo quel che non si sa né si vede,
come fa Lang), per chiarire di che cosa si tratta. 1. Titoli di testa (quasi muti). Esecuzione di una condanna a morte. Tra i giurati che assistono alla scena ci sono Austin Spencer e Tom Garrett. 2. Al bar, Spencer e Garrett commentano l’esecuzione. Austin espone i suoi argomenti contro la pena di morte. Poi presenta a Garrett il procuratore distrettuale Thompson, che è venuto a salutarlo. Arriva Susan, il padre se ne va, e ha inizio la storia d’amore (Susan vuole andare per la prima volta a casa di Garrett). 3. A casa di Garrett. Lunga scena d’amore, interrotta da una telefonata (di Patty Gray). Susan se ne va. 4. A casa di Spencer. Susan vuole fissare al più presto la data delle nozze. Garrett vi si oppone, adducendo la pressione del suo editore (la telefonata di Patty Gray), che gli ha chiesto di finire il prima possibile il secondo romanzo; perciò chiede a Susan di rinviare la data. Garrett e Spencer tornano a discutere della pena di morte: quest’ultimo ipotizza il caso di un colpevole/innocente, la cui condanna metterebbe in discussione il corretto funzionamento della giustizia («Qualcuno di mia conoscenza, di cui potessi provare l’innocenza, dovrebbe farsi arrestare, processare e condannare a morte per un omicidio che non ha commesso»). 5. (Assassinio di Patty Gray). 6. Nell’ufficio di Spencer. Garrett e Spencer commentano il caso riportato in prima pagina dai giornali, per il quale la polizia non è riuscita a trovare indizi. Riparlano della loro idea. Garrett: «Certo che se la si mettesse in atto, sarebbe una storia eccezionale. Ma chi potrebbe farci da cavia?» Spencer: «Lei». Perciò il previsto matrimonio tra Garrett e Susan Spencer viene rimpiazzato, virtualmente ed effettivamente, da due altri avvenimenti: l’assassinio di Patty Gray e la (finta) seduzione di Dolly Moore. Il suocero e il genero scandiscono la successione del primo avvenimento con una serie di fotografie destinate a discolpare Garrett dall’accusa di omicidio, mentre il suo
comportamento con Dolly Moore, costituendo agli occhi della polizia una prova del fatto che sta forse ideando un altro omicidio, porta ad accusarlo di sicuro del primo (le fotografie riprendono le fasi precedenti l’omicidio, mostrando il piano messo in atto dai due uomini: si tratta perciò di indizi falsi, più che manifesti, atti a offuscare la verità, non esistenti né allora né mai, o esistenti solo in quanto falsi). Le due storie si incastrano perché si possono far combaciare e la seconda funge da esca per quello che fino alla fine ci sarà tenuto nascosto della prima. Se non fosse che questa (ri)prende corpo durante il processo, per opera del procuratore distrettuale che ne ricostruisce la logica. Ma noi non possiamo crederci: abbiamo visto con i nostri occhi i due uomini decidere di architettare la storia, in apparenza precedente, dell’innocente/colpevole, nella quale l’oggetto – l’assassinio di una donna – si potrebbe credere del tutto irrilevante, anzi posto in essere solo grazie a essa. La figura ellittica di Patty Gray è circondata da un’atmosfera negativa (la si vede subito morta, nella fredda neutralità di una foto sul giornale; e la sua immagine, che aleggia durante tutto il processo, viene precisandosi solo nel corso dell’inchiesta sul suo passato condotta alla fine dall’assistente di Thompson); quest’atmosfera serve a completare il ritratto di una donna mediocre che si atteggia a donna fatale. Fatalità insita nella donna. Essa diventa l’assolutamente altro, grazie alla sessualità, ed esercita così, aprioristicamente, una violenza bruta e ineluttabile sull’uomo, che ne subisce la pressione. Pressione cui questi, a sua volta, non può non rispondere. Ecco allora l’immagine vuota e potente ripresa in tono minore da Dolly Moore, per dar corpo, nell’intrigo, alla distanza implicita tra Patty Gray e Susan (quest’ultima rompe con Garrett quando lui comincia a compromettersi con la ballerina, non potendone rivelare alla fidanzata il vero motivo, e tanto meno quello falso: né il piano concertato con Spencer, né quanto serve a coprire – egli può soltanto dire l’inverosimile verità, cioè che quello è il suo modo di lavorare al romanzo).
La sostituzione di Susan con Patty Gray, quel bacio (falsamente) romantico interrotto dallo squillo del telefono, un fidanzamento diventato un omicidio (la lista dei cambiamenti potrebbe essere ancora più lunga: a Thompson che lo accusa di aver ritirato dalla banca una somma di denaro per tacitare Patty Gray che lo ricattava, Garrett risponde che quel denaro gli serviva per comprare l’anello di fidanzamento per Susan: l’aveva rimesso sul conto non perché avesse ucciso la moglie, ma perché aveva rotto con Susan). Ebbene, tutto questo mira semplicemente a contrapporre fra loro due donne, quella buona e quella cattiva? Sarebbe davvero troppo poco. Di rado un personaggio “positivo” ha sprigionato, già a prima vista, una così intensa carica negativa come Susan Spencer, interpretata sullo schermo da Joan Fontaine. La regia infonde nell’esile corpo di questa borghese di mondo, che ha movenze a metà fra il rettile e l’insetto, una forma di orrore discreto, in accordo con i pochi tratti personali indicati dalla sceneggiatura, in un film dove la stilizzazione delle figure conta più della credibilità dei personaggi (Spencer ha sollevato Garrett dagli impegni derivanti dal suo mestiere di giornalista, dandogli così la possibilità di diventare un autore di successo, perché sua figlia è abituata a una vita elegante e dispendiosa). Lang ha saputo mettere in bocca al padre la battuta a doppio senso che tende ad assimilare le due donne – quella visibile e quella invisibile – in una figura sola, essenza del femminino: «Si è appena fidanzato con mia figlia e tutto quello cui riesce a pensare è la pena capitale». La morte, da subire o da infliggere, diventa il risvolto del matrimonio e della sua promessa, dell’amore presunto e, per quanto qui sia possibile, spersonalizzato. Paradossalmente, così, il discorso in apparenza esclusivamente etico sulla pena di morte viene portato avanti proprio nel caso di un omicidio vero e falso nello stesso tempo. E quest’omicidio, sostituendosi al matrimonio che deve consentire, ma finirà con l’impedire, stabilisce del tutto astrattamente un nesso fra desiderio sessuale e istinto di morte. Il problema a questo punto è di stabilire se la sostituzione realizzatasi fra le due donne – a un livello
dapprima impercettibile, poi, rivisto più volte il film, assai evidente –, essendo allo stesso tempo un dato stabile e mobile, e appunto per questo efficace, sia di per sé in grado di reggere l’ipotesi della duplicità del film, da cui dipende, per esempio, quella specie di allucinazione che si impadronisce dello spettatore nella stanza con le finestre. A me pare proprio di sì. Infatti questo presupposto è proprio quello che consentirebbe, qui, il dispiegarsi di una messa in atto del cinema per antonomasia. Si sa che L’alibi era perfetto (Beyond a Reasonable Doubt, 1956) è innanzitutto la storia di un film in corso di ideazione e di realizzazione, mentre viene costruendosi pezzo per pezzo, come sceneggiatura e come regia. Ma che l’idea e l’azione cinematografica trovino compimento sullo sfondo di un assassinio di una donna, freddo e calcolato, reale e insieme fittizio, combinato da uno o due uomini, questo è ciò che conferisce al film spessore, algida esattezza e una perversione tutta speciale. Una perversione mentale, stilistica e storica. A pensarci bene, c’è qualcosa di molto singolare nelle diverse motivazioni sottese all’alleanza dei due uomini, il padre e il fidanzato, uno infrange le sue convinzioni etiche, per giocare alla legge uno dei tiri più mancini che si possano immaginare; l’altro la infrange oltre misura per riuscire a piegarla a suo favore. Tutti e due tengono Susan all’oscuro del loro piano, con il pretesto che lei potrebbe non esser così forte da riuscire a tacere la verità. Senza questo particolare tutta la storia diventerebbe davvero inconcepibile. Ma il fatto è che lei, donna, si trova al limite del film che si sta provando e non di quello che si sta facendo. Tocca così ai due uomini spartirsi, con un’ingannevole equivalenza, le parti che Lang ha loro assegnato secondo i rispettivi ruoli. Spencer è l’istigatore (è a lui che viene l’idea), il testimone (è lui che fotografa i falsi indizi) e insieme l’ipotetico deus ex machina (dovrà intervenire il giorno X per scagionare Garrett dall’accusa che l’ha portato alla sedia elettrica e far finalmente trionfare la suprema verità di cui hanno creduto di essere i soli depositari). Se Spencer muore in un incidente poco credibile (non si va
a marcia indietro a quella velocità, salvo in casi d’emergenza, in una stradina così stretta e senza visibilità – qui l’emergenza è quella prevista dal colpo di scena architettato in precedenza: Spencer infatti sta semplicemente andando in tribunale a consegnare le prove a discarico), se muore in modo così violento – l’auto capotta e prende fuoco in seguito all’urto con un camion –, è perché la sua morte è necessaria alla soluzione dell’intreccio: è necessario che le fotografie, bruciate nell’incendio, vengano a mancare a Garrett, dato che erano “false”, o falsificate. Ma tale esito fatale significa anche che nessuno può, singolarmente, prendersela con la legge: anche se ingiusta, essa ha il compito di esprimere la voce della collettività, la sola legittimata a riparare l’ingiustizia. Questa morte inoltre costituisce il prezzo per il ruolo avuto (inconsapevolmente) da Spencer nell’omicidio di Patty Gray, dal momento che è stato lui a fornire a Garrett l’occasione e la strategia per compiere quel delitto. Non va poi dimenticato il male che questo padre ha fatto (involontariamente) alla figlia, spinta a rompere il fidanzamento a causa delle “scappatelle” di Garrett con Dolly Moore. Insomma, Spencer riveste nella storia, secondo Lang, il ruolo dell’innocente e dell’uomo etico che vorrebbe opporsi al male, ma che tuttavia ne resta invischiato. La morale della storia è che Garrett incarna il male che si irradia allo stato puro, è il secondo regista, scaltro e onnipotente, spinto a farsi attore della macchinazione, tramutatasi in trappola, che finisce con il ritorcersi proprio contro di lui (egli muore per aver pronunziato davanti a Susan il nome di Emma Blooker, il vero nome di Patty Gray, che non avrebbe dovuto conoscere). Ma che Lang abbia voluto farne uno scrittore; che la realtà in cui lo fa agire sia stata dapprima concepita, nel corso di una conversazione con Spencer, come un possibile romanzo; che sia presentata in questi termini a Susan (ingannandola), di modo che il secondo romanzo imposto a Garrett dall’editore sia quello che la vicenda del film trasforma: romanzo vissuto che diviene soggetto di una storia; che Patty Gray si rifaccia viva solo in
seguito alla pubblicazione del primo romanzo di Garrett, obbligandolo allora a ideare su due piedi una seconda storia, di cui diventa beneficiario, senza poter più fare distinzione tra quanto è frutto d’immaginazione e quanto appartiene alla vita e alla morte reali: questo è, nel complesso, un modo molto chiaro mediante il quale Lang mostra dove si annida il male assoluto, da cui si sarebbe irresistibilmente attratti, se il percorso che conduce dal romanzo al soggetto della storia e poi al film – ognuno trasformando l’altro – non costituisse di per sé la difesa più sicura nei confronti dell’orrore a cui si tratta di dare un nome. Il film come il male che il film stesso denunzia. È necessario quindi accettare il gioco pericoloso di questa rappresentazione. Ecco la risposta di Garrett a Thompson, prima nella stanza con le finestre (la prima volta), poi nel corso del processo: il 9 di quel mese, verso le undici di sera, mentre Patty Gray veniva strangolata con una calza in una berlina nera, lui, Garrett, era da solo, al cinema. Non può provarlo, era da solo (come un vero spettatore), perciò (è lui a sottolinearlo) bisognerà credergli sulla parola. Non è però in grado di dire con esattezza che film ha visto. Ma, quando il film di Lang finisce, non abbiamo più alcun dubbio. Egli ha solo vissuto in diretta il film che non possiamo far altro che rivedere, per avere la prova della sua duplicità fino alla fine. Tant’è vero che le fotografie carbonizzate che Susan Spencer esamina inutilmente controluce nella stanza con le finestre, non sono solo quel che resta delle fotografie scattate dal padre (noi sappiamo dell’esistenza di queste foto perché abbiamo visto per tre volte i due uomini fare i preparativi, e ci sono state mostrate, in primo piano, per quello che sono: prove irrefutabili della verità di cui sono portatrici, quella dell’inganno architettato). Queste foto carbonizzate sono infatti i fotogrammi virtuali del delitto commesso da Garrett: le tracce frammentarie, intraviste, tanto mnemoniche quanto reali, di quello che lui avrebbe visto o intravisto – come facciamo noi attraverso di lui – se non fosse passato all’azione, la cui violenta realtà non è in alcun modo restituibile: un’immagine confusa in cui si mescolano sesso e morte,
una morte collegata e causata dal sesso. Forse non si era mai associato così freddamente l’istante della morte – quella esemplare inflitta dalla legge, istante insostenibile e del tutto impossibile da rendere – con l’altro istante della morte/assassinio della donna, risvolto di un’altra istantaneità, quella dell’impulso sessuale, altrettanto impossibile da sostenere e da rendere. Nel prologo, quando scorrono i titoli di testa, il momento dell’esecuzione rimane, come al solito, fuori campo, ma la si vede riflessa nello sguardo fisso di Garrett in primo piano: la morte/assassinio e l’impulso sessuale trascorrono entrambi nel gelido rigore del fuori campo, in cui consiste l’intero film. Quelle fotografie rovinate rappresentano poi, per Susan che le guarda e per lo spettatore che ricorda, quel che resta della morte di Spencer, del fulmineo istante che ribalta tutto il film, passato anch’esso troppo in fretta e che perciò si vorrebbe fermare, per poter rivedere quel che si è solo visto parzialmente (si è tentati di far scorrere immagine per immagine ogni istante, per potervi scoprire con meraviglia tutte le pose che testimoniano, ancora una volta, il carattere proprio dell’invisibile, che i classici del cinema lasciano sempre intravedere, in maggior o minor misura, al di là della bellezza troppo cruda del visibile). Infine, si può immaginare che Susan, dopo l’assassinio di Patty Gray e le scappatelle “sessuali” di Garrett con Dolly Moore, abbia a sua volta la visione di ciò che per lei è diventato insopportabile: il suo essere l’immagine riflessa dell’una e dell’altra. Sarebbe pertanto questo scambio tra l’inafferrabile enigmaticità del tempo reale e la scomposizione dello spazio a prefigurarne già una sorta di traduzione e di fissazione tanto spirituale quanto materiale: è qui l’origine della nostra visione (o quanto meno della mia) nella stanza con le finestre, di fronte a quelle facciate piatte che si stagliano, in lontananza, come tante pagine di un album, perforate da innumerevoli rettangolini neri. È così che l’elemento fotografico, nell’ultimo film americano di Fritz Lang, finisce con il servire da finzione speculare per il fantasma della regia. L’elemento fotografico è infatti ciò che si presenta sotto forma di
tanti punti fermi, o di sospensione, tra il film che ne articola le tracce e lo schermo dello spettatore, il quale ne coglie lo scorrimento fra lo schermo reale e l’interno della propria coscienza, in una sorta di programma intermittente che dipende proprio solo da lui. Forse è un po’ riduttivo accostare così violentemente in Fritz Lang l’istante ideale, orribile della morte – e lo sguardo gravido di fascino e terrore, che questo suppone nel suo folle desiderio di dominio – alla scena di sesso che ne sarebbe il supporto e quasi una cassa di risonanza. In effetti in molti dei suoi film la minaccia di morte e il sesso sono tenuti tendenzialmente separati. In questi la donna, invece di essere la figura chiave da cui prende forma la minaccia, facendo più o meno del film una storia a doppiofondo, è in genere piuttosto la semplice compagna del protagonista impegnato ad affrontare (quasi) da solo la realtà dei fatti, e anche l’immagine della morte. È ad esempio senza alcun indugio che il capitano Thorndike persegue il suo piano radicale di assassinare Hitler (Duello mortale, Man Hunt, 1941). E se JerryJoan Bennett viene poi coinvolta nella corsa in cui lui si troverà più volte faccia a faccia con la morte in un crescendo di violenza (come nella terribile sequenza del métro di Londra, quando è inseguito dall’agente nazista con il bastone animato), non si istituisce tuttavia fra di loro (o per lo meno ciò accade in misura minima) quel legame simbolico che fa sì che il guardare la morte (individuale o sociale) dipenda dal sesso e dal marchio ossessivo della sua differenza. (Quasi) la stessa cosa si può dire per Furia (Fury, 1936), che ha palesemente messo in evidenza il dispiegarsi dell’istinto di morte, innestandolo in modo inequivocabile sul dispiegarsi del dispositivo cinematografico. Nella scena del tribunale (le «diciassette inquadrature» – illustrate da Jean Douchet2), l’occhio della cinepresa si fa strumento al tempo stesso sociale e metafisico della verità: gli attori del linciaggio, trasformati in spettatori nella sala dell’udienza – di fronte al giudice e alla giuria – grazie al documentario, si vedono messi a confronto con la loro
stessa immagine, il cui grado di realtà è ormai incontestabile. Questa singolare forma di testimonianza offerta dal completo dominio delle apparenze sembra poter offrire così la sognata occasione di rifondare la pratica della giustizia seguendo molto da vicino l’obiettività della legge. Ma attraverso lo sguardo vendicatore di JoeSpencer Tracy, incorporato all’occhio dell’obbiettivo per renderlo strumento di una manipolazione a servizio dell’istinto di morte di un solo uomo, l’immagine cinematografica passa immediatamente dall’ordine della legge democratica alla violenza pura della volontà di potenza. Causato in un primo momento da un cieco disordine (il linciaggio di Joe), quest’istinto di morte si concentra di rimando nello sguardo di colui che, per vendicarsi della folla assassina, diventa quasi l’omologo del dittatore deciso a manipolarla. Nascosto e invisibile, Joe diventa un altro Mabuse, un Mabuse della cronaca, facendosi passare per morto e mettendo così virtualmente a morte coloro che sono stati visti e messi sotto accusa dall’occhio della cinepresa, attraverso lo sguardo assente e onnipotente di Joe. L’uomo e la società sono, qui, messi a confronto direttamente e nessun ruolo è riservato alla donna: la società può tradire se stessa, fino al punto da farsi sedurre dalla violenza e dalla morte, ignorando la legge; l’uomo che è vittima di tale delirio non può che rifletterlo, esprimendo una violenza tanto più estrema in quanto esercitata qui attraverso la legge stessa, dando luogo a una forma di perversione, a un vero e proprio raggiro della legge (si potrebbe qui istituire un nesso tra Furia e L’alibi era perfetto: l’utilizzazione della legge per sostituirsi a essa, o per beffarsene, è un tratto che accomuna Garrett e Joe, anche se uno è colpevole e l’altro innocente – sebbene colpevole di aver simulato quella morte da cui deriva tutto il suo potere). Con questi presupposti il cinema può sempre oscillare fra la verità sociale e legale e il loro travestimento, operato dall’istinto di morte di un solo individuo. Così in Furia la
donna sarà soltanto l’eletta mediatrice dell’ordine simbolico: sarà necessario l’intervento di Sylvia SidneyKatherine, che alla fine ritrova Joe per persuaderlo a desistere dalla vendetta e ad accettarsi, di fronte a lei, agli autori del linciaggio e alla società, come un normale essere vivente, un uomo fra gli altri. Pensiamo anche a quel momento (sottolineato da Jean-Louis Comolli e François Géré3) in Anche i boia muoiono (Hangmen Also Die!, 1943) quando lo sguardo dei due chirurghi appartenenti alla resistenza, tanto più penetrante in quanto messo in risalto dalle mascherine, converge su Grüber, il poliziotto nazista, uccidendolo letteralmente sotto un tiro incrociato di occhiate, grazie a un sapiente gioco di campi e di controcampi, che trasformano questi partigiani in “carnefici” della pura verità dello sguardo messo a nudo, facente funzioni dell’occhio della cinepresa, così isolato e fisso, come se fosse dotato di per sé di una carica mortale. Come in Furia e in Duello mortale, qui (nonostante il ruolo giocato in una scena chiave dall’impostazione della situazione fittizia da parte della signorina Novotny, la giovane resistente ceca) ci si trova di fronte a uno sguardo sull’azione che, in nome della violenza di cui partecipa si esercita (di preferenza) direttamente tra uomini, da e per altri uomini. Come se all’azione orchestrata da Heydrich, tesa a liquidare i partigiani cechi, questi, malgrado tutte le loro buone ragioni, potessero replicare solo con un’azione in cui la morte viene inferta a sua volta senza la mediazione della legge. Lo sguardo dell’uomo, infatti, è in sé portatore di quella carica mortale di cui il cinema diventa fatalmente depositario e che deve continuamente restituire alla società per liberarsi dal pericolo di poterla esercitare contro di essa. In Fritz Lang ci sono quindi due grandi tipologie (con tutte le sfumature e le interferenze possibili fra l’una e l’altra) secondo cui la macchina cinematografica è portatrice della carica mortale che ha finito con l’incarnare. Entrambe vengono assunte nella logica ambigua cui Lang ha sempre attribuito lo strano potere del cinema. Da un lato esso è la prova vivente e l’emanazione di una forza del Male, il cui concentrato di
violenza nella messa-a-morte-mediante-lo-sguardo è la punta acuminata che attraversa lo spazio sociale e storico; dall’altra il cinema, catarsi e forza morale che circoscrive e denunzia gli influssi maligni, facendoli come virare su se stessi, diventerà lo strumento privilegiato per combatterli. La prima tipologia mette in relazione, direttamente, l’uomo e la società in cui questi esercita il potere secolare della violenza e della morte (nella giustizia come nella guerra, nell’economia come nella politica). La seconda prende in considerazione la donna, o quel che le sta attorno: assegna alla donna (come in genere si è fatto dopo il Romanticismo) l’ambigua proprietà di concentrare, e di poter perciò rifrangere sull’uomo stesso, quella luminescenza di morte che si è infine identificata con lo sguardo d’amore. Questo potere è un modo di testimoniare il nuovo statuto storico in cui la donna si è dimostrata vincente e continua a esserlo. Fino a quando non si sono visti a poco a poco dissolversi (con tutto il lento lavorio del cinema moderno) i termini di una condizione diventata essa stessa troppo classica, cioè storica. Questa seconda tipologia presenta alcuni punti culminanti, istanti crudeli di un teatro da camera in cui, nel confronto con la donna, singola o con il suo doppio, duale, buona e/o cattiva, uccisa o in procinto di esserlo, la creazione si interroga anche su quali siano i propri mezzi e i propri fini. È il caso, ad esempio, di Dietro la porta chiusa (Secret Beyond the Door, 1947) che esaspera fino all’inverosimile il fantasma dell’assassinio della donna amata e desiderata, la reversibilità di amore e morte. In questo che è il più “psicanalitico” tra i film di Lang, Celia-Joan Bennett crede che Mark-Michael Redgrave abbia ucciso la prima moglie e lui stesso ne è convinto, per un inspiegabile senso di colpa; sicché la minaccia di morte, concentrata sulla donna, è di nuovo messa in atto per poter essere sventata, proprio grazie alla donna che vi si presta, permettendo all’uomo di allestire una scena in cui il suo fantasma regni sovrano e alla fine lei se ne liberi insieme a lui. Lang ha saputo rappresentare questo fantasma mediante una messa in scena in cui l’immagine trionfa in quanto tale grazie a
giochi di specchi e rimandi scenografici. In una stanza identica a quella della moglie (anche riproduzione di quella della moglie morta), l’ultima stanza di una serie di sei in cui hanno avuto luogo gli omicidi, tutte ricostruite con perfetta fedeltà alla verità storica come scenografie cinematografiche o pezzi da museo delle cere, questo ipotetico Barbablù deve compiere l’assassinio, proprio in quella stanza di cui solo il suo immaginario possiederebbe la chiave per aprire la “porta”, se la donna non gliela sottraesse, immedesimandosi in quell’immaginario per risolverlo felicemente. Lo stesso accade in Bassa marea (House by the River, 1950) dove Lang ha fatto del (misero) protagonista uno scrittore maniaco e impotente, che solo l’assassinio di una donna trasforma in un eroe, di fronte a se stesso e alle persone del suo ambiente, a partire dal momento in cui l’omicidio reale diventa garanzia di una finzione virtuale: la pubblicazione finale del romanzo The House by the River, che permette a Stephen Byrne di farne sottilmente intravedere alla moglie la componente di verità. Quel soggetto inverosimile (pensiamo al virtuale secondo romanzo di Garrett) è interessante perché sovrappone due omicidi: uno reale, quello della cameriera Emily, uccisa da Stephen mentre questi voleva baciarla, dopo che lei si era servita del bagno e del profumo di sua moglie; l’altro pensato da Marjorie, la moglie, dopo che lui le ha fatto intravedere la realtà del primo omicidio, che ha così bene assecondato le inclinazioni del suo duplice fantasma di uomo e di scrittore. Questi due omicidi ne presuppongono un terzo, in questo teatro familiare che non teme di addentrarsi nei giochi di sdoppiamento: il fratello di Stephen è innamorato in segreto della cognata, che gli corrisponde inconsciamente, ed è testimone a posteriori dell’omicidio di Emily, sicché Stephen sarà spinto a ucciderlo. Ma John Byrne non muore e ritorna nel momento in cui Stephen sta per ammazzare Marjorie, causando la morte esemplare di Stephen, determinata dal simultaneo ritorno dei suoi due fantasmi: quello del fratello che egli crede morto e di cui fugge quella che ritiene essere
l’immagine; e, soprattutto, quello della ragazza assassinata la cui visione spettrale lo avvolge all’improvviso sotto forma di una tenda che lo strangola quando egli sta per buttarsi giù dalle scale. Una morte la cui messa in scena rimanda, presentando la scomparsa del protagonista, alla morte inferta da questi, mentre il suo romanzo, con la sua storia fin troppo vera, va a coincidere esattamente con il film. E ancora La strada scarlatta (Scarlet Street, 1945), dove un pittore dilettante diventa doppiamente vittima della donna che sarà costretto a uccidere. Christopher CrossEdward G. Robinson è vittima in primo luogo sul piano dell’amore e del sesso, dato che la donna che egli mantiene lo detesta, lo tratta come una sottospecie di uomo e gli preferisce l’amante-protettore. Ma lo diviene in modo più sottile dal punto di vista della sua stessa identità, poiché Kitty-Joan Bennett gli porta via, per giunta con il suo consenso, i suoi quadri e diventa, in virtù di questa appropriazione, ricca e famosa. È un furto totale perché riguarda l’immagine. Ecco perché fra i tanti quadri di Christopher il ritratto di Kitty è quello di cui il film serba ricordo fino all’ultimo. Quando Christopher, divenuto un povero vagabondo dopo la morte di Kitty, vede campeggiare il ritratto nella vetrina di un gallerista e poi lo vede sparire, portato via da un collezionista, si trova di fronte all’immagine più folle – quella in cui il cinema ripropone attraverso la pittura il desiderio di messa in scena. Quell’immagine dipinta della donna che egli ha amato e ucciso è anche la sua stessa immagine: il suo carattere ideale è fatto per appagare ed esacerbare il desiderio soggettivo. Infatti, attraverso quell’immagine, egli si riconosce e si vede, e al contempo consente alla donna di ammirarsi, ma ne è derubato e diventa così la vittima per eccellenza di una situazione in cui solo l’omicidio gli assicura un attimo di potere reale, prima di toglierlo per sempre e restituirlo all’immagine stessa, al quadro. Immagine grazie alla quale l’uomo, qui, non esiste se essa, attraverso la donna, non gli viene insieme offerta e rapita, come motivo e potere dell’azione, restituita pienamente dal film con l’incorporazione della
pittura, restando tuttavia sotto quella minaccia, di cui la donna è il bersaglio e il punto di origine. Un film come Il grande caldo (The Big Heat, 1953) tende invece a mettere in rapporto le due tipologie con una forza diretta e un acutissimo senso dello spazio sociale, caratteri che l’hanno reso esemplare nell’opera di Lang. Qui è necessario che una donna esploda (la donna buona, ideale, “la mamma”) affinché la violenza degli uomini travalichi la legge. La violenza è duplice: quella criminale, che colpisce l’uomo mediante la donna, e quella di Bannion-Glenn Ford che, per vendicarsi, dovrà tentare di salvare la legge a dispetto della propria insufficienza, ponendosi al di là della legge, o meglio accanto a essa, per tutta la durata della crisi. Ed è necessario che una donna, Debby-Gloria Grahame, quella cattiva, o frivola (“la puttana”), rivesta infine i panni di quella buona, grazie a due azioni estreme che la portano, dalla parte di Bannion ma più lontano di lui, al di là di se stessa nell’abbracciare la scelta della violenza e della morte, cosa che la obbligherà a morire a sua volta. Da un lato ci sarà lo sfregio da parte di Vince-Lee Marvin, riflesso di ciò che la donna ha subito (la doppia scena della caffettiera), dall’altra l’uccisione di Bertha Duncan-Jeanette Nolan, riflesso di ciò che Debby avrebbe potuto essere, se il film non l’avesse già santificata in partenza sacrificandola affinché la legge sia di nuovo tale nel cuore di tutti e in particolar modo in quello dello spettatore. È quanto viene ribadito nelle battute finali, quando Debby, in punto di morte, chiede ancora una volta a Bannion di parlare di sua moglie, di modo che il momento della sua morte ripropone quella di Katie Bannion-Jocelyn Brando, operando un’equivalenza fra le due donne. Dinanzi a questo spiegamento di motivazioni decisamente semplice, per cui l’allucinazione rimane contenuta nei limiti degli effetti creati dai piani e dai corpi (anche se sono numerosissimi), l’eccezionalità de L’alibi era perfetto, perciò unico nell’opera di Lang, sta nell’aver intrecciato e sovrapposto in modo tanto astratto le due tematiche. E nel far pagare allo spettatore il prezzo di tale operazione. Probabilmente è quello a cui si
riferiva Rivette quando parlava del concetto. Lang come regista del concetto. Parlava anche di «science-fiction», citando Una donna nella luna (Frau im Mond, 1929) che avrebbe offerto a Lang «il pretesto di realizzare un primo saggio di un universo totalmente chiuso»4. Mi piace questo cortocircuito. Ma soprattutto mi piace quanto suggerisce, come orizzonte possibile del concetto, dell’allucinazione. Si arriva a un ineluttabile incrocio di donne e macchine, di donne e media, che obbliga il pensiero ad andare fino in fondo alle proprie metafore e l’enunciazione a toccare la propria intima essenza. Anche se il romanticismo astrale di Una donna nella luna è molto lontano dal terrore rarefatto che scaturisce da un fantastico acremente quotidiano. Che cosa si vede, infatti, in Una donna nella luna? Una macchina, il missile, che agisce sui suoi occupanti come un dispositivo cinematografico, mescolando il sonnoipnosi del corpo alla fascinazione assoluta dello sguardo captato da uno spettacolo al di là di ogni immaginazione, procedendo così verso quella terra utopica, la luna, le cui presunte ricchezze stanno a indicare l’incanto reale delle immagini nate in uno studio cinematografico. Stranamente, e mi pare sia l’unica volta che succede in tutta l’opera di Lang, qui è la donna a tenere la cinepresa. Non è solo un passeggero portato in primo piano dal destino, secondo il modello romantico – unica donna in mezzo a quattro uomini, come ribadisce lei stessa a difesa del proprio sesso al momento della partenza del missile, e come dice il titolo stesso. Lei manovra la telecamera, girando il film della spedizione. Di fronte a Hellus, il suo fidanzato, che ha progettato il missile e che ora guida l’impresa, lei è la donna con la macchina da presa (riflesso tanto del cameraman di Vertov quanto dell’incerto protagonista di Keaton). Come se qui Lang avesse sottolineato l’altro estremo della curva, il punto di inversione di quanto si delinea nella sua opera: sia che tenga la donna al di fuori del circuito enunciativo per farne l’oggetto del desiderio in senso stretto, con l’istinto di morte a lei così spesso collegato (appena due anni intercorrono tra Una donna nella luna e il successivo M, 1931); sia che ve la introduca, in un torbido legame con la
macchina (e perciò con il cinema stesso), di cui l’uomo rimarrà sempre il sadico animatore (disanimatore). L’alibi era perfetto da questo punto di vista si trova al crocevia che obbliga il pensiero a concepire se stesso, dal momento che, essendo la donna oggetto di manipolazione ingannevole e omicida, si trova sempre più a coincidere (immagine astratta e racconto avvolti uno sull’altro: sta qui tutta la carica della posta in gioco) con il corpo del cinema in quanto macchina. Sfogliando le carte di Fritz Lang, mi piace fermare lo sguardo su di uno schizzo – l’abito da scena di Dolly Moore, per il suo numero di striptease da tre soldi: un corpo senza braccia, con la testa appena accennata, ma con il reggiseno e le mutandine ben visibili sotto un tessuto semitrasparente –, e considerare come questo disegno richiami in modo palese (forse per chi voglia farlo) il momento di passaggio, in Metropolis (1927), fra il corpo astratto dell’Androide e quello della vera-falsa Maria, pronto a uno spogliarello in piena regola di fronte a uomini eccitati con le mani tese verso il corpo traslucido. Mi piace anche, risalendo di film in film, arrivare a Il dottor Mabuse (Dr. Mabuse, der Spieler, 1922), dove il mito della messa in scena si mostra in quanto tale. Mabuse manipola (e fa morire) innanzitutto degli uomini, per esercitare la volontà di potenza e di distruzione che lo rende padrone dello sguardo e perciò della macchina cinematografica di cui diventa l’emblema. E mi viene in mente che Mabuse tuttavia è inconcepibile senza la donna. Ce ne sono due, fra loro contrapposte, una il riflesso dell’altra, in modo quasi troppo semplicistico. Da un lato la Carozza, la sola donna della banda. È una ballerina, che riassume in un’apparizione sulla scena il tipico feticismo voyeuristico nei confronti della donna, con quei giochi che fanno spettacolo e di cui il cinema si alimenta, dal momento che è esso stesso a rimpiazzarli e a riprodurli (si pensi a quando la Carozza, seminuda, viene assalita sulla scena da due figure gigantesche e grottesche, con i nasi ritti come sessi e gli occhi assatanati). E questo nella scena in cui Mabuse, del tutto indifferente allo spettacolo, per la
prima volta esercita lo sguardo ipnotico su una delle sue “vittime”. La Carozza, come per effetto dell’ipnosi, ama Mabuse d’un amore assoluto, non corrisposto e destinato a portarla alla morte (muore in prigione, avvelenata, dal momento che c’è il pericolo che lei possa nuocere a Mabuse). Al contrario, la contessa Told, “la voyeuse”, come estraniata da se stessa a tutto profitto dello sguardo che si diverte a far indugiare sulle cose (risultando pertanto la versione debole del “grande ipnotizzatore”), è invano concupita da Mabuse, il quale la rapisce, dopo averne mandato in rovina e avvelenato il marito. Sicché l’eccesso di desiderio e la sua mancanza si alternano in questa storia, mito e matrice – dove la donna, anche se un po’ marginale, è doppiamente sottoposta al male – per andare a innestarsi, a seconda del sesso, sul terrore fondamentale suscitato da Mabuse, in nome dello sguardo mortifero della messa in scena, negativo della legge, che la legge stessa dovrà ricondurre come fuori da se stesso per poterne trionfare. Scorrendo i vari Mabuse, ci si potrà ricordare che l’opera di Lang si conclude – caso o destino – sull’inquadratura di una donna che muore. Dawn Addams-Marion muore, ne Il diabolico dottor Mabuse (Die 1000 Augen des Dr. Mabuse, 1960), in un letto d’ospedale, tra le braccia del suo innamorato troppo ingenuo, per esser stata la donna ipnotizzata per sempre da Mabuse, falsamente suicida, falsamente aggredita (con il coltello, sessualmente) e falsamente omicida (a colpi di pistola), preda ambigua e consenziente del miglior dispositivo voyeurista che il cinema abbia concepito (la scena dello specchio senza foglio di stagno), all’interno del dispositivo più abusato (“mille occhi”) che il cinema si sia proposto come immagine.
[1.]
[2.]
[3.]
Traduzione di Paola Lagossi. Si ringrazia Paola Lagossi per aver concesso la riproduzione della sua traduzione. *
Il periodo americano di Matteo Pollone Il “periodo americano” di Fritz Lang, che dura circa un ventennio (dal 1936 al 1956) e si compone di ventidue lungometraggi, vede il regista impegnato soprattutto su due fronti. Da un lato, si ha un costante braccio di ferro con i produttori, che vorrebbero irregimentarlo all’interno dei dettami dello studio system; dall’altro, un rapporto ambivalente con lo stile hollywoodiano, del quale sposa i principi di efficacia ed eleganza1 ma di cui tende a forzare, come vedremo, alcuni assetti. Questi aspetti emergono pienamente già nel film dell’esordio hollywoodiano, Furia (Fury, 1936), interpretato da Sylvia Sidney e Spencer Tracy e prodotto dalla Metro-Goldwyn-Mayer. Apparentemente, la carriera americana di Lang si avvia con i migliori auspici: invitato da David O. Selznick a firmare un contratto con il più grande studio dell’epoca, il regista propone alcuni soggetti che vengono scartati, e contemporaneamente cerca di ambientarsi nel nuovo paese, viaggiando e non lavorando per circa un anno. Quando i termini contrattuali stanno per scadere (e Selznick ha ormai lasciato lo studio per fondare la propria casa di produzione), Lang decide di accettare un soggetto altrui, Mob Rule di Norman Krasna, la storia di un tentativo di linciaggio e del successivo processo, che diverrà poi Furia. Nelle parole del futuro regista Joseph L. Mankiewicz, primo dei produttori con i quali Lang si scontrerà duramente, «Louis B. Mayer era un uomo malvagio. Mi ha fatto un favore: mi ha fatto produrre Furia. Non gli piaceva il soggetto, non era interessato ai film a sfondo sociale. Ma Thalberg stava producendo Giulietta e Romeo, e Mayer voleva avere un suo pargolo “intellettuale” da sbattergli in faccia. E questo era Furia»2. Lang è però costretto ad accettare compromessi sia prima delle riprese (gli viene infatti proibito di raccontare la storia di questo tentato linciaggio facendo del protagonista un afroamericano) sia in fase di
montaggio, quando Mankiewicz impone un happy end (con tanto di bacio tra Tracy e Sidney) al posto del più disincantato finale pensato dal regista. Il risultato è comunque in linea con il proposito, da parte dello studio, di battere strade nuove: la scelta di un attore da poco contrattualizzato (Tracy è arrivato l’anno prima dalla Fox) e di un apprezzato autore europeo alla prima esperienza americana sono significativamente parte di una strategia di rinnovamento che il film avrebbe dovuto inaugurare. Nonostante Tracy sia il primo degli attori a vivere con difficoltà il perfezionismo autoritario di Lang (un altro nome illustre a patire il lavoro sul set del regista austriaco sarà Edward G. Robinson), la sua interpretazione di un personaggio che «da onesto roosveltiano [diviene] nella sua sete di vendetta quasi un Mabuse»3 è certamente uno degli indiscutibili punti di forza del film. Nonostante il contratto con la Metro-Goldwyn-Mayer non venga rinnovato, i primi tre film americani di Lang sono spesso considerati una sorta di trilogia, anche in virtù della presenza, in tutti e tre, di Sylvia Sidney come protagonista femminile. Questa “trilogia sociale” si completa quindi con Sono innocente! (You Only Live Once, 1937, con Henry Fonda) e You and Me (1938, con George Raft). Prodotto da Walter Wanger e distribuito dalla United Artists, Sono innocente! conosce un destino non dissimile da quello di Furia. Ispirato, come il precedente film, dalla cronaca del tempo (in particolare dalle imprese della coppia di rapinatori Bonnie Parker e Clyde Barrow, uccisi solo tre anni prima), Sono innocente! conosce un importante ridimensionamento nella parte finale, quando la protagonista si riunisce al compagno, ormai ricercato, e ne condivide le attività criminali. Se la cupezza e l’assoluta mancanza di speranza caratterizzano il racconto di Sono innocente!, You and Me, girato invece per la Paramount ancora una volta su un soggetto di Norman Krasna, affronta il tema del reinserimento dei carcerati adottando un tono più leggero, vicino a quello della commedia.
Per quanto non nascano come una vera e propria trilogia, i primi film di Lang in America risultano coesi non solo per via dei temi trattati, ma anche per un simile impianto formale. Le tre storie sono caratterizzate da un’apparente contraddizione, tipicamente langhiana: figlie di una rigorosa documentazione e del tentativo di dare voce a un’America più autentica di quella normalmente edulcorata da Hollywood, le vicende vedono i personaggi come mossi dai disegni imperscrutabili del fato: «credo che sia questa – spiega Lang a Peter Bogdanovich – la caratteristica principale di tutti i miei film: la lotta con il destino»4. Una simile tensione si avverte anche sul piano stilistico: se la ricostruzione d’ambiente – sia esso il paesino di Furia, il carcere di Sono innocente! o il grande magazzino di You and Me – risulta estremamente accurata, le scelte d’illuminazione e i tagli d’inquadratura spostano la dimensione figurativa su un piano più radicalmente astratto. L’esempio più eloquente è forse quello della cella di Sono innocente! (fig. 1): «Lang si era documentato sul sistema carcerario americano, visitando San Quentin e Alcatraz; la sua cella della morte è una ricostruzione esatta di quella di San Quentin, filmata da Leon Shamroy, come ha detto Lang, “con geniale fantasia”»5. Lang, creatore di perfette macchine narrative e spettacolari in patria, non rifiuta certamente i principi fondanti del découpage classico. Ciononostante, i suoi primi film presentano una serie di soluzioni visive che in parte contraddicono i principi di trasparenza e funzionalità messi a punto dalla Hollywood sonora. Da un lato, come nota Tom Gunning, «Lang non abbandonerà mai i tratti geroglifici dei suoi film muti»6, e usi non convenzionali del montaggio si trovano ad esempio in Furia, nel quale alcune comari che spettegolano sono trasformate, grazie a una dissolvenza incrociata, in un gruppetto di galline all’interno di un’aia, in un perfetto esempio di metafora visiva realizzata secondo i principi del montaggio intellettuale.
Va poi notato come lo spettatore dei primi film di Lang venga costantemente interpellato da sguardi che si rivolgono direttamente alla macchina da presa. Sempre in Furia, Lang arriva a chiamare in causa, durante il dibattimento processuale che occupa la seconda parte del film, il dispositivo stesso: un proiettore viene rivolto verso l’obiettivo e tutti i presenti guardano il pubblico direttamente negli occhi. Le immagini mostrate al processo servono a individuare, tra la folla, i responsabili dell’aggressione al carcere nel quale si trovava il personaggio interpretato da Tracy. Il montaggio isola i volti di quelli che sono, a tutti gli effetti, degli everyman, non dissimili dal pubblico seduto in sala. La scena suona come una dichiarazione d’intenti: fin dall’esordio americano, Lang è deciso a puntare la sua macchina da presa direttamente sulle contraddizioni profonde che attraversano il paese che lo ospita. In fuga dal nazismo, il regista non riserva agli Stati Uniti un trattamento caratterizzato dalla gratitudine: lo interessano, invece, le falle del sistema, le possibili derive autoritarie, il rapporto sbilanciato dell’individuo con la società, le sacche di fascismo quotidiano anche all’interno di un sistema democratico. Dopo tre film realizzati con tre case di produzione diverse, Lang approda alla 20th Century Fox, per la quale realizza inizialmente due western, Il vendicatore di Jess il bandito (The Return of Frank James, 1940), nel quale ritrova Henry Fonda, e Fred il ribelle (Western Union, 1941), con Robert Young e Randolph Scott. Il vendicatore di Jess il bandito è il sequel di un’opera di enorme successo, Jess il bandito (Jesse James), diretto da Henry King e distribuito nelle sale l’anno precedente. Nella storia (completamente inventata) di come il fratello di Jesse James (nel film di King interpretato dal divo Tyrone Power) decida di vendicarsi dell’assassino di questi, Bob Ford (John Carradine), vi è molto di langhiano: il regista stempera il romanticismo del modello, concentrandosi sul tema della vendetta, vero punto di convergenza tra il genere e la sua filmografia. Soprattutto, Lang è interessato al western nella chiave del racconto di un mondo che genera il proprio mito,
come quando Frank James, a teatro, assiste a una rappresentazione nella quale i fratelli Ford mettono in scena l’assassinio di Jesse. Come è stato notato7, la sequenza non si offre soltanto come un memorabile momento autoriflessivo, ma si pone come speculare rispetto alle scene che, nella seconda parte del film, racconteranno il processo a Frank. L’aula del tribunale, come già in Furia, non è il luogo nel quale si stabilisce una verità, bensì dove prende forma un articolato procedimento di messa in scena. Infine, Lang si trova certamente a suo agio con i presupposti ideologici che il film esprime: come già in Jess il bandito – e come del resto in Furore (The Grapes of Wrath, 1940) di John Ford, prodotto dalla Fox nello stesso anno e sempre interpretato da Fonda – il vero nemico è il capitale, qui incarnato dalla compagnia ferroviaria, potere monopolistico più efficace (e minaccioso) di quello dello Stato. Il secondo western di Lang è più classicamente incentrato sulle fasi della conquista e assoggettamento della wilderness di fine Ottocento. Lang gira Fred il ribelle prevalentemente in esterni, dopo essersi documentato minuziosamente su un aspetto della colonizzazione solitamente poco trattato dal genere: quello della costruzione della linea del telegrafo8, che qui, con la sua capacità di mettere in comunicazione i territori americani, si pone in antitesi con la contemporanea Guerra Civile, ferita simbolica del continente. Nella celebrazione della tecnica e nel grande catalogo di topoi del genere (il fuorilegge redento, i banditi in agguato, gli scontri con gli indiani, la prateria in fiamme ecc.), Fred il ribelle appare più convenzionale de Il vendicatore di Jess il bandito, quasi in antitesi, grazie a scelte apertamente spettacolari, rispetto alla dimensione più intima e notturna del film precedente. I due film Fox rappresentano anche la prima esperienza di Lang con il Technicolor, utilizzato spesso in chiave antinaturalistica, specie nelle tinte fosche de Il vendicatore di Jess il bandito. Ma quella del colore è una breve parentesi: già dal film successivo, Duello mortale (Man Hunt, 1941), Lang tornerà al bianco e nero.
Dopo il successo di Duello mortale, la 20th Century Fox propone a Lang un altro film a tema bellico, Confirm or Deny (1941), da un soggetto di Samuel Fuller e Henry Wales. L’insoddisfazione rispetto alla sceneggiatura (di Jo Swerling) e all’attore scelto dallo studio, Don Ameche, portano però Lang ad abbandonare il progetto dopo sole due settimane, sostituito da Archie Mayo. Darryl F. Zanuck propone così a Lang la regia dell’esordio americano di Jean Gabin, Ondata d’amore (Moontide, 1942). È proprio Gabin, su suggerimento di Marlene Dietrich, a chiedere che sia Lang a dirigere il film. Gli scontri con Zanuck finiscono però per portare il regista ad abbandonare il set e, questa volta, lo studio. Anche Ondata d’amore sarà portato a termine da Archie Mayo. Duello mortale, che finisce così per essere il terzo e al momento ultimo film realizzato da Lang per la 20th Century Fox, è convenzionalmente considerato la prima delle pellicole “antinaziste” che impegneranno Lang nella prima metà degli anni quaranta. Ad essa seguiranno inizialmente Anche i boia muoiono (Hangmen Also Die!, 1943), Il prigioniero del terrore (Ministry of Fear, 1944) e, due anni e due film più tardi, Maschere e pugnali (Cloak and Dagger, 1946). Prima de Il prigioniero del terrore, Lang accarezza l’idea di realizzare un remake del classico espressionista Il Golem - Come venne al mondo (Der Golem, wie er in die Welt kam, Paul Wegener e Carl Boese, 1920) ambientato nella Praga occupata da nazisti, ma rivolge presto la sua attenzione altrove. Anche i boia muoiono è un film importante per diversi motivi. È il primo che Lang produce, grazie ad Arnold Pressburger e a un accordo di distribuzione con la United Artists; è poi l’unica esperienza hollywoodiana di Bertolt Brecht. Il drammaturgo, che tra il maggio 1941 e l’ottobre 1947 vive negli Stati Uniti, è accreditato (con il nome di Bert Brecht) come co-autore, con Lang, del solo soggetto, ma pare ormai assodato9 che anche la sceneggiatura, firmata ufficialmente da John Wexley, veda un contributo non indifferente di Brecht, nonostante Wexley, che aveva scritto con Milton Krims Confessioni di una spia nazista (Confessions of a Nazi Spy, Anatole Litvak, 1939), il primo film apertamente antinazista
prodotto a Hollywood, se ne attribuisca interamente la paternità di fronte alla Writers Guild of America. L’ammirazione di Lang per Brecht, manifestata dallo stesso regista in più occasioni10, è da leggersi anche come influenza dell’opera del drammaturgo su quella del regista per lunga parte della sua carriera. Ciò è reso evidente dal processo di “epicizzazione” che Lang opera sui soggetti che gli vengono sottoposti a Hollywood, lavorando sull’esplicitazione dei nodi concettuali (talvolta in chiave puramente figurativa, altrove attraverso il dialogo) spesso all’inizio dell’opera o, in più rari casi, nel finale, come accade con la “lezione” di Sylvia Sidney in You and Me, con tanto di cifre scritte sulla lavagna con il fine di dimostrare all’uomo che ama e ai suoi amici che “il crimine non paga”. Questo film, in particolare, vede il musicista tedesco Kurt Weill come autore della colonna sonora, ed è definito da Gunning come una sintesi tra un gangster film, un musical, una romantic comedy e un Lehrstück brechtiano11. La fonte d’ispirazione per Duello mortale è un romanzo di spionaggio uscito nel 1939, L’uomo che non doveva vivere (Rogue Male) di Geoffrey Household; Il prigioniero del terrore è tratto dal più celebre Quinta colonna (The Ministry of Fear, 1943) di Graham Greene; Maschere e pugnali dal saggio romanzato Cloak and Dagger: The Secret Story of O.S.S. di Corey Ford e Alastair MacBain (1946). Anche i boia muoiono è quindi l’unico dei film “antinazisti” ispirato direttamente a una storia vera, quella dell’attentato del 1942 al “boia di Praga”, il gerarca Reinhard Heydrich, e alla successiva rappresaglia da parte dell’esercito occupante. La durata inusitata (134 minuti, uno in più di La signora Miniver, Mrs. Miniver, di William Wyler, uscito l’anno precedente), l’assoluto rigore del racconto, il senso globale della messa in scena, la drammatizzazione di uno schema narrativo che appare in tutta evidenza man mano che il film procede, il rifiuto di qualsiasi tipo di identificazione secondaria con un personaggio “forte”, nella tradizione hollywoodiana (gli attori sono tutti caratteristi, senza alcun divo a spiccare tra essi), e la
scelta di realizzare invece un’opera corale nella quale ogni personaggio, sapientemente tipizzato, è chiamato a funzionare come simbolo e ad apparire come variabile di un teorema fanno di Anche i boia muoiono un’opera in qualche modo eccezionale anche nella variegata produzione dei film americani legati allo sforzo bellico. Soprattutto, Anche i boia muoiono è forse il film che più di ogni altro dimostra l’interesse di Lang per i processi di falsificazione12, che, come si è visto, sono soprattutto al centro dei due film “processuali” realizzati in USA, Furia e Il vendicatore di Jess il bandito. In Anche i boia muoiono la bugia, l’inganno, l’orchestrazione della menzogna diventano strumento di resistenza e prova d’eroismo, e il complotto che si stringe sul traditore Emil Czaka (Gene Lockhart), si presenta come la versione solarizzata delle forze oscure che altrove abitano le pellicole del regista. Di ciò è un esempio lampante proprio il film successivo, nel quale il protagonista, interpretato da Ray Milland, si trova inconsapevolmente al centro di un complotto, non diversamente da quanto accade in molte trame hitchcockiane. Il rimando a Hitchcock non deve suonare pretestuoso: se in Duello mortale e Anche i boia muoiono l’impegno propagandistico è un assunto attorno al quale si edifica l’opera, ne Il prigioniero del terrore il messaggio antinazista suona come il più classico dei “McGuffin”. Rivelatore è, in questo senso, il lavoro di regia. Va specificato che Il prigioniero del terrore, grazie al quale Lang torna temporaneamente alla Paramount, è scritto da Seton I. Miller, anche produttore del film. Lang si trova quindi nella condizione di non poter operare modifiche alla sceneggiatura, optando invece per un lavoro di intensa spettacolarizzazione: se nei due film precedenti si sforzava di conservare un rigore e un’uniformità che avvicinavano le opere alla freddezza di una formulazione logica, ne Il prigioniero del terrore Lang procede invece per accumulo, senza trascurare nessun artificio. In altre parole, se Duello mortale e Anche i boia muoiono hanno l’asciuttezza di una formula matematica, Il prigioniero del terrore appare come un raffinatissimo e virtuosistico arabesco. Dal punto di vista
figurativo, il film è una summa di soluzioni formali tipiche delle produzioni horror e thriller dell’epoca (fig. 2), già da qualche anno confluite in quello che sarà poi successivamente definito “noir”. Il tono onirico, allucinato, che caratterizza l’opera (il cui protagonista, all’inizio, è appena uscito da un manicomio), può a ragione fare de Il prigioniero del terrore l’approdo di Lang a un genere che negli anni successivi frequenterà assiduamente. Sempre del 1944 è infatti La donna del ritratto (The Woman in the Window), opera tra le più significative del periodo americano di Lang e vera pietra miliare del genere noir. Scritto da Nunnally Johnson a partire dal romanzo Once Off Guard di J.H. Wallis, uscito due anni prima, racconta la storia del professor Richard Wanley (Edward G. Robinson), coinvolto in un’avventura notturna con una sconosciuta (Joan Bennett, al secondo film con Lang dopo Duello mortale e la mancata conclusione di Confirm or Deny) che lo porta a commettere un delitto, ad adoperarsi nell’occultamento del cadavere, a subire un ricatto da parte del minaccioso Heidt (Dan Duryea, al secondo film consecutivo con Lang) e infine a optare per il suicidio. Come è noto, quasi tutto ciò che il film racconta, a partire dall’incontro di Wanley con Alice fino al suicidio dell’uomo, si rivelerà, nell’epilogo, solamente un sogno. Il pubblico ne è sorpreso non solo perché nel rappresentare il passaggio dal sonno alla veglia Lang non utilizza nessuna delle transizioni in voga all’epoca a Hollywood (anzi, il risveglio di Wanley avviene senza che via sia nemmeno uno stacco a separare mondo inconscio e mondo reale), ma soprattutto perché non vi è alcuna discontinuità formale tra le scene che precedono l’addormentarsi di Wanley e quelle che lo vedono coinvolto in un’improbabile trama delinquenziale. In altre parole, proprio quelle soluzioni talvolta bollate come “espressioniste” (illuminazione contrastata, inquadrature dal taglio inusitato ecc.) che abbondano ne Il prigioniero del terrore e in molti dei film a tema criminale dei primi anni quaranta, qui sono assenti. Lang sceglie di adottare i principi della più classica delle
“inverted detective stories”, nella quale lo spettatore sa già dal principio tutto ciò che è successo e assiste, passo dopo passo, alle indagini. Con il consueto rigore, dunque, gli spettatori partecipano all’angoscia del personaggio principale, che vede tutte le sue cautele smantellate dalla severità del metodo poliziesco e – naturalmente – dall’accanirsi del destino. Al momento della rivelazione, come nota Leonardo Gandini, «si ha la sensazione di trovarsi di fronte a una sorta di dichiarazione programmatica, basata su un provvisorio ma eloquente atto di disvelamento dei meccanismi che presiedono alla costruzione – narrativa e figurativa – degli altri noir»13. Di conseguenza «è legittimo considerare La donna del ritratto come una specie di esercizio brechtiano sul noir, sulla sua inclinazione a declinare il crimine secondo le modalità di un onirismo tanto impercettibile quanto pervasivo, e perlopiù ancorato a uno stadio di alterazione mentale dei personaggi»14. Questo «onirismo impercettibile» è, per Helmut Weihsman, connaturato ai principi stessi della regia langhiana, e soprattutto a una concezione dello spazio filmico che è «simbolica e illustrativa»: Egli si limita a suggerire o a proiettare lo spazio sull’occhio della macchina da presa. La disposizione topografica de La donna del ritratto rivela una certa lucidità e fluidità spaziali (interfluidium) in una dimensione allusiva e allucinatoria quasi sonnambolica. Ambienti onirici, privi di sostanza compaiono e si evolvono/dissolvono gli uni negli altri, si dilatano all’infinito mediante specchi e altri espedienti, in modo molto simile a quello in cui agiscono i nostri sogni, quando veniamo trasportati in spazi immaginari e in dimensioni visionarie. […] Lang dirige lo sviluppo dell’azione senza bruschi stacchi, con ellissi di immagini in dissolvenza, senza ricorrere alle soggettive e/o al monologo interiore […]. Lang ci permette di condividere il punto di vista del sognatore, e nella prospettiva di chi sogna gli ambienti devono ovviamente apparire meno concreti15.
Il successo de La donna del ritratto, prodotto dalla International Pictures e distribuito dalla RKO, è considerevole. Per il film successivo, La strada scarlatta (Scarlet Street, 1945), prodotto dallo stesso Lang (attraverso la neonata Diana Productions, fondata in società con Joan Bennett e Walter Wanger) e distribuito dalla Universal Pictures, egli mette al centro della trama un altro ritratto, chiama a raccolta lo stesso cast
(Robinson, Bennett e Duryea) lo stesso direttore della fotografia, Milton R. Krasner, e dà forma ancora una volta a «un mondo vagamente irreale e inconsistente, senza spessore, dominato dalla presenza di vetri, specchi, e ombre che costantemente duplicano l’immagine dei personaggi, minandone la verosimiglianza e la messa a fuoco»16. L’occasione è il remake de La cagna (La chienne) il film di Jean Renoir distribuito in Francia nel 1931. Adattata dal romanzo omonimo (1930) di Georges Alphonse de La Fouchardière e del dramma di André Mouëzy-Éon che ne viene immediatamente tratto, La cagna è un’opera dai temi troppo espliciti per la Hollywood degli anni quaranta, al punto che il primo tentativo di rifarla (con la regia di Ernst Lubitsch, per la Paramount), naufraga prima ancora che si incomincino i lavori. La storia del film di Lang, scritto da Dudley Nichols, è quella di un impiegato di banca, Christopher Cross (Robinson), dalla vita familiare infelice – è costantemente vessato dalla moglie Adele (Rosalind Ivan) – e dalla passione per la pittura, che un giorno si imbatte in una giovane donna, Kitty (Bennett), per la quale perde la testa. Legata a un criminale di mezza tacca, Johnny (Dureya), Kitty sfrutta Cross per farsi mantenere. Quando questi comprende la verità, la uccide, ma del delitto viene incolpato Johnny, che sarà condannato a morte. Nonostante la trama ricalchi piuttosto fedelmente quella del film di Renoir, Lang modifica le ambientazioni, rendendole meno sordide (sfondo della vicenda è il quartiere Greenwich Village di New York, ricostruito in studio), e non esplicita, in accordo con i dettami del codice Hays, la professione della protagonista femminile, ne La cagna una prostituta e qui, apparentemente, soltanto una mantenuta. Ciononostante, il film rappresenta comunque una sfida di Lang al codice di autoregolamentazione interna di Hollywood, soprattutto nel voler far passare la condanna a morte di un uomo innocente, che effettivamente viene qui condotto al patibolo senza che vi sia pentimento da parte dell’autore
materiale del delitto. Cross, dal canto suo, finirà per impazzire e vagare per la città senza dimora e senza meta. La natura “scandalosa” dell’opera è certamente uno dei fattori che determinano il successo del film, e contemporaneamente una delle più violente campagne di boicottaggio da parte della Legion of Decency e un insolitamente ampio numero di censure locali. Come riportato dal «New York Times» all’epoca, l’accanimento delle autorità pubbliche nei confronti de La strada scarlatta è «una delle azioni più drastiche mai intraprese […] contro un film prodotto da una major hollywoodiana»17. Decisamente meno scandaloso è il già citato Maschere e pugnali, con il quale Lang torna a tessere una trama di spionaggio sullo sfondo della seconda guerra mondiale. Prodotto dalla United States Pictures per conto della Warner Bros., Maschere e pugnali è un film che, nonostante il tema e il divo protagonista (Gary Cooper), subisce da parte della Warner un drastico taglio nell’ultima parte. Il ridimensionamento finisce per snaturare l’opera, oggi considerata la quarta delle pellicole “antinaziste” di Lang ma originariamente pensata soprattutto come un grido d’allarme nei confronti dell’utilizzo dell’energia atomica nell’industria bellica. Come abbiamo visto, in Lang si ha spesso, all’inizio del film, l’esposizione di un’idea o di un principio, che viene poi sviluppato e drammatizzato. In questo caso, il personaggio interpretato da Cooper, il fisico nucleare Alvah Jesper (vagamente ispirato a J. Robert Oppenheimer), è inquieto nei confronti dell’utilizzo dell’energia atomica a fini offensivi: una disillusione che emerge chiaramente da un monologo che pronuncia all’interno del suo laboratorio nel corso della scena che lo presenta al pubblico. Reclutato per entrare in contatto con una collega (Helen Thimig) costretta a lavorare per la Germania ma fortunosamente riparata in Svizzera, finisce per essere coinvolto in un complesso gioco di spie. Nel finale, girato e inizialmente montato, Jesper scopre che anche i nazisti sono sul punto di fabbricare un ordigno nucleare. Così, all’interno del laboratorio segreto
dei tedeschi egli riprende il discorso fatto all’inizio, e condanna ancora una volta l’utilizzo improprio della propria disciplina, adombrando il pericolo di un’escalation nucleare globale. La forza puramente teorico-espositiva di questo epilogo, che arriva dopo la liberazione dei prigionieri e la fuga che a oggi chiudono il film, è determinata dal fatto che, esattamente come l’introduzione del personaggio, non è direttamente in relazione, sul piano diegetico, con la trama dell’opera. Si pone insomma come una chiosa, un momento esplicito di riflessione, ma contemporaneamente offre alla Warner la possibilità di rinunciarvi senza sforzo, non sacrificando nulla dell’azione ed evitando di offrire agli spettatori battute che, dopo il bombardamento di Hiroshima e Nagasaki, possono risultare, nel loro allarmismo ed esplicito pacifismo, piuttosto controverse. Come scrive Noël Simsolo: La pace è stata appena firmata e i nemici non sono più i nazisti, ma i rossi. Inoltre, dato che l’atomica conferisce una supremazia teorica agli Stati Uniti nei confronti del blocco orientale, non è più il momento di contestarne la legittimità e di parlare di pace. In tempi di guerra fredda un messaggio pacifista non è più all’ordine del giorno. Maschere e pugnali diventa soltanto un film di spionaggio18.
Il racconto dell’uomo portato a utilizzare prevalentemente l’intelletto che improvvisamente scopre sulla propria pelle la brutalità del mondo trova in Maschere e pugnali uno degli esiti più alti della filmografia di Lang: la scena in cui Jesper si scontra con Luigi (Marc Lawrence) nell’ingresso di un condominio. La scena di violenza, non edulcorata né spettacolarizzata, priva di musica, presenta delle reminiscenze di quella, simile, della morte dell’ispettore della Gestapo Alois Gruber (Alexander Granach) in Anche i boia muoiono, ma qui Lang estende l’azione il più possibile, nel tentativo di rappresentare tutto il peso, e la fatica, della lotta per la vita. Amareggiato dai conflitti con la Warner, Lang torna ad atmosfere più vicine al noir: Dietro la porta chiusa (Secret Beyond the Door, 1947), un’altra produzione Diana distribuita dalla Universal, è un grosso insuccesso, e per la prima volta sembra che Lang, la cui fama legata
ai rapporti con i produttori non è delle più lusinghiere, non abbia possibilità di rimettersi al lavoro a breve. A correre in suo aiuto è Howard Welsch, che gli propone un contratto per due film da realizzare, a basso costo, con la sua casa di produzione, la Fidelity Pictures. Il primo, il noir in costume Bassa marea (House by the River, 1950), sarà distribuito dalla Republic, il secondo, il western Rancho Notorious (1952), dalla RKO. Bassa marea, scritto da Mel Dinelli a partire dal romanzo The House by the River di A.P. Herbert, racconta di uno scrittore, Stephen Byrne (Louis Hayward) che uccide la giovane domestica Emily (Dorothy Patrick) dopo un tentato approccio sessuale. Poi, con l’aiuto del fratello John (Lee Bowman), il cadavere viene abbandonato nel grande fiume che scorre davanti alla casa. Quando il corpo riemerge, però, sarà proprio il fratello a essere accusato del delitto. Nelle intenzioni di Lang, con Bassa marea si sarebbe potuto affrontare il tema razziale già tentato inutilmente con Furia: l’idea del regista è infatti quella di fare della domestica desiderata e poi uccisa una donna di colore, ma anche questa volta è costretto a fare un passo indietro. Ciò che sembra interessare soprattutto il regista è l’indagine sul processo della creazione letteraria: Stephen, romanziere di nessun successo, trova un nuovo riferimento ispirativo in se stesso e nel delitto che ha compiuto, mettendo su carta, di fatto, una sorta di confessione. Il meccanismo di proiezione del desiderio che più volte nel cinema di Lang prende corpo (in maniera programmaticamente “teorica” ne La donna del ritratto), qui è declinato secondo un doppio principio: l’omicidio si rinnova sulle pagine scritte da Stephen ma contemporaneamente mina la mente dell’uomo (come del resto accadeva già, non troppo diversamente, ne La strada scarlatta). Nel finale, Emily riappare come una visione o uno spettro (fig. 3), causando la morte del diabolico protagonista. Complice l’ambientazione tardo ottocentesca, Bassa marea è infatti l’opera nella quale Lang ricorre, più che altrove, a soluzioni di carattere “gotico” (la scena del delitto è immersa in un’oscurità
diffusa, con la poca luce filtrata dagli spessi tendaggi dell’ingresso), dando forma a un ambiente che appare minacciato da cupi presagi, come se una maledizione incombesse sul luogo e sui personaggi. Molto diverso è invece il film successivo, I guerriglieri delle Filippine (American Guerrilla in the Philippines, 1950), scritto e prodotto da Lamar Trotti per la 20th Century Fox. Inizialmente programmato per un’uscita a guerra in corso, il film viene accantonato e ripreso dopo alcuni anni, quando ormai il regista scelto da Zanuck, Henry King, non è più disponibile. Il lavoro di Lang è quindi, in questo caso, puramente su commissione. Come già era stato per Fred il ribelle, il regista, non sentendo particolarmente nelle sue corde il progetto, accetta a patto di poter girare prevalentemente in location reali. La compresenza di questi due fattori – il realismo d’ambientazione e la distanza dai fatti raccontati – fanno de I guerriglieri delle Filippine un’opera che attenua il più possibile la retorica tipica del genere, e che dimostra un’attenzione inedita agli usi e ai costumi della popolazione indigena. Contrariamente agli altri film che Lang dedica alla seconda guerra mondiale, I guerriglieri delle Filippine è più classicamente un film di genere bellico. Ciononostante, come ricorda Lotte Eisner, come nella tetralogia “antinazista” «il protagonista si trova in una situazione in cui il nemico è dappertutto, ogni attività è necessariamente clandestina, non è più possibile nessun atto “normale”. Lentamente i personaggi si spostano dall’azione passiva, fuga, sopravvivenza, verso un momento più attivo e positivo di lotta per riconquistare la completa libertà»19. Nel periodo in cui il regista è impegnato nelle Filippine, negli Stati Uniti Seymour Nebenzal, produttore di M (1931), riesce a realizzare un remake del film, intitolato semplicemente M, distribuito nel 1951 e diretto da Joseph Losey. Il ritratto dell’assassino (David Wayne) nell’America degli anni cinquanta «gioca essenzialmente sulla chiave psicanalitica, ovvero l’interiorizzazione di un conflitto esterno, non nel senso mitico-simbolico del
modello langhiano, ma in quanto lacerazione esistenziale del sociale»20. A Bogdanovich, Lang confessa di non aver mai voluto vedere il film21. Rancho Notorious, terzo western di Lang e quarto film da lui girato in Technicolor (la fotografia è di Hal Mohr) esce nel 1952, e racconta la storia di un uomo, Vern Haskell (Arthur Kennedy), alla ricerca del rapinatore (Lloyd Gough) che ha violentato e ucciso la sua fidanzata (Gloria Henry). Seguendo le sue tracce, arriva al Chucka-Luck, un ranch gestito da Altar Keane (Marlene Dietrich, alla sua unica collaborazione con Lang) come rifugio per banditi e ricercati in fuga. Rancho Notorious, scritto da Daniel Taradash a partire da un soggetto originale di Silvia Richards, è uno dei film del periodo americano di Lang ad aver guadagnato, negli anni, lo status di cult movie, soprattutto in virtù dell’estrema stilizzazione, dovuta in parte anche alle scarse possibilità offerte dal risicato budget messo a disposizione da Welsch. Il West di Rancho Notorious è infatti poco più di un fondale dipinto: «lo scenario della vallata chiusa, covo dei ricercati e degli outcasts, con il suo rancho sala da gioco e la sua chiave notturna e crepuscolare, è uno dei più intensi, dei più irreali, dei più europei di tutto il West»22. Scandito dalla canzone Legend of Chuck-a-Luck di Ken Darby, che introduce i temi portanti dell’opera («hate, murder and revenge»: temi che si potrebbero estendere a gran parte del cinema di Lang), Rancho Notorious assume la forma di una ballata: la vicenda si dipana come fosse l’illustrazione delle parole della canzone, una storia più volte raccontata, scarnificata dei suoi elementi realistici e proiettata direttamente nello spazio del Mito. Ancora una volta, al centro del film vi sono omissioni, menzogne, inganni, simboleggiati dalla ruota della fortuna truccata il cui nome, Chuck-a-Luck, viene dato al ranch di Altar Keane (e inizialmente allo stesso film23). Come altre opere “eccentriche” del periodo, da Duello al sole (Duel in the Sun, 1946) di King Vidor al successivo Johnny Guitar (1954) di Nicholas Ray, Rancho Notorious mette a nudo i procedimenti simbolici del
genere, finendo per assumere la forma di una «parabola brechitana sulla cultura capitalistica patriarcale»24. Al di là del mito del West, al centro dell’opera è incastonato quello della diva protagonista. Presentata indirettamente attraverso le parole delle persone che Vern incontra nel corso della sua ricerca, Altar Keane è già una leggenda. Ecco quindi che i flashback che introducono Marlene Dietrich sembrano quasi, a livello di enunciazione programmatica, sovrapporre l’immagine della diva a quella del suo personaggio. Rancho Notorious, in altre parole, è un manifesto dei procedimenti autoriflessivi ricorrenti – ma mai così espliciti – del cinema dell’autore, e una raffinata operazione metacinematografica pensata come dono di Lang a Dietrich. Diverso è il caso dell’opera successiva, La confessione della signora Doyle (Clash by Night, 1952), prodotta da Jerry Wald, Norman Krasna e Harriet Parsons, distribuita ancora una volta dalla RKO e ricordata soprattutto come uno dei primi film nei quali Marilyn Monroe ricopre un ruolo di una certa importanza. In molti hanno notato come le immagini iniziali del film, con il risveglio della piccola comunità di pescatori, il ritorno sulla terraferma dei pescherecci, l’attenzione riservata agli animali (gabbiani e foche) e alle fasi della lavorazione del pesce in fabbrica, presentino una qualità quasi “documentaria”, insolita per un cineasta come Lang. Effettivamente, tali inquadrature vengono girate da Lang e dal suo operatore, Nicholas Musuraca, in totale libertà durante i primi sopralluoghi a Monterey, in California. Come scrive Gunning, Lang si avvicina maggiormente al nuovo realismo del cinema americano del secondo dopoguerra, dando grande rilievo alle riprese in esterni, attraverso una storia drammatica di infedeltà che metteva in discussione la stabilità della famiglia americana, e che era suggellata dai dialoghi di un drammaturgo il cui lavoro aveva consentito nuove sperimentazioni nel campo della recitazione25.
Non stupisce – ricorda ancora Gunning – che per questa trasposizione di uno dei drammi più celebri (nonché il preferito di Lang) di Clifford Odets, Scontro nella notte
(Clash by Night), messo in scena per la prima volta nel 1941, fosse stato inizialmente contattato Nicholas Ray, «forse il regista che meglio ha compreso l’avvicendarsi di nuovi sviluppi nella recitazione e nella drammaturgia che un’opera teatrale come quella di Odets implicava per il cinema americano in vista di una sua trasposizione»26. La confessione della signora Doyle, anche in virtù della derivazione teatrale, appare dunque come un’opera insolita nel percorso langhiano. Lo sceneggiatore, Alfred Hayes, non si limita a spostare l’azione dal distretto newyorchese di Staten Island a Monterey, ma soprattutto stempera il commento sociale del dramma sulla disoccupazione di Odets irrobustendo i toni melodrammatici e mettendo al centro della vicenda la Mae di Barbara Stanwyck. Il risultato finale, con l’amalgama delle dinamiche mélo e l’approccio realista, risulta essere forse l’unico vero Kammerspielfilm realizzato da Lang nel corso della sua carriera. Pur non dando forma, come altrove, a un’esplicita riflessione sul medium, il regista inserisce ne La confessione della signora Doyle il dispositivo cinematografico: Earl Pfeiffer, il personaggio interpretato da Robert Ryan, è infatti il proiezionista del cinema del paese, e proprio all’interno della cabina di proiezione si consuma la scena più drammatica del film, lo scontro tra Pfeiffer e Jerry D’Amato (Paul Douglas). Tra il 1952 e il 1953 Lang è guardato con sospetto dalla Commissione per le attività antiamericane. Come cofondatore della Hollywood Anti-Nazi League nel 1936, amico di Bertold Brecht, Hanns Eisler, John Wexley, autore di un film (Maschere e pugnali) firmato da due dei “dieci di Hollywood”, Ring Lardner Jr. e Albert Maltz, Lang incomincia ad avere difficoltà a trovare un impiego. Dopo alcuni mesi di inattività, grazie all’interessamento di Harry Cohn, riesce a strappare un accordo per dirigere una piccola produzione indipendente per conto della Warner Bros., Gardenia blu (The Blue Gardenia, 1953), da un racconto di Vera Caspary intitolato The Gardenia (1952). L’aggettivo “blue” viene aggiunto, pare, per richiamare alla mente del pubblico l’efferato delitto di Elizabeth Short, uccisa
nel gennaio del 1947 e ribattezzata dalla stampa “The Black Dahlia”, la Dalia Nera L’attenzione che Lang riserva al mondo del giornalismo a partire da questo film ha portato alcuni studiosi a vedere in Gardenia blu il primo esito di una nuova “trilogia”, incentrata sul potere e sulla pervasività dei media. Simsolo è forse il primo a considerare Gardenia blu, Quando la città dorme (While the City Sleeps, 1956) e L’alibi era perfetto (Beyond a Reasonable Doubt, 1956) come un “trittico”27. In Gardenia blu, l’aggressività dei media è rappresentata dal personaggio di Casey Mayo, il giornalista interpretato da Richard Conte che tenta di sfruttare il più possibile, con grande cinismo, l’omicidio di un pittore donnaiolo (Raymond Burr) per il quale manca ancora un colpevole. In opposizione alla figura maschile vi è poi Norah Larkin (Anne Baxter), convinta di essere la responsabile del delitto ricercata dalla polizia e dai reporter. Per E. Ann Kaplan, il film è incentrato sull’inconciliabilità di due mondi: quello maschile, minaccioso, del noir, e quello femminile, minacciato, del film hollywoodiano “sulla donna”28. Norah, la potenziale assassina, è un personaggio squisitamente langhiano, con il quale il regista in effetti sembra empatizzare. Nella mise en scène del momento in cui legge sul giornale la lettera che Mayo rivolge all’omicida, «la cinepresa inquadra Norah che a sua volta la guarda […]. In questo, si sente fortemente la presenza del regista – la sua complicità? –, nello stile ineccepibile che porta al momento cruciale in cui lei guarda verso la cinepresa»29. Girato in soli venti giorni e realizzato su commissione in un momento di difficoltà, Gardenia blu riesce comunque a inserirsi organicamente all’interno della produzione langhiana, e contribuisce a rilanciare la carriera del regista. Al termine della lavorazione, infatti, Cohn non intercede più per Lang presso altri, ma lo invita direttamente a realizzare due film per la Columbia. Il primo, Il grande caldo (The Big Heat), vedrà la luce nel 1953, il secondo, La bestia umana (Human Desire), l’anno successivo.
Tratto dal romanzo omonimo di William P. McGivern, pubblicato a puntate sul «Saturday Evening Post» tra il dicembre 1952 e il febbraio 1953, sceneggiato da Sydney Boehm, ex giornalista specializzato in cronaca nera, Il grande caldo è certamente l’opera più radicale tra quelle che Lang gira negli Stati Uniti. Lo è sul piano della rappresentazione della violenza e della riflessione su di essa, ma anche nel disincanto con cui il regista osserva e dipinge l’America degli anni cinquanta, molto lontana dall’immagine rassicurante e serena che essa dà di stessa anche attraverso Hollywood. Dave Bannion (Glenn Ford), detective della squadra omicidi della polizia di Kenport, è il tipico everyman langhiano che si sente «martirizzato dal fato»30. A Kenport il crimine organizzato ha saputo penetrare le istituzioni e lo stesso distretto di cui fa parte il protagonista. Come nota Colin McArthur31, il film incomincia con un movimento di penetrazione del mondo ordinario di Bannion da parte di quello, sinistro, del boss Mike Lagana (Alexander Scourby) e del suo braccio destro Vince Stone (Lee Marvin). Con l’uccisione della moglie (Jocelyn Brando), Bannion viene definitivamente raggiunto dalla minaccia criminale e da essa trasformato: il secondo movimento del film, da questo punto in avanti, vede l’allontanamento di Bannion dalla comunità, il perseguimento della sua vendetta, il ricorso alla violenza al di fuori dei limiti istituzionali. L’opera si chiude però su un terzo movimento: dopo la caduta, infatti, si assiste a al reinserimento dell’uomo nella società, anche grazie all’aiuto di Debby Marsh (Gloria Grahame), la donna del gangster che si fa carico delle azioni irreparabili e accetta l’inevitabile martirio. Ancora una volta, dunque, lo schema portante del racconto appare in tutta la sua matematica evidenza, ma nell’aprirsi a una serie di rispecchiamenti (Debby Marsh/Katie Bannion), o di possibilità (la famiglia del poliziotto corrotto Duncan come doppio negativo di quella di Bannion), Il grande caldo rifiuta programmaticamente la dimensione catartica della violenza. Non vi è happy ending, e, per citare Gunning,
nemmeno un vero e proprio ending: «si ha la sensazione che il film stia ricominciando e che il “The End” impresso nel fotogramma sopraggiunga in modo del tutto arbitrario»32. Prendendo a prestito le parole che Raymond Bellour dedicherà a Psyco (Psycho, Alfred Hitchcock, 1960), anche Il grande caldo può essere definito un’opera in cui «la parte d’ombra continua ad aumentare, seguendo il gioco regolato-sregolato che guida il film dall’inizio alla sua conclusione»33. Il secondo film realizzato per la Columbia vede ancora una volta Glenn Ford e Gloria Grahame come protagonisti. La bestia umana è il secondo remake di Lang di un’opera di Renoir, in questo caso l’adattamento del romanzo La bestia umana (La Bête humaine, 1890) di Émile Zola, distribuito in Francia nel 193834. Contrariamente a quanto accaduto con La strada scarlatta, in questo caso le differenze con il modello cinematografico (ma anche con quello letterario) sono molte. Così le sintetizza Andrew Sarris: Se L’angelo del male di Renoir è la tragedia di un uomo sciagurato, trascinato dal flusso della vita, il remake di Lang, La bestia umana, è l’incubo di un uomo innocente intrappolato nelle torbide trame del destino. Quello che ricordiamo di Renoir sono i volti di Gabin, Simon e Ledoux. Quello che ricordiamo di Lang sono i modelli geometrici dei treni, i binari e le angolazioni funeste della camera. Se Renoir incarna l’umanesimo, Lang incarna il determinismo. Se Renoir si preoccupa della condizione dei suoi personaggi, Lang è ossessionato dalla struttura della trappola35.
Scritto, come La confessione della signora Doyle, da Alfred Hayes, La bestia umana è anch’esso incentrato su un personaggio che ritorna in seno a una piccola comunità (là la Mae Doyle di Stanwyck, qui il Jeff Warren di Ford, reduce della guerra di Corea), ma nello studio d’ambiente dei ferrovieri, contrariamente a quello dei pescatori del film del 1952, Lang rinuncia a un trattamento verosimile del contesto. Anche in virtù della prima esperienza dell’autore con un formato panoramico, il VistaVision (ideale per un mondo dallo sviluppo “orizzontale” come quello dei treni), La bestia umana si presenta infatti come un’ulteriore tappa della scarnificazione espressiva e della tensione verso l’essenzialità che caratterizza l’ultima fase dell’esperienza
americana del regista e che troverà pieno compimento nei due film prodotti da Bert E. Friedlob per l’RKO, Quando la città dorme e L’alibi era perfetto. Prima, però, Lang ha l’opportunità di tornare a lavorare un’ultima volta per la Metro-Goldwyn-Mayer. L’occasione è rappresentata da Il covo dei contrabbandieri (Moonfleet, 1955), lussuoso adattamento (di Jan Lustig e Margaret Fitts) dell’omonimo romanzo (1898) di J. Meade Falkner noto in Italia come Il diamante di Barba Nera. Il covo dei contrabbandieri nasce sulla scia di altri successi avventurosi in costume della MGM come Scaramouche (1952) di George Sidney e Il prigioniero di Zenda (The Prisoner of Zenda, 1952) di Richard Thorpe, entrambi interpretati, come Il covo dei contrabbandieri, da Stewart Granger. «Ripensandoci – confessa Lang a Bogdanovich – probabilmente ho firmato quel contratto perché dopo Furia ero stato bandito dalla MGM per vent’anni, e tornare a lavorarci era una bella soddisfazione»36. Nonostante dichiari in più occasioni di non trovarsi pienamente a proprio agio con il Cinemascope, Lang affronta il progetto anche per la sfida che esso comporta sul piano dell’immagine: il mondo in Eastmancolor dell’Inghilterra tardo settecentesca è ricostruito quasi interamente in studio, e offre al regista la possibilità di portare a compimento una delle sue opere più raffinate sul piano compositivo, costantemente attenta a distribuire, all’interno del quadro, décor e personaggi secondo un rigoroso principio di equilibro interno dell’immagine. Patrick Brion nota come questo «dramma crepuscolare che si svolge sempre di notte e nel quale i personaggi si trovano man mano coinvolti in un intrigo che li stritola uno dopo l’altro»37, sia in realtà tutt’altro che eccentrico se visto in relazione con il resto dell’opera del regista. Ciononostante, Il covo dei contrabbandieri è ingiustamente considerato, per primo dallo stesso Lang, come un’opera minore all’interno della sua filmografia. Quando la città dorme, che Casey Robinson trae da un romanzo di Charles Einstein, The Bloody Spur (1953)
ispirato alla figura del serial killer William Heirens, appare immediatamente più nelle corde di Lang: come in M, il panico suscitato dalle gesta di un maniaco omicida funziona soprattutto come un pretesto per sezionare spietatamente il mondo che lo ospita. Da questo punto di vista, Quando la città dorme si presenta come una summa del pensiero di Lang sull’America. Il regista non è interessato né al mystery né alla suspense: come scrive Simsolo, «Quando la città dorme si struttura sulla scomposizione e sulla trasparenza»38, mostrando immediatamente, prima ancora dei titoli di testa, il volto dell’assassino. La New York notturna, filmata in SuperScope, non è più lo scenario da trasfigurare con sensibilità noir. A prevalere sono la pianificazione e la messa in atto delle strategie del gruppo di giornalisti protagonisti del film, impegnati in scene di dialogo al chiuso: uffici, appartamenti e bar. L’attenzione di Lang è dunque tutta per il mondo dei media, sineddoche di una società improntata alla competizione. Tredici anni dopo Anche i boia muoiono, il regista torna idealmente a una forma corale di racconto, ma mentre, nello spirito della resistenza al nazismo, il film del 1943 raccontava la perfetta armonizzazione di più forze tese a conquistare insieme un obiettivo comune, qui la trama si configura come una vera e propria gara di “tutti contro tutti”, all’inseguimento dello scoop. Il secondo film che Lang realizza per Friedlob, L’alibi era perfetto, esce anch’esso nel 1956, e rappresenterà l’ultimo capitolo dell’avventura americana di Lang: Ho spiegato che cosa volevo al mio montatore, Gene Fowler, per lasciare il film in buone mani, e poi me ne sono andato. Ho ripensato al passato, a quanti film mi avevano mutilato, e dato che non volevo morire di un attacco cardiaco, mi sono detto, “Basta con questa corsa di topi”. E ho deciso di non girare più film in questo paese39.
[1.]
[2.]
[3.]
Note al testo Paolo Bertetto La regia di Fritz Lang. Forma e fascinazione La biografia di Lang a Berlino è di grande interesse e il libro di Patrick McGillighan (Fritz Lang: The Nature of the Beast, London, Faber and Faber, 1997) ricostruisce bene la sua avventura. Regista di successo, fin da Die Spinnen (1919), Lang non è un autore per élite culturali. È il regista di film di successo, amati dal pubblico, come Il dottor Mabuse (1922) e I Nibelunghi (1924). Non a caso può permettersi un film costoso come Metropolis (1927), che poi non è premiato dal pubblico e viene ridotto a una versione più breve e meno inventiva. Ma dopo Metropolis Lang lavora con produttori indipendenti, soprattutto Seymour Nebenzahl, ma dimostra di sapersi adattare anche a queste nuove condizioni produttive. Nel periodo berlinese tuttavia ci sono due eventi oscuri e drammatici che Lang ha in un caso preferito cancellare e nell’altro caso ha ricordato e rammentato in modo arbitrario e inesatto. Il primo episodio nel settembre 1920 è la scomparsa della prima moglie Liza Rosenthal, una ebrea lituana che muore per un colpo di pistola al petto dopo aver scoperto il marito in intimità con Thea von Harbou, che diverrà la seconda moglie. Lang aveva parlato di suicidio. La polizia di incidente. Ma molti nel mondo del cinema a Berlino ritenevano Lang in vario modo colpevole. La seconda questione è quella del rapporto con il nazismo e con Goebbels. Mentre Thea si iscrive al partito nazista (NSDAP) e divorzia da Lang – per motivi sentimentali e non politici, a differenza delle affermazioni del regista – Lang è considerato in un primo tempo vicino ai nazisti. Risulta infatti incluso in una lista di registi e artisti di cinema vicini al movimento hitleriano, con Carl Boese e Luis Trenker Lang sembra aver vantato addirittura un’amicizia con Goebbels. In America scrive un articolo durante la guerra in cui racconta la proposta di Goebbels di dirigere il cinema nazista, la sua accettazione coatta e poi l’immediata fuga a Parigi. Lang afferma di non essere poi più tornato in Germania, ma il suo passaporto lo smentisce. L’incontro con Goebbels c’è stato veramente o è un’invenzione di Lang? 1
Sul cinema di Lang si vedano L. Eisner, Fritz Lang (1976), Milano, Mazzotta, 1978; ma anche E.A. Kaplan, Fritz Lang. A Guide to References and Resources, Boston, G.K. Hall, 1981; L. Eisner, Lo schermo demoniaco (1952), Roma, Editori Riuniti, 1983; T. Gunning, The Films of Fritz Lang: Allegories of Vision and Modernity, London, BFI, 2000; P. Bertetto, B. Eisenschitz (a cura di), Fritz Lang. La messa in scena, Torino, Lindau, 1993; F. Lang, Trois lumières. Écrits sur le cinéma, a cura di A. Eibel, Paris, Ramsay, 2007; B. Eisenschitz, Fritz Lang au travail, Paris, Cahiers du cinéma, 2011; l’ottimo J. McElhaney (a cura di), A Companion to Fritz Lang, Oxford, John Wiley & Sons, 2015; e l’intervista P. Bogdanovich, Il cinema secondo Fritz Lang (1967), Parma, Pratiche, 1988. Sull’interpretazione della messa in scena di Lang, mi permetto di rinviare ai miei saggi: P. Bertetto, Fritz Lang Metropolis, Torino, Lindau, 2007, 4a ed.; Id., Otto Hunte. Entwurfe fur “Die Nibelungen”, in A. Arns, H. P. Reichmann (a cura di), Otto Hunte: Architekt für den Film, Frankfurt am Main, Deutsches Filmmuseum, 1996. Nelle varie versioni diversamente restaurate del film, le inquadrature degli occhi di Mabuse appaiono in numero e in modi differenti. 2
Si veda F.W. Nietzsche, La volontà di potenza (1901), Milano, Bompiani, 2001. Su Mabuse personaggio nietzschiano si veda P. Bertetto, Microfilosofia del cinema, Venezia, Marsilio, 2014, il capitolo Dr. Mabuse e M. Il superuomo bipolare e il soggetto parafrenico. 3
4
G. Deleuze, L’immagine-movimento (1983), Milano, Ubulibri, 1985.
Questa immagine suggestiva è ripresa ne La donna che visse due volte (Vertigo, 1958) di Hitchcock e ne La camera verde (La chambre verte, 1978), da Hitchcock e da Truffaut.
5
Sul destino dei popoli si veda O. Spengler, Il tramonto dell’Occidente (1918), Milano, Longanesi, 2008. 6 7
La vetrina appare come luogo simbolico anche in M e Furia.
Si veda J. Lacan, La funzione dell’immaginario nella formazione del Sé, in Id., Scritti (1966), Torino, Einaudi, 1974. 8
Il testo è riprodotto nel catalogo a cura di Bertetto, Eisenschitz, Fritz Lang. La messa in scena, cit., p. 452.
9
F. Lang, Kitsch Sensation Kultur und Film (1924), ora tradotto in italiano in Bertetto, Eisenschitz (a cura di), Fritz Lang. La messa in scena, cit., pp. 163-166. 10
G. Deleuze, F. Guattari, Che cos’è la filosofia? (1991), Torino, Einaudi, 1996. 11
12
Bertetto, Eisenschitz (a cura di), Fritz Lang. La messa in scena, cit.
13
Deleuze, Guattari, Che cos’è la filosofia? cit.
14
A. Eibel, Fritz Lang, Paris, Klincksieck, 2017, p. 75.
15
Ibid., p. 31.
Sull’ipnosi in Lang cfr. R. Bellour, Le corps du cinéma, Paris, POL, 2009, pp. 361-371.
16
Stilwille im Film è non a caso il titolo di uno dei primi articoli di Lang, comparso in «Jugend», n. 3, 1924. 17
Si veda il catalogo: Bertetto, Eisenschitz (a cura di), Fritz Lang. La messa in scena, cit., con l’elenco dei materiali della Cinémathèque française, dati da Lang a Lotte Eisner. E si veda anche Bertetto, Otto Hunte. Entwurfe für “Die Nibelungen”, cit. 18
Scrive Lang: «Nel mio primo film sui Nibelunghi – Siegfried – ho cercato di risolvere questo problema, la messa in scena delle masse, usando un numero relativamente piccolo di comparse e facendole restare rigide, quasi un elemento decorativo messo dietro gli interpreti principali, un fondale vivo però immobile: infatti in Sigfried la massa non recita, ma è quasi un oggetto» (F. Lang, Aufgelöste Massen, in «De Film-Gids», 2 aprile 1924).
19
S.M. Ėjzenštejn, Za kadrom (Fuori campo), postfazione a N. Kaufman, Japonskoe Kino, Moskva, Teakinopečat, 1929 (trad. it. in Id., Il montaggio, Venezia, Marsilio, 1986). In un saggio del 1933, intitolato Nell’interesse della forma (in «Kino», 12 novembre 1932, trad. it. in «Bianco e nero», 7/8, 1971), Ėjzenštejn scrive: «Idea, ion. 1) aspetto, apparenza; 2) forma, genere, modo, proprietà, qualità…; in particolare: modo di esposizione, forma e genere di discorso; 3) idea, prototipo, ideale. Ricordiamo ancora una volta l’indissolubilità genetica di… idea (n. 3), modo di esposizione (n. 20
2), aspetto (n. 1)». Sull’immagine eidetica si veda P. Bertetto, Lo specchio e il simuacro. Il cinema nel mondo diventato favola, Milano, Bompiani, 2007. Anita Trivelli Il dottor Mabuse K. Pinthus, Il dottor Mabuse, in M. Sesti (a cura di), Fritz Lang, Edizioni Carte Segrete/Comune di Roma 1990, p. 47. 1
Le due parti del film del 1922 furono presentate al pubblico a un mese di distanza l’una dall’altra. Undici anni dopo Lang realizzò il sequel Il testamento del dottor Mabuse (Das Testament des Dr. Mabuse, 1933). Tra il 1961 e il 1964 furono realizzati altri cinque film con Mabuse protagonista, interpretato dallo stesso attore, Wolfgang Preiss. Nel 1990 Chabrol realizzò Doctor M, omaggio ai cento anni della nascita di Lang e alla riunificazione della Germania, dove compare Preiss in un cameo. L’interprete del primo Mabuse è Rudolf Klein-Rogge, l’attore langhiano per eccellenza e allora marito di Thea von Harbou, con la quale Lang co-sceneggiò il film e che sposerà in seconde nozze. Klein-Rogge reciterà nello stesso ruolo del citato sequel del 1933, censurato dal regime hitleriano. Per il lavoro di direzione degli attori di Lang cfr. L. Moullet, Fritz Lang, in P. Bertetto (a cura di), Azione! Come i grandi registi dirigono gli attori, Roma, minimum fax, 2007, pp. 83-94. 2
F. Lang, Kitsch - sensazione - cultura e cinema (1924), in P. Bertetto, B. Eisenschitz (a cura di), Fritz Lang. La messa in scena, Torino, Lindau, 1993, p. 164.
3
S. Kracauer, Il cinema tedesco dal “Gabinetto del Dr. Caligari” a Hitler, Milano, Mondadori, 1977, p. 104. Sempre Kracauer osserva che Mabuse «ha avuto origine nella mentalità del ceto medio» (ibid.). 4
G. Corni, Weimar. La Germania dal 1918 al 1933, Roma, Carocci, 2020, pp. 91-95.
5
Ibid., pp. 93-95 (la citazione di Corni si riferisce a M. Stibbe, Germany 1914-1933. Politics, Society and Culture, London, Longman, 2010; i corsivi sono miei). L’epoca weimeriana è rievocata dalla serie televisiva tedesca neo-noir Babylon Berlin (2017-), creata, scritta e diretta da Tom Tykwer, Achim von Borries e Hendrik Handloegten e ispirata ai romanzi di Volker Kutscher (la serie di Gereon Rath), dalla chiara matrice langhiana sia nell’opera letteraria che in quella televisiva. 6
Il romanzo ebbe molto successo e forse fu von Harbou, amica dell’autore, a favorirne il contatto con Lang. Presentando il film, Jacques aveva scritto che «Mabuse è la personificazione di oscure e selvagge pulsioni, che devono essere vinte affinché Mabuse possa diventare Sigfrido» (F. Bono, Germania 1, in Sesti [a cura di], Fritz Lang, cit., p. 24). L’adattamento eliminò i monologhi dei personaggi letterari e la sottotrama sul desiderio di Mabuse di crearsi un proprio paese in Sudamerica; aggiunse l’abilità di Mabuse come falsario e il dispiegamento delle carte nelle sue mani all’inizio del film (scena probabilmente ispirata dal serial Fantômas del 1913 di Feuillade); cambiò il finale: nel romanzo Mabuse veniva ucciso su un aereo in volo in uno scontro a fuoco con le forze dell’ordine, nel film impazzirà a seguito dello scacco totale delle sue imprese criminali. 7
8
L. Eisner, Fritz Lang (1976), Milano, Mazzotta, 1978, p. 339.
P.G. Tone, Strutture e forme del cinema tedesco degli anni Venti, Milano, Mursia, 1978, p. 52. Il film costò 15 milioni di marchi, fu girato in diciassette
9
settimane e diviso in due parti: Dr. Mabuse, der Spieler. Erster Teil: Der große Spieler. Ein Bild der Zeit (Il dottor Mabuse. Parte I: Il grande giocatore. Un quadro dell’epoca) e Dr. Mabuse, der Spieler. Zweiter Teil: Inferno. Ein Spiel von Menschen unserer Zeit (Il dottor Mabuse. Parte II: Nell’inferno del crimine. Uomini d’epoca). Produzione: Uco-Film der DeclaBioscop (produttore Erich Pommer); distribuzione: Universum Film Aktiengesellschaft (UFA); première all’UFA-Palast am Zoo di Berlino il 27 aprile (I parte) e il 26 maggio (II parte) 1922. Le due parti sono composte ciascuna di sei atti. Sotto la direzione di Erich Pommer, la Decla-Bioscop era diventata la più dinamica delle società cinematografiche tedesche di primo Novecento. Nel 1921 la UFA assorbì la Decla-Bioscop, della quale tuttavia restò attiva una unità di produzione separata sotto l’egida di Pommer. Nata a Babelsberg (quartiere di Potsdam), la UFA vantava gli studios più moderni d’Europa e fu fucina di importanti maestranze e cineasti (come l’allora scenografo Hitchcock, che lavorò al fianco di Murnau e dello stesso Lang). Per approfondimenti sull’UFA cfr. T. Elsaesser, Il ruolo dell’UFA 1917-1933, in G. Spagnoletti (a cura di), Schermi germanici. UFA 1917-1933, Venezia, Marsilio, 1993, pp. 31-67. Nel volume figura anche un contributo di Paolo Bertetto sul rapporto tra tecnologia e cinema e stile di Lang: Lang e l’UFA. Le tecniche realizzative e la forma assoluta, pp. 157164. Eisner, Fritz Lang, cit., p. 15 (F. Lang, Discorso introduttivo all’inafferrabile, Università della California, Riverside, 28 giugno 1967). 10
Di attentati e omicidi il pubblico di quegli anni aveva una triste esperienza, se si pensa alla rivoluzione spartachista del 1919 e agli assassinii di Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Kurt Eisner, nello stesso anno, fino a quello del ministro degli Affari esteri Walter Rathenau, un mese dopo l’uscita del film. Del resto, riferisce Bertetto nel suo Microfilosofia del cinema (Venezia, Marsilio, 2014, p. 222), «secondo alcuni giornali dell’epoca, il film inizia con scene della guerra civile a Berlino provocata dalla rivolta dei socialisti indipendenti e degli spartachisti – sono immagini perdute che neanche il restauro è riuscito a recuperare, ma che presentano subito Berlino come metropoli del conflitto e della violenza». 11
Siegfried Kracauer (Il cinema tedesco, cit., p. 88) identifica l’elemento che accomuna il Dr. Mabuse ad altri film dell’epoca weimeriana (Vanina, 1922, Il Gabinetto delle figure di cera, 1924 ecc.) nel simbolismo di scene che si addentrano nella natura del potere tirannico. 12
Nel libro Cultura e cinema nella Repubblica di Weimar (a cura di G. Grignaffini e L. Quaresima, Venezia, Marsilio, 1978), gli interventi di E. Collotti, Crisi della socialdemocrazia, e F. Masini, Ideologia borghese e critica della cultura, riflettono sulle cause che favorirono l’ascesa del nazionalsocialismo, sottolineando come il vivace rinnovamento culturale della stagione weimeriana non trovò interlocutori adeguati nel mondo politico e sociale. 13
P. Bertetto, Fritz Lang Metropolis, Torino, Lindau, 1990, pp. 105-106. Eisenschitz osserva che in Lang il «rifiuto di essere classificato come espressionista […] corrisponde alla volontà spesso affermata» di non avere alcuno stile, «di dedurre la sua narrazione dalle esigenze della storia da raccontare» (Bertetto, Eisenschitz [a cura di], Fritz Lang. La messa in scena, cit., p. 21). Per un riesame della nozione di film espressionista si rinvia a due saggi di Leonardo Quaresima: Der Expressionismus als Filmgattung, in U. Jung, W. Schatzberg (a cura di), Filmkultur zur Zeit der 14
Weimarer Republik, München-London-New York-Paris, Saur, 1992, e Il cinema espressionista come “angewandte Kunst”, in S. Barron, W.D. Dube (a cura di), Espressionismo tedesco: arte e società, Milano, Bompiani, 1997. Senza dimenticare il classico di R. Kurtz, del 1926, Il cinema espressionista, Milano, Longanesi, 1981. La rilevanza del motivo del gioco negli studi in lingua tedesca nei primi decenni del Novecento è confermata anche dal lavoro sul tema svolto dallo storico e linguista olandese Johan Huizinga, che copre i primi quaranta anni del secolo: Homo ludens, iniziato nel 1903 e pubblicato nel 1939, inviso ai nazisti. Huizinga assegna alla parola Spiel una qualità “ludica” che vediamo estranea a Mabuse, il quale, da questo punto di vista, è un falso giocatore, un «guasta-gioco» per usare il termine di Huizinga, in cui Hitler deve essersi identificato. 15
Paolo Bertetto (Microfilosofia del cinema, cit., p. 222) riferisce dello spostamento dell’ambientazione narrativa da Monaco (nel romanzo) a Berlino (nel film). Lang lascia indefinita la città, come l’identità del protagonista. Siegfried Kracauer (Il cinema tedesco, cit., p. 103) ricorda che il regista dichiarò «che la sua intenzione era di rappresentare la società intera con Mabuse presente ovunque ma in nessun luogo riconoscibile […] una onnipresente minaccia». 16
Il fatto che Mabuse sia un dottore psicanalista è un elemento importante per il Bild der Zeit langhiano, ed è comune ad altri film cardine del periodo (si pensi a Il gabinetto del dottor Caligari di Robert Wiene, 1920). Del resto, non sembra casuale che ne Il testamento del dottor Mabuse la persona scelta da Mabuse per proseguire la sua opera criminale dal manicomio in cui è rinchiuso sia proprio lo psicanalista che della clinica è il direttore. Inoltre, nell’immediato primo dopoguerra, la pratica dell’ipnosi era piuttosto diffusa sia in ambito medico-sanitario (per trattare i traumi dei reduci), sia come evento spettacolare correlato alla telepatia e alla magia. Per questi temi nel Mabuse si vedano gli studi di: Bertetto, Microfilosofia del cinema, cit.; R. Bellour, L’ipnosi-cinema, pp. 57-80, e R. Eugeni, «Capitargli sotto gli occhi»: ipnosi, sguardo e potere in Svengali di A. Mayo, pp. 157-169, entrambi in L. Albano, V. Pravadelli (a cura di), Cinema e psicoanalisi. Tra cinema classico e nuove tecnologie, Macerata, Quodlibet, 2008. 17
Il padre del regista, Anton Lang, era architetto comunale, e nel cinema langhiano l’architettura assume un duplice ruolo funzionale: alla struttura delle immagini e alla costruzione diegetica. Del resto, come è stato notato, esiste un’affinità tra il pensiero e le opere architettoniche di Adolf Loos e il lavoro di Lang. L’eredità dell’architetto austriaco, e della più ampia tradizione culturale e intellettuale viennese, è l’aspirazione condivisa a un’arte essenziale. E la capacità proiettiva del regista rifunzionalizza nei suoi film il proprio immaginario architettonico ricorrendo ad ambienti congestionati e costrittivi, contrappuntati dal costante tentativo di fuga dei personaggi che si sentono o sono effettivamente intrappolati. Cfr. L. Laufer Lupino, Adolf Loos e Fritz Lang. Lo spazio dell’angoscia, in «Cinema Sessanta», nn. 5-6, settembre- dicembre 1989. 18
Paolo Bertetto (Fritz Lang, cit., pp. 75 e 80-82) riconduce il «sincretismo architettonico» di Lang al rapporto tra la sua Weltanschauung e la «geometrizzazione» degli elementi spaziali. La matrice architettonica dello stile di Lang è ulteriormente indagata dallo studioso nel suo saggio La volontà di stile e le sue forme, in Bertetto, Eisenschitz (a cura di), Fritz Lang. La messa in scena, cit. Per approfondimenti recenti di Bertetto sul 19
Lang del periodo tedesco si rinvia ai seguenti capitoli: Dr. Mabuse e M. Il superuomo bipolare e il soggetto parafrenico, nel citato Microfilosofia del cinema; e Lang, la volontà di stile e l’intensità, in Id., Il cinema e l’estetica dell’intensità, Milano-Udine, Mimesis, 2016. Cresciuto nel cuore della Mitteleuropa, Lang ha metabolizzato le sue esperienze formative e di vita in «una singolare mescolanza di romanticismo, simbolismo e decadentismo». Pittore, scultore, attore, poliglotta, viaggiatore, collezionista, soldato, patriota e dandy con il monocolo, Lang è «un lucido bohémien, senza troppe illusioni, […] [un] Wilhem Meister e perdigiorno nello stile di von Eichendorff […], incuneato fra Goethe e D’Annunzio, […] [che] non ama l’alta letteratura, anzi mostra subito di prediligere il feuilleton, la narrazione a effetto, gli eroi popolari, le ragazze dei Kabaret e dei bistrot» (S. Socci, Fritz Lang, Milano, Il Castoro, 1995, p. 13). 20
Un riferimento alla cultura cinese come a un mondo sconosciuto e inquietante è al Palais Andalusia, quando Mabuse cercherà di ipnotizzare il procuratore von Wenk con “occhiali cinesi” e le parole «Tsi-Nan-Fu» (che torneranno nella scena dell’ipnosi all’Auditorium). La fascinazione per l’orientalismo fu coltivata tanto da Lang quanto da von Harbou. Tsi-Nan-Fu (oggi Jinan) è la capitale della Provincia dello Shandong, dal patrimonio culturale taoista e confuciano, che fu colonia della Germania imperiale dal 1897 al 1919. Per la funzione intimidatoria dello sguardo fisso e il suo rafforzamento dovuto agli occhiali cfr. il libro dello zoologo D. Morris, La scimmia nuda. Studio zoologico sull’animale uomo, Milano, Bompiani, 1968. 21
Sandor è un nome di origine ungherese che significa “protettore degli uomini”, mentre Weltmann è traducibile come “uomo di mondo” (in tedesco Welt significa “mondo” e Mann “uomo”). Il nome e il cognome di questa ennesima, fortunata mascherata di Mabuse indicano la pungente consapevolezza di Lang del delirio d’onnipotenza del suo protagonista, che ha presa sul pubblico perché fa leva sulla credulità e suggestionabilità della massa. Anche in questo è evidente la riflessione del cineasta sulla sua arte. 22
T. Gunning, The Films of Fritz Lang: Allegories of Vision and Modernity, London, BFI, 2000, p. 100. Lo studioso spiega che i bigliettini da visita con fotografia, introdotti nell’Ottocento per lo scambio tra amici e parenti, furono in seguito adottati anche nel mondo dello spettacolo, specialmente per i ritratti di famosi attori teatrali, e già negli anni dieci del Novecento servivano a promuovere le star del cinema. 23
24
Ibid.; il termine avatar per i diversi ruoli di Mabuse è sempre di Gunning.
Di Mabuse, Bertetto (Fritz Lang, cit.) sottolinea la facoltà ipnotica in quanto elemento autoriflessivo del film. Il fondamento fascinatorio del cinema è ulteriormente argomentato dallo studioso in una successiva riflessione sulla qualità metacinematografica de Il dottor Mabuse (cfr. Id., Lo specchio e il simulacro. Il cinema nel mondo diventato favola, Milano, Bompiani, 2007). E sul protagonista del film langhiano, è ancora Bertetto a osservare che si tratta di «un personaggio fronesico; da fronesis, che è pensiero e sentimento insieme», e che «Mabuse è una proiezione di Lang, è il modo in cui Lang diventa la potenza del cinema. […] Sono l’uno il personaggio concettuale dell’altro. All’infinito» (Id., Microfilosofia del cinema, cit., pp. 228 e 231). 25
T. Elsaesser, Fritz Lang: storia di due deviazioni, in Bertetto, Eisenschitz (a cura di), Fritz Lang. La messa in scena, cit., p. 195. Nel medesimo libro, 26
sul motivo del potere Jean Douchet (La tragedia dell’eroe langhiano, pp. 303-309) aggiunge: «Soltanto la volontà appassiona l’eroe langhiano. Volontà di potenza […] “possedere” – nel senso magico, demoniaco del termine – la volontà e la mente altrui». Volontà riconducibile per Bertetto «a un personaggio concettuale nietzscheano» (id., Microfilosofia del cinema, cit., p. 224). Anche per Lang Mabuse era «un figlio di Nietzsche» (Bono, Germania 1, cit., p. 24). 27
Socci, Fritz Lang, cit., p. 25.
Nel sequel del 1933 ritroviamo infatti Mabuse internato in un manicomio criminale, dove morirà, anche se lì riprende per interposta persona la sua attività criminale. 28
Lo scontro tra la banda di Mabuse asserragliata nel suo appartamento e le forze dello Stato ha funzionato da modello per i successivi film di gangster statunitensi (Scarface di Hawks, in particolare), come osserva Gunning, sottolineando anche il forte riferimento di quelle scene al contesto tedesco (Id., Fritz Lang, cit., p. 113). Quanto a von Wenck, Kracauer lo descrive come «una specie di gangster legale, con la polizia che gli serve da banda», aggiungendo che il film «evitava di riconoscere una superiorità morale ai rappresentanti della legge» (Id., Il cinema tedesco, cit., pp. 104 e 186-187). Su questo personaggio si veda anche Bertetto, Microfilosofia del cinema, cit., p. 228. 29
R. Bellour, Doppia visione, in Bertetto, Eisenschitz (a cura di), Fritz Lang. La messa in scena, cit., pp. 467-468.
30
Lo studio del film è stato condotto sulla seguente versione originale: Fritz Lang, Dr Mabuse, der Spieler, visionabile su Youtube (www.yousubtitles.com/…), con didascalie originali in tedesco e sottotitoli in inglese; e con confronti con la versione italiana Il dottor Mabuse, DVD Ermitage Cinema 2003 (due dischi, doppiato in italiano), e con quella francese Dr. Mabuse, le joueur, DVD RDM Edition 2012 (due dischi, didascalie originali in tedesco e sottotitoli in francese). 31
32
Gunning, Fritz Lang, cit., p. 114.
Ibid., p. 116 (corsivi dell’autore. Le traduzioni in italiano sono di Anita Trivelli). 33
Paolo Bertetto Metropolis La documentazione su Metropolis è molto ampia. Si citano qui solo i testi legati alla produzione del film e al restauro. L’«UFA Magazine», numero speciale Metropolis, del 1927 contiene immagini e testi di Lang, Thea von Harbou, Freund, Klein-Rogge, Frolich e altri, nonché materiali sulla realizzazione di alcune sequenze. Un secondo fascicolo è pubblicato ancora nel 1927 a cura della Parufamet. Per i testi di Lang sulla regia e su Metropolis si vedano in particolare l’ampio e documentato catalogo con bibliografia F. Latell, W. Sudendorf (a cura di), Fritz Langs Metropolis, Berlin, Stiftung Deutsche Kinemathek, 2010, e F. Lang, Trois lumières. Écrits sur le cinéma, a cura di A. Eibel, Paris, Ramsay, 2007. Si veda anche il romanzo di Thea von Harbou, Metropolis, Berlin, Scherl, 1926, che è posteriore alla sceneggiatura e ha vari punti di divergenza dal film. Sul restauro si veda la brochure Metropolis edita dal Münchner Filmuseum (1988) e la documentazione fornita in video con le versioni degli ultimi due restauri. Documenti molto interessanti sono a Berlino, alla Stiftung
1
Deutsche Kinemathek e a Francoforte, al Deutsches Filmmuseum. Si veda anche il volume su Hunte, scenografo di Lang: A. Arns, H.P. Reichmann (a cura di), Otto Hunte: Architekt für den Film, Frankfurt am Main, Deutsches Filmmuseum, 1996. Sull’eidetico si veda P. Bertetto, Lo specchio e il simulacro. Il cinema nel mondo diventato favola, Milano, Bompiani, 2007. E si veda anche Ėjzenštejn, citato nel saggio introduttivo; G. Deleuze, L’immagine-tempo (1985), Milano, Ubulibri, 1989, e R. Arnheim, Il pensiero visivo (1969), Torino, Einaudi, 1974. Sui problemi affrontati nell’analisi del film si vedano in particolare P. Bertetto, Fritz Lang Metropolis, Torino, Lindau, 1990 (4a ed. ampliata 2007); T. Elsaesser, Metropolis, London, BFI, 2000; T. Gunning, The Film of Fritz Lang. Allegories of Vision and Modernity, London, BFI, 2000; J. McElhaney (a cura di), A Companion to Fritz Lang, Oxford, John Wiley & Sons, 2015. Si vedano anche sull’iconografia langhiana H. Weihsmann, Gebaute Illusionen. Architektur im Film, Wien, Promedia, 1988; H. Schönemann, Fritz Lang. Filmbilder Vorbilder, Berlin, Potsdam Museum-Hentrich, 1992; D. Neumann, Film Architectures: Set Designs from Metropolis to Blade Runner, New York, Prestel, 1999. E sulla metropoli moderna cfr. gli ampi volumi di W. Benjamin, I «passages» di Parigi (19271940), Torino, Einaudi, 2000, e G. Simmel, La metropoli e la vita dello spirito (1903), Roma, Armando Editore, 1995. Sulla macchina in Metropolis, invece, si veda A. Huyssen, The Vamp and the Machine, in «New German Critique», nn. 23-24, 1981-1982. E sui nodi sul rapporto uomo-macchina nel marxismo, K. Marx, Il Capitale (1867, 1885, 1894), Roma, Ed. Riuniti, 1992; G. Lukàcs, Storia e coscienza di classe (1923), Milano, Sugar, 1974. Sul modello visivo si veda W. Worringer, Astrazione e empatia (1908), Torino, Einaudi, 2008. Sull’idea di spazio faustiano si veda O. Spengler, Il tramonto dell’Occidente (1918), Milano, Longanesi, 2008. Sul montaggio in opposizione al modello langhiano cfr. S.M. Ėjzenštejn, La Forma del film (1929), Torino, Einaudi, 1964.
2
S. Ėjzenštejn, Il principio cinematografico e l’ideogramma (1929), in Id., La forma cinematografica (1949), Torino, Einaudi, 1986, p. 32.
3
M. Foucault, La prose d’Actéon, trad. it. in Id., Scritti letterari, Milano, Feltrinelli, 1971, p. 91; G. Deleuze, Differenza e ripetizione (1968), Bologna, il Mulino, 1971, p. 207. 4
In Lang compaiono alcuni personaggi di Superuomo negativo. Ad esempio Lio Sha, che invero è una donna di eccezionali capacità, a capo di una rete di gangster in Die Spinnen (1919) e naturalmente il dottor Mabuse, che è un soggetto dotato di capacità eccezionali e che esplicita la sua contiguità con il pensiero di Nietzsche affermando – in una didascalia – che nella vita conta soltanto la «Wille zur Macht», la volontà di potenza (F.W. Nietzsche, La volontà di potenza [1901], Milano, Bompiani, 2001). In Metropolis Fredersen ha aspetti del Superuomo negativo, parzialmente limitati dal riscatto finale. Thea von Harbou sceneggiatrice di Ingratitudine (Der Herrscher) nel 1937, realizzato da Harlan, costruirà un modello di Superuomo (positivo) che si afferma aderendo al progetto sociale e razziale nazista. E in L’inafferrabile (Spione, 1928) anche Haghi ha aspetti superomistici. Ma come si è detto il modello del Superuomo è una versione popolare e ideologica dell’Oltreuomo nietzschiano. Va rammentato che Mabuse è legato ad aspetti semiti e connesso ai moti spartachisti. E che Haghi nella mente di Lang e von Harbou è più ispirato a Lenin e Trotzkij che ai dittatori di destra. Sul capro espiatorio come elemento per produrre 5
equilibrio nel sistema sociale cfr. R. Girard, Il capro espiatorio (1982), Milano, Adelphi, 1987. Nel film è predisposta un’onomastica di indubbio interesse. Oltre a Fredersen, che suona come figlio di Freder, mentre ne è il padre, sono significativi naturalmente i nomi di Maria e di Josaphat che rinviano ai Vangeli, ovviamente, e che con Freder sembrano costituire la sacra famiglia. Il nome di Freder è legato ad amico e a libertà. Ed è curioso anche il numero dell’operaio Georgy che scambia la propria vita con quella di Freder: 11811 un numero “palindromo” che si legge da sinistra e da destra. 6
La figura della madre è stata naturalmente studiata con riflessioni molto acute dalla Feminist Film Theory. Si vedano in particolare E. A. Kaplan, Motherhood and Representation, New York, Routledge, 1992, e P. Petro, Joyless Streets. Women and Melodramatic Representation in Weimar Germany, Princeton, Princeton University Press, 1988. Di indubbio interesse è poi la riflessione psicanalitica di R. Dadoun, Metropolis: MotherCity - “Mittler” - Hitler, in «Camera Obscura», n. 15, autunno 1986. 7
Paolo Bertetto M Il titolo italiano è M - Il mostro di Düsseldorf, un titolo scelto per sfruttare l’ondata di interesse mediatico per un assassino seriale di Düsseldorf, Kurten. Ma gli elementi narrativi del film rinviano piuttosto a una grande città come Berlino. E quindi citare il titolo italiano diventa fuorviante. 1
Su M e il cinema di Fritz Lang, si vedano tra i molti saggi, N. Burch, De “Mabuse” à “M” le travail de Fritz Lang, in D. Noguez (a cura di), Cinéma, Théorie, lectures, «Revue d’Esthétique», numero monografico, 1973; A. Kaes, M, London, BFI, 1999; e i libri citati nel saggio introduttivo, nota 1. Sugli aspetti psicologici, storici e ideologici di M si veda il mio Microfilosofia de cinema, Venezia, Marsilio, 2014, pp. 221-248. Della «camera scatenata» di Freund parla Stefan Lorant in Die entfesselte Kamera, in «Illustrierte Fim-Zeitung», 17 marzo 1927. Karl Freund parla di «camera in movimento continuo» in A Tribute for Carl Mayer, London, s.n., 1947. I testi sono riportati in L. Berriatua, Los proverbios chinos de F.W. Murnau, Madrid, Filmoteca Espanola, 1991. 2
Sulla Cosa nell’orizzonte filmico, si veda S. Zižek, L’universo di Hitchcock, Milano, Mimesis, 2007. 3
Sulla nozione di eidetico, si veda P. Bertetto, Lo specchio e il simulacro. Il cinema nel mondo diventato favola, Milano, Bompiani, 2007. 4
Sul protagonista di M come personaggio concettuale, si veda Bertetto, Microfilosofia del cinema, cit. 5 6
Si veda Kaes, M, cit., molto efficace nella ricostruzione del contesto.
B. Balázs, L’uomo visibile (1924), Torino, Lindau, 2008. Fondamentale è poi J. Aumont, Du visage au cinéma, Paris, ed. de l’Etoile, 1993. 7
Sulle dinamiche dello sguardo nel Lang muto, si veda il saggio introduttivo. 8
Lang ostacola l’identificazione con il personaggio dell’investigatore, il commissario della Kriminalpolizei Lohmann, con un atteggiamento che è all’opposto di quello delle detective stories americane. Lohmann, infatti, non viene raccontato come un detective interessante che lo spettatore può 9
amare, a differenza dei personaggi dei grandi noir americani interpretati da Humphrey Bogart, Robert Mitchum e via di seguito. Al contrario è un personaggio non particolarmente attraente dal punto di vista fisico, ed è intenzionalmente costruito da Lang come una figura a volte anche sgradevole. Non a caso nel film si vede un’immagine francamente poco raffinata (e quindi poco langhiana): un’inquadratura di Lohmann dal basso, in cui noi vediamo le gambe leggermente aperte e la pancia prominente. Si tratta di un’immagine che sottolinea la concretezza di Lohmann, il suo essere un individuo poco gradevole, un vecchio e un po’ grasso ispettore della polizia (di Berlino presumibilmente), ripreso in contre-plongée per sottolineare gli aspetti anche grevi, un po’ volgari, della sua personalità. Sono tutti elementi intenzionalmente delineati per rendere difficile l’identificazione dello spettatore con la figura dell’investigatore. Si veda P. McGilligan, Fritz Lang: The Nature of the Beast, London, Faber and Faber, 1997. La morte della prima moglie di Lang, Lisa Rosenthal, è evocata anche in un mio romanzo, Autunno a Berlino, Milano, Piemme, 2011. 10
Sulla configurazione psichica del personaggio si vedano R. Dadoun, Le pouvoir et sa folie (d’après M le maudit), in «Positif», n. 188, 1976; Bertetto, Microfilosofia del cinema, cit., cap. Dr. Mabuse e M. Il superuomo bipolare e il soggetto parafrenico, che interpreta il protagonista attraverso Freud e soprattutto Melanie Klein. È Freud a usare il termine parafrenico per definire esperienze psichiche che uniscono determinazioni paranoidi e schizoidi. Sulla posizione paranoica e schizoide si vadano anche le ricerche di Melanie Klein. Cfr. in particolare S. Freud, Osservazioni psicoanalitiche su un caso di paranoia descritto in note autobiografiche: Presidente Schreber (1911), in Id., Casi clinici, Torino, Boringhieri, 1952; Id., Introduzione al narcisismo (1914), Torino, Boringhieri, 1976; M. Klein, La psicoanalisi dei bambini (1932), Firenze, Martinelli, 1988. 11
Anita Trivelli, Arianna Vergari Altri film a Berlino I paragrafi dedicati a Destino, I Nibelunghi, L’inafferrabile sono di Anita Trivelli, e il paragrafo su Il testamento del dottor Mabuse è di Arianna Vergari. 1
Jacques Aumont Duello mortale Rogue male è un’espressione cinegetica che designa un maschio solitario particolarmente pericoloso (ad esempio un cinghiale o un elefante ecc.); il titolo viene evocato nel romanzo nel momento in cui l’eroe si rifugia nella sua tana (scavata nel terreno) e si definisce «rogue male». Questo era anche il nome di un gruppo hard rock (metal) irlandese attivo intorno al 1985, il cui album si intitolava significativamente Animal Man. 1
Furthman era stato lo sceneggiatore di Avventurieri dell’aria (Only Angels Have Wings, 1939) e sarebbe stato quello di I misteri di Shanghai (The Shanghai Gesture, 1941) e Acque del Sud (To Have and Have Not, 1944). Dopo Susanna! (Bringing Up Baby, 1938), Nichols aveva lavorato con Ford in Ombre rosse (Stagecoach, 1939) e Lungo viaggio di ritorno (The Long Voyage Home, 1940). 2
Bernard Eisenschitz, nel suo seminale e approfondito studio su questo film, nota che Lang non esitava a contraddirsi a seconda dell’interlocutore 3
che aveva davanti e della situazione in cui si trovava. (B. Eisenschitz, Man Hunt de Fritz Lang, Crisnée, Yellow Now, 1992, p. 75). «Ho sempre trovato più interessante mostrare, come in una partita a scacchi, mossa dopo mossa, i movimenti di due avversari […]. Ma questo duello mentale, in senso vero e proprio, di due cervelli, richiede forse di essere trattato in termini psicologici? Ho forti dubbi in proposito…» (lettera di Lang citata e commentata da Eisenschitz, Man Hunt de Fritz Lang, cit., pp. 49-50). 4
Pericolosa partita è il film da cui Duello mortale cita quasi letteralmente l’episodio della caccia all’uomo con i cani al guinzaglio. Per la cronaca, durante le riprese di questa scena è stato Lang a fare il verso dei cani, suscitando lo stupore dell’addetto al missaggio.
5
Per accogliere la richiesta, cauta, di Zanuck, Lang dovette aggiungere una macchina da cucire nell’appartamento di Jerry, oggetto che viene portato in primo piano dal fatto che Walter Pidgeon lo tocca ripetutamente, quasi lo accarezza. 6
Queste foto e lo storyboard furono (insieme ad altri documenti) depositati da Fritz Lang presso la Cinémathèque française; ora si trovano nella Bibliothèque du Film di Parigi. 7
Si può, d’altra parte, trovare un po’ curioso che Zanuck abbia approvato espressamente questo modo di fare nella riunione di pre-produzione del 4 febbraio 1941. Forse questo dialogo è sottotitolato in inglese nelle copie distribuite negli Stati Uniti, cosa che non ho potuto verificare. 8
Lang aveva suggerito di aggiungere alla sceneggiatura la battuta di Quive-Smith: «Some of our best agents are at Scotland Yard», battuta che alla fine non è stata mantenuta (e sicuramente avrebbe indebolito, rendendola esplicita, la sensazione di oppressione e fatalità provata di fronte alla proliferazione e alla comparsa repentina dei nazisti). 9
Da Metropolis (1927) al dittico indiano, è noto l’interesse di Lang per il meticciato (forse in parte per ragioni biografiche). Il suo primo film come regista si intitola Halbblut (1919, letteralmente “mezzosangue”). 10
Da notare che Zanuck, da produttore attento, si dice d’accordo con questa idea, ma chiede che si “copra”, girando anche le corrispondenti inquadrature di Quive-Smith e lasciando la decisione ai montatori. In effetti, nella versione finale del film, un montaggio alternato contrappone i due avversari, anche se i momenti dedicati a Thorndike sono molto più lunghi. 11
Questa particolare caratterizzazione dello spazio emerge anche dal romanzo, dove la scena è ugualmente importante e ancora più lunga: il rifugio dell’eroe è scavato nel terreno e l’ingresso è molto simile a quello della tana di una volpe. Le trattative con Quive-Smith durano diversi giorni, prima che il rogue male riesca a liberarsi in maniera simile a quanto accade nel film. 12
Se nel 1937 (data del romanzo) una simile pseudo-confessione era ancora un elemento plausibile, invece con l’invasione della Polonia e lo scoppio della guerra non aveva più alcun senso. Ciò può essere visto come una piccola debolezza nella sceneggiatura – ma d’altra parte, la verosimiglianza non è di certo il fulcro del film. 13
F. Grafe, E. Patalas, H. Prinzler, P. Syr, Fritz Lang, München, Carl Hanser Verlag, 1976, trad. francese, Paris, Rivages, 1985, p. 117. 14
15 Il fatto che il villain venga ucciso da una forte scossa elettrica non è forse del tutto irrilevante: in un certo senso è assimilabile a un’esecuzione sulla sedia elettrica (l’idea proviene dal romanzo).
Per capire l’importanza di questo progetto formale, si può confrontare Duello mortale con l’adattamento che nel 1976 la BBC produsse a partire dallo stesso romanzo, Rogue Male, per la regia di Clive Donner. Il bel Peter O’Toole interpreta, in maniera più realistica di Walter Pidgeon, un ricco gentiluomo, e nel complesso la verosimiglianza di questa versione è decisamente più marcata. La fuga dalla Germania è evocata tramite dettagli, si pensi alla scena della ritirata in una campagna inglese. Ciononostante, tutti questi dettagli pittoreschi non hanno necessariamente una potenza visiva (questo film è disponibile online al seguente link: youtube.com/…). 16
Vale la pena notare che durante le riprese venne usato lo stesso “trucco” sia nel caso del tunnel sotterraneo che per la presa d’aria nella parete della caverna. Arthur Miller, il direttore della fotografia, fece collocare del velluto nero in entrambi gli spazi, in un caso (la metropolitana) per accentuare la percezione di un abisso senza fondo, nell’altro per poter ottenere, tramite doppia esposizione, un’immagine nitida sia della superficie della roccia che del volto del tedesco (su quest’ultimo caso, si veda Eisenschitz, Man Hunt de Fritz Lang, cit., p. 79). 17
Le letture freudiane su questa scena non mancano, ma credo non colgano la questione essenziale. Ci vuole molta immaginazione per vedere qualche simbolo fallico in questa lama, o nella metropolitana che esce dal tunnel (ma è anche vero che, due decenni dopo, Hitchcock non esiterà a dare la stessa interpretazione all’ultima inquadratura del suo Intrigo Internazionale, North by Northwest, 1959). 18
Anche in questo caso, la sceneggiatura risulta più esplicita del film. Secondo quanto scritto, infatti, Thorndike, uscendo dal nascondiglio, fa un piccolo discorso a Vaner, il giovane mozzo, dicendogli quanto apprezzi l’aria aperta dopo aver trascorso del tempo in un simile buco. 19
Silvio Alovisio Dietro la porta chiusa Cfr. R. Aurich et al. (a cura di), Fritz Lang. Leben und Werk, Berlin, Jovis, 2001, p. 388.
1
Cfr. P. Bogdanovich, Il cinema secondo Fritz Lang (1967), Parma, Pratiche, 1988, pp. 64-65. 2
Per un approfondimento sulla produzione del film cfr. M. Bernstein, Fritz Lang, Incorporated, in «Velvet Light Trap», n. 22, 1986, pp. 41-52; P. McGilligan, Fritz Lang, London, Faber and Faber, 1997, pp. 352-374; e B. Eisenschitz, Fritz Lang au travail, Paris, Cahiers du cinéma, 2011, pp. 181185.
3
Il romanzo era stato poi edito in volume, in versione accresciuta, l’anno successivo con il titolo Museum Piece n. 13 (New York, Doubleday), trad. it. Camera chiusa n. 13, Milano, Garzanti, 1956. 4
5
Lang dovrà ricorrere in extremis all’aiuto di Bon Cormack, della Disney.
6
Cfr. Bogdanovich, Il cinema secondo Fritz Lang, cit., p. 64.
Per una valida introduzione e una bibliografia essenziale al female gothic cfr. M. Jancovich, Bluebeard’s Wives: Horror, Quality and the Gothic (or 7
Paranoid) Woman’s Film in the 1940s, in «The Irish Journal of Gothic and Horror Studies», n. 12, 2013, pp. 20-43. Cfr. K. Hollinger, Listening to The Female Voice in the Woman’s Film, in «Film Criticism», v. 16, n. 3, 1992, p. 46.
8
Ibid., p. 47. Sulla voce fuori campo nel woman movie esiste una bibliografia molto estesa e in costante aggiornamento di cui non è possibile rendere conto in questa sede. Si vedano almeno K. Silverman, The Acoustic Mirror, Bloomington, Indiana University Press, 1988; B. Sjorgen, Into the Vortex. Female Voice and Paradox in Film, Chicago, University of Illinois Press, 2010.
9
T. Gunning, The Films of Fritz Lang: Allegories of Vision and Modernity, London, BFI, 2000, p. 350. 10
S. Rybin, Joan Bennett, Fritz Lang, and the Frame of Performance, in J. McElhaney (a cura di), A Companion to Fritz Lang, Oxford, John Wiley & Sons, 2015, p. 351 (traduzione di S. Alovisio).
11
12
Gunning, The Films of Fritz Lang, cit., p. 351.
13
Cfr. Rybin, Joan Bennett, Fritz Lang, cit., pp. 351-356.
Secondo Humphries, il film suggerirebbe in modo indiretto che Celia soffra di disturbi mentali non meno gravi di quelli di Mark (cfr. R. Humphries, Fritz Lang. Cinéaste américain, Paris, Albatros, 1982, pp. 128-146). 14
15 Hollinger, Listening to The Female Voice in the Woman’s Film, cit., p. 47. Humpries ritiene che Celia provi per il fratello «sentimenti incestuosi» (Humphries, Fritz Lang. Cinéaste américain, cit., p. 129). 16
N. Simsolo, Fritz Lang, Paris, Edilig, 1985, p. 78.
Hollinger, Listening to The Female Voice in the Woman’s Film, cit., p. 45 (traduzione di S. Alovisio). 17
Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro VII. L’etica della psicoanalisi (1986), Torino, Einaudi, 1994, pp. 109-210. 18
19 Sui mondi chiusi di Lang cfr. L. Braudy, The World in a Frame, Chicago, University of Chicago, 2002, p. 52. 20
Gunning, The Films of Fritz Lang, cit., p. 325.
Cfr. C. Fujwara, Beyond a Reasonable Doubt and the Caesura, in McElhaney (a cura di), A Companion to Fritz Lang, cit., pp. 161-175. 21
Cfr. S. Jenkins, Fritz Lang. Fear and Desire, in Id. (a cura di), Fritz Lang. The Image and the Look, London, BFI, 1981, p. 106; M.A. Doane, The Desire to Desire. The Woman’s Film of the 1940s, Bloomington, Indiana University Press, 1987, pp. 150-151. 22
Hollinger, Listening to The Female Voice in the Woman’s Film, cit., pp. 46-48; Gunning, The Films of Fritz Lang, cit., pp. 359-361. 23
Richard Humpries considera l’inquadratura finale «profondamente ambigua». A suo avviso, inoltre, il fatto che Celia insista sul “noi” significa che «attraverso il contatto con Mark, lei finisce per capire che è nevrotica» (Humphries, Fritz Lang. Cinéaste américain, cit., p. 145; traduzione di S. Alovisio). 24
Raymond Bellour L’alibi era perfetto
J. Rivette, La main, in «Cahiers du cinéma», n. 79, novembre 1957; S. Daney, L’invraisemblable vérité, in «Libération», 18 luglio 1981, riportato in S. Daney (a cura di), Ciné journal: 1981-1986, Paris, Cahiers du cinéma, 1986.
1
J. Douchet, Dix-sept plans, in R. Bellour (a cura di), Le Cinéma américain. Analyses de films, Paris, Flammarion, 1980. 2
J-L. Comolli, F. Géré, Deux fictions de la haine, in «Cahiers du cinéma», n. 286, marzo 1978.
3
4
Rivette, La main, cit, p. 48.
Matteo Pollone Il periodo americano Cfr. E. Rohmer, Riscoprire l’America, in «Cahiers du cinéma», n. 54, 1955, in G. Grignaffini, La pelle e l’anima, Firenze, La casa Usher, 1984, p. 150. 1
Intervista riportata in A. Morsiani, Joseph L. Mankiewicz, Firenze, La Nuova Italia, 1991, p. 8. Il film a cui si fa riferimento è Giulietta e Romeo (Romeo and Juliet, 1936) di George Cukor, interpretato da Leslie Howard e Norma Shearer, moglie di Thalberg. 2
G. Fofi, Fritz Lang, in R. Bellour (a cura di), Il Western: fonti, forme, miti, registi, attori, filmografia, Milano, Feltrinelli, 1973, p. 304. 3
P. Bogdanovich, Fritz Lang, in Id., Chi ha fatto quel film? Conversazioni con i grandi registi di Hollywood, Roma, Fandango libri, 2010, p. 305.
4
5
L.H. Eisner, Fritz Lang (1976), Milano, Mazzotta, 1978, p. 157.
T. Gunning, The Films of Fritz Lang: Allegories of Vision and Modernity, London, BFI, 2000, p. 217 (traduzione di M. Pollone).
6
Ad esempio da N. Simsolo, nel suo Fritz Lang, Paris, Edilig, 1982, pp 5759. 7
«Non ricordo chi ha scritto il copione [Robert Carson, n.d.a.], ma ha dovuto aggiungere molte vicende, perché in realtà, durante la ricostruzione della linea telegrafica non è successo un bel niente, tranne che sono rimasti senza legno per i pali. […] Ho fatto molte ricerche, e ho scoperto che l’unico altro problema che hanno incontrato, è il prurito dei bisonti. Il bisonte sente prurito, si gratta contro il palo del telegrafo e il palo casca giù. Tutto qua. Naturalmente, nel film succedevano molte più cose, e molto più interessanti. E quando ho finito il film, ho scoperto che per stendere la linea telegrafica c’è voluta neanche la metà del tempo che abbiamo impiegato noi per le riprese!» (Bogdanovich, Fritz Lang, cit., p. 311). 8
Cfr. G. Gemünden, Brecht in Hollywood: Hangmen Also Die! and the AntiNazi Film, in «TDR/The Drama Review» n. 4, inverno 1999, pp. 65-76. 9
Ad esempio a Bogdanovich: «Brecht è, almeno sinora, il più grande talento tedesco di questo secolo» (Bogdanovich, Fritz Lang, cit., pp. 305306). 10
«L’ispirazione gli venne senza dubbio dall’Opera da tre soldi di Brecht e Weill, la cui musica innovativa, l’allestimento e le idee politiche erano ancora in grado di fornire brani da cabaret di successo. Sebbene Brecht (fuggito dal Terzo Reich e ora in esilio a Svendborg, in Danimarca) non abbia avuto nessun ruolo in questo film, You and Me rappresenta il punto più alto dell’influenza di Brecht su Lang, un film più “brechtiano”, direi, rispetto al film antinazista Anche i boia muoiono, al quale invece i due
11
collaborarono durante l’esilio hollywoodiano di Brecht» (Gunning, The Films of Fritz Lang, cit., p. 262). Questo aspetto, come ricorda Lotte Eisner, è uno di quelli che non trova d’accordo Brecht e Lang: «Brecht si lamenta che il film sugli ostaggi è una “triste confabulazione” pieno di fantasmi, intrighi e falsità, che si pone rigorosamente nel contesto di una ribellione borghese» (Eisner, Fritz Lang, cit., p. 198). 12
13
L. Gandini, Il film noir americano, Torino, Lindau, 2001, p. 68.
14
Ibid., p. 69.
H. Weihsmann, L’architettura della notte. Sogno o realtà? Note su The Woman in the Window, in P. Bertetto, B. Eisenchitz (a cura di), Fritz Lang. La messa in scena, Torino, Lindau, 1993, p. 291.
15
16
Gandini, Il film noir americano, cit., p. 75.
Cfr. M. Bernstein, A Tale of Three Cities: The Banning of Scarlet Street, in «Cinema Journal», n. 1, autunno 1995, p. 28 (traduzione di M. Pollone). 17
N. Simsolo, Cloack and Dagger, in Bertetto, Eisenchitz (a cura di), Fritz Lang. La messa in scena, cit., p. 317.
18
19
Eisner, Fritz Lang, cit., p. 252
20 G. Cremonini, G. De Marinis, Joseph Losey, Firenze, La Nuova Italia, 1981, p. 21. 21
Cfr. Bogdanovich, Fritz Lang, cit., p. 337.
22
Fofi, Fritz Lang, cit., p. 304.
«Il film era finito, e andai nell’ufficio della persona che mandava avanti lo studio per conto di Howard Hughes: credo fosse un alto dirigente della Hughes Tool Company. “Ah, Mr. Lang! Lei certo sa che Mr. Hughes ha cambiato il titolo del film.” Naturalmente io rabbrividii. “Cioè?” “Rancho Notorious.” “Ah. E perché?” “Perché Mr. Hughes pensa che in Europa non sappiano cosa vuol dire ‘Chuck-A-Luck’.” Risposi: “Ah-ha. E secondo lei sanno cosa vuol dire Rancho Notorious?”, e me ne andai» (Bogdanovich, Fritz Lang, cit., p. 339). 23
R. Wood, Rancho Notorious: a Noir Western in Colour, in «CineAction!», nn. 13-14, estate 1988, p. 85. 24 25
Gunning, The Films of Fritz Lang, cit., p. 393 (traduzione di M. Pollone).
26
Ibid. (traduzione di M. Pollone).
27
Cfr. Simsolo, Fritz Lang, cit., pp. 101-109.
E.A. Kaplan, The Place of Women in Fritz Lang’s The Blue Gardenia, in Id. (a cura di), Women in Film Noir, London, BFI, 1998, pp. 81-88. 28
J. Bergstrom, Il mistero di The Blue Gardenia, in Bertetto, Eisenchitz (a cura di), Fritz Lang. La messa in scena, cit., p. 397. 29
P. McGilligan, Fritz Lang: The Nature of the Beast, London, Faber and Faber, 1997, p. 382. 30 31
Cfr. C. McArthur, The Big Heat, London, BFI, 1992.
32
Gunning, The Films of Fritz Lang, cit., p. 432 (traduzione di M. Pollone).
R. Bellour, Psicosi, nevrosi, perversione, in Id., L’analisi del film (1979), Torino, Kaplan, 2005, p. 245.
33
34
Il film è uscito in Italia con il titolo L’angelo del male.
A. Sarris, The American Cinema: Directors and Directions, 1929-1968, New York, Dutton & Co., 1968, p. 64 (traduzione di M. Pollone). 35 36
Bogdanovich, Fritz Lang, cit., p. 360.
P. Brion, Moonfleet. Il capolavoro maledetto, in Bertetto, Eisenchitz (a cura di), Fritz Lang. La messa in scena, cit., p. 416. 37 38
Simsolo, Fritz Lang, cit., p. 105.
39
Bogdanovich, Fritz Lang, cit., p. 369.
Filmografia I riferimenti fondamentali per la filmografia del regista sono: la filmografia di Bernard Eisenschitz in P. Bertetto, B. Eisenschitz (a cura di), Fritz Lang. La messa in scena, Torino, Lindau, 1993; quella di Lotte Eisner, Fritz Lang, London, Secker & Warburg, 1976; e quella di Hans Helmut Prinzler in F. Grafe, E. Patalas, H. Prinzler, P. Syr, Fritz Lang, München, Carl Hanser Verlag, 1976. FRITZ LANG SCENEGGIATORE
1917 Die Hochzeit im Exzentrik Klub produzione May-Film GmbH, Berlin (per la serie «Joe Deebs», n. 9); regia Joe May; sceneggiatura Fritz Lang; interpreti Harry Liedtke, Magda Madeleine, Bruno Kastner, Wilhelm von Haxthausen, Käthe Haack; première Berlino, 27 aprile 1917. Hilde Warren und der Tod produzione May-Film GmbH, Berlin; regia Joe May; sceneggiatura Fritz Lang; interpreti Mia May, Hans Mierendorff, Bruno Kastner, Ernst Matray, Georg John, Hermann Picha; première Berlino, 31 agosto 1917.
1919 Die Rache ist mein produzione Decla-Filmgesellschaft, Berlin; regia Alwin Neuß; sceneggiatura Fritz Lang; interpreti Paul Otto, Alwin Neuß, Arnold Czempin, Martha Daghofer (= Lil Dagover); première Berlino, marzo 1919. Wolkenbau und Flimmerstern produzione Decla-Filmgesellschaft, Berlin; regia ?; sceneggiatura Fritz Lang, Wolfgang Geiger; interpreti Margarete Frey, Karl-Gerhard Schröder, Albert Paul, Ressel Orla. Bettler GmbH produzione Decla-Filmgesellschaft, Berlin; regia Alwin Neuß; sceneggiatura Fritz Lang; interpreti Alwin Neuß, Fred Selva-Goebel, Paul Otto, Lil Dagover; première 2 maggio 1919 (?). Totentanz produzione Helios-Film, Berlin; regia Otto Rippert; sceneggiatura Fritz Lang; interpreti Sascha Gura, Werner Krauss, Josef Römer; première 19 giugno 1919.
Lilith und Ly produzione Fiat-Film, Wien; regia Erich Kober; sceneggiatura Fritz Lang; interpreti Hans Marschall, Elga Beck, Ernst Escherich, August Hartner. Die Pest in Florenz produzione Decla-Filmgesellschaft, Berlin; regia Otto Rippert; sceneggiatura Fritz Lang; interpreti Theodor Becker, Marga von Kierska, Erich Bartels, Julietta Brandt, Erner Hübsch; première Berlino, 23 ottobre 1919. Die Frau mit den Orchideen produzione Decla-Filmgesellschaft, Berlin; regia Otto Rippert; sceneggiatura Fritz Lang; interpreti Werner Krauss, Carl de Vogt, Gilda Langer.
1920 Die Herrin der Welt 8. Teil - Die Rache der Maud Fergusson produzione May-Film GmbH, Berlin; regia Joe May; sceneggiatura Joe May, Fritz Lang, Wilhelm Roellinghoff; da un romanzo di Karl Figdor; interpreti Mia May, Hans Mierendorff, Ernst Hofmann, Rudolf Lettinger, Henry Bender; première Berlino, 30 gennaio 1920.
1921 Das indische Grabmal 1. Die Sendung des Yogi 2. Das indische Grabmal produzione May-Film GmbH, Berlin, per EFA, Berlin; regia Joe May; sceneggiatura Thea von Harbou, Fritz Lang; da un romanzo di Thea von Harbou; interpreti Olaf Fönss, Mia May, Conrad Veidt, Erna Morena, Bernhard Goetzke, Lya de Putti, Paul Richter; première Berlino, 22 ottobre 1921, 17 novembre 1921. FRITZ LANG REGISTA
1919 Halbblut (t.l. Mezzosangue) produzione Decla-Filmgesellschaft, Holz & Co., Berlin; produttore Erich Pommer; regia Fritz Lang; sceneggiatura Fritz Lang; fotografia Carl Hoffmann; interpreti Ressel Orla (Juanita), Carl de Vogt (Axel), Gilda Langer, Paul Morgan, Carl Gerhard-Schröder, Axel von Straaten; metraggio 1608 m; première Berlino, 3 aprile 1919.
Der Herr der Liebe (t.l. II signore dell’amore) produzione Helios-Film, Berlin; produttore Erwin Rosner, Erich Pommer; regia Fritz Lang; sceneggiatura Leo Koffler; fotografia Emil Schünemann; architetto scenografo Carl Ludwig Kirmse; interpreti Karl de Vogt (Disescu), Gilda Langer (Yvette), Erika von Unruh, Fritz Lang, Nadjah Gezza; metraggio 1316 m; distribuzione Decla Film AG; première Berlino, settembre 1919. Die Spinnen 1. Abenteuer: Der Goldene See (t.l. I ragni. Il lago dorato) produzione Decla-Filmgesellschaft, Holz & Co., Berlin; produttore Erich Pommer; regia Fritz Lang; sceneggiatura Fritz Lang; fotografia Emil Schünemann; architetto scenografo Hermann Warm, Otto Hunte, Carl Ludwig Kirmse, Heinrich Umlauff; interpreti Carl de Vogt (Kay Hoog), Lil Dagover (Naela, sacerdotessa del Sole), Ressel Orla (Lio Sha), Georg John (dottor Telphas), Rudolf Lettinger (John Terry, Re del diamante), Edgar Pauly (John Quattro-dita), Paul Morgan (esperto), Paul Biensfeldt, Friedrich Kühne, Harry Frank; metraggio 1900 m/1951 m; luoghi delle riprese LixiAteliers, Berlin-Weissensee; première Berlino, 3 ottobre 1919. Harakiri produzione Decla-Filmgesellschaft, Holz & Co., Berlin; produttore Erich Pommer; regia Fritz Lang; sceneggiatura Max Jungk; dal testo teatrale Madame Butterfly di John Luther Long e David Belasco; fotografia Max Fassbaender; architetto scenografo Heinrich Umlauff; scenografia e consulenza etnografica Heinrich Umlauff (arredamenti forniti dal I.F.G. Umlauff Museum di Amburgo); interpreti Paul Biensfeldt (Daimyo Toyugawa), Lil Dagover (O-Take-San, sua figlia), Georg John (bonzo), Meinhard Maur (il principe Matahari), Niels Prien (Olaf J. Anderson, ufficiale di marina), Herta Hedén (Eva), Loni Nest (figlio di O-Take-San e di Niels Prien); metraggio 2525 m/2238 m; luoghi delle riprese Decla-Ateliers, Woltersdorf; première Berlino, 18 dicembre 1919.
1920 Die Spinnen 2. Abenteuer: Das Brillantenschiff (t.l. I ragni. La nave dei diamanti) produzione Decla-Filmgesellschaft, Holz & Co., Berlin; produttore Erich Pommer; regia Fritz Lang; sceneggiatura Fritz Lang; fotografia Karl Freund; architetto scenografo Hermann Warm, Otto Hunte, Carl Ludwig Kirmse, Heinrich Umlauff; interpreti Carl de Vogt (Kay Hoog), Ressel Orla (Lio Sha), Georg John (il Maestro dei ragni), Rudolf Lettinger (John Terry, Re del diamante), Thea Zander (Ellen, sua figlia), Reiner Steiner (capitano del cargo di diamanti), Freiedrich Kühne (All-hab-mah, lo yoghi), Meinhard Maur (cinese), Paul Morgan (giudeo), K.A. Römer; metraggio 2219 m/2815 m; première Berlino, 13 febbraio 1920. Das wandernde Bild (t.l. La statua errante) produzione May-Film GmbH, Berlin; produttore Joe May; regia Fritz Lang; sceneggiatura Thea von Harbou, Fritz Lang; fotografia Guido Seeber;
architetto scenografo Otto Hunte, Erich Kettelhut; interpreti Mia May (Irmgard Vanderheit), Hans Marr (Georg Vanderheit/John, suo fratello), Rudolf Klein Rohden (= Klein-Rogge) (Will Brand, cugino di Georg), Harry Frank, Loni Nest (la figlia di Irmgard); metraggio 2032 m; data e luoghi delle riprese Königssee (Bayern), Fürstenau im Odenwald, Watzmann, luglio 1920; May-Atelier, Berlin-Weissensee; première Berlino, 25 dicembre 1920.
1921 Kämpfende Herzen (Die Vier um die Frau) (t.l. Cuori in lotta; Quattro intorno a una donna) produzione Decla-Bioscop AG, Berlin; produttore Erich Pommer; regia Fritz Lang; sceneggiatura Thea von Harbou, Fritz Lang; da un soggetto di Rolf E. Vanloo; fotografia Otto Kanturek; architetto scenografo Ernst Meiwers, Hans Jacoby; interpreti Carola Toelle (Florence Yquem), Hermann Böttcher (suo padre), Ludwig Hartau (Harry Yquem, sensale), Anton Edthofer (Werner Krafft/William, suo fratello), Rudolf Klein-Rogge (Upton, ricettatore), Robert Forster-Larrinaga (Meunier), Harry Frank (Bobby), Paul Morgan (fabbricante di gioielli falsi); metraggio 1707 m; luoghi delle riprese Neubabelsberg; première Berlino, 3 febbraio 1921.
1921 Der müde Tod. Ein Deutsches Volkslied in sechs Versen (Destino) produzione Decla-Bioscop AG, Berlin; produttore Erich Pommer; regia Fritz Lang; sceneggiatura Thea von Harbou, Fritz Lang; fotografia Erich Nitzschmann, Hermann Salfrank (parte tedesca), Fritz Arno Wagner (episodi veneziano, orientale e cinese); architetto scenografo Robert Herlth (episodio cinese, con l’eccezione del palazzo imperiale), Walter Röhrig (parte tedesca, con l’eccezione della collina dei salici), Hermann Warm (episodi orientale e veneziano, palazzo imperiale cinese, collina dei salici); interpreti Lil Dagover (la fidanzata; Zobeide; Fiammetta; Tiaotsien), Walter Janssen (il fidanzato; l’europeo; Liang), Bernhard Goetzke (la Morte; El Mot; l’arciere), Hans Sternberg (il sindaco), Ernst Rückert (il pastore), Max Adalbert (il notaio; il ministro delle finanze), Erich Pabst (l’istitutore), Paul Rehkopf (il sacrestano), Wilhelm Diegelmann (il medico), Karl Platen (il farmacista), Max Pfeiffer (il guardiano notturno), Hermann Picha (il sarto), Georg John (il becchino; il mendicante), Marie Wismar (la vecchia), Grete Berger (la madre), Rudolf Klein-Rogge (il derviscio; Girolamo), Eduard von Winterstein (il califfo), Erika von Unruh (Aisha), Lewis Brody (il moro), Lothar Müthel (il confidente), Lina Paulsen (la nutrice), Paul Biensfeldt (Ahi, il mago), Karl Huszar (l’imperatore), Paul Neumann (il carnefice); metraggio 2306 m; luoghi delle riprese Neubabelsberg; première Berlino, 6 ottobre 1921.
1922 Dr. Mabuse, der Spieler 1: Der Große Spieler - Ein Bild Der Zeit 2: Inferno. Ein Spiel von Menschen unserer Zeit (Il dottor Mabuse 1: Il grande giocatore. Un quadro dell’epoca 2: Nell’inferno del crimine. Uomini dell’epoca)
produzione Uco-Film der Decla-Bioscop AG, Berlin; produttore Erich Pommer; regia Fritz Lang; sceneggiatura Thea von Harbou; dal romanzo di Norbert Jacques; fotografia Carl Hoffmann, Erich Nitzschmann; architetto scenografo Carl Stahl-Urach, Otto Hunte, Erich Kettelhut, Karl Vollbrecht; costumi Vally Reinecke; interpreti Rudolf Klein-Rogge (dottor Mabuse), Aud Egede Nissen (Cara Carozza), Gertrude Welcker (contessa Dusy Told), Alfred Abel (conte Told), Bernhard Goetzke (procuratore von Wenk), Paul Richter (Hull), Robert Forster-Larrinaga (Spoerri), Hans Adalbert Schlettow (Georg), Georg John (Pesch), Julius Falkenstein (Karsten, amico di Wenk), Lydia Potechina (la russa), Anita Berber (danzatrice in frac), Paul Biensfeldt (l’uomo con il revolver), Julie Brandt, Auguste Prasch-Grevenberg, Adele Sandrock, Max Adalbert, Gustav Botz, Heinrich Gotho, Leonhard Haskel, Erner Hübsch, Gottfried Huppertz, Hans Junkermann, Adolf Klein, Erich Pabst, Edgar Pauly, Hans Sternberg, Olaf Storm, Erich Walter; metraggio 3496 m (prima parte), 2533 m (seconda parte); data e luoghi delle riprese novembre 1921 - marzo 1922, Decla, Neubabelsberg; Jofa, BerlinJohannisthal; distribuzione Decla-Bioscop; première Berlino, 27 aprile 1922, 26 maggio 1922.
1924 Die Nibelungen 1: Siegfried 2: Kriemhilds Rache (I Nibelunghi 1: La morte di Sigfrido 2: La vendetta di Crimilde) produzione Decla-Bioscop AG, Berlin; produttore Erich Pommer; regia Fritz Lang; sceneggiatura Thea von Harbou; fotografia Carl Hoffmann, Günther Rittau, Walther Ruttmann; architetto scenografo Otto Hunte; co-scenografo Erich Kettelhut; costruzione del drago Karl Vollbrecht; costumi Paul Gerd Guderian (morto durante le riprese del primo film), Aenne Willkomm; armature, costumi e armi degli Unni Heinrich Umlauff, atelier del suo museo di Amburgo; fotografia Horst von Harbou; musiche Gottfried Huppertz; interpreti Gertrud Arnold (regina Ute), Margarete Schön (Crimilde), Hanna Ralph (Brunilde), Paul Richter (Sigfrido), Theodor Loos (re Gunther), Hans Carl Müller (Gerenot), Erwin Biswanger (Giselher), Bernhard Goetzke (Volker von Alzey), Hans Adalbert Schlettow (Hagen Tronje), Hardy von François (Dankwart), Georg John (il mimo Alberico), Frieda Richard (serva runica), Georg Jurowski (sacerdote), Iris Roberts (paggio). Nella seconda parte soltanto: Rudolf Klein-Rogge (re Etzel), Georg John (Blaodel, suo fratello), Hubert Heinrich (Werbel, il menestrello), Rudolf Rittner (Rüdiger von Bechlarn), Fritz Alberti (Dietrich von Bern), Georg August Koch (Ildebrando), Grete Berger (donna unna); metraggio 3216 m (prima parte), 3576 m (seconda parte); data e luoghi delle riprese 1922 - marzo 1924, Decla-Bioscop, Neubabelsberg; Rehbergen; distribuzione UFA; première Berlino, 14 febbraio 1924, 26 aprile 1924.
1927 Metropolis produzione Universum-Film AG, Berlin; produttore Erich Pommer; regia Fritz Lang; sceneggiatura Thea von Harbou; fotografia Karl Freund, Günther Rittau; architetto scenografo Otto Hunte, Erich Kettelhut, Karl Vollbrecht; sculture e robot Walter Schulze-Mittendorf; costumi Aenne Willkomm; effetti speciali Konstantin Tschetwerikoff, Günther Rittau, Eugen
Schüfftan; fotografia Horst von Harbou; musiche Gottfried Huppertz; interpreti Alfred Abel (Joh Fredersen), Gustav Fröhlich (Freder, figlio di Joh Fredersen), Rudolf Klein-Rogge (Rotwang, l’inventore), Fritz Rasp (lo smilzo), Theodor Loos (Josaphat), Erwin Biswanger (No. 11811), Heinrich George (Groth, guardiano della macchina centrale), Olaf Storm (Jan), Hanns Leo Reich (Marinus), Heinrich Gotho (maestro di cerimonie), Margarete Lanner (la donna nell’automobile), Max Dietze, Georg John, Walter Kühle, Arthur Reinhard, Erwin Vater (operai), Grete Berger, Olly Böheim, Ellen Frey, Lisa Gray, Rose Lichtenstein, Helene Weigel (operaie), Beatrice Garga, Anny Hintze, Margarete Lanner, Helen von Münchhofen, Hilde Woitscheff (le donne dei Giardini Eterni), Fritz Alberti (l’uomo creatore, scena della Torre di Babele), Brigitte Helm (Maria/l’essere artificiale); metraggio 4189 m; data e luoghi delle riprese 22 maggio 1925-30 ottobre 1926, Staaken, Neubabelsberg, Rehbergen; première Berlino, 10 gennaio 1927.
1928 Spione (L’inafferrabile) produzione Fritz Lang Film GmbH; produttore Fritz Lang; regia Fritz Lang; sceneggiatura Thea von Harbou; fotografia Fritz Arno Wagner; architetto scenografo Otto Hunte, Karl Vollbrecht; fotografia Horst von Harbou; musiche Werner H. Heymann; interpreti Rudolf Klein-Rogge (Haghi), Gerda Maurus (Sonja Barranikowa), Lien Deyers (Kitty), Louis Ralph (Morrier), Craighall Sherry (capo della polizia Jason), Willy Fritsch (No. 326), Paul Hörbiger (Franz, autista), Hertha von Walther (Lady Leslane), Lupu Pick (Matsumoto), Fritz Rasp (colonnello Jellusic), Julius Falkenstein (direttore dell’hotel), Georg John (macchinista), Paul Rehkopf (teppista), Grete Berger (infermiera), Hermann Vallentin, Hans H. von Twardowski (segretario di Jason), Rosa Valetti (madre di Kitty); metraggio 4364 m; data e luoghi delle riprese 27 dicembre 1927 - marzo 1928, Neubabelsberg; dist UFA; première Berlino, 22 marzo 1928.
1929 Frau im Mond (Una donna nella luna) produzione UFA; produttore Fritz Lang; regia Fritz Lang; sceneggiatura Thea von Harbou; fotografia Curt Courant, Oskar Fischinger, Otto Kanturek, Konstantin Tschetwerikoff; architetto scenografo Emil Hasler, Otto Hunte, Karl Vollbrecht; fotografia Horst von Harbou; musiche Willy SchmidtGentner; interpreti Klaus Pohl (professor Georg Manfeldt), Willy Fritsch (Wolf Helius), Gustav von Wangenheim (ingegnere Hans Windegger), Gerda Maurus (Friede Velten), Gustl Stark-Gstettenbaur (Gustav), Fritz Rasp (Walt Turner), Tilla Durieux, Hermann Vallentin, Max Zilzer, Mahmud Terja Bey, Borwin Walth (finanzieri), Margarete Kupfer (governante da Helius), Max Maximilian (autista di Helius), Alexa von Porembsky (una venditrice di violette), Gerhard Dammann (caposquadra), Heinrich Gotho (inquilino del secondo piano); metraggio 4365 m; luoghi delle riprese Neubabelsberg; distribuzione UFA; première Berlino, 15 ottobre 1929.
1931 M produzione Nero-Film AG; produttore Seymour Nebenzahl; regia Fritz Lang; sceneggiatura Thea von Harbou; musiche Edvard Grieg (motivo da Peer Gynt); fotografia Fritz Arno Wagner; assistente operatore Karl Vash; montaggio Paul Falkenberg; architetto scenografo Emil Hasler; suono Adolf Jansen; direttore di produzione Gustav Rath, Löwenberg fotograia Horst von Harbou; interpreti Peter Lorre (Hans Beckert), Ellen Widmann (Frau Beckmann), Inge Landgut (Elsie Beckmann), Gustaf Gründgens (lo svaligiatore di casseforti), Friedrich Gnass (il ladro), Fritz Odemar (il baro), Paul Kemp (il borsaiolo), Theo Lingen (l’imbroglione), Ernst Stahl-Nachbaur (il prefetto di polizia), Franz Stein (il ministro), Otto Wernicke (il commissario Lohmann), Theodor Loos (il commissario Groeber), Georg John (il venditore ambulante cieco), Rudolf Blümner (l’avvocato della difesa), Karl Platen (il guardiano), Gerhard Bienert (ispettore della polizia criminale), Rosa Valetti (la tenutaria), Hertha von Walther (una prostituta); durata 117 min; data e luoghi delle riprese 18 dicembre 1930 - 16 febbraio 1931, Staaken; première Berlino, 11 maggio 1931.
1933 Das Testament des Dr. Mabuse (II testamento del dottor Mabuse) produzione Nero-Film AG; produttore Seymour Nebenzahl; regia Fritz Lang; sceneggiatura Thea von Harbou; musiche Hans Erdmann; fotografia Fritz Arno Wagner; assistente operatore Karl Vash; montaggio Conrad von Molo; architetto scenografo Emil Hasler; costumi Karl Vollbrecht; suono Adolf Jansen; direttore di produzione Gustav Rathje; interpreti Rudolf KleinRogge (dottor Mabuse), Oskar Beregi (professor Baum), Karl Meixner (Hofmeister), Theodor Loos (dottor Kramm), Otto Wernicke (il commissario Lohmann), Klaus Pohl (Müller), Wera Liessem (Lilli), Gustav Diessl (Thomas Kent), Camilla Spira (Anna dei gioielli), Rudolf Schündler (Hardy), Theo Lingen (Karetzky), Paul Oskar Höcker (Bredow), Paul Henckels (il litografo), Georg John (il domestico del professor Baum), Ludwig Stössel (funzionario dell’ufficio di collocamento), Hadrian Maria von Netto (Nicolai Grigoriew), Paul Bernd (ricattatore), Henry Pless (poliziotto), E.A. Licho (dottor Hauser), Gerhard Bienert (ispettore della polizia criminale Voberg); durata 122 min; luoghi delle riprese Staaken; distribuzione Deutsche Universal-Film AG; première Budapest, 04.1933; Vienna, 12 maggio 1933. Versione francese: Le testament du Dr. Mabuse produzione Nero des Films Osso; regia Fritz Lang; co-regista, adattamento, dialoghi A. René Sti; stessi tecnici salvo montaggio Lothar Wolff; assistente alla regia Saul C. Colin; interpreti Jim Gérald (commissario Lohmann), René Ferté (Hardy), Monique Rolland (Lilli), Rudolf Klein-Rogge (dottor Mabuse), Raymond Cordy (Karetsky), Maurice Maillot (Kent), Ginette Gaubert (Anna), Thomy Bourdelle (professor Baum), Daniel Mendaille (Bredow), Karl Meixner (Hofmeister), Hadrian Maria von Netto (Nicolai Grigoriew), Gerhard Bienert (ispettore), Silvio De Pedrelli, Marcel Merminod, Georges Tourreil, Georges Paulais, Jacques Ehrem, Lily Rezillot, Georges Koudria; durata 95 min; distribuzione Les Films Osso; première Parigi, aprile 1933.
1934 Liliom (La leggenda di Liliom) produzione Fox Europa; produttore Erich Pommer; produttore associato André Daven; regia Fritz Lang; sceneggiatura Robert Liebmann; da un testo teatrale di Ferenc Molnár; dialoghi Bernard Zimmer; musiche Jean Lenoir, Franz Waxman; suono Viens gosse de gosse di Jean Lenoir; fotografia Rudolph Maté; montaggio Ernest Hajos; architetto scenografo Paul Colin; set decorator René Renoux; dipinti Ferdinand Earle; costumi René Hubert; suono E. Zylberberg; fotografia Walter Limot; interpreti Charles Boyer (Liliom Zadowski), Madeleine Ozeray (Julie, sua figlia), Florelle (Madame Moscat), Alcover (Alfred), Robert Arnoux (uomo forte), Roland Toutain (il marinaio), Alexandre Rignault (Hollinger), Henri Richard (il commissario), Richard Barencey (il poliziotto del Purgatorio), Raoul Marco (l’ispettore), Antonin Artaud (l’arrotino), Léon Arvel (l’impiegato), René Stern (il cassiere), Maximilienne (Madame Menoux), Mimi Funès (Marie), Viviane Romance (la sigaraia), Mila Parély (la dattilografa celeste); durata 120 min; data delle riprese dicembre 1933 - febbraio 1934; distribuzione Société Anonyme Française Fox Film; première Parigi, 13 maggio 1934.
1936 Fury (Furia) produzione Metro-Goldwyn-Mayer; produttore Joseph L. Mankiewicz; regia Fritz Lang; sceneggiatura Bartlett Cormack, Fritz Lang; da un soggetto di Norman Krasna; musiche Franz Waxman; fotografia Joseph Ruttenberg; montaggio Frank Sullivan; architetto scenografo Cedric Gibbons; costumi Dolly Tree; suono Douglas Shearer; interpreti Sylvia Sidney (Katherine Grant), Spencer Tracy (Joe Wilson), Walter Abel (procuratore distrettuale), Bruce Cabot (Kirby Dawson), Edward Ellis (lo sceriffo), Walter Brennan («Bugs» Meyers), Frank Albertson (Charlie), George Walcott (Tom), Arthur Stone (Durkin), Morgan Wallace (Fred Garrett), George Chandler (Milton Jackson), Roger Gray (lo straniero), Edwin Maxwell (Vickery), Howard Hickman (il governatore), Jonathan Hale (l’avvocato difensore), Leila Bennett (Edna Hooper), Esther Dale (Mrs Whipple), Helen Flint (Franchette), Edward Le Saint (dottore), Frank Sully (dinamitardo), Mira McKinney (la donna isterica), Raymond Hatton (Hector), Arthur Hoyt (Grouch), Murdock MacQuarrie (amico di Dawson), Victor Potel (Jorgeson); durata 94 min; luoghi delle riprese MGM Studios; distribuzione MGM; première 22 maggio 1936.
1937 You Only Live Once (Sono innocente!) produzione Walter Wanger Productions; produttore Walter Wanger; regia Fritz Lang; sceneggiatura Gene Towne, Graham Baker; da un soggetto di Gene Towne; musiche Alfred Newman: canzone A Thousand Dreams of You di Louis Alter, Paul Francis Webster; fotografia Leon Shamroy; montaggio Daniel Mandell; architetto scenografo Alexander Toluboff; costumi Helen Taylor; suono Frank Maher; interpreti Sylvia Sidney (Joan “Jo” Graham), Henry Fonda (Eddie Taylor), Barton MacLane (Stephen
Whitney), Jean Dixon (Bonnie Graham), William Gargan (padre Dolan), Warren Hymer (Mugsy), Charles “Chic” Sale (Ethan), Margaret Hamilton (Hester), Guinn Williams (Rogers), Jerome Cowan (dottor Hill), John Wray (Warden), Jonathan Hale (procuratore distrettuale); durata 87 min; distribuzione United Artists; première 27 gennaio 1937.
1938 You and Me produzione Paramount Pictures; produttore Fritz Lang; regia Fritz Lang; sceneggiatura Virginia Van Upp; da un soggetto di Norman Krasna; musiche Kurt Weill, Boris Morros; canzoni You Can’t Get Something for Nothing, The Right Guy for Me di Kurt Weill, Sam Coslow, You and Me di Frederick Hollander, Ralph Freed; fotografia Charles B. Lang jr.; montaggio Paul Weatherwax; architetto scenografo Hans Dreier, Ernest Fegté; set decorator A.E. Freudeman; suono Harry Lindgren, Walter Oberst; interpreti Sylvia Sidney (Helen Roberts), George Raft (Joe Dennis), Robert Cummings (Jim), Barton MacLane (Mickey), Roscoe Karns (Cuffy), Harry Carey (Mr Morris), Warren Hymer (Gimpy), George E. Stone (Patsy), Guinn Williams (tassista), Vera Gordn (Mrs Levine), Carol Paige (cantante), Bernadene Hayes (Nellie), Egon Brecher (Mr Levine), Joyce Compton (Curly Blonde), Cecil Cunningham (Mrs Morris), Willard Robertson (Dayton), Roger Gray (bagnino), Adrian Morris (Knucks), Harlan Briggs (McTavish), Paula De Cardo, Harriette Haddon (venditrici di sigarette), Arthur Hoyt (Mr Klein); durata 90 min; distribuzione Paramount; première New York, 1° giugno 1938.
1940 The Return of Frank James (II vendicatore di Jess il bandito) produzione 20th Century-Fox; produttore esecutivo Darryl F. Zanuck; produttore associato Kenneth Macgowan; regia Fritz Lang; sceneggiatura Sam Hellman; musiche David Buttolph; fotografia George Barnes; montaggio Walter Thompson; architetto scenografo Richard Day, Wiard B. Ihnen; set decorator Thomas Little; costumi Travis Banton; suono W.D. Flick, Roger Heman; interpreti Henry Fonda (Frank James), Gene Tierney (Eleanor Stone), Jackie Cooper (Clem), Henry Hull (Magg. Rufus Todd), John Carradine (Bob Ford), J. Edward Bromberg (detective George Runyan), Donald Meek (McCoy), Eddie Collins (impiegato della stazione), George Barbier (giudice Ferris), Ernest Whitman (Pinky Washington), Charles Tannen (Charlie Ford), Lloyd Corrigan (Randolph Stone), Russell Hicks (pubblico ministero), Victor Kilian (predicatore), Edward McWade (colonnello Jackson), George Chandler (Roy), Bud Fine (Deputato), Irving Bacon (spettatore a teatro), Frank Shannon (sceriffo Daniels), Barbara Pepper (Nellie Blane); Technicolor; durata 92 min; luoghi delle riprese Sabrina Lake, Mammoth Lake, Convict Lake, Owens River Gorge, Mother Lode, Bishop, Sonora; distribuzione 20th Century-Fox; première New York, 9 agosto 1940.
1941
Western Union (Fred il ribelle) produzione 20th Century-Fox; produttore esecutivo Darryl F. Zanuck; produttore associato Harry Joe Brown; regia Fritz Lang; sceneggiatura Robert Carson; da un romanzo di Zane Grey; musiche David Buttolph; fotografia Edward Cronjager, Allen M. Davey; montaggio Robert Bischoff, Gene Fowler jr.; architetto scenografo Richard Day, Wiard B. Ihnen; set decorator Thomas Little; costumi Travis Banton; suono Bernard Freericks, Roger Heman; interpreti Robert Young (Richard Blake), Randolph Scott (Vance Shaw), Dean Jagger (Edward Creighton), Virginia Gilmore (Sue Creighton), John Carradine (Doc Murdoch), Slim Summerville (Herman), Chill Wills (Homer), Barton MacLane (Jack Slade), Russell Hicks (il governatore), Victor Kilian (Charlie), Minor Watson (Pat Grogan), George Chandler (Herb), Chief Big Tree (capo Cavallo Pezzato), Chief Thundercloud (capo indiano); Technicolor; durata 95 min; luoghi delle riprese Utah, 20th Century-Fox, Los Angeles; distribuzione 20th CenturyFox; première New York, 6 febbraio 1941. Man Hunt (Duello mortale) produzione 20th Century-Fox Film Corporation; produttore esecutivo Darryl F. Zanuck; produttore associato Kenneth Macgowan; regia Fritz Lang; sceneggiatura Dudley Nichols; da un romanzo di Geoffrey Household; musiche Alfred Newman; fotografia Arthur Miller; montaggio Allen McNeil; architetto scenografo Richard Day, Wiard B. Ihnen; set decorator Thomas Little; costumi Travis Banton; suono Eugene Grossman, Roger Heman; effetti speciali Fred Sersen; direttore di produzione Ben Silvey; interpreti Walter Pidgeon (capitano Alan Thorndike), Joan Bennett (Jerry Stokes), George Sanders (Magg. Quive-Smith), John Carradine (Mr Jones), Roddy MacDowall (Vaner, il giovane mozzo), Ludwig Stossel (dottore), Heather Thatcher (Lady Risborough), Frederick Worlock (Lord Risborough), Roger Imhof (capitano Jensen), Egon Brecher (“Whiskers”), Holmes Herbert (Saul Farnsworthy); durata 105 min; data e luoghi delle riprese 12 marzo - 12 aprile 41, 20th Century-Fox Studios; distribuzione 20th Century-Fox; première New York, 13 giugno 41.
1943 Hangmen Also Die! (Anche i boia muoiono) produzione Arnold Productions, Inc.; produttore Fritz Lang; produttore esecutivo Arnold Pressburger; regia Fritz Lang; sceneggiatura John Wexley, Bertolt Brecht, Fritz Lang da un adattamento e soggetto di Bertolt Brecht, Fritz Lang; musiche Hanns Eisler; fotografia James Wong Howe; montaggio Gene Fowler jr.; architetto scenografo William Darling; set decorator Julie Heron; costumi (Anna Lee) Eleanor Behm; suono Fred Lau; direttore di produzione Carley Harriman; interpreti Brian Donlevy (dottor Franticek Svoboda), Walter Brennan (professor Stepan Novotny), Anna Lee (Mascha Novotny), Gene Lockhart (Emil Czaka), Dennis O’Keefe (Jan Horak), Alexander Granach (ispettore della Gestapo Alois Gruber), Margaret Wycherly (Ludmilla Novotny), Tonio Selwart (capo della Gestapo Kurt Haas), Jonathan Hale (Dedic), H.H. von Twardowski (Reinhard Heydrich), Nana Bryant (Mrs Novotny), Billy Roy (Boda Novotny), Reinhold Schuenzel (ispettore Ritter), Louis Donath (Schirmer), Arno Frey (tenente Itnut), Sarah
Padden (Mrs Dvorak), Byron Foulger (Bartos), Edmund MacDonald (dottor Pillar), Lionel Stander (tassista), Lester Sharpe (Rudy), Arthur Loft (Gen. Votruba), George Irving (Nezval), James Bush (Pescacek), Virginia Farmer (proprietaria della pensione), William Farnum (Viktorin), Emmett Vogan (Kvarda); durata 131 min; distribuzione United Artists; première Los Angeles, 26 marzo 1943.
1944 Ministry of Fear (Il prigioniero del terrore) produzione Paramount; produttore associato Seton I. Miller; regia Fritz Lang; sceneggiatura Seton I. Miller; da un romanzo di Graham Greene; musiche Victor Young; fotografia Henry Sharp; montaggio Archie Marshek; architetto scenografo Hans Dreier, Hal Pereira; set decorator Bertram Granger; costumi Edith Head; suono W.C. Smith, Don Johnson; interpreti Ray Milland (Stephen Neale), Marjorie Reynolds (Carla Hilfe), Carl Esmond (Willi Hilfe), Hillary Brooke (seconda signora Bellane), Percy Waram (ispettore Prentice), Dan Duryea (Cost/Travers), Alan Napier (dottor Forrester), Erskine Sanford (Mr Rennit), Thomas Louden (Mr Newland), Aminta Dyne (prima signora Bellane), Eustace Wyatt (il cieco), Mary Field (Miss Penteel), Byron Foulger (Mr Newby), Lester Matthews (dottor Morton), Helena Grant (Mrs Merrick); durata 88 min; distribuzione Paramount; première New York, 16 ottobre 1944. The Woman in the Window (La donna del ritratto) produzione International Pictures, Inc.; produttore Nunnally Johnson; regia Fritz Lang; sceneggiatura Nunnally Johnson; dal romanzo Once Off Guard di J.H. Wallis; musiche Arthur Lange; fotografia Milton Krasner; montaggio Marjorie Johnson, Gene Fowler jr.; architetto scenografo Duncan Cramer; set decorator Julia Heron; costumi (Joan Bennett) Muriel King; suono Frank McWorther; effetti speciali Vernon L. Walker, Paul Lerpae; interpreti Edward G. Robinson (professor Richard Wanley), Joan Bennett (Alice Reed), Raymond Massey (procuratore Frank Lalor), Edmund Breon (dottor Michael Barkstone), Dan Duryea (Heidt), Thomas E. Jackson (ispettore Jackson), Dororthy Peterson (Mrs Wanley), Arthur Loft (Claude Mazard), Frank Dawson (Collins), Carol Cameron (Elsie Wanley), Bobby Blake (Dickie Wanley); durata 99 min; distribuzione RKO Radio Pictures; première 10 ottobre 1944.
1945 Scarlet Street (La strada scarlatta) produzione Diana Productions; produttore Fritz Lang; produttore esecutivo Walter Wanger; regia Fritz Lang; sceneggiatura Dudley Nichols; dal romanzo La Chienne di Georges de la Fouchardière e da un testo teatrale di Georges de la Fouchardière e Mouézy-Eon; musiche Hans J. Salter; fotografia Milton Krasner; montaggio Arthur D. Hilton; architetto scenografo Alexander Golitzen; set decorator Russell A. Gausman, Carl Lawrence; costumi Travis Banton; suono Bernard B. Brown (sup), Glenn E. Brown;
effetti speciali John P. Fulton; interpreti Edward G. Robinson (Christopher Cross), Joan Bennett (Kitty March), Dan Duryea (Johnny Prince), Margaret Lindsay (Millie), Rosalind Ivan (Adele Cross), Jess Barker (Janeway), Charles Kemper (uomo con un occhio bendato), Anita Bolster (Mrs Michaels), Samuel S. Hinds (Charles Pringle), Vladimir Sokoloff (Pop Lejon), Arthur Loft (Dellarowe), Russell Hicks (Hogarth), Cyrus W. Kendall (Nick), Fred Essler (Marchetti), Edgar Dearing, Tom Dillon (poliziotti), Chuck Hamilton (autista), Gus Glassmire, Howard Mitchell, Ralph Littlefield, Sherry Hall, Jack Statham (impiegati), Rodney Bell (Barney, cameriere), Byron Foulger (Jones), Will Wright (cassiere), Richard Cramer (principale Keeper); durata 102 min; distribuzione Universal Pictures Company; première 28 dicembre 45.
1946 Cloak and Dagger (Maschere e pugnali) produzione United States Pictures, Inc, for Warner Bros.; produttore Milton Sperling; regia Fritz Lang; sceneggiatura Albert Maltz, Ring Lardner jr.; da un soggetto di Boris Ingster, John Larkin, ispirato al romanzo omonimo di Corey Ford, Alastair MacBain; musiche Max Steiner; fotografia Sol Polito; montaggio Christian Nyby; architetto scenografo Max Parker; set decorator Walter Hilford; costumi Leah Rhodes; suono Francis J. Scheid; effetti speciali Harry Barndollar, Edwin B. DuPar; direttore di produzione Frank Mattison; interpreti Gary Cooper (professor Alvah Jesper), Lilli Palmer (Gina), Robert Alda (Pinkie), Vladimir Sokoloff (dottor Polda), J. Edward Bromberg (Trenk), Marjorie Hoshelle (Ann Dawson), Ludwig Stoessel (il tedesco), Helene Thimig (Katarin Loder), Dan Seymour (Marsoli), Marc Lawrence (Luigi), James Flavin (colonnello Walsh), Clifton Young (Comandante americano), Ross Ford (paracadutista), Robert Coote (Cronin), Pat O’Moore (l’inglese), Charles Marsh (Erich); durata 106 min; distribuzione Warner Bros.; première New York, 4 ottobre 1946.
1947 Secret Beyond the Door (Dietro la porta chiusa) produzione Diana Productions, Inc.; produttore Fritz Lang; produttore esecutivo Walter Wanger; regia Fritz Lang; sceneggiatura Silvia Richards; dal racconto Museum Piece No. 13 di Rufus King; musiche Miklos Rozsa; fotografia Stanley Cortez; montaggio Arthur D. Hilton; architetto scenografo Max Parker; set decorator Russell A. Gausman, John Austin; costumi Travis Banton; suono Leslie I. Carey, Glenn E. Anderson; interpreti Joan Bennett (Celia Lamphere), Michael Redgrave (Mark Lamphere), Anne Revere (Caroline Lamphere), Barbara O’Neil (Miss Robey), Natalie Schafer (Edith Potter), Paul Cavanagh (Rick Barrett), Anabel Shaw (ragazza della buona società), Rosa Rey (Paquita), James Seay (Bob Dwight), Mark Dennis (David), Virginia Brissac (Sarah), Houseley Stevenson (Andy), Marie Harmon, Kay Morley (ragazze della buona società), Eddy C. Waller (Lem), Lucio Villegas (il prete), Paul Fierro, David Cota (duellanti messicani), Donna De Mario (giovane messicana); durata 99 min; data e luoghi delle riprese 61 giorni, Universal City; distribuzione Universal International Pictures; première New York, 15 gennaio 1948.
1950 House by the River (Bassa marea) produzione Fidelity Pictures, Inc.; produttore Howard Welsch; produttore associato Robert Peters; regia Fritz Lang; sceneggiatura Mel Dinelli; dal romanzo The House by the River di Alan P. Herbert; musiche George Antheil; fotografia Edward Cronjager; montaggio Arthur D. Hilton; architetto scenografo Boris Leven; set decorator Charles Thompson, John McCarthy jr.; costumi Adele Palmer; suono Dick Tyler, Howard Wilson; effetti speciali Howard & Theodore Lydecker; direttore di produzione Joseph Dillpe; interpreti Louis Hayward (Stephen Byrne), Lee Bowman (John Byrne), Jane Wyatt (Marjorie Byrne), Dorothy Patrick (Emily Gaunt), Ann Shoemaker (Mrs Ambrose), Jody Gilbert (Flora Bantam), Peter Brocco (procuratore generale), Howland Chamberlain (procuratore distrettuale), Margaret Seddon (Mrs Whittaker), Sarah Padden (Mrs Beach), Kathleen Freeman, Will Wright (ispettore Sarten), Leslie Kimmell (Mr Gaunt), Effie Laird (Mrs Gaunt); durata 88 min; distribuzione Republic Pictures Corp.; première 4 aprile 1950. American Guerrilla in the Philippines (I guerriglieri delle Filippine) produzione 20th Century-Fox Film Corp.; produttore Lamar Trotti; regia Fritz Lang; sceneggiatura Lamar Trotti; da un romanzo di Ira Wolfert; musiche Cyril J. Mockridge; fotografia Harry Jackson; montaggio Robert Simpson; architetto scenografo Lyle R. Wheeler, J. Russell Spencer; set decorator Thomas Little, Stuart Reiss; costumi Travilla, Charles Le Maire; suono Bernard Freericks, Harry M. Leonard; effetti speciali Fred Sersen; direttore di produzione F.E. Johnson; interpreti Tyrone Power (Chuck Palmer), Micheline Presle (Jeanne Martinez), Tom Ewell (Jim Mitchell), Bob Patten (Lovejoy), Tommy Cook (Miguel), Juan Torena (Juan Martinez), Jack Elam (Spenser), Robert H. Barrat (generale Douglas MacArthur), Carleton Young (colonnello Phillips), Maria Del Val (señora Martinez), Eddie Infante (Col. Dimalanta), Orlando Martin (colonnello Benson), Miguel Anzures (il traditore filippino), Chris De Varga, Eduardo Rivera (ufficiali giapponesi), Rosa Del Rosario, Kathy Ruby, Erlinda Cortez (partigiani); Technicolor; durata 105 min; luoghi delle riprese Luzon, Subic Bay, Philippines; distribuzione 20th Century-Fox Film Corp.; première New York, 7 novembre 1950.
1952 Rancho Notorious produzione Fidelity Pictures, Inc.; produttore Howard Welsch; regia Fritz Lang; sceneggiatura Daniel Taradash; da un soggetto di Silvia Richards; musiche Emil Newman; canzoni Gypsy Davey, Get Away, Young Man, Legend of Chuck-a-Luck di Ken Darby, cantate da Ken Darby (Legend of Chuck-a-Luck); fotografia Hal Mohr; montaggio Otto Ludwig; architetto scenografo Wiard B. Ihnen; set decorator Robert Priestley; costumi Joe King, (per Marlene Dietrich) Don Loper; suono Hugh McDowell, Mac Dalgleish; direttore di produzione Ben Hersh; interpreti Marlene Dietrich (Altar Keane), Arthur Kennedy (Vern Haskell), Mel Ferrer (Frenchy Fairmont), Lloyd Gough (Kinch), Gloria Henry (Beth Forbes), William Frawley (Baldy Gunder), Lisa Ferraday (Maxine), John Raven (croupier del
Chuck-a-Luck), Jack Elam (Geary), George Reeves (Wilson), Frank Ferguson (predicatore), Francis MacDonald (Harbin), Dan Seymour (Comanche Paul), John Kellogg (il negoziante), Rodric Redwing (Rio), Stuart Randall (Starr), Roger Anderson (Red), Felipe Turich (Sanchez), Stan Jolley (deputato Warren), Charles Gonzales (Hevia), Jose Dominguez (Gonzales), Lane Chandler (lo sceriffo), Fuzzy Knight (Barbiere), Fred Graham (Ace Maguire), Russell Johnson (croupier), Dick Elliott (il narratore); Technicolor; durata 89 min; distribuzione RKO Radio Pictures; première 7 febbraio 1952. Clash by Night (La confessione della signora Doyle) produzione Wald-Krasna Productions, Inc.; produttore Harriet Parsons; produttore esecutivo Jerry Wald; regia Fritz Lang; sceneggiatura Alfred Hayes; da un testo teatrale di Clifford Odets; musiche Roy Webb; canzone I Hear a Rhapsody di Joe Gasparre, Jack Baker, George Fragos, cantata da Tony Martin; fotografia Nicholas Musuraca; montaggio George J. Amy; architetto scenografo Albert S. D’Agostino, Carroll Clark; set decorator Darrell Silvera, Jack Mills; costumi Michael Woulfe; suono Jean L. Speak, Clem Portman; effetti speciali Harold Wellman; interpreti Barbara Stanwyck (Mae Doyle), Paul Douglas (Jerry D’Amato), Robert Ryan (Earl Pfeiffer), Marilyn Monroe (Peggy), J. Carrol Naish (zio Vince), Keith Andes (Joe Doyle), Silvio Minciotti (signor D’Amato), Diane e Deborah Stewart (le gemelle); durata 105 min; luoghi delle riprese studios RKO, Los Angeles, Monterey, CA; distribuzione RKO Radio Pictures; première 16 maggio 1952.
1953 The Blue Gardenia (Gardenia blu) produzione Alex Gottlieb Productions, Blue Gardenia Productions; produttore Alex Gottlieb; regia Fritz Lang; sceneggiatura Charles Hoffman; dal racconto The Gardenia di Vera Caspary; musiche Raoul Kraushaar; canzone Blue Gardenia di Bob Russell, Lester Lee, cantata da Nat “King” Cole; fotografia Nicholas Musuraca; montaggio Edward Mann; architetto scenografo Daniel Hall; costumi Maria Donovan, Israel Berne; suono Ben Winkler; effetti speciali Willis Cook; direttore di produzione Maurie M. Suess; interpreti Anne Baxter (Norah Larkin), Richard Conte (Casey Mayo), Ann Sothern (Crystal Carpenter), Raymond Burr (Harry Prebble), Jeff Donnell (Sally Ellis), Richard Erdman (Al), George Reeves (ispettore Haynes), Ruth Storey (Rose), Ray Walker (Homer), Nat “King” Cole (se stesso), Celia Lovsky (donna cieca), Frank Ferguson (ubriaco), Alex Gottlieb; durata 90 min; data delle riprese 28 novembre 1952 - 24 dicembre 1952; distribuzione Warner Bros; première 23 marzo 1953. The Big Heat (Il grande caldo) produzione Columbia Pictures Corporation; produttore Robert Arthur; produttore esecutivo Jerry Wald; regia Fritz Lang; sceneggiatura Sydney Boehm; da un romanzo di William P. McGivern; musiche Daniele Amfitheatrof; fotografia Charles Lang jr.; montaggio Charles Nelson; architetto scenografo Robert Peterson; set decorator William Kiernan; costumi Jean Louis; suono George Cooper; interpreti Glenn Ford (Dave
Bannion), Gloria Grahame (Debby Marsh), Jocelyn Brando (Katie Bannion), Alexander Scourby (Mike Lagana), Lee Marvin (Vince Stone), Jeannette Nolan (Bertha Duncan), Peter Whitney (Tierney), Willis Bouchey (tenente Wilkes), Robert Burton (Gus Burke), Adam Williams (Larry Gordon), Howard Wendell (commissario Higgins), Cris Alcaide (George Rose), Michael Granger (Hugo), Dorothy Green (Lucy Chapman), Carolyn Jones (Doris), Ric Roman (Baldy), Dan Seymour (Atkins), Edith Evanson (Selma Parker), Norma Randall (Jill), Linda Bennett (Joyce), Kathryn Eames (Marge); durata 90 min; data e luoghi delle riprese 17 marzo - 15 aprile 1953, Columbia Studios; distribuzione Columbia Pictures; première 6 ottobre 1953.
1954 Human Desire (La bestia umana) produzione Columbia Pictures Corporation; produttore Lewis J. Rachmil; produttore esecutivo Jerry Wald; regia Fritz Lang; sceneggiatura Alfred Hayes; dal romanzo La Bête humaine di Emile Zola (e il film La Bête humaine di Jean Renoir, 1938); musiche Daniele Amfitheatrof; fotografia Burnett Guffey; montaggio William A. Lyon, Aaron Stell; architetto scenografo Robert Peterson; set decorator William Kiernan; costumi Jean Louis; suono John Livadary; interpreti Glenn Ford (Jeff Warren), Gloria Grahame (Vicki Buckley), Broderick Crawford (Carl Buckley), Edgar Buchanan (Alec Simmons), Kathleen Case (Ellen Simmons), Peggy Maley (Jean), Diane DeLaire (Vera Simmons), Grandon Rhodes (John Owens), Dan Seymour (barista), John Pickard (Matt Henley), Paul Brinegar (ferroviere), Dan Riss (procuratore Gruber), Victor Hugo Greene (Davidson), John Zaremba (Russell), Carl Lee (John Thurston), Olan Soule (Lewis); durata 90 min; data e luoghi delle riprese dicembre 1953 - gennaio 1954, Columbia Studios, Rock Island Railroad, Oklahoma; distribuzione Columbia Pictures; première 6 agosto 1954.
1955 Moonfleet (Il covo dei contrabbandieri) produzione MGM; produttore John Houseman; produttore associato Jud Kinberg; regia Fritz Lang; sceneggiatura Jan Lustig, Margaret Fitts; da un romanzo di John Meade Falkner; musiche Miklos Rozsa; fotografia Robert Planck; montaggio Albert Akst; architetto scenografo Cedric Gibbons, Hans Peters; set decorator Edwin B. Willis, Richard Pefferle; costumi Walter Plunkett; suono Wesley C. Miller; direttore di produzione Al Shenberg; interpreti Stewart Granger (Jeremy Fox), George Sanders (Lord Ashwood), Joan Greenwood (Lady Ashwood), Viveca Lindfors (Anne Minton), Jon Whiteley (John Mohiune), Liliane Montevecchi (danzatrice Gipsy), Sean McClory (Elzevir Block), Melville Cooper (Felix Ratsey), Alan Napier (Parson Glennie), John Hoyt (giudice Maskew), Donna Corcoran (Grace), Jack Elam (Damen), Dan Seymour (Hull), Ian Wolfe (Tewkesbury), Lester Matthews (maggiore Hennishaw), Skelton Knaggs (Jacob), Richard Hale (Starkhill), John Alderson (Greening), Ashley Cowan (Tomson), Frank Ferguson (il vetturino), Booth Colman (capitano Stanhope), Peggy Maley (affittacamere), Oliver Blake (Crispin), Lillian Kemble Cooper (Mary Hicks), Guy Kingsford (capitano Hawkins), John O’Malley (tenente Upjohn), Leo
Britt (Ephraim); Eastmancolor, Cinema-Scope; durata 87 min; data e luoghi delle riprese 18 agosto - 12 ottobre 1954, MGM, Culver City, Oceanside, Ca.; distribuzione MGM; première 12 maggio 1955.
1956 While the City Sleeps (Quando la città dorme) produzione Bert E. Friedlob Productions, Inc.; produttore Bert Friedlob; regia Fritz Lang; sceneggiatura Casey Robinson; dal romanzo The Bloody Spur di Charles Einstein; musiche Herschel Burke Gilbert; fotografia Ernest Laszlo; montaggio Gene Fowler jr.; architetto scenografo Carroll Clark; set decorator Jack Mills; costumi Norma; suono Jack Solomon, Buddy Myers; direttore di produzione George Yohalem; interpreti Dana Andrews (Edward Mobley), Rhonda Fleming (Dorothy Kyne), George Sanders (Mark Loving), Ida Lupino (Mildred Donner), Howard Duff (Ten. Burt Kaufman), Thomas Mitchell (Jon Day Griffith), Vincent Price (Walter Kyne), Sally Forrest (Nancy Liggett), John Barrymore jr. (Robert Manners), James Craig (Harry Kritzer), Vladimir Sokoloff (George Palsky), Robert Warwick (Amos Kyne), Ralph Peters (Meade), Larry Blake (sergente di polizia), Edward Hinton (O’Leary), Mae Marsh (Mrs Manners), Sandy White (Judith Fenton), Celia Lovsky (Miss Dodd), Pitt Herbert (barista), David Andrews (pianista), Andrew Lupino; durata 100 min; data delle riprese 7 agosto 1955; distribuzione RKO Teleradio Pictures; première 16 maggio 1955. Beyond a Reasonable Doubt (L’alibi era perfetto) produzione Bert E. Friedlob Productions, Inc.; produttore Bert Friedlob; regia Fritz Lang; sceneggiatura Douglas Morrow; musiche Herschel Burke Gilbert; canzone Beyond a Reasonable Doubt di Alfred Perry, cantata da The Hi-Lo’s; fotografia William Snyder; montaggio Gene Fowler jr.; architetto scenografo Carroll Clark; set decorator Darrell Silvera; suono Jimmy Thompson, Terry Kellum; direttore di produzione Maurie M. Suess; interpreti Dana Andrews (Tom Garrett), Joan Fontaine (Susan Spencer), Sidney Blackmer (Austin Spencer), Barbara Nichols (Dolly Moore), Arthur Franz (Hale), Philip Bourneuf (Thompson), Edward Binns (tenente Kennedy), Shepperd Strudwick (Wilson), Robin Raymond (Terry), William Leicester (Charlie Miller), Dan Seymour (Greco), Rusty Lane (giudice), Joyce Taylor (Joan), Carleton Young (Kirk), Trudy Wroe (guardarobiera), Joe Kirk (impiegato), Charles Evans (governatore), Wendell Niles (presentatore), Joey Ray (Eddie), Steve McQueen; durata 80 min; data delle riprese 26 marzo - 30 aprile 1956; distribuzione RKO Teleradio Pictures; première 13 settembre 1956.
1959 Der Tiger von Eschnapur (La tigre di Eschnapur) Das indische Grabmal (II sepolcro indiano) produzione CCC Film, Berlin, Régina S.A. Critérion Films, Paris, Rizzoli Film, Roma; produttore Artur Brauner; regia Fritz Lang; sceneggiatura Fritz Lang, Werner Jörg Lüddecke; dal romanzo di Thea von Harbou e dalla sceneggiatura originale di Fritz Lang e Thea von Harbou (1921); musiche
Michel Michelet (La tigre), Gerhard Becker (Il sepolcro); fotografia Richard Angst; montaggio Walter Wischniewsky; architetto scenografo Willi Schatz, Helmut Nentwig; costumi Günter Brosda (Debra Paget), Claudia Herberg; suono Clemens Tütsch; direttore di produzione Eberhard Meichsner; coreografia Robby Gay, Billy Daniel; interpreti Debra Paget (Seetha), Paul Hubschmid (Harald Berger), Walther Reyer (Chandra), Claus Holm (dottor Walter Rhode), Sabine Bethmann (Irene Rhode), Valery Inkijinoff (Yama, gran sacerdote), René Deltgen (principe Ramigani), Jochen Brockmann (Padhu), Jochen Blume (Asagara), Luciana Paoluzzi (Baharani), Guido Celano (General Dagh), Angela Portaluri (contadina), Richard Lauffen (Bhowana), Helmut Hildebrand (servitore di Ramigani), Panos Papadopoulos (messaggero); Eastmancolor; durata 97 min (La tigre), 101 min (Il sepolcro); data e luoghi delle riprese 5-8- novembre 1959, Udaipur, Jaipur (Rajasthan, Indien), CCC-Studios, Berlin-Spandau; distribuzione Gloria; première Hannover, 22 gennaio 1959 (La tigre), Stuttgart, 5 marzo 1959 (Il sepolcro).
1960 Die 1000 Augen des Dr. Mabuse (Il diabolico dottor Mabuse) produzione CCC-Filmkunst, Berlin, Cei-Incom, Roma, Critérion Films, Paris; produttore Artur Brauner; regia Fritz Lang; sceneggiatura Fritz Lang, Heinz Oskar Wuttig; da un’idea di Jan Fethge; musiche Bert Grund, Gerhard Becker; canzone Schau ich zum Himmelszelt di Werner Müller; fotografia Karl Löb; montaggio Traute e Walter Wischniewsky; architetto scenografo Erich Kettelhut, Johannes Ott; costumi Ina Stein; suono Eduard Kessel; direttore di produzione Alfred Bittins; interpreti Dawn Addams (Marion Menil), Peter Van Eyck (Henry B. Travers), Gert Fröbe (commissario Kras), Wolfgang Preiss (professor Jordan), Werner Peters (Hieronymus B. Mistelzweig), Lupo Prezzo (Cornelius), Andrea Checchi (Berg), Marie Luise Nagel (la «felicità bionda»), Reinhard Kolldelloff (Piede equino), Howard Vernon (No. 12), Nico Pepe (gestore dell’hotel), Jean-Jacques Delbo (servitore), David Camerone (Parker), Linda Sini (Corinna), Werner Buttler (No. 11), Rolf Möbius (ufficiale di polizia), Bruno W. Pantel (primo giornalista), Albert Bessler (ingegnere dell’hotel); durata 103 min; data e luoghi delle riprese 5 giugno 1960, CCC-Studios, Berlin-Spandau; distribuzione Prisma; première Stoccarda, 14 settembre 1960. FRITZ LANG ATTORE
1963 Le mépris (II disprezzo) produzione Rome-Paris Films, Paris, Films Concordia, C.C. Champion, Roma; regia Jean-Luc Godard; sceneggiatura Jean-Luc Godard; da un romanzo di Alberto Moravia; interpreti Brigitte Bardot, Jack Palance, Fritz Lang (che recita se stesso), Michel Piccoli, Georgia Moll; première Parigi, 20 dicembre 1963.
Bibliografia essenziale a cura di Arianna Vergari SCRITTI DI LANG F. Lang, Kontingentverfahren und Qualitätsfilme, in «Der Film», n. 30, 23 luglio 1922. F. Lang, Aufgelöste Massen, in «De Film-Gids», 2 aprile 1924. F. Lang, Arbeitsgemeinschaft im Film, in «Der Kinematograph», n. 887, 17 febbraio 1924. F. Lang, Kitsch Sensation Kultur und Film, in E. Beyfuss, A. Kossowsky (a cura di), Das Kulturfilmbuch, Berlin, Chryselius, 1924 (trad. it. Id., Kitsch - sensazione - cultura e cinema, in P. Bertetto, B. Eisenschitz [a cura di], Fritz Lang. La messa in scena, Torino, Lindau, 1993). F. Lang, Mein ideales film-Manuskript, in «Film-Kurier», 24 marzo 1924. F. Lang, Stilwille im Film, in «Jugend», n. 3, 1924. F. Lang, Was ich in Amerika sah, in «Filmkurier», 11, 13 e 17 dicembre 1924. F. Lang, Was lieben und hassen wir am amerikanischen Film, in «Deutsche Filmwoche», n. 23, 2 ottobre 1925. F. Lang, Moderne Filmregie, in «Filmbühne», n. 1, 1927. F. Lang, Was ich noch zu sagen habe, «Mein Film», n. 59, 1927. F. Lang, Fritz Lang über sich selbst, in H. Treuner (a cura di), Filmkün stler. Wir über uns selbst, Berlin, Sibyllen-Verlag, 1928. F. Lang, Die mimische Kunst im Lichtspiel, in «Der Film», n. 1, 1° gennaio 1929. F. Lang, Mein Film M: Ein Tatsachenbericht, in «Die Filmwoche», 20 maggio 1931. F. Lang, I Do Not Believe in Censorship, in «Los Angeles Daily News», 15 agosto 1946. F. Lang, On the Problems of Today, in «Films and Filmings», n. 9, giugno 1962. F. Lang, Fitz Lang vous parle, in «Cinéma 62», n. 70, 1962. F. Lang, La nuit viennoise. Une confession de Fritz Lang, a cura di G. Berg, in «Cahiers du cinéma», n. 169, agosto 1965; n. 179, giugno 1966. F. Lang, Trois lumières. Écrits sur le cinéma (1964), a cura di A. Eibel, Paris, Ramsay, 2007. INTERVISTE G. Bachmann, The Impact of Television on Motion Pictures, in «Film Culture», n. 2, dicembre 1957. G. Berg, Fritz Lang, “Contempt”, in «Take One», n. 2, novembre-dicembre 1968. C. Beylie, B. Tavernier, Fritz Lang. Ordre et génie, in «Ecran», n. 51, ottobre 1976. M. Ciment, G. Fofi, L. Seguin, R. Tailleur, Fritz Lang à Venise, in «Positif», n. 94, aprile 1968. E. Creelman, Fritz Lang Discusses His Latest Film, Woman in the Window, in «The New York Sun», 6 ottobre 1944.
M. Delahaye, J. Wagner, Fritz Lang entre deux portes, in «Présence du Cinéma», luglio-settembre 1959. J. Domarchi, J. Rivette, Entretien avec Fritz Lang, in «Cahiers du cinéma», n. 99, settembre 1959. W. Friedkin, Entretien de Fritz Lang avec William Friedkin, videointervista, 21-24 febbraio 1975. G. Gandert, Fritz Lang über M: Ein Interview, in G. Gandert, U. Gregor, M, Hamburg, Marion von Schröder, 1963. H. Hart, Fritz Lang Today, in «Films in Review», giugno-luglio 1956. P. Haudiquet, Rencontre avec Fritz Lang et Charles Boyer, in «La Cinématographie Française», 29 aprile 1964. C. Higham, J. Greenberg, Fritz Lang, in Iid., The Celluloid Muse. Hollywood Directors Speak, London-New York, Angus & Robertson-Henry Regnery, 1969. E. Jawitz, Gespräche mit Regisseuren. Paul Wegener, Fritz Lang, in «FilmKurier», 24 marzo 1924. R. Jungk, Der Star, von dem Man spricht, in «Stuttgarter Zeitung», 8 dicembre 1950. A. Kossowsky, Türme und Katakomben, Gespräch mit Fritz Lang, in «FilmKurier», n. 151, 30 giugno 1925. M. Mardore, Fritz Lang dit: «L’Amérique ne m’a pas dévoré, j’y ai beaucoup appris», in «Les Lettres françaises», n. 904, 7 dicembre 1961. P. Mazars, Je ne recherche pas le crime pour lui-même, in «Le Figaro littéraire», 9 dicembre 1961. L. Mishkin, What’s Wrong with Films? Here’s Fritz Lang’s Version, in «New York Morning Telegraph», 8 giugno 1941. J.-L. Noames, Nouvel entretien avec Fritz Lang, in «Cahiers du cinéma», n. 156, giugno 1964. C.J. Philippe, Une entretien avec Fritz Lang, in «Télérama», n. 599, luglio 1961. G.D. Phillips, Fritz Lang Remembers, in «Focus on Film», 1975. M. Shivas, Fritz Lang Talks About Dr. Mabuse, in «Movie», n. 4, novembre 1962. L. Spitzer, Fritz Lang über den Film der Zukunft, in «Die Filmtechnik», n. 2, 15 luglio 1925. M. Tazelar, Fritz Lang Likes Hollywood, America and Social Themes, in «New York Herald Tribune», 7 febbraio 1937. N. Wendevogel, Scharf und schnell: Fritz Lang, in «Der Tagesspiegel», 1° luglio 1971. MONOGRAFIE E VOLUMI SU LANG R.A. Armour, Fritz Lang, Boston, Twayne, 1978. R. Aurich et al. (a cura di), Fritz Lang. Leben und Werk, Berlin, Jovis, 2001. N. Bedeković, A. Kraß, A. Lembke, Durchkreuzte Helden. Das Nibelungenlied und Fritz Langs Film Die Nibelungen im Licht der Intersektionalitätsforschung, Bielefeld, Transcript, 2014. P. Bertetto, Fritz Lang Metropolis, Torino, Lindau, 1990 (4a ed. ampliata 2007). P. Bertetto, B. Eisenschitz (a cura di), Fritz Lang. La messa in scena, Torino, Lindau, 1993 (ed. francese Fritz Lang. La mise en scène, Paris,
Cinémathèque française, 1994; ed. spagnola Fritz Lang, Valencia, Filmoteca de la Generalitat Valenciana, 1995). P. Bogdanovich, Fritz Lang in America, New York, Praeger, 1967 (trad. it. Id., Il cinema secondo Fritz Lang, Parma, Pratiche Editrice, 1988). J.-L. Bourget, Fritz Lang, Ladykiller, Paris, Presses Universitaires de France, 2009 K. Bruns, Kinomythen 1920-1945. Die Filmenwurfe der Thea von Harbou, Stuttgart, Metzler, 1993. Q. Casas, Fritz Lang, Madrid, Cátedra, 1991. M. Ciment, Fritz Lang. Le meurtre et la loi, Paris, Découvertes Gallimard, 2003. F. Courtade, Fritz Lang, Paris, Le Terrain Vague, 1963. D. Dürrenmatt, Fritz Lang. Leben und Werk, Basel, Museum des Films, 1982. A. Eibel, Fritz Lang, Paris, Klincksieck, 2017. B. Eisenschitz, Man Hunt de Fritz Lang, Crisnée, Yellow Now, 1992. B. Eisenschitz, Fritz Lang au travail, Paris, Cahiers du cinéma, 2011. L.H. Eisner, L’écran démoniaque, Paris, André Bonne, 1952 (trad. it. Id., Lo schermo demoniaco, Roma, Editori Riuniti, 1983). L.H. Eisner, Fritz Lang, London, Secker & Warburg, 1976 (trad. it. Id., Fritz Lang, Milano, Mazzotta, 1978). T. Elsaesser, Metropolis, London, BFI, 2000. F. Gehler, U. Kasten, Fritz Lang: Die Stimme von Metropolis, Berlin, Henschel, 1990. G. Geser, Fritz Lang. Metropolis und Die Frau im Mond. Zukunftsfilm und Zukunftstechnik in der Stabilisierungszeit der Weimarer Republik, Meitingen, Corian-Verlag H. Wimmerer, 1996. F. Grafe, E. Patalas, H. Prinzler, P. Syr, Fritz Lang, München, Carl Hanser Verlag, 1976. B. Grant, Fritz Lang: Interviews, Jackson, University of Mississippi, 2003. T. Gunning, The Films of Fritz Lang: Allegories of Vision and Modernity, London, BFI, 2000. R. Humphries, Fritz Lang. Cinéaste américain, Paris, Albatros, 1982 (rev. e trad. inglese Id., Fritz Lang. Genre and Representation in His American Films, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1989). S. Jenkins (a cura di), Fritz Lang. The Image and the Look, London, BFI, 1981. P. Jensen, The Cinema of Fritz Lang, New York-London, Barnes & CoZwemmer Ltd.,1969. C. Johnston, Study Unit 10. Fritz Lang: Notes on Film Material, London, BFI, 1969. A. Kaes, M, London, BFI, 1999. E.A. Kaplan, Fritz Lang. A Guide to References and Resources, Boston, G.K. Hall, 1981. R. Keiner, Thea von Harbou und der deutsche Film bis 1933, Zürich-New York-Hildesheim, Olms, 1984. S. Kracauer, From Caligari to Hitler, Princeton, Princeton University Press, 1947 (trad. it. Id., Il cinema tedesco dal “Gabinetto del Dr. Caligari” a Hitler, Milano, Mondadori, 1977). F. Latell, W. Sudendorf (a cura di), Fritz Langs Metropolis, Berlin, Stiftung Deutsche Kinemathek, 2010. G. Leblanc, B. Devismes, Le double scénario chez Fritz Lang, Paris, Armand Colin, 1991.
M. Lefeuvre, Comprendre et interpréter un storyboard. L’exemple de Ministry of Fear de Fritz Lang, 1944, Paris, Bibliothèque du Film (BiFi), 2004. D.J. Levin, Richard Wagner, Fritz Lang, and the Nibelungen. The Dramaturgy of Disavowal, Princeton, Princeton University Press, 1998. L. Maibohm, Fritz Lang. Seine Filme - sein Leben, München, Wilhelm Heyne Verlag, 1981. C. McArthur, The Big Heat, London, BFI, 1992. J. McElhaney (a cura di), A Companion to Fritz Lang, Oxford, John Wiley & Sons, 2015. P. McGilligan, Fritz Lang: The Nature of the Beast, London, Faber and Faber, 1997. F. Mendez-Leite von Hafe, Fritz Lang. Su vida y su cine, Barcelona, Dai mon, 1980. M. Mesnil, Fritz Lang. Le Jugement, Paris, Michalon, 1996. J. Mikuz, Fritz Lang, Ljubljana, Moderna Galerija, 1985. M. Minden, H. Bachmann (a cura di), Fritz Lang’s Metropolis. Cinematic Visions of Technology and Fear, New York, Camdem House, 2000. L. Moullet, Fritz Lang, Paris, Editions Seghers, 1963. FW. Ott, The Films of Fritz Lang, Secaucus, The Citadel Press, 1979. C. Schnauber, Fritz Lang in Hollywood, Wien, Europa Verlag, 1986. H. Schönemann, Fritz Lang. Filmbilder, Vorbilder, Berlin, Potsdam MuseumHentrich, 1992. M. Sesti (a cura di), Fritz Lang, Roma, Edizioni Carte Segrete-Comune di Roma, 1990. N. Simsolo, Fritz Lang, Paris, Edilig, 1985. S. Socci, Fritz Lang, Milano, Il Castoro, 1995. G. Sturm, Fritz Lang. Films, textes, références, Nancy, Presses Universitaires, 1990. M. Töteberg, Fritz Lang in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Reinbek, Rowohlt, 1985. S. Villani, L’essenza e l’esistenza. Fritz Lang e Jean Renoir: due modelli di regia, due modelli di autore, Torino, Lindau, 2007. H. Weihsmann, Gebaute Illusionen. Architektur im Film, Wien, Promedia, 1988. H.G. Weinberg, An Index to the Creative Work of Fritz Lang, supplemento di «Sight and Sound», Index Series, n. 5, febbraio 1946. SAGGI E ARTICOLI SU LANG A. Aprà, Cloak and Daggers: esempi dello stile di Fritz Lang, in «Film critica», 1963. R. Bellour, Sur Fritz Lang, in «Critique», n. 226, marzo 1966. M. Bernstein, Fritz Lang, Incorporated, in «Velvet Light Trap», n. 22, 1986. M. Bernstein, A Tale of Three Cities: The Banning of Scarlet Street, in «Cinema Journal», n. 1, autunno 1995. P. Bertetto, Lang e l’UFA. Le tecniche realizzative e la forma assoluta, in G. Spagnoletti (a cura di), Schermi germanici. UFA 1917-1933, Venezia, Marsilio, 1993. P. Bertetto, Otto Hunte. Entwurfe fur “Die Nibelungen”, in A. Arns, H.P. Reichmann (a cura di), Otto Hunte: Architekt für den Film, Frankfurt am Main, Deutsches Filmmuseum, 1996.
P. Bertetto, Dr. Mabuse e M. Il superuomo bipolare e il soggetto parafrenico, in Id., Microfilosofia del cinema, Venezia, Marsilio, 2014. P. Bertetto, Lang, la volontà di stile e l’intensità, in Id., Il cinema e l’estetica dell’intensità, Milano-Udine, Mimesis, 2016. C. Beylie, L’œuvre allemande de Fritz Lang, in «L’Avant-Scène Cinéma», n. 39, luglio-agosto 1964. C. Beylie, L’œuvre américaine de Fritz Lang (1936-1956), in «L’AvantScène Cinéma», n. 78, febbraio 1967. M. Blumenthal-Barby, Faces of Evil. Fritz Lang’s Dr. Mabuse, the Gambler, in «Seminar. A Journal of Germanic Studies», vol. 49, n. 3, 2013. C. Blümlinger, Narrazione e fermo immagine. La leggenda di Liliom di Fritz Lang (1997), in «Imago», vol. 11, n. 1, 2015. P. Bogdanovich, Fritz Lang, in Id., Chi ha fatto quel film? Conversazioni con i grandi registi di Hollywood, Roma, Fandango libri, 2010. A. Brauner, Fritz Lang war nicht zu bändigen, in «Die Zeit», 21 dicembre 1966. S. Bruzzi, Imperfect Justice: Fritz Lang’s Fury (1936) and Cinema’s Use of the Trial Form, in «Law and Humanities», vol. 4, n. 1, 2010. L. Buñuel, Metropolis, in «Cahiers du cinéma», n. 223, agosto-settembre 1971. N. Burch, De “Mabuse” à “M”. Le travail de Fritz Lang, in «Revue d’esthétiques, 1973. N. Burch, D. Jorge, Propositions, in «Afterimage», primavera 1974. E. Butler, Dr. Mabuse. Terror and Deception of the Image, in «German Quarterly», vol. 78, n. 4, 2005. E. Cieslik, The Monster and the Mob. A Critical Analysis of Fritz Lang’s Fury (1936) and James Whale’s Frankenstein (1931), in «Film Matters», vol. 12, n. 2, 2021. J-L. Comolli, F. Géré, Deux fictions de la haine, in «Cahiers du cinéma», n. 286, marzo 1978. H. Cossar, “Wait, how did I miss that?”. Understanding the “Twist” in Fritz Lang’s The Woman in the Window, in «Quarterly Review of Film and Video», vol. 26, n. 1, 2009. M. Cowan, The Heart Machine: “Rhythm” and Body in Weimar Film and Fritz Lang’s Metropolis, in «Modernism/Modernity», vol. 14, n. 2, 2007. J. Crary, Dr. Mabuse and Mr. Edison, in K. Brougher (a cura di), Art and Film since 1945. Hall of Mirrors, Liverpool, Tate Gallery, 1996. G. Crippa, Un mondo diviso, un oggetto mancante. Montaggio alternato e perversione del desiderio in M. di Fritz Lang, in «Comunicazioni sociali», vol. 42, n. 2, 2020. R. Dadoun, Le pouvoir et sa folie (d’après M le maudit), in «Positif», n. 188, 1976. S. Daney, L’invraisemblable vérité, in «Libération», 18 luglio 1981, riportato in S. Daney (a cura di), Ciné journal: 1981-1986, Paris, Cahiers du cinéma, 1986. B. Davis, Fritz Lang’s Dr. Mabuse Trilogy and the Horror Genre, 1922-1960, in S. Hantke (a cura di), Caligari’s Heirs: The German Cinema of Fear after 1945, Lanham, Scarecrow Press, 2007. M. Del Ministro, Lang, in Id., Cinema tra immaginario e utopia, Bari, Dedalo, 1984. N. Deyo, Ministry of Fear. Fritz Lang’s De-suturing Operation, in Id., Film Noir and the Possibilities of Hollywood, London, Palgrave Macmillan, 2020.
E. Dimendberg, From Berlin to Bunker-Hill: Urban Space, Late Modernity, and Film Noir in Fritz Lang’s and Joseph Losey’s M, in «Wide Angle», vol. 19, n. 4, 1997. J. Domarchi, Avec M Fritz Lang en 1932 annonçait la destinée de l’Allemagne, in «Arts», nn. 8-9, 1961. W.C. Donahue, The Shadow Play of Religion in Fritz Lang’s Metropolis, in «New England Review», vol. 24, n. 4, 2003. J. Douchet, L’étrange obsession, in «Cahiers du cinémas», n. 122, agosto 1961. J. Douchet, Dix-sept plans, in R. Bellour (a cura di), Le Cinéma américain. Analyses de films, Paris, Flammarion, 1980. P. Dubois, Le cinéma en procès, selon Fritz Lang, in C. Biet, L. Schifano (a cura di), Représentations du procès: droit, théâtre, littérature, cinéma, Nanterre, Université Paris X-Nanterre, 2003. L.H. Eisner, Notes sur le style de Fritz Lang, in «La Revue du Cinéma», n. 5, febbraio 1947. L.H. Eisner, The German Films of Fritz Lang, in «The Penguin Film Review», n. 6, aprile 1948. T. Elsaesser, Fritz Lang’s Traps for the Mind and Eye. Dr Mabuse the Gambler and Other Disguise Artists, in Id., Weimar Cinema and After. Germany’s Historical Imaginary, London-New York, Routledge, 2000. T. Elsaesser, Too Big and Too Close: Alfred Hitchcock and Fritz Lang, in S. Gottlieb, R. Allen (a cura di), The Hitchcock Annual Anthology, New York, Wallflower Press, 2009. G. Franju, Le style de Fritz Lang, in «Cinématographes», n. 3, 1937. K. Freund, Meine Arbeit an Metropolis, in «B.Z. am Mittag», 7 gennaio 1927. G. Fofi, Fritz Lang, in R. Bellour (a cura di), Il Western: fonti, forme, miti, registi, attori, filmografia, Milano, Feltrinelli, 1973. G. Gandert Gero, Fritz Lang, in «Kinemathek», n. 20, novembre 1965. K. Gellen, Indexing Identity: Fritz Lang’s M, in «Modernism/Modernity», vol. 22, n. 3, 2015. G. Gemünden, Brecht in Hollywood: Hangmen Also Die! and the Anti-Nazi Film, in «TDR/The Drama Review» n. 4, inverno 1999. D. Golding, The Darker Side of Fritz Lang’s Metropolis. Coloniality in Modernist Cinema, in «Postcolonial Studies», vol. 22, n. 3, 2019. N. Grob,“Bringing the Ghostly to Life”. Fritz Lang and His Early Dr. Mabuse Films, in D. Scheunemann (a cura di), Expressionist Film. New Perspectives, Rochester, Camden, 2003. F. Guerin, The Spell of Light. Cinema as Modern Magic in Faust, Der Golem, Siegfried, and Metropolis, in Id., A Culture of Light. Cinema and Technology in 1920s Germany, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2005. S. Hall, Trading Places. Dr. Mabuse and the Pleasure of Role Play, in «German Quarterly», vol 76, n. 4, 2003. T. Herzog, Fritz Lang’s M (1931): An Open Case, in N. Isenberg (a cura di), Weimar Cinema. An Essential Guide to Classic Films of the Era, New York, Columbia University Press, 2009. S. Hoklas, Allegorien der modernen Großstadt bei Fritz Lang: Von der historischen Weltstadt über die Zukunftsmetropole zum aktuellen Zeitbild, in G. Dietze, D. Dornhof (a cura di), Metropolenzauber. Sexuelle Moderne und urbaner Wahn, Wien, Böhlau Verlag, 2014. E. Horn, Media of Conspiracy: Love and Surveillance in Fritz Lang and Florian Henckel von Donnersmarck, in «New German Critique», n. 103,
2008. S. Jacobs, Panoptic Paranoia and Phantasmagoria: Fritz Lang’s Nocturnal City, in J. Fisher, B. Mennel, Spatial Turns. Space, Place, and Mobility in German Literary and Visual Culture, Leiden, Brill, 2010. M. Jancovich, “Master of Concentrated Suspense”. Horror, Gender and Fantasy in the Critical Reception of Fritz Lang during the 1940s, in «Studies in European cinema», vol. 5, n. 3, 2009. A. Kaes, A Stranger in the House: Fritz Lang’s Fury and the Cinema of Exile, in «New German Critique», vol. 89, 2003. E.A. Kaplan, The Place of Women in Fritz Lang’s The Blue Gardenia, in Id. (a cura di), Women in Film Noir (1978), London, BFI, 1998. T. Kłys, Fiancées and Widows. Women’s Encounters with Death in the Silent Films of Fritz Lang, in «Images», vol. 25, n. 34, 2019. L. Koepnick, Rilke’s Rumblings and Lang’s Bang, in «Monatshefte», vol. 98, n. 2, 2006. H. Lange, Nazis vs. the Rule of Law: Allegory and Narrative Structure in Fritz Lang’s M, in «Monatshefte», vol. 101, n. 2, 2009. L. Laufer Lupino, Adolf Loos e Fritz Lang. Lo spazio dell’angoscia, in «Cinema Sessanta», nn. 5-6, settembre-dicembre 1989. A. Lennig, Fritz Lang, in Id., The Silent Voice: A Sequel, Albany, SUNYA, Faculty-Student Association, 1967. A. McAuley, Savior of the Working Man. Promethean Allusions in Fritz Lang’s Metropolis (1927), in M.S. Cyrino, M.E. Safran, Classical Myth on Screen, New York, Palgrave Macmillan, 2015. R. McCormick, A. Guenther-Pal, Fritz Lang. The Artistic Composition of the Film Drama, in Iid. (a cura di), German Essays on Film, London, Continuum, 2004. B. Mennel, White Law and the Missing Black Body in Fritz Lang’s Fury (1936), in «Quarterly Review of Film and Video», vol. 20, n. 3, 2003. D. Miyao, The Hand of Buddha: Madame Butterfly and the Yellow Peril in Fritz Lang’s Harakiri (1919), in «Quarterly Review of Film and Video», vol. 33, n. 8, 2016. P. Molina-Siles, Drawing Metropolis. The architectural dream of Fritz Lang, in «EGA. Revista de expresión gráfica arquitectónica», vol. 22, n. 29, 2017. L. Moullet, Fritz Lang, in P. Bertetto (a cura di), Azione! Come i grandi registi dirigono gli attori, Roma, minimum fax, 2007. S. Müller, Embodied Cognition and Camera Mobility in F. W. Murnau’s The Last Laugh and Fritz Lang’s M, in «Paragraph. A Journal of Modern Critical Theory», vol. 37, n. 1, 2014. J. Olive, Les structures de l’enfermement urbain de Metropolis à Blade Runner, in «Les Cahiers de la Cinémathèque», n. 44, 1985. D. Orth, Fritz Lang, Long Takes und die Plansequenz, in S. Brössel, S. Kaul (a cura di), Echtzeit im Film. Konzepte - Wirkungen - Kontexte, München, Brill-Fink, 2020. E. Rhode, Fritz Lang (The German Period 1919-1933), in Id., The Tower of Babel, London, Weidenfeld and Nicholson, 1966. J. Rivette, La Main, in «Cahiers du cinéma», n. 76, novembre 1957. I. Roberts, Primitive Miasmas and the Iconography of the Future in Fritz Lang’s Frau Im Mond (1929), in «Studies in European cinema», vol. 12, n. 2, 2015. J. Samper Vendrell, The Queer Threat to Civilization in Fritz Lang’s M, in «The Germanic review», vol. 92, n. 3, 2017.
A. Sarris, Fritz Lang (1890-1976): Was the Prophet of Our Paranoia, in «The Village Voice», 16 agosto 1976. P.H. Schröder, Ornament und Ideologie, in «Filmkritik», n. 8, 1964. T. Schur, Early Nothing. Fritz Lang’s Dialectic of Enlightenment, in «Quarterly Review of Film and Video», vol. 32, n. 4, 2015. N. Smedley, Fritz Lang’s Trilogy: The Rise and Fall of a European Social Commentator, in «Film History», vol. 5, n. 1, 1993. G. Stoicea, Re-Producing the Class and Gender Divide: Fritz Lang’s Metropolis, in «Women in German Yearbook», vol, 22, n. 1, 2006. M. Tratner, Lovers, Filmmakers, and Nazis: Fritz Lang’s Last Two Movies as Autobiography, in «Biography», vol. 29, n. 1, 2006. H. Treuner, Fritz Lang, ein Meister des Deutschen Films, in «Tägliche Rundschau», 6 novembre 1927. F. Truffaut, Fritz Lang en Amérique, in Id., Les films de ma vie, Paris, Flammarion, 1975 (trad. it. Id., I film della mia vita, Venezia, Marsilio, 1978). T. Welsch, Sound Strategies: Lang’s Rearticulation of Renoir, in «Cinema Journal», vol. 39, n. 3, 2000. W. Wenders, Sein Tod ist keine Lösung, in «Der Spiegel», 1976. G. Werner, Fritz Lang and Goebbels: Myths and Facts, in «Film Quarterly», vol. 43, n. 3, 1990. D. Willis, Fritz Lang: Only Melodrama, in «Film Quarterly», n. 2, inverno 1979-1980. S. Wodianka, Fritz Lang in Hollywood. Das mythische Eigene und die Fremdheit des Mythos, in «Cahiers d’Études Germaniques», n. 76, 2019. R. Wood, Rancho Notorious: a Noir Western in Colour, in «CineAction!», nn. 13-14, estate 1988. A.P. Young, Noir and Exilic Cinema. Fritz Lang’s Fury, Trauma, and the German Critique, in «The Journal of Popular Film and Television», vol. 49, n. 2, 2021. F. Zappe, In the Shadow of the “Indeterminate Speech-Act”. The Populist Politics of Rumor in Fritz Lang’s Early Sound Films, in «European Journal of American Studies», vol. 15, n. 4, 2020. NUMERI SPECIALI DI RIVISTE DEDICATI A LANG «Cahiers du cinéma», n. 99, settembre 1959; n. 437, 1990. «Cinéma 82», n. 282, giugno 1982. «Cinémonde», n. 973, 27 marzo 1953. «Current Biography», maggio 1942. «Image et Son», n. 216, aprile 1968 «Mise en Scène», n. 1, 1972 «Positif», n. 11, settembre 1954; n. 188, 1976; n. 285, 1984, nn. 365-366, 1991. «Trafic», n. 41, primavera 2002. «UFA Magazine», numero speciale Metropolis, 1927.
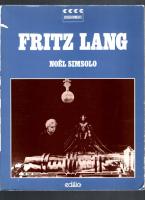





![Schattenbilder - Lichtgestalten: Das Kino von Fritz Lang und F.W. Murnau. Filmstudien [1. Aufl.]
9783839411032](https://ebin.pub/img/200x200/schattenbilder-lichtgestalten-das-kino-von-fritz-lang-und-fw-murnau-filmstudien-1-aufl-9783839411032.jpg)


