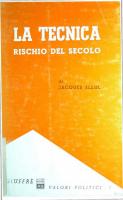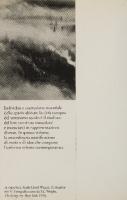Figure femminili del sapere (XII-XV secolo) 8843017318, 9788843027323
Dalle Mille e una Notte al Medioevo castigliano e francese, ecco una serie di studi intorno alle immagini femminili del
202 100 2MB
Italian Pages 138 [142] Year 2003
Recommend Papers

- Author / Uploaded
- Patrizia Caraffi
File loading please wait...
Citation preview
BIBLIOTECA MEDIEVALE SAGGI/
12.
Collana diretta da Mario Mancini, Luigi Milone e Francesco Zambon
A Mina, Dea e Stella
I lettori che desiderano informazioni sui volumi pubblicati dalla casa editrice possono rivolgersi direttamente a: Carocci editore via Sardegna so, 00187 Roma, telefono o6 l 42 81 84 17, fax o6 l 42 74 79 31
Visitateci sul nostro sito Internet: http://www.carocci.it
Patrizia Caraffi
Figure femminili del sapere (XII-XV secolo)
Carocci editore
Volume pubblicato con il contributo del MIUR e dell'Università di Bologna.
1" edizione, luglio 1003 © copyright 1003 by Carocci editore S.p.A., Roma
Finito di stampare nel luglio 1003 dalle Arti Grafiche Editoriali srl, Urbino ISBN
88-430-1731-8
Riproduzione vietata ai sensi di legge (art. 171 della legge 11 aprile 1941, n. 633) Senza regolare autorizzazione, è vietato riprodurre questo volume anche parzialmente e con qualsiasi mezzo, compresa la fotocopia, anche per uso interno o didattico.
Indice
Introduzione
9
I,
Alleanze e saperi femminili nei Lais di Maria di Francia
15
1.
Medea, donna divina
37
3·
Tawaddud, Teodor e il sapere delle fanciulle
67
4·
Tarsiana, nobile giullaressa
91
5·
Christine de Pizan e Boccaccio: silenzio e crudeltà
7
123
Introduzione
Nella Epistre au Dieu d'Amours (1399)1 Christine de Pizan scrive: Mais se /emmes eussent !es livres fait l je sçay de vray
que autrement fust de fait, l car bien scevent qu'a tort son t encoulpées ( Ma se le donne avessero scritto i libri, l so per certo che sarebbe stato diverso, l poiché ben sanno che a torto sono accusate, vv. 417-419) . La tradizione scritta, da sempre maschile, afferma la scrittrice, rappresenta le donne in modo falsato e solo parziale. L'assenza di una tradizione intellettuale femminile , infatti, non è dovuta ad una presunta inferiorità naturale delle donne così tanto teorizzata, ma a un vuoto nell 'educazione delle fanciulle; il diritto al sapere e alla parola pubblica viene ribadito con forza nella Cité des Dames (1405) , in particolare nel I libro, tutto dedicato alle figure fondatrici della civiltà, del sapere e delle arti. Nel dia logo tra Christine e Ragione, l'autrice affronta la questione delle capacità intellettuali femminili: Sans faille, Dame, voirement monstra Dieux grans merveilles en la force d'ycelles femmes dont vous comptez, mais ancores me fait sage, s'il vous plait, s'il a point pleu a cellui Dieu qui tant leur fait de graces de honorer le sexe femenin par previlegier aucunes d'd Ies de vertu, de hault entendement et grant sciences, et se elles ont point l' engin abile a ce, car je le desire moult savoir pour ce que hommes maintiennent que entendement de femme est de petite apprehesive. (Dama, certamente Dio fece meraviglie con la forza di quelle dame di cui raccontate. Ma spiegatemi ancora, vi prego, se Dio, che ha concesso loro tante grazie, non ha mai voluto onorare il sesso fem minile concedendo ad alcune donne la virtù, una grande intelligen9
FIGURE FE.\1:\U:-;IU DEL SAPERE
za e un profondo sapere, e se esse hanno un ingegno capace di questo. Desidero molto saperlo, perché gli uomini affermano che le donne hanno scarse capacità intellettuali.)l Nella risposta di Ragione, la differenza tra uomo e donna è di tipo culturale e non naturale , riconducibile alla diversa educazione ricevuta: Je te dis derechief, et ne doubtes le contraire, que se coustume estoit de mettre les petites filies a l'escole et que suivamment on les feist apprendre les sciences, camme on faiz aux fùz, qu' elles apprendroient aussi parfaictement et entendroient les soubtilletéz de toutes les ars et sciences, camme ilz font. (Te lo ripeto, e non dubitare del contrario, che se ci fosse l'usanza di mandare le bambine a scuola e di insegnare loro le scienze come si fa con i bambini, imparerebbero altrettanto bene e capi rebbero le sottigliezze di tutte le arti, così come essi fanno.)3 L'esclusione delle donne dal sapere e dalla parola pubblica, così ben evidenziata da Christine de Pizan, ha origini molto antiche e trova la sua giustificazione teorica nelle dottrine elaborate da Aristotele intorno alla natura femminile, poi riprese nel Medioevo da teologi e filosofi, in particolare da Tommaso d'Aquino4. La donna è considerata mas occasiona tus. maschio difettoso, secondaria, per natura imperfetta, quindi anche inadatta allo studio delle lettere. Nell 'ordine simbolico patriarcale il maschile è identificato con il pensie ro razionale e la donna semmai è carne, corpo, seduzione. In tutto imperfetta e fonte di ogni vizio, quando una donna parla, racconta o canta, è pericolosa. Voce, corpo femminile e bellezza, insieme non possono stare, senza tingersi di noir, e non solo per la cultura cattolica, romana, d'Occidente. TI mito antico ha trasmesso al Medioevo numerose rappresen tazioni, perché non si deve dimenticare che di donne imma ginate si trattas, di un femminile vocale sempre mancante di qualcosa. Eco6, in origine molto loquace, è destinata - voce privata del corpo consumato da un amore non corrisposto a ripetere le parole dell'altro. La Sibilla, voce attraversata dal
IO
II'TRODt:ZIO:\E
divino, per il dono che Apollo le ha concesso è condannata a vivere tanti anni quanti i granelli di sabbia che stanno nel pugno della sua mano, e diventa così vecchia, che il suo corpo tutto si secca e rimane solo la voce. Cassandra è dota ta di parola sapiente e profetica, ma non può essere creduta. Le sirene sono donne con il corpo d'uccello, esseri mostruo si che in epoca medievale assumono le caratteristiche di fan ciulle marine , per metà pisciformi. Esse sono dotate di un immenso sapere: «Noi tutto sappiamo, l quanto nell'ampia terra di Troia l Argivi e Teucri patirono per volere dei numi; l tutto sappiamo quello che avviene sulla terra nutrice» (Odissea, 12, 184-191), ma il loro canto seducente è letale7. La tradizione che invoca di continuo il peccato della prima donna, l'eccesso di curiosità e di parola di Eva, ha tramandato un grande desiderio di silenzio femminile. Meglio una donna silenziosa, possibilmente bella, che ascolti, per obbedire, come Penelope o Griselda, che non parli e tantomeno scriva. Così dal Bonium o Bocados de Oro, una delle grandi opere del XIII secolo dedicate al sapere: E vido a una muger que llevava fuego, e dixo: el llevador es peor que el llevado. E vido a una muger enferma que se non podia mover en su lecho, e dixo: el mal queda con el mal. E vio a una muger que llevavan a soterrar e mugeres que lloravan en pos ella, e dixo: duelese el mal porque pierde el mal. E vio una moça que aprendia a escrebir, e dixo: non acrescas mal con el mal8• (E vide una donna che portava il fuoco, e disse: chi porta è peggio di ciò che porta. E vide una donna ammalata che non poteva muo versi dal letto e disse: il male si incontra con il male. E vide il fune rale di una donna e donne che piangevano per lei, e disse: il male si lamenta per aver perso il male. E vide una giovane, mentre stava imparando a scrivere e disse: non aggiungere male ad altro male.) La natura ingannatrice e doppia della donna si riflette sulla sua parola, di cui bisogna sempre diffidare. Autorevoli esem pi in tal senso ci vengono offerti nella letteratura castigliana dalle raccolte di racconti di origine orientale. Nel Cali/a e Dimna (XIII secolo) , i rischi che si corrono a servire un re
II
FIGURE FE.\1:\II:-;ru DEL SAPERE
sono paragonabili solo ai danni di un veleno o alle conse guenze del rivelare i segreti alle donne: Que dizen los sabios que tres cosas son a que se non atreve sinon omne loco, nin estuerçe dellas sinon el sabio; la una es servir rey; la otra es meter las mugeres en su poridat; la terçera bever vidi ganbre a prueva9. (l saggi dicono che tre sono le cose che nessuno osa fare, se non un pazzo, né si salva se non un saggio; la prima è servire un re; la seconda è rivelare un segreto a una donna; la terza bere del veleno per prova.)
E nel Sendebar (XIII secolo), una delle opere più rappresenta tive della letteratura misogina medievale, il più grande perico lo per la regalità è rappresentato proprio dalle parole di una donna, concubina del re, che con la seduzione e l'inganno mette a repentaglio la vita del principe e la stabilità dell'intero regno. Nella disputa tra la donna e i consiglieri del re, che si svolge attraverso la narrazione di racconti, a ritmo serrato, il concetto ribadito più volte dai consiglieri è sempre lo stesso: E yo, seiior, non te di este enxemplo sinon por que sepas el enga iio de las mugeres, que son muy fuertes sus artes e son muchos, que non an cabo nin fin (p. 85) 10 •
(Signore, ti ho raccontato questo esempio perché tu sappia che gli inganni delle donne, dalle molteplici e potenti arti, sono infiniti.) E seiior, non te di este enxemplo, sinon a qu' el engaiio de las mugeres que non an cabo nin fin (p. uo) .
(Signore, ti ho raccontato questo esempio per mostrarti che gli inganni delle donne sono infiniti.) E, seiior, non te di este enxemplo sinon que non creas a las muge
res que son malas, que dize el sabio que «aunque se tornase la tierra papel, e la mar tinta e los peçes d'ella péndolas, que non podrian escrevir las maldades de las mugeres». E el rey mand6la quemar en una caldera en seco (pp. 154-5) . (E, signore, ti ho dato quest'esempio affinché tu non dia ascolto alle donne, che sono malvagie: il saggio dice che «se anche la terra 12
II'TRODL'ZIO:\E
diventasse carta, e il mare inchiostro e i pesci penne, non si potrebbero scrivere le malvagità delle donne». E il re ordinò di mandarla al rogo.) Negli studi raccolti nel presente volume, alcuni dei quali riprendono e approfondiscono argomenti trattati in preceden za11, ho cercato di mettere a fuoco alcune figure femminili del sapere che sfuggono a un sistema di opposti così netto - da una pane un femminile obbediente e muto, dall'altra una voce di donna autonoma e per questo pericolosa - e appaio no più sfumate, e luminose al tempo stesso. Sono fanciulle fragili nel corpo, ma forti nell'animo - come Shahrazàd o la schiava Teodor, che deve confrontarsi in una disputa con i più grandi sapienti del regno, o la principessa Tarsiana, lette rata e musicista, che con la sua arte deliziosa dona gioia e felicità -, o la regina Medea che, rappresentata da Euripide in poi come una terribile maga, nel Medioevo recupera antichi tratti di grandezza e autorità femminili. Accanto a queste figure, due grandi scrittrici del Medioevo francese: Maria di Francia, studiata nel gioco di alleanze e saperi femminili dei Lais, e Christine de Pizan, prima scrittrice di professione del Medioevo europeo. Note 1. Christine de Pizan, Epistre au Dieu d'Amours, in Oeuvres Poétiques ed. M. Roy, Didot, Paris 1886. 2. Christine de Pizan, LA Città delle Dame, a cura di P. Caraffi, ed. di E. ]. Richards, Luni, Milano-Trento 1997, Libro I, cap. XXVII, pp. 150-1; anche Christine de Pz"zt;n. Una città per sé, a cura di P. Caraffi, Carocci, Roma 2003. Rinvio a questi due volumi per la bibliografia critica aggiorna ta su questa grande scrittrice. 3· Christine de Pizan, LA Città delle Dame, cit., pp. 152-3. 4· C. Thomasset, LA natura della donna, in G. Duby, M. Perrot, Storia delle donne in Occzdente, II: Il Medioevo, a cura di Klapisch-Zuber, Later za, Roma-Bari 1990, pp. 56-87; M. T. D'Alvemy, Come vedono la donna i teologi e i filosofi, in M. C. De Matteis, Idee sulla donna nel Medioevo, Patron Editore, Bologna 1981, pp. 259-303. 5· Si veda il bel saggio di C. Frugoni, LA donna nelle immaginz; la donna immaginata, in Duby, Perrot, Storia delle donne in Occidente, II: Il Medioevo, cit ., pp. 424-57; C. Grossinger, Picturing Women in LAte Medie val and Renaissance Art, Manchester University Press, Manchester 1997. de Christine de Pisan,
13
FIGURE FE.'d.'dl:-.:IU DEL SAPERE
6. ]. Cerquiglini-Toulet, Écho et Sibylle, la voix /éminine au Moyen Age, in Le genre de la voix, in "Equinoxe", 23, Automne 2002, pp. 81-91; A. Cavarero, A più voci. Filosofia dell'espressione vocale, Feltrinelli, Milano 2003. 7· E. Cantarella, Itaca. Eroz; donne, potere tra vendetta e diritto, Feltri nelli, Milano 2002; M. Lao, Il libro delle Sirene, Di Renzo Editore, Roma 2000. 8. Bonium o Bocados de Oro, ed. H. Knust, in Mitteilungen aus dem Eskurial, Litterarischen Vereins in Stuttgart, Tiibingen 1879, pp. 66-394, a p. 191. Si veda M. E. Lacarra, Representaciones de mujeres en la literatura de la edad media (escrita en castellano), in l. M. Zavala, Breve historia /eminista de la literatura espaiiola (en lengua castellana), n: La mujer en la literatura espaiiola, Anthropos, Barcelona 1993, pp. 21-68. 9. Cali/a e Dimna, ed. J. M. Cacho Blecua y M. ] . Lacarra, Castalia,
Madrid 1987, p. 130. 10. Sendebar, ed. de M. ]. Lacarra, Càtedra, Madrid 1989. Sulla miso ginia nelle raccolte di racconti medievali, si veda M. J. Lacarra, Algunos datos para la historia de la misoginia en la Edad Media, in Studia Riquer, " Quadems Crema", Barcelona 1986, pp. 339-61. Anche P. Caraffi, Il re, il sapere e gli inganni delle donne nel "Sendebar», in La regalità, a cura di C. Donà e F. Zambon, Carocci, Roma 2002, pp. 203-16. II. Alcuni argomenti esposti in questo volume sono stati trattati in precedenza e pubblicati su rivista o in Atti di convegni: «Entre !es deus out grant amur»: alleanze femminili nei "Lais» di Maria di Francia, in I lais e l 'arte del racconto, in "L'Immagine Riflessa" , 2, 1993, pp. 233-49. Medea sapiente e amorosa: da Euripide a Christine de Pizan, in Actes du IIIème Colloque lnternational "Christine de Pizan» (Lausanne, 1�22 juillet 1998), Champion, Paris 2000, pp. 133-47; Medea medievale, in Atti della SIFR, Pisa 28-30 settembre 2000, in "Studi Mediolatini e Volgari", XLVll, 2001, pp. 223-37; Le parole di Tarsiana. Sul motivo della "fanciulla perseguitata» nel "Libro de Apolonio», in "Messana", n.s., 8, 1991, pp. 109-28; La malinconia del re nel "Libro de Apolonio», in Filologia romanza e cultura medievale. Studi in onore di Elio Mel/i, a cura di A. Fassò, L. Formisano, M. Manci ni, Edizioni dell'Orso, Alessandria 1998, pp. 195-203; Silence des /emmes et cruauté des hommes: Christine de Pizan e Boccaccio, in Context and Conti nuities. Proceedings o/ the IVth lnternational Colloquium on Christine de Pizan (Glasgow 21-27 ]uly 2ooo) published in honour o/ Liliane Dulac, ed.
by A. Kennedy, R. Brown-Grant, J. Laidlaw and C. Miiller, 3 voli ., vol. I, pp. I7S-86. Tutti hanno subito profonde modifiche. n capitolo 3 è inedito.
14
I
Alleanze e saperi femminili nei Lais di Maria di Francia
1. Maria di Francia, una delle scrittrici più autorevoli del Medioevo, fu attiva nella seconda metà del XII secolo, ma i suoi versi eleganti e pieni di charme sono giunti fino a noi con intatta capacità di suscitare grandi emozionP. La firma di Maria di Francia compare in tre opere attribuite alla stes sa mano, databili tra il n6o e il 1190: le Fables, Marie ai num, si sui de France (ll mio nome è Maria e sono francese, v. 4) ,
l'Espurgatoire Saint Patrice, ]o, Marie, ai mis, en memoire, l le livre de l'Espurgatoire (io, Maria, ho scritto l il libro del Purgatorio, vv. 297-298) e i Lais, Oà., seignurs, ke dit Marie (Udite, signori, cosa dice Maria, Guigemar, v. 3 ) , a cui è dedicato questo capitolo. La materia trattata, così come la lingua ed elementi interni all'opera riconducono alla corte anglonormanna di Enrico II Plantageneto e di Eleonora d'A quitania, dove i Lais di Maria erano molto apprezzati, come ci segnala Denis Piramus, scrittore anglonormanno a lei con temporaneo: . . . e dame Marie autresi ki en rime fist et basti e compassa les vers des lais ki ne sunt pas del tut verais; e si en est ele mult loee e la rime par tut amee, kar mult l'aiment si l'unt mult cher cunte, barun et chivaler; e si en aiment mult l'escrit, et lire le funt, si unt delit, e si les funt sovent retreire. Les lais solent as dames plaire 15
FIGURE FE.\1:-JI:-;ru DEL SAPERE
de joie les oient e de gré, qu'il sunt sulum lur volenté1.
(vv. 35-48) ( . . . e anche dama Maria l che in rima ha scritto e costruito l e ordinato i versi dei lais l che non sono del tutto veri; l per questo essa è molto lodata l e le sue rime son molto amate, l e molto le amano e le hanno care l conti, baroni e cavalieri; l e molto amano anche il testo scritto, l e lo fanno leggere con gran piacere, l e spesso lo fanno raccontare. l Ma i lais piacciono di solito anche alle dame l che con gioia e volentieri li odono, l ché son fatti secondo il loro volere.) I Lais, magnifica raccolta di dodici racconti brevi e capola voro della letteratura medievale, esordiscono con una decisa dichiarazione di autorità intellettuale femminile: nel Prologo l'autrice, che ha avuto il dono del sapere (esci'ence, v. I) e dell'eloquenza (eloquence, v. 2) spiega come per interpretare correttamente (gloser la lettre) i testi antichi sia necessario applicarsi nello studio (estudi'er, v. 24) , impresa faticosa (gre vose ovre, v. 25) . Tuttavia, invece di tradurre qualche hone estoire (bella storia) dal latino al volgare, strada già percorsa da altri e dunque priva di originalità e di merito, intende rivolgere i propri sforzi ai lais, che aveva ascoltato, fissando nella memoria collettiva attraverso la propria scrittura, la propria arte, quei racconti trasmessi oralmente e altrimenti destinati ali'oblio: Des lais pensai, k' o'iz aveie. N e dutai pas, bien le saveie, Ke pur remambrance les firent Des aventures k'il o'irent Cil ki primes les comencierent E ki avant les enveierent. Plusurs en ai o'i conter, N es voil laissier ne oblier: Rimé en ai e fait ditié Soventes fiez en ai veillié3. (vv. 33-42)
16
I. ALLEA:-.IZE E SAPER! FE�IMI�ILI �El LAI5 DI �IARIA DI FRA�CIA
(Mi vennero in mente i lais, che avevo ascoltato. l Non ebbi dubbi, sapevo bene, l che quelli che per primi li composero l e li trasmisero agli altri, l volevano perpetuare il ricordo l delle avven ture che avevano udito. l Tanti ne ho sentiti raccontare, l e non li voglio tralasciare, né farli cadere nell'oblio. l Ne ho fatto delle rime e li ho messi in poesia, l assai spesso ho vegliato per essi.) Una poesia della memoria, della remambrance, che è anche e soprattutto memoria femminile. Al centro delle dodici storie, raffinato incontro tra meraviglioso celtico e mondo cortese, perfette come nitide miniature, troviamo un personaggio femminile, a cui l'attenzione tutta dell'autrice si rivolge. Una delle immagini più frequenti nei Lais rappresenta la reclusione di una giovane donna, quasi ancora fanciulla, tenuta prigioniera e fatta sorvegliare da un marito geloso, molto più anziano, non amato. n motivo della malmariée4, diffuso nella letteratura dell'xi e del XII secolo, nei Lais, pur avvolti da un alone meraviglioso, assume tratti di fine reali smo; quel realismo e quell'attualità di cui parlava Leo Spit zer, nel definire i Lais come Problem-Miirchen (favole-proble mi): «Ella inventa, per così dire, favole-problemi, nel senso che vengono inseriti nel mondo della favola, un mondo misterioso , semplice , fantastico , privo di complicazioni, incoerente e mutevole, problemi concepiti con una razionali tà estrema, che però, attraverso la realtà della favola, si spo gliano della loro componente razionale. Ma questi fatti meravigliosi, accaduti nel paese delle meraviglie, sono avve nimenti reali [ . . . ] n problema, collocato in paesi e in tempi così remoti, sembra arrivare di lontano e avvicinarsi a noi, con la sua scottante ed eterna attualità [ . . . ] In fondo in tutti i Lais si parla di un'unica cosa, dell'amore»s. E il parlare d'amore di Maria di Francia passa attraverso lo sguardo delle altre donne. Descrivendo la figura della malmariée, la scrittrice mostra le contraddizioni di pratiche matrimoniali rigide, espressione di interessi precisi della società feudale: la conservazione del patrimonio, l'importan za di un erede maschio, il lignaggio, il controllo sulle donne che dovevano assicurare, con la verginità prima e la fedeltà poi, la purezza della discendenzé. Questo motivo, esposto
17
FIGURE FE.\1:-JI:-;ru DEL SAPERE
chiaramente in Yonec, affiora di continuo - in Laiistic, Gui gemar, Milon, Deus Amanz ... -, e si intreccia strettamente con la descrizione di una rete di legami femminili, di allean ze duali o di gruppo che, nello spazio separato e chiuso della camera o della torre, costituiscono una garanzia reci proca di vita e felicità. La brevità, dichiarata da Maria di Francia come scelta stilistica - Les contes ke jo sai verrais, l
dunt li Bretun unt /ait les lais, l vos conterai assez brie/ment (l racconti che io so essere veri, l da cui i Bretoni trassero i lais, l vi narrerò assai brevemente, Guigemar, vv. 19-21) -, e il ritmo elegante e preciso dell 'ottosillabo rendono queste immagini ancora più incisive, tanto che i Lais sono stati paragonati a miniature, «pittura in movimento», «forma sce nica», «pittura drammatizzata»7. 2. In Guigemar, il signore che governa la città è molto vec chio e ha sposato une dame de haut parage l franche, curtei se, bele e sage (una dama di alto lignaggio, l nobile, cortese, bella e saggia, vv. 211-212). Poiché la natura vuole che tutti i vecchi siano gelosi, osserva Maria, egli rinchiude la sua sposa in una stanza costruita appositamente: Il ne la guardat mie a gas: En un vergier, suz le dongun, La out un clos tut envirun; De vert marbre fu li muralz, Mult par esteit espés e halz! N'i out fors une sule entree: Cele fu noit e jur guardee. De l'altre part fu clos de mer; Nuls ne pout eissir ne entrer Si ceo ne fust od un batel, Se busuin eiist al chastel. Li sire out fait dedenz le mur, Pur mettre i sa femme a seiir, Chaumbre: suz ciel n'aveit plus bele! (vv. 218-231) (La sua vigilanza non era uno scherzo: l in un giardino, sotto la torre, l c'era tutt'attorno un recinto; l il muro era di marmo verde, 18
I. ALLEA:-.IZE E SAPER! FEMMI�IU �El LAI5 DI :\IARIA DI FRA�CIA
l molto alto e spesso! l C'era una sola entrata: l ed era sorvegliata notte e giorno. l Dall'altra parte era circondato dal mare; l nessu no poteva uscire o entrare l se non con una barca, l se al castello era necessario. l n signore aveva fatto costruire nel recinto, l per tenere la moglie al sicuro, l una carnera: al mondo non ce n'era
una più bella ! ) Se la giovane signora è fatta sorvegliare d a un vecchio prete eunuco, le fa invece compagnia una fanciulla nobile e raffi nata, nipote del marito, che l'aiuta e la consiglia e a cui ben presto si lega di affettuosa amicizia: Entre !es deus out gran! amur (Fra le due c'era un grande affetto, v. 250) . È lei ad avere il coraggio di avvicinarsi alla nave incantata che tra sporta Guigemar ferito; è ancora lei a entrare per prima e a vedere il bel cavaliere addormentato, come morto. È lei che, con belle parole, incoraggia Guigemar a rivelarsi alla sua signora: «Sire, fet ele, vus arnez! Gardez que trop ne vus celez ! Arner poez en iteu guise Que bien ert vostre arnur assise. Ki ma darne vodreit arner Mut devreit bien de li penser. Ceste arnur sereit covenable, Si vus arndui feussez estable: Vus estes bels e ele est bele!» (vv. 444-453) («Signore, disse, voi amate! l State attento a non nascondere trop po il vostro amore! l Potete amare così da l ben riporre il vostro amore. l Chi volesse amare la mia signora l dovrebbe avere un'alta stima di lei. l Quest'amore sarebbe degno l se ambedue foste costanti: l voi siete bello e bella è anche lei !») In un'atmosfera da racconto di fate, come è stato sottolinea to più volte8, la relazione tra la fanciulla e la dama è dunque determinante per la felicità di quest'ultima; quando la pre senza di Guigemar viene scoperta ed egli è costretto a fuggi-
19
FIGURE FE.\1:\U:-;IU DEL SAPERE
re, della giovane non è più detto nulla, scompare, e la dama viene rinchiusa da sola, in una torre di marmo grigio, come una tomba: Ses sires l'ad mise en prisun l en une tur de mar bre bis (TI signore l'ha imprigionata l in una torre di marmo scuro, vv. 658-659). La torre, manifestazione e simbolo di forza, potere e conquista, qui diventa il luogo della prigionia e il segno di un'autorità esercitata in maniera ingiusta. Laiistic (L'usignolo) racconta di una dama strettamente sorvegliata - la dame ert estreit gardee (v. 49) - e sola, senza nessuna fanciulla che le tenga compagnia. Può solo conver sare con l'amico, che abita accanto, e da cui è separata da un muro di pietra grigia: un haut mur de piere bise (v. 38). n canto dell'usignolo è il pretesto per potersi alzare tutte le notti e andare alla finestra, a vedere il suo amico. L'interven to brutale del marito geloso, che dà la caccia all'usignolo, lo cattura e lo uccide, rompe l'incanto mai più recuperabile di rari istanti di felicità, una perdita simbolizzata in maniera struggente dal corpicino dell'usignolo morto. Maria è parti colarmente feroce nei confronti del marito, che agisce per engresté e si dimostra villano: A sun seignur l'ad demandé, E il i' ocist par engresté: Le col li rumpt a ses deus meins. De ceo fist il ke trop vileins. Sur la dame le cors geta, Si que sun chainse ensanglanta Un poi desur le piz devant. (vv. II3-II9) (Chiese l'usignolo al marito, l ed egli, perverso, l'uccise: l gli spez zò il collo con le mani. l Che barbara azione ha commesso. l Gettò il corpo addosso alla moglie, l sì che le insanguinò la cami cia l un po' sopra il cuore.) La dama, a sua volta narratrice, e novella Filomela9, invia al cavaliere l'uccellino avvolto in una stoffa di seta preziosa su cui ha ricamato il racconto dell'accaduto10• In contrasto evi dente con il marito villano, il cavaliere, cortese e sollecito 20
I. ALLEA:-.IZE E SAPER! FEMMI�IU �El LAI5 DI :\IARIA DI FRA�CIA
ne fu pas vileins ne lenz (v. 148) -, fa forgiare un cofanetto d'oro puro e ornato da pietre preziose, e vi mette l'usignolo, che porterà sempre con sé, reliquia di un amore perduto. Come una maestra della miniatura, Maria di Francia sa dare risalto ai particolari, alle nuances, ai colori sapientemente dosati, come il rosso del sangue sul bianco della camicia, immagine della ferita mai più guaribile del cuore. 3 · In Yonec Maria di Francia espone il problema in tutta la sua complessitàu. L'accento è posto, ancora una volta, sul l'ingiustizia della pratica matrimoniale che consegna una fan ciulla di alto lignaggio, oggetto muto di uno scambio tra padre e pretendente, a un uomo molto più vecchio di lei, che la sposa per avere una discendenza, e la imprigiona in una torre: En Bretaingne maneit jadis Uns riches hum, vielz e antis; [. . .] Mut fu trespassez en eage. Pur ceo k'il ot bon heritage, Femme prist pur enfanz aveir, Ki aprés lui fuissent si heir. De haute gent fu la pucele, Sage, curteise e forment bele, Ki al riche hume fu donee Pur sa beauté l'ad mut amee. De ceo ke ele iert bele e gente, En li garder mis t mut s'entente; Dedenz sa tur l'ad enserreie En une grant chambre pavee. (vv. II-12 e 17-28) (C'era una volta in Bretagna l un uomo ricco e vecchissimo; 1 . l Il signore era di età avanzata. l Poiché possedeva molti beni, l si sposò per avere figli l che fossero poi suoi eredi. l Di alto lignag gio era la fanciulla l che fu data al ricco signore, l saggia, cortese e molto bella; l per la sua bellezza egli l'amava molto. l Per il fatto che era bella e gentile, l non faceva che sorvegliarla; l la chiuse dentro la sua torre, l in una grande stanza pavimentata.) .
21
.
FIGURE FE.\1:-JI:-;ru DEL SAPERE
La durezza della prigionia è aggravata dal divieto di parlare con le altre donne, che stavano in una chambre vicina, e dalla sorveglianza di una donna anziana, vedova, sorella del marito: n ot une sue serur
Veille ert et vedve, sanz seignur; Ensemble od la dame l'ad mise Pur li tenir mieuz en justise. Autres femmes i ot, ceo crei, En une autre chambre par sei, Mes ja la dame n'i parlast, Si la vielle nel comandast. Issi la tint plus de set anz. Unques entre eus n'eurent enfanz Ne fors de cele tur n'eissi, Ne pur parent ne pur ami. (vv. 29-40) (Aveva una sorella, l vecchia e vedova, senza signore; l la affiancò alla moglie l perché la tenesse d'occhio meglio. l C'erano, credo, altre donne l in un'altra camera separata, l ma la dama non pote va parlare con loro l senza il permesso della vecchia. l Così la tenne più di sette anni. l Non ebbero figli l e lei non uscì mai da quella torre l né per vedere parenti o amici.) Sorvegliata e in silenzio. La prigionia è resa più dura dall 'es sere separata dalla comunità delle donne, dal gineceo: una dimensione femminile collettiva, interna, domestica - in opposizione a uno spazio esterno pubblico e maschile - spa zio dell'identità e di possibili alleanze, presente in tante opere di epoche differenti1 1• Penso a Flamenca, per esempio, la protagonista del bel romanzo omonimo provenzale (XIII secolo) e altra celebre malmariée; nella prigionia la conforta no due damigelle, Alis e Margarida, come lei colte e raffina te (cortesas son e essenhadas, v. 1354) . Con loro Flamenca ha una relazione di dolce alleanza e complicità; la comune incli nazione per le lettere13 diventa determinante quando si tratta di elaborare le risposte ai frammenti di messaggio amoroso che Guglielmo le sussurra, in chiesa, gabbando la stretta sor veglianza del geloso Archimbaut: 22
I. ALLEA:-aE E SAPER! FEW.U:-JIU :-lEI UIL5 DI :\!ARIA DI FRA:-JCIA
- Margarida, trop ben t'es pres e ja iest bona trobairis. - O eu, domna, mellor non vist, daus vos e daus Alis en fora. (vv. 4576-4579) (Margherita, ti esprimi perfettamente l già sei una brava trovatrice. l Certo, la migliore mai vista, l a parte voi e Alice.) Flamenca dis: «Qui t' ensenet Margarida, ni qui. t mostret, fe que.m deus, tan de dialetica S' aguessas legit arismetiga, astronomia e musica, non agras meils la fesica del (s) mals qu' eu ai loncs tems suffertz. Ja mos cors mais non t' er cubertz quar tan ben con eu vei que.l saps; de mon conseil voi sia caps, eu et Alis non serem plus, quar nostre cors son assas us . . . (vv. 5441-5452)14 (Flamenca disse: «Chi ti insegnò, l Margherita, e chi ti mostrò l per la fede che mi devi, tanta dialettica? l Se avessi imparato l'arit metica, l l'astronomia e la musica, l non conosceresti meglio l'ori gine l dei mali che ho sofferto per lungo tempo. l Mai ti nascon derò il mio cuore, l mi accorgo che lo conosci quanto me, l desi dero che tu guidi le mie decisioni; l Alice ed io scompariremo, l e i nostri cuori saranno uno solo . . . ) TI reciproco e cortese scambio di complimenti sulle rispettive
capacità poetiche, si accompagna a questo "sentirsi" tre e una allo stesso tempo. In Yonec, la tristezza e il desiderio di morte sono i soli e cupi compagni della dama, mentre la sua bellezza sfiorisce: Mut ert la dame en grant tristur, Od lermes, od suspir e plur; Sa beuté pert en teu mesure 23
FIGURE FE.\1:\Il:-\IU DEL SAPERE
Cume cele ki n' en ad cure. De sei meYsme mieuz vousist Que morz hastive la preisist. (vv. 45-50) (Molto triste era la dama, l sempre in lacrime, pianti e sospiri; l perdeva la sua bellezza l perché non se ne dava più cura. l Desi derava per sé l che la morte la portasse via al più presto.) Si eleva il lamento della malmaritata, che rivendica il proprio diritto al desiderio e alla felicità e maledice duramente chi la consegnò al vecchio geloso: Mut se pleineit e suspirot E en plurant se dementot: «Lasse, fait ele, mar fui nee! Mut est dure ma destinee! En ceste tur sui en prisun, Ja n'en istrai si par mort nun. Cist vielz gelus, de quei se crient, Que en si grant prisun me tient? Mut par est fous e esba1z! (vv. 65-73) ( Molto si lamentava e sospirava l e fra il pianto si doleva: l «Ahimè, essa diceva, sono nata disgraziata ! l Che destino crudele! l Sono imprigionata in questa torre, l e non ne uscirò che dopo morta. l Di che ha paura quel vecchio geloso, l che mi tiene in così stretta prigionia? l È proprio folle e stolto! ) Maleeit seient mi parent E li autre communalment Ki a cest gelus me donerent E de sun cors me mar1erent! A forte corde trai e tir, Il ne purrat jamés murir! Quant il dut estre baptiziez, Si fu el flum d' enfern plungiez: Dur sunt li nerf, dures les veines, Ki de vif sane sunt tutes pleines ! (vv. 81-90)
I. ALLEA:-.IZE E SAPER! FE�IMI�ILI �El LAI5 DI �IARIA DI FRA�CIA
(Siano maledetti i miei genitori l e anche gli altri l che mi diedero in sposa a questo geloso l e mi congiunsero alla sua persona! l Forte è la corda che tiro, l ché quello non muore mai! l Quando lo battezzarono l dovettero immergerlo nel fiume dell'inferno: l duri ha i nervi, dure le vene, l tutte colme di sangue vivo ! ) Alla maledizione scagliata contro i genitori che l'hanno conse gnata al vecchio geloso, a sua volta paragonato implacabil mente a una creatura infernale, segue il ricordo nostalgico delle storie che aveva sentito raccontare, Mut ai sovent oi" cun ter (v. 91), e delle avventure che capitavano un tempo, quan do le dame trovavano amanti beaus e curteis, pruz e vaillanz (belli e cortesi, prodi e valenti, v. 98) . n suo desiderio - che ironicamente Maria trasforma in preghiera a Dio - Deus, ki de tut ad poé'st� l Il en /ace ma volenté. ' (che Dio onnipoten te l esaudisca il mio desiderio ! , vv. 103- 104) - evoca il cavalie re-astore che ritornerà, come la fata in Lanval, ogni volta che lei lo desidera1s. Uno spazio della libertà, della fuga e dell'ap pagamento, possibile solo nel meraviglioso, nel sogno, nella reverie. . fino a quando lo sguardo obliquo e infido della veil le scopre il segreto che ha fatto rifiorire la bellezza della dama, ormai spenta. n venir meno dell'alleanza tra donne causa la tragedia: il cavaliere-astore verrà trafitto da lame taglienti, fissate alla finestra, dove era solito passare quando andava dalla sua dama. Puntuale il commento di Maria, che definisce il marito fellone e traditore: Que aparaillot le felun. ' (che ordiva quel malvagio ! , v. 296) , que cist veillarz a tort ocist (e questo vecchio lo uccise a tradimento, v. 532) . Vi è quasi una corrispondenza simmetrica, e contraria, tra i due lais Guigemar e Yonec, entrambi di ambientazione meravigliosa. A fianco delle dame prigioniere vi sono una giovane e una vecchia, entrambe imparentate con i rispettivi mariti: in Guigemar è una nipote, in Yonec una sorella. Tut tavia, in Guigemar l'alleanza tra le due donne è più forte del legame di parentela e favorisce l'esperienza amorosa. La pre senza dell' altra donna, o delle altre, è indispensabile; quando l'altra è assente (come in Laustic) , o è nemica (come in Yonec) , l'esito può solo essere tragico. . . .
.
25
FIGURE FE.\1:\U:-;IU DEL SAPERE
4· Mi pare dunque che oltre ai motivi folclorici e tradizio nali, vi sia nella scrittura di Maria di Francia un'attenzione estrema alle alleanze tra donne, come condizione indispensa bile per la felicità. Questo motivo, che in alcuni lais, come si è visto, trova un ampio spazio di approfondimento, in altri è solo accennato, ma non per questo meno significativo. Nel brevissimo Chievre/oil (Il caprifoglio) l 'autrice non manca di ricordare che Isotta si fida moltissimo di Brenguein: Sa meschine apelat a sei l Brenguein, ki mut ot hone /ei (Chia mò la sua ancella, l Brenguein, che era molto fidata, vv. 89-90). Milun, nel lai omonimo, ama una fanciulla une /ille bele l e mut curteise dameisele (una bella figlia, l una fanciulla assai cortese, vv. 23-24) ; i due si frequentano assiduamente, finché la giovane donna si accorge che è in attesa di un figlio. La situazione imbarazzante verrà risolta grazie all'aiu to della sorella, riche dame, pruz e senee (donna ricca, virtuo sa e saggia, v. 70) , a cui verrà affidato il neonato, e di una donna anziana, che le garantisce assistenza e discrezione: Une vielle ki la garda, A ki tut sun estre geY, Tant la cela, tant la covri, Unques n'en fu aparcevance En parole ne en semblance. (vv. 90-94) (Una vecchia che la assisteva, l a cui svelò il suo stato, l la tenne nascosta così bene, l che nessuno si accorse di niente, l né dalle parole né dall'aspetto.) Maria si sofferma su particolari apparentemente superflui, come la descrizione delle cure prestate al piccolo: Puis le cuchent en un bercel Envolupé d'un blanc lince!. Dedesuz la teste a l' enfant Mistrent un oreiller vaill ant E desus lui un covertur U rlé de martre tut entur. (vv. 99-104)
I. ALLEA:-.IZE E SAPER! FEMMI�IU �El LAI5 DI :\IARIA DI FRA�CIA
(Poi lo adagiarono in una culla, l avvolto in un lenzuolo bianco. l Sotto la testa del bimbo l misero un guanciale prezioso l e, sopra, una coperta l orlata tutt'intorno di martora.) Par les viles ou il errouent Set feiz le jur se resposoent; L'enfant feseient aleitier, cuchier de nuvel e baignier. (vv. 109-112) (Nelle città dove passavano l si fermavano sette volte al giorno; l facevano allattare, riposare l e lavare il bambino.) Particolari importanti, perché rivelatori di un sapere e di un'esperienza femminile, così come la preoccupazione dimo strata dalla donna che suo figlio sia allevato nel migliore dei modi, indipendentemente dal sesso: Ore gart k'il seit bien nuriz, l Quei! ke ço seit, u fille u /iz (Dovrà pensare ad alle varlo bene, l sia maschio o femmina, vv. 76-77). Deuz Amanz (I due innamorati) racconta di una giovane troppo amata dal re suo padre, che non può stare senza di lei e non la vuole concedere a nessuno1 6• Come pretesto, egli impone una prova, impossibile da superarsi: ogni pretenden te alla mano di sua figlia dovrà salire con lei in braccio fino alla cima di un monte, senza mai fermarsi. Per superare que sta prova immane, e non ferire il padre con il disonore della fuga, la principessa decide di rivolgersi all'autorità di una donna più anziana, sua parente di Salemo17, esperta di far maci e abile conoscitrice di erbe e radici, da cui manda il suo innamorato, sicura che saprà dargli buoni rimedi e con sigli: En Salerne ai une parente, Riche femme, mut ad grant rente. Plus de trente anz i ad esté; L'art de phisike ad tant usé Que mut est saive de mescines. Tant cunuist herbes e racines, Si vus a li volez aler 27
FIGURE FE.\1:-dl:'\IU DEL SAPERE
E mes lettres od vus porter E mustrer li vostre aventure, Ele en prendra cunseil e cure: Teus leituaires vus durat E teus beivres vus baillerat Que tut vus recunforterunt E hone vertu vus durrunt. (vv. 103-n6) (A Salerno c'è una mia parente, l donna ricca, con grandi beni. l Ha vissuto lì più di trent'anni; l ha tanto praticato l'arte medica l che è diventata molto esperta di farmaci. l Così bene conosce erbe e radici, l e, se vorrete andare a trovarla, l portandovi dietro una mia lettera l e raccontarle il vostro caso, l lei provvederà e vi con siglierà: l vi darà tali filtri l e vi consegnerà tali bevande l che vi conforteranno tutto l e vi infonderanno grande vigore.)
TI giovane segue il consiglio e si reca da quella che verrà poi indicata come la zia dell'amica, a voler quasi rafforzare il legame tra le due: A Salerne vait surjurner, A l'aunte s'arnie parler. [ . ] Par mescines l'ad esforcié. Un tel beivre li ad chargié, J a ne sera t tant travaillez Ne si ateinz ne si chargiez, Ne li resfreschist tut le cors, N eis les vaines ne les os, E qu'il nen ait tute vertu Si tost com il' avra beii. (vv. 137-138 e 143-150) .
.
(Ora va a stare a Salerno, l a parlare con la zia della sua amica. l... l Lo ha rafforzato con medicine. l Gli ha poi dato un filtro tale che, l per quanto affaticato, l provato e gravato, l gl'infonderà vigore alle membra, l alle vene, alle ossa, l e gli farà effetto com pletamente, l non appena l'avrà bevuto.)
I. ALLEA:-.IZE E SAPER! FEMMI�IU �El LAI5 DI :\IARIA DI FRA�CIA
Ancora una volta, l 'alleanza con un'altra donna potrebbe condurre alla felicità. Al momento di affrontare la prova, il giovane però si dimentica di bere il filtro, per una mancanza di prudenza, kar n'ot en lui point de mesure (perché in lui non c'era misura, v. 189), che gli sarà fatale. Egli morirà, stre mato per lo sforzo, e accanto a lui si spegnerà la sua amica: Puis que sun ami ot perdu Unkes si dolente ne fu. Lez lui se cuche e estent Entre ses braz l'estreint e prent; Suvent li baise oilz e buche. Li dols de lui al quor la tuche: Ilec rnurut la darneisele, Ki tant ert pruz e sage e bele. (vv. 231-238) (Dopo aver perduto il suo amico, l provò un terribile dolore. l Ecco che si corica e stende accanto a lui, l lo stringe e lo prende fra le sue braccia; l più e più volte gli bacia gli occhi e la bocca. l Il dolore per lui le spezza il cuore: l lì morì la fanciulla l che era tanto virtuosa e saggia e bella.) 5· Anche la storia di Fresne (Il frassino) si svolge in un uni verso fortemente segnato dalla presenza femminile. In Breta gna vivono due cavalieri, entrambi ricchi, prodi e valorosi; entrambi sono sposati. Una delle due dame dà alla luce due gemelli; l'altra, /einte e orguilluse l e mesdisanz e envi'use (subdola e altezzosa, l e maldicente e invidiosa, vv. 27-28) , sostiene pubblicamente l'impossibilità che una donna abbia due figli con una sola gravidanza, a meno che siano stati concepiti da due uomini diversi. Per la sua calunnia la dama verrà odiata da tutte le donne in Bretagna:
Mut en fu la darne baie; Pois en dut estre rnaubailie. Tutes les fernrnes ki l' oirent, Povres e riches, l' enhairent. (vv. 53-56) 29
FIGURE FE.\1:\U:-;IU DEL SAPERE
(Per questo la dama fu molto odiata; l e in seguito gliene venne gran danno. l Tutte le donne che lo seppero, l povere e ricche, gliene vollero male.) Dopo poco lei stessa partorisce due bambine gemelle; per proteggere se stessa e la sua reputazione decide di uccidere una delle due bambine. Non è un caso che sia una bambina quella destinata a morire ; la pratica dell'infanticidio era assai diffusa all'epoca ed è sicuramente non casuale anche che in Milun , là dove agisce la solidarietà tra le due sorelle e il figlio in questione è maschio, il problema non si ponga, né in termini di infanticidio, né di abbandono18 • È a questo punto che Maria ci propone un quadro di interni: siamo nella chambre delle donne, che confortano la dama, e le impediscono di commettere un assassinio: Celes ki en la chambre esteient La cunfortoent e diseient Qu'eles nel suffereient pas: De humme ocire n'est pas gas ! (vv. 95-98) (Le donne che erano in carnera l la confortavano e dicevano l che mai avrebbero sopportato un tal fatto: l uccidere non è uno scherzo!) Ecco di nuovo l'intervento delle altre donne, prima per impedirle una follia, poi per andarle in aiuto; una fanciulla del suo seguito, che lei amava molto, e mut amee e mut che rie (e molto l'amava e le voleva bene, v. 102) , si offre per portare via la piccola e abbandonarla nei pressi di un mona stero. Per il fatto che viene lasciata nell'incavo di un frassi no, la bambina verrà chiamata Fresne e, a partire da questo momento, è come se nascesse una seconda volta, ora con madri e sorelle simboliche: la figlia del portiere dell'abbazia la lava e l'allatta, e crescerà nel convento, dove la badessa decide di adottarla e farla passare per sua nipote. Proprio su questo aspetto Michelle Freeman osserva che la coppia zia/nipote (in Fresne, in Deus amanz) fa parte di quella riap propriazione e «deliberate feminization of [largely male] 30
I. ALLEA:-.IZE E SAPER! FEMMI�IU �El LAI5 DI :\IARIA DI FRA�CIA
concems and procedures»19 attuata da Maria di Francia, in questo caso della coppia maschile zio/nipote, che incontria mo così di frequente nella letteratura medievale: Carloma gno/Orlando, Marco/Tristano, Artù/Galvano . . . Fresne vivrà con le monache, diventando una bella fan ciulla, nobile e cortese: En Britaine ne fu si bele l ne tant curteise dameisele (non c'era in Bretagna damigella l così bella e così cortese, vv. 237-238). A Dol - che racchiude nel nome, sofferenza, come un presagio, gli avvenimenti succes sivi20 - vive un signore di nome Gurun, che ben presto si innamora di Fresne, convincendola a partire con lui e a diventare così la sua concubina. P rima di andarsene, la badessa le racconta tutto e le consegna il ricco drappo con cui era stata avvolta e un anello d'oro, segni della sua nobile nascita, e da cui lei non si separerà mai. Vivono a lungo insieme, finché i chevalier fiu/é, i feudatari, non gli impongo no di sposare una gentildonna, per avere un erede; il cavalie re accetta il loro consiglio e lascia che scelgano loro. La pre scelta sarà proprio la sorella gemella di Fresne, di nome Codre (Nocciolo) . Di fronte a questi avvenimenti, Fresne pare non avere alcuna reazione, unques peiur semblant ne /ist (non mostrò di adombrarsi, v. 352) , neanche il giorno del matrimonio, e tutti si meravigliano: La dameisele es chambres fu; Unques de quank'ele ad vei.i Ne fist semblant que li pesast Ne tant qu'ele se curuçast. Entur la dame bonement Serveit mut afeitieement. A grant merveile le teneient Cii e celes ki la veeient. (vv. 375-382) (La ragazza era nell e stanze; l per ciò che vedeva l non mostrò mai di soffrire l né di disperarsi. l Intorno alla sposa, anzi, affabil mente l serviva con molta grazia. l Ne erano molto meravigliati l i cavalieri e le dame che la guardavano.)
31
FIGURE FE.\1:\U:-;IU DEL SAPERE
Anche sua madre la osserva e l'ammira, senza riconoscerla, ed è ben strano, visto che Fresne e Codre sono sorelle gemelle (serurs gemeles, v. 348). Nessuna reazione apparente, e la sera la fanciulla va persino a preparare il letto nuziale; poiché la coperta è vecchia e logora, la sostituisce con il palie, il suo drappo prezioso. La madre accompagna Codre al letto nuziale, riconosce il drappo e di conseguenza Fresne, che potrà, recuperata l'identità nobile e annullate le nozze, sposare il suo amico. La storia di Fresne può essere considerata un anteceden te a quella più nota di Griselda, che godette di una grande fortuna nel Medioevou: un giovane marchese sceglie Grisel da, di origini umilissime, come sua sposa, strappandole una promessa d'obbedienza. Questa obbedienza non verrà mai meno, anche a fronte delle prove più terribili, come la finta uccisione di entrambi i figli. Griselda acconsente sempre, in silenzio, non si ribella mai di fronte alla violenza continua e ripetuta di uno sposo-tiranno che la ripudia, e la manda a chiamare per incaricarla dei preparativi delle sue seconde nozze con la fanciulla che è in realtà quella figlia creduta morta, e solo a questo punto, dopo anni di tormenti, decide di porre fine al suo gioco crudele. Griselda, o il modello femminile definito attraverso la rinuncia e, scrive Danielle Régnier-Bohler, le démembrement della sua personalità: Griselidis est le lieu meme où s'exprime l'idéologie de la soumis sion quasi providentielle de la femme à l'homme. Dépouillée des signes de l' ascension sociale, des prolongements d'elle meme que sont ses deux enfants, réduite à elle meme, ne gardant que sa che mise, prix de sa virginité: le démembrement docile auquel se prete Griselidis est une réponse aux fantasmes de l'agression dont la femme, en d'autres lieux, en d'autres textes, se rend coupable11• L'annullamento di Griselda, richiesto come prova della sua lealtà, si esprime attraverso il silenzio della sottomissione, totale e disumana, di fronte al potere assoluto e tirannico dell'uomo23. D silenzio di Fresne è differente : Fresne non si ribella, perché non può. Qui non si tratta, come in Griselda, anche se le due storie sono evidentemente collegate, di un 32
I. ALLEA:-aE E SAPER! FEMMI:-JIU :-lEI LAL5 DI :\!ARIA DI FRA:-JCIA
marito capriccioso e crudele che mette alla prova la propria moglie, ma di una società feudale dalle regole rigide, che impone un matrimonio tra pari e a cui Gurun, nonostante ami, riamato, Fresne Mut la cheri e mut l'ama (la tenne molto cara e molto l'amò, v. 308) -, non si ribella, per non perdere il sostegno e l'appoggio degli altri cavalieri: -
Lungement ot od li esté, Tant que li chevalier fiufé A mut grant mal li aturnerent. Soventefeiz a lui parlerent Qu'une gentil femme espusast E de cele se delivrast; Lié sereient s'il eiist heir Ki aprés lui peiist aveir Sa tere e sun heritage. Trop i avreient grant damage, Si il laissast pur sa suinant Que d'espuse n'eiist enfant. Jamés pur seinur nel tendrunt Ne volentiers nel servirunt, Si il ne fait lur volenté. Li chevaliers ad graanté Qu' en lur conseil femme prendra: Ore esgardent u ceo sera ! (vv. 313-330) (A lungo è vissuta con lui, l finché i feudatari l non gliene mosse ro rimprovero. l Molte volte gli dissero l di sposare una gentildon na l e di lasciare l'altra; l sarebbero stati lieti che egli avesse un erede l in grado di ereditare l la sua terra e i suoi possedimenti. l Molto sarebbero stati danneggiati l se lui avesse rinunciato, per l'amante, l ad avere figli da una moglie. l Non lo vorranno più per signore l né di buon grado lo serviranno l se non farà quello che vogliono. l li cavaliere ha garantito l che si sposerà, come da loro consigliato: l adesso provvedano a chi scegliere! ) Fresne conosce le proprie origini, le sono state rivelate dalla zia/badessa, che le restituisce anche il drappo e l'anello, quando lascia il convento per seguire Gurun e Maria allude 33
FIGURE FE.\1:-dl:'\IU DEL SAPERE
alla funzione futura dei due oggetti: Son palie emporte e sun anel: l De ceo li poet estre mut bel (Con sé portò il drappo di seta e l'anello l un giorno le potranno essere utili, vv. 293294) . Fresne è quindi consapevole del proprio gesto quando stende con cura il prezioso palie, segno rivelatore che con durrà al riconoscimento. Come nei lais finora esaminati, anche Fresne è costellato da presenze femminili , alcune delle quali solitamente margi nali nella società degli uomini: le dame della chambre, la figlia del portiere, la badessa, Fresne concubina prima di essere dame. Maria di Francia stabilisce una dimensione dif ferente , basata sulle relazioni di alleanza tra queste donne, che Michelle Freeman definisce un alternative birth-giving, un lignaggio alternativo alla società maschile e patriarcale24. Note 1. Ph. Ménard, Marie de France et nous, in Amour et merveille. Les "Lais" de Marie de France, Etudes recueillies par J. Dufoumet, Champion, Paris 1995, pp. 7-24. 2. Denis Piramus, La vie Seint Edmund le Rei, ed. H. Kjellrnan, Elan ders boktryckeri aktiebolag, Goteborg 1935, citato in C . Donà, Il racconto, in La Letteratura francese medievale, a cura di M. Mancini, il Mulino, Bologna 1997, pp. 271-344, a p. 300. 3· Cito dall'edizione di ]. Rychner, riprodotta a fronte nd volume Maria di Francia, Lais, a cura di G. Angdi, Mondadori, Milano 1983 (ried. Luni, Milano-Trento 2000) . 4· D. Evans, Marie de France, Chrétien de Troyes, and the "malma riée", in Chrétien de Troyes and the Troubadours. Essays in memory o/ the late Leslie Topsfield, edited by P. S. Noble and L. M. Paterson, St. Cathe rine's College, Cambridge 1984, pp. 159-71. 5· L. Spitzer, Maria di Francia, autrice di /avole problematiche, in Saggi di Critica Stilistica, Sansoni, Firenze 1985, pp. 15-68, alle pp. 28, 30-1. 6. Cfr. gli studi di G . Duby raccolti nd volume Medioevo maschio. Amore e Matrimonio, Laterza, Roma-Bari 1988. 7· Si veda G. Angeli, Maria di Francia o il racconto come scena, in "Saggi e ricerche di letteratura francese", 2.4, 1985, pp. 9-25. 8. In Guigemar, considerato tra i lais fiabeschi, Maria gioca voluta mente con dementi dd meraviglioso celtico: la cerva bianca, la nave magi ca, la dama bella come una fata, pur non essendolo: ki de beuté resemble /ee, v. 704; la fanciulla, che rimanda alla figura della fata accompagnante o messaggera e fa pensare a Lunete accanto a Laudine nell ' Yvain di Chré tien de Troyes. Si vedano gli studi di ]. Koopmans e P. Verhuyck, Guige-
34
I. ALLEA�E E SAPER! FEMMI:-.IIU :-lEI Ulll DI MARIA DI FRA:-.ICIA
mar et sa dame, in "Neophilologus" 68, 1984, pp. 9-21, tions sur le lai de "Guigemar", in Mélanges C. Foulon,
di A. Saly, Observa Institut de français, Université de Haute Bretagne, Rennes 1980, pp. 329-39, di C. Méla, Le lai de Guigemar. Selon la lettre et l'écriture, in "Marche Romane" , 30, 1980, pp. 193-202, di H. Bloch, The medieval text Guigemar as a provocation to the discipline o/ medieval studies, in "Romanic Review", 79, 1988, pp. 6373- Più di recente L. Harf-Lancner, La reine ou la /ée: l'itinéraire du Héros dans les "Lais" de Marie de France, in Amour et merveille. Les "Lais" de Marie de France, cit., pp. 81-108; C. Donà, La cerva divina. Guigemar e il viaggio iniziatico, in "Medioevo Romanzo", 20, 1996, pp. 321-77 e 21, 1997, pp. 3-68 e M. Virdis, Per Marie de France, in Gloser la lettre. Marie de France - Renaut de Beaujeu - ]ean Renart, Bulzoni, Roma 2001, pp. 23-97. 9· Si veda in questo volume, il CAP. 2, pp. 25, 48 note 14 e 15. 10. A. Paupert, Les /emmes et la parole dans les "Lais" de Marie de France, in Amour et merveille. Les "Lais" de Marie de France, cit., pp. 16987. n. n motivo della malmaritata in Yonec è stato analizzato da V. Cirlot in Un mal matrimonio segun Maria de Francia, in "Medievalia", 1983, pp. 27-37· u . Si veda lo studio di D. Régnier-Bohler, Geste, parole et cloture: les réprésentations du gynécée dans la littérature médiévale du XIII et XIV siècle, in Mélanges de Langue et Littérature Médiévale of/erts à Alice P/anche, in "Annales de la Faculté de Nice", 48, 1984, pp. 393-404. 13. Tutto il romanzo è un grande inno alla letteratura; si veda M. Manci ni, "Flamenca" e l'elogio delle "letras", in La na"ativa in Provenza e in Catalo gna nel XIII e XIV secolo, a cura di F. Beggiato, ETS, Pisa 1995, pp. 27-40. 14. Flamenca , texte établi, traduit et présentée par J. C. Huchet, 10h8, Bibliothèque Médiévale, Paris 1988. 15. Per un'analisi dei motivi folclorici in Yonec si rimanda allo studio di D'A. S. Avalle, Fra mito e fiaba. I:ospite misterioso, in Mélanges d'étu des romanes du moyen age of/erts à ]ean Rychner, Klincksieck, Strasbourg 1978, pp . 34-44· 16. n motivo dell'incesto padre-figlia, evitato o commesso, avrà poi grande fortuna durante il XIII secolo, in opere come La Manekine di Phi lippe de Beaumanoir, La Belle Hélène de Constantinople, Le Roman d'A pollonius de Tyr e nella versione castigliana di quest'ultimo, il Libro de Apolonio, per cui rimando al CAP. 4 di questo volume. 17. Si può leggere qui una probabile allusione a Trotula, l'esponente femminile più nota della scuola medica salernitana, attiva intorno alla metà dell'XI secolo; cfr. M. M. Rivera Garretas, Trotula: el cuerpo de mujer, in M. M. Rivera Garretas, Textos y espacios de mujeres, !caria, Bar celona 1990, pp. 105-29 e F. Bertini, Trotula, il medico, in F. Bertini, F. Car dini, C. Leonardi, M. T. Fumagalli Beonio Brocchieri, Medioevo al /e mmi m'le, Laterza, Roma-Bari 1989, pp. 97-n9. 18. M. M. Rivera Garretas, Maria de Francia: el in/antictdio, in Rivera Garretas, Textos y espacios de mujeres, cit., pp. 131-58. 19. Cfr. M. Freeman, The Power o/ Sisterhood: Marie de France's "Le
35
FIGURE FE.'d.'dl:-.:IU DEL SAPERE
Fresne",
in Women and Power in the Middle Ages, ed. by M. Erler and M. Kowaleski, The University of Georgia Press, Athens-London 1988, p. 163. 10. H. Bloch, Medieval Misogyny and the invention o/ Western Romantic Love, The University of Chicago Press, Chicago 1991, pp. 170-1. 11. Dopo la prima versione di Boccaccio (Decameron, X, 10), quella di Petrarca (Seni/es, XVII, 3) e di Chaucer (Canterbury Tales. The Clerk's Tale), per cui si veda a R. Kirkpatrick, The Griselda Story in Boccaccio, Petrarch and Chaucer, in Chaucer and the Italian Trecento, ed. by P. Boita ni, Cambridge University Press, Cambridge 1983, pp. 131-48 e J. Bronfman, Chaucer's Clerk's Tale. The Griselda Story Receveid, Rewritten, Illustrated,
Garland, New York-London 1994. Per le versioni francesi E. Golenist cheff-Koutouzoff, L'histoire de Griseldis en France au XIV et au XV siècle, Slatkine Reprints, Genève 1975 (I" ed. Paris 1933) . Per il panorama europeo si vedano V. Branca, Origini e fortuna europea della Griselda, in Id., Boc caccio Medievale, Sansoni, Firenze 1981 (I" ed. 1975), pp. 388-94; ]. E. Ruiz Doménec, Griselda, la potenza del negativo, in "Le Forme e la Storia" n.s. 1, 1990, pp. 109-10; La circolazione dei temi e degli intrecci narrativi: il caso Griselda, a cura di R. Morabito, Japadre, L'Aquila 1988; La storia di Grisel da in Europa, a cura di R. Morabito, Japadre, L'Aquila 1990. 11. D. Régnier Bohler, Femme/Faute/Fantasme, in La condici6n de la mujer en la Edad Media, Ed. Universidad Complutense, Madrid 1986, pp. 476-99, a p. 479· 13. Sulle voci e i silenzi delle donne, si veda D. Régnier-Bohler, Voci letterarie, voci mistiche, in Duby, Perrot, Storia delle donne in Occidente, II: Il Medioevo, cit., pp. 461-539 e M. Freeman, Marie de France's poetics o/ silence: the implications /or a /eminine "translatio", in "Publications of the Modern Language Association ", 99, 1984, pp. 860-83. 14. Si veda Freeman, The Power o/ Sisterhood, cit ., pp. 160-1: «Marie has thus preserved and furthered a cdebration of an alternative birth giving, the sort in which maiden aunts, servant women, and concubines might well participate, that is, those women who are marginai in the public area of a male-dominated society [ . . . ] Marie has substituted a lineage horn of sisterhood for the more familiar patriarchy>>.
2
Medea, donna divina
1 . Medea, mito terribile e perturbante, ha esercitato un'at trazione fatale negli autori che , sin dall 'Antichità, si sono misurati con questa figura femminile. Le opere intorno a Medea sono numerosissime e diversi i tentativi di dar loro una sorta di classificazione. Duarte Mimoso Ruiz, per esem pio, in uno studio di taglio antropologico, in cui esamina tutte le arti, dalla letteratura alla pittura, alla scultura, alla musica, al cinema1, ne classifica circa trecento. Tra i capola vori del Novecento, il film di Pasolini, del 1970, probabil mente ispirato alle Argonautiche di Apollonia Rodio (III secolo a.C.)l. Maria Callas meglio di ogni altraJ esprime l'in tensità di una eroina paradossalmente silenziosa - «ciò che per tutti è voce, diventa qui sguardo»4 -, una Medea che vede ciò che gli altri non percepiscono, mentre Giasone e gli Argonauti «sono raffigurati come una banda di giovani pre doni arroganti e aggressivi, che rubano cavalli e tesori sacri»s. D conflitto tra la dimensione arcaica e sacra e quella moderna, la techné greca violenta e ottusa, ma anche il con flitto tra eros e maternità6, cifra dello scontro estremo tra maschile e femminile, conduce alla tragedia. Questa è anche la prospettiva della maggior parte degli autori che scrivono intorno a Medea tra Ottocento e Nove cento, da Franz Grillparzer a Corrado Alvaro7. Recentemen te, nel romanzo Medea. Voci, del 1996, Christa Wolf cerca invece di recuperare l'identità più antica di Medea «non un'infanticida, dunque, al contrario una donna forte e gene rosa, depositaria di un remoto sapere del corpo e della terra che una società intollerante emargina e annienta negli affetti fino a lapidarie i figli»8. Medea è «colei che sa consigliare e 37
FIGURE FE.\1:\U:-;IU DEL SAPERE
provvedere»9, il suo sapere è legato alla medicina e alla gua rigione, ma nel momento in cui scopre l'orribile segreto di Corinto, su cui si fonda il potere del re, deve essere elimina ta, insieme ai suoi figli. Per ricordare brevemente le linee essenziali del mito: Medea, principessa di Colchide, aiuta Giasone ad impadro nirsi del Vello d'Oro, che gli farà recuperare il trono usurpa to da suo zio Pelia. Per riuscire nell'impresa, che è una vera e propria aventure, Giasone deve affrontare una serie di prove, tra cui la terribile lotta con un drago, che sarebbero impossibili da superare senza la preziosa alleanza di Medea, che per lui tradisce, abbandona la sua gente e in alcune ver sioni uccide e fa a pezzi il fratello Apsirto per fermare gli inseguitori inferociti. Dopo alterne vicende, la coppia giunge in esilio a Corinto, dove Medea, considerata la barbara stra niera, è accolta con ostilità e diffidenza. Giasone si accorge che può recuperare parte del potere e del prestigio solo se abbandona Medea, da cui ha avuto due figli maschi, e sposa Creusa, figlia del re Creante. Medea si vendica uccidendo prima la principessa, con una magnifica veste intrisa di vele no letale, e poi i due figli avuti da Giasone, quindi si alza in volo su un carro del Sole trainato da due draghi. L'uccisione dei figli, che non compare nella tradizione precedente ad Euripide, è il segno del pericolo rappresenta to da una donna che si ribella. Se una madre non uccide mai la figlia sono spesso delle madri assassine che, come Medea, uccidono i loro figli per meglio distruggere il marito. Ma sono comunque sempre dei figli maschi quelli che esse uccidono togliendo così allo sposo la tracotante tranquillità del padre il cui nome e la stirpe i figli perpetueranno. E ancora: li fatto è che, nella tragedia, tra i sessi c'è una tensione viva e la donna che raggiunge il pàthos insorge sempre contro l'uomo. Con formemente alla "razza delle donne" - che gli àndres evocano
2. :\IEDEA, DOI\1\A DIVII\A
quando vogliono provare terrore e attrazione al tempo stesso -, la madre vive con sua figlia in un circuito chiuso, ma la collera fem minile è una minaccia per il figlio maschio in quanto egli rappre senta il padre10• René Girard riconduce questo gesto al quadro rituale del sacrificio, che trova conferma nelle rappresentazioni icono grafiche11 , in cui Medea che uccide i figli è vicino ad un alta re: «All'oggetto reale del suo odio che rimane fuori portata, Medea sostituisce i propri figli [ . . . ] Medea prepara la morte dei propri figli nel modo in cui un sacerdote prepara un sacrificio»12• Medea distrugge la genealogia maschile di Giasone, la sua discendenza13. L'atto di Medea è condannato in maniera così grave soprattutto perché non inscritto nell'ordine pater no; una vicenda vicina, e nota al mondo occidentale14, è quella di Procne e Filomela. Tereo, re di Tracia, sposa Proc ne, figlia del re di Atene, e violenta sua sorella Filomela; per impedirle di parlare, le taglia la lingua, ma Filomela affida alla tessitura di una tela la narrazione delle sue disgrazie. La vendetta sarà tremenda: Procne uccide Iti, il figlio che lei aveva avuto da Tereo e glielo offre come crudele pasto, poi le due donne vengono trasformate in rondine e usignolo, eternamente in lacrime e inseguite da Tereo, a sua volta tra sformato in falco1s. L'unione tra una dea e un essere mortale, lo sottolinea George Devereux in Femme et Mythe, genera des en/ants semblables à Dieu16, di conseguenza è possibile interpretare la morte rituale dei figli di Medea anche come ritorno all'al tro mondo, quello divino della madre; infatti, nelle versioni più antiche la morte dei figli viene o attribuita ai corinzi Euripide per primo imputa a Medea l'uccisione dei figli, per poter meglio presentare Corinto sulla scena del teatro greco durante le feste di Dioniso, in una «sorta di disinvolta cosmesi di stato»17- o narrata come pratica mancata di con versione all'immortalità attraverso la sepoltura rituale nel tempio di Hera18• Anche lo smembramento di Apsirto, ai nostri occhi così terrificante, può essere interpretato - e
39
FIGURE FE.\1:\U:-;IU DEL SAPERE
Pasolini anticipa la morte di Apsirto con quella rituale di un giovane schiavo - come un rito propiziatorio agrario legato alla fertilità della terra19. Inoltre lo smembramento (diaspa ragmos) compare in altri episodi del mito di Giasone e Medea, come pratica di ringiovanimento o guarigione, atto che avvicina Medea alle dee protettrici. In Colchide, e pro babilmente dopo aver affrontato il drago, Medea fa a pezzi Giasone e lo fa bollire in un calderone magico che gli ridona vita e giovinezza; la stessa pratica verrà attuata a Iolco, per ringiovanire il padre di Giasone, Esone2'0• Nella declinazione del mito, questi due atti, uccisione dei figli e smembramen to, sono stati enfatizzati o ignorati per dare più o meno risal to alla crudeltà di Medea. Dunque, la storia di una donna innamorata tradita, non solo nell'amore, ma nel patto con Giasone che aveva com portato per Medea l'abbandono della sua comunità e il tra dimento, con il furto di un oggetto sacro, una donna che si ritrova in terra straniera, considerata una barbara incivile, e che si vendica con crudeltà. Ma Medea non è una donna qualunque: figlia del re Eeta, discende dal Sole11 , di cui è nipote è sul carro del Sole che Medea vola via da Corinto , è sorella o nipote di Circe «terribile dea dalla parola umana» ( Odissea, 10,136)11 e figlia, secondo la versione più antica, quella di Esiodo nella Theogonia, di Idia, dea marina, "colei che sa" . n suo stesso nome rinvia alla sfera del sapere, del l'intelligenza, alla metis13. N ella tradizione più recente la madre di Medea diventa Ecate, sovrana degli Inferi. n deci so cambiamento di genealogia di Medea nel tempo è legato alla necessità di costruire un'immagine più forte, non più donna sapiente, donna divina, ma strega, fattucchiera terrifi cante, come osserva lucidamente Alain Moreau in Le mythe -
-
de ]ason et Médée: Le changement de généalogie est lié au passage de la deésse bien faisante à la sorcière maléfique. Fille d'une Océanide, Medée est en rapport avec les puissances élementaires énumérées par Hésio de au début de la Théogonie. Fille d'Hécate, elle est, certes, tou jours liée au monde divin, mais elle est surtout mise en relation
40
2.
:\IEDEA, DOI\1\A DIVII\A
avec la déesse nocturne qu'on invoque lorsqu'à minuit, aux carre fours, on s'adonne aux pratiques magiques24. Se nelle versioni più antiche del mito Medea era una sorta di fata/maga benefica2s, dal v secolo a.C. si trasforma pro gressivamente in strega, esperta in magia nera; il discorso intorno al sapere di Medea, un sapere femminile, in qualche modo sempre un po' scomodo, difficile da accettare, è dun que un nodo fondamentale, intorno a cui riflettere.
2. Medea, nei tempi antichi figura di dea-madre, legata ai riti di fecondità e di guarigione, subisce a partire da Euripi de (V secolo a.C.), che narra di Medea a Corinto, una gra duale trasformazione, fino a divenire l'immagine di un fem minile negativo, altero e indomito, che fa paura: fantasme de l'homme grec qui détient tous les pouvoirs et imagine, dans la terreur et la fascination, des femmes qui refuseraient l'im plicite pacte social où l'homme est tout et la femme n'est rien; des femmes qui se révolteraient, qui tueraient et installeraient la gyné cocratie: Médée, Clitemnestre, les Lemniennes, les DanaYdes ou les Arnazones. Fantasme archétypique des démons féminins de la nuit, ces etres funestes qui tuent, castrent, stérilisent, torturent ou vam pirisen t26 . Euripide presenta sin dall'inizio Medea in termini eroici, tra scinata, come l'Aiace sofocleo, dal thumos, il furore, la colle ra appassionata, la «feroce risoluzione eroica»27. Tuttavia nella tragedia di Euripide è impressionante la totale adesione del Coro che sottolinea la grandezza eroica di Medea: essa lascerà un segno femminile nella memoria, al posto di una scrittura assente, delle "nuove parole" che final mente ribalteranno una cultura terribilmente androcentrica: Coro:
Risalgono le correnti dei sacri fiumi e giustizia e ogni cosa è stravolta. Menzogneri i consigli degli uomini né i divini
FIGURE FE.\1:\Il:-\IU DEL SAPERE
giuramenti han più valore. Ma nuove parole stravolgeranno la mia vita così da darle gloria. Onore giunge alla razza femminile. Parole infauste non ci saranno più contro le donne. Le muse degli antichi poeti non più inneggeranno alla mia infedeltà. Febo, guida dei canti, alla nostra mente non concesse la divina poesia della lira: avrei fatto risonare a mia volta un inno contro la razza dei maschi. n lungo corso del tempo molto può dire sulla sorte nostra e degli uomini18. In Eu ripide Medea non è solo furore, è anche la donna sapiente, sophe, e pharmakis, esperta di filtri e veleni; pro prio questi tratti verranno colti dalla tradizione successiva e amplificati fino ad assumere i toni feroci e neri di Seneca (4 a.C.-65 d.C.), che trasforma Medea in mostro, una furia, una strega maledetta: Nutrix:
Pavet animus, horret: magna pernicies adest. Immane quantum augescit et semet dolor accendit ipse vimque praeteritam integrat. Vidi furentem saepe et aggressam deos, caelum trahentem: maius his, maius parat Medea monstrum. Namque ut attonito gradu evasit et penetrale funestum attigit, totas opes effudit et quidquid diu etiam ipsa timuit promit atque omnem explicat turbam malorum, arcana secreta abdita, et triste laeva comparans sacrum manu pestes vocat quascumque ferventis creat barena Libyae quasque perpetua nive Taurus coercet frigore Arctoo rigens, et omne monstrum.
2. :\IEDEA, DOI\1\A DIVII\A
(Nutrice: Mi trema il cuore, e teme: incombe una catastrofe. Cre sce a dismisura la sua esasperazione e s'infiamma da sé e ritrova il vigore di un tempo. L'ho vista spesso in preda al furore, andar contro gli dei e trarre giù il cielo: ma quel che medita Medea è ancora più mostruoso. Come corre, di un passo allucinato, nella parte più interna della casa, dà fondo a tutte le sue arti, tira fuori tutto quello che faceva paura anche a lei, scatena una folla di malefici, cose arcane, segrete, misteriose; preparando il fosco sacri ficio con la mano sinistra, chiama a raccolta ogni flagello generato dalle sabbie della Libia infuocata o imprigionato nelle nevi eterne del Tauro sotto il cielo del nord, ogni mostruosità.) 29
Medea evoca il caos, il disordine, la sovversione, la rovina del mondo: . . . invadam deos et cuncta quatiam. . . . Sola est quies, mecum ruina cuncta si video obruta: mecum omnia abeant. Trahere, cum pereas, libet. (vv. 423-424 e 427-429) (Aggredirò gli dei, farò crollare il mondo [ . . . ] La mia pace è solo vedere tutto in rovina con me. Vada tutto in malora con me. È bello travolgere altri nella propria caduta.)3° E nell'invocazione di Medea a Ecate - la dea triforme, divi nità del cielo, della terra e degli inferi - Ovidio (43 a.C.-17 d.C. ) , auto re di una Medea andata perduta, in un 'ampia sezione delle Metamorfosi ci offre il ritratto di una furia sca tenata e onnipotente: Tuque triceps Hecate, quae coeptis conscia nostris Adiutrixque uenis cantusque artisque magorum, Quaeque magos, Tellus, pollentibus instruis herbis, Auraeque et uenti montesque amnesque lacusque, Dique omnes nemorum, dique omnes noctis, adeste; Quorum ope, cum uolui, ripis mirantibus, amnes In fontes rediere suos concussaque sisto, Stantia concutio cantu freta, nubila pella 43
FIGURE FE.\1:\II:-;ru DEL SAPERE
Nubilaque induco, uentos abigoque uocoque, Vipereas rumpo uerbis et carmine fauces, Viuaque saxa sua conuulsaque robora terra Et siluas moueo, iubeoque tremescere montis Et mugire salurn manesque exire sepulcris. (VII, vv. 194-206) (E tu, Ecate dalle tre teste, che sei conscia della mia impresa e giungi quale soccorritrice delle nenie e delle operazioni dei maghi; e tu, o terra, che ai maghi offri quali armi le erbe dotate di virtù; e voi, brezze e venti e monti e fiumi e laghi; e voi, numi tutti dei boschi, numi tutti della notte, siatemi propizi. Per il vostro potere, al voler mio, fra lo stupore delle rive, i fiumi ritornano alla loro sorgente; al canto mio, io placo il mare sconvolto, io sconvolgo il mare in bonaccia: scaccio le nuvole e le addenso, respingo i venti e li richiamo; con parole del mio carme infrango le fauci dei serpen ti, trascino come cose vive e rupi e querce divelte dalla loro terra e selve; comando ai monti di scuotersi, al suolo di mugghiare, ai Mani di uscire dai sepolcri.)31 Anche nelle Heroides, raccolta di lettere immaginarie inviate da figure femminili del mito agli amati lontani, nonostante emerga fortemente il rimpianto e la nostalgia di chi è stata abbandonata, Ovidio mantiene in Medea dei tratti che lascia no intravedere una violenza estrema. Pensando alla rivale, Medea esclama: Rideat et vitiis laeta sit illa meis ! Rideat et Tyrio iaceat sublimis in astro Flebit et ardores vincet adusta meos ! Dum ferrum flammaeque aderunt sucusque veneni Hostis Medeae nullus inultus erit. (XII, vv. 178-182) (Che rida, e gioisca dei miei difetti! Rida, e giaccia altera su por pora di Tiro - piangerà, e le fiamme che la bruceranno supereran no le mie! Finché ci sarà ferro, fuoco e succhi velenosi, nessun nemico di Medea resterà impunito.) Quo feret ira, sequar! facti fortasse pigebit; Et piget infido consuluisse viro. 44
2. :\IEDEA, DOI\1\A DIVII\A
Viderit ista deus, qui nunc mea pectora versat! N escio quid certe mens mea maius agit. (XII, vv. 209-212) (Dove l'ira mi porterà, io la seguirò! Della mia azione forse mi pentirò; mi pento però anche di aver dato aiuto a un marito infe dele. Ma di questo si occupi il dio che ora sconvolge il mio petto. Sì, la mia mente sta meditando qualcosa di enorme.)3 2 3 · La dialettica del personaggio, da una parte un femminile pericoloso, che può minare l 'ordine patriarcale nella sua legge fondamentale, la discendenza, e dall'altra la donna sapiente, in altri tempi legata ai riti di fecondità e di guari gione, si concentra in epoca medievale, segnata profonda mente dal cristianesimo e dall'idea di peccato-redenzione , su due figure fondamentali: la fata e la strega. Nell'una, divinità luminosa, come nell'altra, l'invasa dal demonio, permane l'e sperienza di amante tradita. Ma parlando di Medea si vuole parlare in realtà della natura della donna e del suo ruolo nella storiaH. Giovanni Boccaccio, che tratta di Medea di frequente nelle sue opereH - nella Genealogia Deorum Gentilium, nel De Casibus Virorum Illustrium, nel De Mulieribus Claris, nella Elegia di madonna Fiammetta -, utilizza il mito dell'an tichità per un discorso sui vizi e le virtù del suo tempo. Nel
De Mulieribus Claris (XVII , De Medea regina Colcorum, 1361) , che circolava anche i n traduzione francese all 'inizio del Quattrocento (De Cleres et Nobles Femmes, 1401) , l'enfasi va tutta sulla castità femminile, e gli exempla del passato offro no la materia per considerazioni sulla natura delle donne, in base al concetto di "virtù" , categoria morale basata sull'uso che una donna fa della propria sessualitàH. Boccaccio attrae l'attenzione sulla lussuria legata allo sguardo femminile e offre un ritratto di Medea a dir poco terrificante, concentra to di perversione e crudeltà: Medea, sevissimum veteris perfidie documentum, Oete, clarissimi regis Colcorum, et Perse coniugis filia fuit: formosa satis et malefi tiorum longe doctissima. Nam, a quocunque magistro instructa sit,
45
FIGURE FE.\1:\II:-;ru DEL SAPERE
adeo herbarum vires familiares habuit, ut nemo melius; novitque piene cantato carmine turbare celum, ventos ex antro ciere, tempe states movere, flumina sistere, venena conficere, elaboratos ignes ad quodcunque incendium conponere et huiusmodi perficere omnia. (Crudelissimo esempio di antica perfidia, Medea fu figlia di Eeta, famosissimo re della Colchide, e di sua moglie Perse. Fu donna bellissima e molto esperta nel maleficio. Ella ebbe infatti - quale che sia stato il suo maestro - tale conoscenza della virtù delle erbe, che nessuno la superò. Pronunciando formule rituali, riusciva senza fallo a turbare il cielo, a sprigionare i venti, a suscitare le tempeste, ad arrestare il corso dei fiumi, a preparare veleni e fuo chi per appiccare qualunque incendio, e a compiere altre azioni del genere.)36 Medea è compresa anche tra gli esempi di donne abbandona te e tradite nella seconda parte del Roman de la Rose di Jean de Meun (1270 ca.); la Vieille mette in guardia le giovinette dai falsi amanti traditori. Ancora una volta Medea è dipinta come una maga esperta di veleni: Et li /it avoir la toison l par son art et par sa poison 37 (E gli fece avere il vello l con le sue arti e il veleno, vv. 13247-13248) , capace di orribili delitti: Dont ses enfans, quant el le sot, Pour ce que de J asson les ot, Estrangla de duel et de rage, Dont el ne fist mie que sage Quant el lessa pitié de mere Et fist pis que marrastre amere. (vv. 13257-13262) (Quando lo seppe, per il dolore e la rabbia, e perché li aveva avuti da Giasone, strangolò i suoi due bambini. Non si comportò sag giamente, quando abbandonò ogni pietà di madre e agì peggio di una crudele matrigna.)
È ancora l'immagine di una strega quella offerta dal Livre des Lamentacions de Mathéolus, opera violentemente misogi na scritta in latino nel XIII secolo e tradotta in francese da
2. :\IEDEA, DOI\1\A DIVII\A
Jean le Fèvre nel 1370. Medea è compresa tra gli esempi di donne negromanti che fanno sacrifici al demonio, che si aggirano furtive di notte, e vanno a prendere i capelli e la corda dell'impiccato per i loro riti: Elles vont au gibet de nuys Prendre les cheveulx et la corde Du pendu, c'est chose trop orde. La morte de l' ame est avancie Par leur false nigromancie. Medée, ce dit le poete, Jadis, fili e du roy lEete, Fu sorciere et enchanteresse, En magique fu grant maistresse: Des herbes congnoissoit chascune Et l'influence de la lune38. (II, vv. 2034-2044) (Vanno vicino al patibolo, di notte l a prendere i capelli e la corda l dell'impiccato, cosa davvero ripugnante. l Con la loro negroman zia maledetta l provocano la morte dell'anima. l Medea, come rac conta il poeta, l figlia del re Eete, fu in passato l strega e incanta trice, l grande maestra di magia: l conosceva tutte le erbe l e gli influssi lunari.) Un altro esempio dello stesso genere ci viene dall'O vide Moralisé, opera immensa ( 72.000 versi ottosillabi) scritta da autore anonimo tra il 1291 e il 1328, rimaneggiamento delle
Metamorfosi di Ovidio, di cui viene rispettata la divisione in libri, che integra con considerazioni di tipo morale e interpre tazioni allegoriche. I primi 2.114 versi (su 3.676) del VII Libro raccontano il mito di Medea e Giasone. Di nuovo ci troviamo di fronte a un esempio di funesto furore femminile: Et quant Medea sot de voir Qu' el ne porrait sa pais avoir D'ire et de rage forsena. Sa rage tant la demena, Que deus enfans, qui sien estoient, Pour ce que lor pere sambloient 47
FIGURE FE.\1:\U:-;IU DEL SAPERE
O cist en despit de J ason, Puis mist en flambe sa meson, Si s'enfu1 par l'air volant. Trop ot Jason le cuer dolant Et, s'il peiist, morte l' eiist: Jamais home ne deceiist. Mais li deux dragon li sauverent, qui par l' air volant l' emporterent39. (vv. 1487-1500) (E quando Medea comprese l che non avrebbe trovato pace l diventò folle d'ira e di rabbia. l La rabbia la sconvolse tanto l che uccise i suoi due figli, l poiché assomigliavano al loro padre, l per ferire Giasone, l poi appiccò il fuoco alla casa l e fuggì volando nell'aria. l Giasone aveva il cuore a pezzi l e, se avesse potuto, l'a vrebbe uccisa: l mai nessuno l'aveva ingannato. l Ma due draghi la salvarono, l portandola via in volo.) Da notare come anche il volo, che in Euripide avviene su un carro del Sole, e sottolinea così l 'origine divina di Medea, qui è più vicino a quelli, notturni, delle streghe. Accanto a questa tradizione di crudeltà, ne esiste una meno feroce, dove emerge un altro volto di Medea; uno dei testi più interessanti da questo punto di vista è sicuramente il Roman de Troie (circa n6o- n7o) , di Benoit de Sainte Maure, intellettuale, clerc, forse appartenente alla corte di Enrico II ed Eleonora d'Aquitania, che descrive in 30.ooo versi, com'è noto, la storia della guerra di Troia. TI primo lungo episodio del Roman de Troie4° è proprio dedicato a Giasone e Medea. Per più di 1.300 versi (vv. 71 52078) Benolt de Sainte-Maure ci racconta, con dovizia di particolari e lunghe e accurate descrizioni, e concentrandosi quasi esclusivamente sull'episodio di Iolco, in Colchide, l'in contro tra Giasone e Medea, l'innamoramento e la conquista del vello d'oro; fedele alle regole della medievalizzazione del testo, la città è descritta come luogo dell'abbondanza e della ricchezza. I cavalieri ospiti vengono ricevuti con tutti gli onori dal re e dai baroni ( Oetés vait contr'elz, li reis. l Si 4·
2. :\IEDEA, DOI'\1'\A DIVII'\A
baron e si vasvassor l les reçurent a grant henor,
11982ooo). n re manda a chiamare Medea, sua unica figlia ed erede, eliminando così uno dei motivi di demonizzazione del personaggio, l 'uccisione e lo smembramento del fratello Apsirto, che ho ricordato prima. n poeta insiste sul sapere della principessa: vv.
Li reis es chanbres enveia E si tramist par Medea: C'ert une fille qu'il aveit, Qui de mout grant beauté esteit. Il n'aveit plus enfanz ne eir. Trop iert cele de grant saveir. Mout sot d' engin, de maYstrie, De conjure, de sorcerie; Es arz ot tant s'entente mise Que trop par iert saive e aprise; Astronomie e nigromance Sot tote par cuer dé s' enfance. D'arz saveit tant e de conjure De der jor feYst nuit oscure. (vv. 1211-122.4) (Il re mandò a chiamare l Medea nei suoi appartamenti: l era sua figlia l che era bellissima. l Egli non aveva altri figli né eredi. l Medea era molto sapiente. l Era maestra d'ingegno, l nella magia e negli incantesimi; l aveva studiato tanto le arti l da diventare esperta e sapiente; l conosceva a memoria sin dall'infanzia l l'a stronomia e la negromanzia. l Conosceva così tanto della magia e degli incantesimi l che avrebbe potuto mutare il giorno in notte buia.) ma anche sulla bellezza senza pari di Medea e sulla sua cor tesia: Mais el pàis ne el regné N en esteit riens de sa biauté. Par mi la sale vint le pas; La chiere tint auques en bas, Plus fine e fresche e coloree 49
FIGURE FE.\1:-JI:-;ru DEL SAPERE
Que la rose quant el est nee. Mout fu corteise e bien aprise. (vv. 1247-1253) (In tutto il paese e nel regno l non c'era una donna così bella. l Attraversò lentamente la sala; l il suo viso, un po' reclinato, l era più fine, fresco e colorito l che la rosa novella. l Era molto cortese e ben educata.) Già dalla sua prima comparsa Medea, accompagnata da sette fanciulle, fa pensare alla figura della fata. Non appena vede Giasone, se ne innamora; Amore, a cui nessuno può resistere, la imprigiona nei suoi lacci: Des or la tient bien en ses laz l Amors vers cui riens n 'a des/ense (vv. 1294- 129 5) . Medea lo mette in guardia dai pericoli che dovrà affrontare per conqui stare il vello d'oro, protetto da tori di bronzo e da un terribi le drago, che sputa fuoco e veleno ma, quando si rende conto che Giasone è deciso e dunque morirà sicuramente, gli propone un patto, come una fata. In cambio di felicità e ric chezza impone al proprio cavaliere una promessa: se egli le accorderà il suo amore e le promette di sposarla e di essere leale, Medea lo aiuterà. Giasone risponde senza esitare: - Dame, fait il, je qu' en diroie? Sor toz les dex te jureroie E sor trestote vostre loi Amer toz jors e tenir foi. A fame vos esposerai, Sor tote rien vos amerai; Ma dame seroiz e m'arnie, De mei avreiz la seignorie. (vv. 1429-1436) (Dama - fece lui - che vi posso rispondere? l Vi giuro su tutti gli dei l e sul vostro credo l di amarvi per sempre e di esservi fedele. l Vi prenderò come mia sposa, l sopra ogni cosa vi amerò; l sare te la mia signora e la mia amica, l su di me avrete ogni potere.) Quindi i due futuri amanti si accordano per incontrarsi la notte seguente e , dopo uno splendido monologo in cui 50
2. :\IEDEA, DOI\1\A DIVII\A
Medea esprime tutte le sue esitazioni, le ansie, l'emozione dell'attesa, durante la quale va e viene senza sosta, dall'uscio alla finestra, pensive e pallida, finalmente Giasone la raggiun ge. Egli giura sulla statua di Giove che sarà un marito fedele e un fedele amante leial seignor, leial amant (v. 1633) , giura mento, avverte l'autore, che poi non saprà mantenere: ]ason ensi li otreia, l mais envers li s'en parjura (vv. 163 5- 1636) . Quando all'alba, come due amanti cortesi, essi si separa no, Medea consegna a Giasone alcuni oggetti : un talismano, un balsamo che lo proteggerà dal fuoco e un anello che lo renderà invincibile, poi gli insegna come vincere gli esseri mostruosi a guardia del vello; Giasone segue scrupolosamen te gli insegnamenti di Medea e ritorna vittorioso. Tutti vedo no in lui un essere sovrannaturale, fatato: Bien le tienent tuit a /aé (v. 2002) . Qui il racconto si conclude rapidamente sulla fuga di Giasone e Medea, che compie una grande follia, per troppo amore: Grant folie fist Medea: Trop ot le vassal aamé. Pour lui laissa son parenté, Son pere e sa terre e sa gent. Mais assez l' en prist malement, Quar, si cum li auctors recante, Puis la laissa, si fist grant honte. (vv. 2030-2036) (Medea commise una grande follia: l aveva amato troppo il vassal lo. l Per lui aveva abbandonato i suoi parenti, l il padre, la sua terra e la sua gente. l Ma la pagò molto cara l poiché, come rac conta l'autore, l Giasone in seguito l'abbandonò, con grande onta.) Giasone, che deve tutto a Medea, anche la vita, la tradisce laidement e, per togliere dall'eroina qualsiasi ombra, l'autore ci dice che saranno gli dei, adirati, a vendicarla: El l'aveit gardé de morir, Ja puis ne la deiist guerpir.
51
FIGURE FE.\1:-JI:-;ru DEL SAPERE
Trop l' engigna, ce peise mei; Laidement li menti sa fei. Trestuit li deu s' en corrocierent, Qui mout asprement l' en vengierent. (vv. 2037-2042) (L'aveva salvato dalla morte, l mai avrebbe dovuto lasciarla. l Troppo la ingannò, e me ne dolgo; l con disonore tradì il giura mento. l Tutti gli dei si adirarono per questo, l e la vendicarono molto duramente.) Nel Livre de Leesce41, composto tra il 1380 e il 1387, Jehan le Fèvre costruisce una sorta di risposta alla misoginia del Livre des Lamentacions de Mathéolus, attraverso l 'intervento di Dame Leesce, che ribatte a tutte le accuse di Mateolo nei confronti delle donne. Medea viene raccontata come esem pio di principessa bella, nobile e saggia ingiustamente ingan nata dalle false promesse di Giasone: Mais on doit avoir en memoire Comment Medée le reçut Et comment Jason la deçut. Medée estoit fille de roy Et ne pensoit a nul desroy; Elle estoit belle, bonne et sage. (vv. 2380-2385) (Ma bisogna ricordare l come Medea l'aveva ricevuto l e come Giasone la tradì. l Medea era figlia di re l e non pensava al tradi mento; l era bella, nobile e saggia.) Quasi 1 .300 versi dopo, l'autore ci parla di nuovo di Medea, pe r lodarne il sapere senza pari, un sapere che proviene dallo studio delle sette arti liberali. Cade completamente qualsiasi riferimento a una scienza oscura, alla magia nera; al contrario il suo sapere suscita meraviglia a tal punto da farla considerare una donna divina: Moult fu sage a grant merveille; En son temps n'ot oncques pareille. 52
2. :\IEDEA, DOI\1\A DIVII\A
De tous les sept ars fu maistresse Et loée camme deesse. (vv. 3639-3642) (Era sapiente in modo straordinario; l nel suo tempo non ve ne furo no di eguali. l Era maestra nelle sette arti l e lodata come una dea.) 5· Medea emerge ovunque anche nell'opera di Christine de Pizan (1365-1430?) che, come Christa Wolf, recupera la ver sione più antica del mito, quella di una donna più divina che umana, dal sapere immenso. È sorprendente come dall Epistre au Dieu d'Amours (1399) al Livre du débat de deux amans, all ' Epistre Othea (1400-140I) , alla Mutacion de Fortune (1400-1403) , alla Cité des Dames (1405) , alle Cent bal lades d'amant et de dame (Lay de Dame, 1409·10)42, Medea attraversa l'opera di Christine de Pizan, personaggio chiave della sua scrittura43 . Nella Epistre au Dieu d'Amours (maggio 1399) Christine si scaglia contro l'Ars amatoria di Ovidio e il Roman de la Rose di Jean de Meun, opere che insegnano l'arte di ingan nare le fanciulle: livre d'Art de grant decevance (v. 377) . Tra i falsi amanti ingannatori, /aulz amans, desloiaulz (v. 64 e v. 65) , il faulz ]ason (v. 437). Christine sottolinea la grande leal tà di Medea, il suo sapere, la fama conquistata da Giasone grazie a lei e come egli ricambierà la generosità della sua amica con un tradimento: '
Que fut jadis Medée au faulz Jason? Trés loialle, et lui fist la toison D'or conquerir par son engin soubtil, Don t il acquist loz plus qu' autres cent mil. Par elle fu renommée dessus tous, Si lui promist que loial ami doulz Seroit tout sien, mais sa foy lui menti Et la laissa pour autre et s' en parti44. (vv. 437-444) (Che ne fu in passato di Medea con Giasone il falso? l Molto leale, gli fece conquistare il vello l grazie al suo fine ingegno, l e questo 53
FIGURE FE.\1:\II:-;ru DEL SAPERE
gli procurò più onore che a centomila uomini. l Grazie a lei fu famoso più di tutti, l così le promise che sarebbe stato l il suo dolce e leale amico, ma la tradì, l la lasciò per un'altra e se ne andò.) Nel Livre de la Mutacion de Fortune45 (1400-1403) Christine de Pizan dedica alla storia di Medea e Giasone quasi cinque cento versi (14301-14786) . Fortissima qui l'idea del conflitto tra amore e intelletto: Medea, bella, intelligente e molto colta, pratica le arti magiche come un ramo del sapere, una scienza: Sur toutes les femmes soubtille, Sage, clergece et es VII . ars Apprise, et adés, tost et tars, Estudioit plus en magique Qu' en la science de logique. Si en avoit l' experience Et en sot toute la science. (vv. 14302-14308) (Più di ogni altra donna intelligente, l saggia e maestra nelle lette re l e nelle sette arti, di continuo l studiava la magia, l più che la logica. l In questo modo divenne esperta l e ne conobbe tutti i segreti.) Pur di proseguire lo studio Medea non accetta nessuno sposo, per quanto nobile sia, in questo vicina a tante dame della Città, da Pentesilea a Sinoppe, Camilla, le Sibille, le profetesse, Cassandra, che disprezzano l'unione sessuale per dedicarsi alle armi o allo studio: Belle estoit de corps et de vis, Courtoise et bien duite a devis. Mais tant estoit de grant courage Qu'il n'yert roy tant de hault parage, Qu' elle daignast a mari prendre, Tant prisoit la vertu d'apprendre. (vv. 14311-14316) (Aveva un bel viso e un bel corpo, l era cortese e molto sapiente. l Ma era di così forte volontà l che non esisteva re di illustre lignag54
2. :\IEDEA, DOI\1\A DIVII\A
gio l che lei si degnasse di accettare come marito l tanto amava lo studio.) Medea è una regina, royne honoree, presentata in tutto il suo splendore e circondata dalla compagnia delle dame (vv. 14324 ss. ) . Non appena lo vede, si innamora di Giasone, senza riuscire a distinguere (lui semble) la sua vera natura falsa e ingannatrice, dietro la bella apparenza: Moult lui semble, en tout cas, perfaict, Bel et doulx, courtois et gentil, Sage en parler, en sens soubtil. (vv. 14376-14378) (Le sembrò perfetto in tutto, l bello e dolce, cortese e nobile, l saggio nel parlare e molto intelligente.) Amore, tiranno, si sa ben vendicare di tanta ritrosia: Or lui couvient un estrangier Amer, malgré sien ! Bien vengier S' en scet Arnours, qui tant rebelle L' ot trouvee! . . . (Ora le tocca amare l uno straniero, suo malgrado! Amore, l che la trovò tanto ribelle, l si sa ben vendicare! ) Giasone è uno straniero, u n chevalier estrangier, l'intruso, il falso e ingannatore (le parjure e desloyal) , che riesce a con quistare il vello d'oro solo par Medee et par son sçavoir, un sapere che tuttavia non l'aiuta a riconoscere l'inganno: Et celle, qui seult estre sage Adés pert et sens et savoir, Et n' apperçoit que decevoir La veult cellui qui mentira. (vv. 14534-14537) (E lei, che seppe essere saggia l ora perde senno e sapere, l e non si accorge che la vuole ingannare l colui che mentirà.) 55
FIGURE FE.\1:\II:-;ru DEL SAPERE
Nell'opera di Christine è Giasone lo straniero e non Medea, ribaltando così completamente l'immagine tradizionale del l'eroina che giunge da un Oriente lontano, barbaro e primi tivo, in contrasto con la civiltà greca; Amore rende ciechi e anche la persona più saggia non si rende conto dell'inganno, per il troppo amare (que le plus sage n'apperçoit l sa follie, par trop amer, vv. 14688- 14689) . Giasone inganna Medea e, cosa ancora più grave, le carpisce i suoi segreti , la separa dalla sua terra, dal suo mondo, da quello che sarebbe stato il suo regno, per poi !asciarla sola e senza più risorse. Moult estrangement l' entalente Amour, qui si la scet blecier Que son pays lui fait laissier Et son regne et son heritage, Son chier pere et tout son lignage, Pour un chevalier estrangier, Qui pourra tost son cuer changier Et elle laissier separee De ses amis et esgaree. (vv. 14720-14728) (Straordinariamente la colma di desiderio l Amore, che la sa ferire così tanto, l da farle abbandonare il suo paese l e il suo regno e l'eredità, l il suo caro padre e tutti i parenti, l per un cavaliere straniero, l che potrà presto mutare il suo cuore, l e !asciarla, lon tana l dai suoi amici e smarrita.) Più divina che umana, Medea si vendica, uccidendo i figli avuti da Giasone. Christine racconta senza giudicare, breve mente, in pochi versi: Medee si s' enflama, Quant elle sot le mariage, Que mourir le fist plain de rage Et deux enfens, qu' ot eus de lui, Sanz estre rescoux de nullui. (vv. 14774-14778)
2. :\IEDEA, DOI\1\A DIVII\A
(Medea si infuriò talmente, l quando seppe del matrimonio, l che pieno di rabbia lo uccise l e i due bambini, che aveva avuto da lui, l e non furono difesi da nessuno.)
È una vendetta resa inevitabile e quasi giustificata dagli avvenimenti, unico tocco di crudeltà di tutto l'episodio. 6. Nella complessa opera di revisione della tradizione lette raria maschile-+6 che Christine de Pizan compie nella Cité des Dames trovano spazio figure femminili dell'antichità e del mito, con cui la scrittrice si confronta e, a volte, si identifica. Figure autorevoli, nella costruzione di una genealogia fem minile e " altra " , che forniscono la materia prima pe r la costruzione della Città, così splendente che tutte le donne nobili vi si possono specchiare, nel senso più medievale e didascalico del termine: Car vous povez veoir que la matiere
dont elle est /aite est toute de vertu, voire si reluisant que tou tes vous y povez mirer (La Città è stata costruita, come pote te vedere, con i materiali della virtù, così rilucenti che voi tutte vi potete specchiare, Cité III, XIX, pp. 498-9 )47. Tra que ste, un grande personaggio: Medea. Christine separa in due momenti diversi la storia di Medea, distinguendo nella nar razione il tempo della forza e dell'intelligenza, del sapere, da quello dell'esperienza amorosa, che segna anche la sconfitta e la perdita di sé. Medea è raccontata una prima volta tra le donne enluminee de grant science (I, XXXII, Ci dit de Medee et d'une autre royne nommee Circes) , e una seconda tra le donne che hanno amato troppo , così tanto da uscirne distrutte (II, LVI , De Medee amante) . Di fronte a una tradizio ne così feroce, Christine de Pizan recupera la versione più antica del mito, quella di una donna più divina che umana, dal sapere straordinario. Lo sguardo femminile di Christine illumina Medea di una luce totalmente diversa: essa è accolta nella Cité des Dames (I, XXXII) tra le donne e le dee di gran de sapere e creatrici di civiltà nel mondo: Saffo, Circe, Car menta, Minerva, Cerere, Iside e tutte le altre: Medee, de laquelle assez d'istoires font rnencion, ne sceut pas rnoins d'art et de science que celle devant diete [Manto, n.d. r. ] . 57
FIGURE FE.\1:\II:-;ru DEL SAPERE
Elle fu fille de Othes, roy de Colcos et de Perse, moult belle de corsage, haulte et droite et assez plaisant de viaire, mais de savoir elle passa et exceda toutes femmes. (Medea, della quale si parla in molti scritti, non fu inferiore nella conoscenza delle arti e delle scienze [di Manto, n.d. r. ] . Figlia di Eeta, re della Colchide, e di Perse, era molto bella, alta, dritta, slanciata e di viso assai grazioso, ma era nel sapere che superava tutte le altre donne, pp. 162-3) n sapere di Medea è immenso, abbraccia tutte le scienze e le
arti, comprese quelle magiche; poiché nulla le rimane ignoto, conosce e pratica anche gli incantesimi, senza per questo essere una strega: Elle savoit de toutes herbes les vertus et tous les enchantemens que faire se pevent. Et de nulle art qui estre puist sceue, elle n'e stoit ignorente. Elle faisoit par vertu d'une chançon qu'elle savait troubler et obscurcir l' air, mouvoir les vens des fossez et cavernes de la terre, commouvoir les autres tempestes en l'air, arrester les fleuves, confire poisons, composer feux sanz labour pour ardoir quelconques chose qu' elle vouloit et toutes semblables choses savoit faire. (Conosceva le proprietà delle piante e tutti gli incantesimi possibi li: non ignorava nulla di ciò che si poteva sapere. Con le formule magiche che conosceva poteva far tremare l'aria e oscurare il cielo, far uscire dalle profondità della terra il vento delle caverne, provo care la tempesta, arrestare il corso dei fiumi, preparare veleni, suscitare spontaneamente il fuoco per bruciare tutto quello che voleva: sapeva fare tutto questo, pp. 164-5) La grande, bella e sapiente Medea aiuta Giasone nella con quista del Vello d'Oro: Ceste fu celle qui par l'art de son enchantement /ist conquerir a Jason la toison d'or (Fu lei che con i suoi incantesimi permise a Giasone di conquistare il vello d'oro, II, XXXII, pp. 164- 5). n primo racconto termina qui; ritroviamo Medea nel II Libro della Cité (II, LVI), dove Christine narra di donne fedeli in amore, a volte fino alla
2. :\IEDEA, DOI\1\A DIVII\A
morte: nell'ordine Didone, Medea, Tisbe, Ero, Sigismonda, Elisabetta, la dama di Fayel, la castellana di Vergy, Isotta e Deianira. Proprio Didone costituisce il parallelo più interes sante-4-B e, come per Medea, la storia di Didone è narrata in due capitoli diversi. Christine racconta la storia di Didone una prima volta tra le regine sagge nel I Libro (XLVI), esal tando la prudenza, l 'intelligenza e il coraggio della regina fondatrice: Et la dame, tant comme elle pot, exploita de parfaire sa cité. Et quant parfaicte fu, elle establi lois et ordenances au peuple pour vivre selon droit et justice. Et tant se gouverna nottablement et par grant prudence qu' en toutes terres en aloient les nouvelles et ne parloit on se d'elle non telement que pour la gran t vertu qui fu veue en elle, tant pour la hardiece et belle entreprise que fait avoit comme pour son tres prudent gouvernement. (La dama cercò più che poté di terminare la costruzione della città. E quando fu terminata, promulgò leggi e ordinamenti perché il popolo potesse vivere secondo il diritto e la giustizia. Il suo governo fu notevole e di grande prudenza, al punto che la sua fama si diffu se dappertutto, e non si parlava che di lei, del suo coraggio straordi nario, della sua audacia e della bella impresa che aveva compiuto, così come della grande saggezza nel governare, pp. 210-1) La seconda parte della storia di Didone, e la sua rovina, è narrata nel II Libro (LV) . La saggezza e la grandezza di Dido ne vengono annientate dall'amore per Enea, che non sa amare altrettanto nobilmente. La grande regina soccombe per troppo amore, Dido qui trop amoit: Mais selon que l' experience se monstra, moult fu plus grande l'a mour de Dido vers Eneas que celle de lui vers elle [ . . . ] S'en ala, sans congié prendre, de nuit, en recelee, traytreusement, sans le sceu d'elle. Et ainsi paya son oste, laquelle departie fu si grant douleur a la lasse Dido qui trop amoit que elle voult renoncier a joye et vie. (Ma l'esperienza dimostrò che l'amore di Didone per Enea fu molto più grande di quello di lui per lei [ . . . ] Egli se ne andò
59
FIGURE FE.\1:\II:-;ru DEL SAPERE
senza prendere congedo, di notte, di nascosto come un traditore, senza il suo consenso: così ripagò l'ospitalità. Quella partenza inflisse un terribile dolore a Didone, che troppo aveva amato, e volle rinunciare alla gioia e alla vita, pp. 380-1) Anche Medea ama de trop grant amour Jason e si annienta nel momento in cui affida l'anima, il corpo e tutto il suo sapere nelle mani di Giasone che, non riuscendo a distingue re l'inganno, le sembra degno del suo amore. Come nella Mutacion de Fortune, lui sembla anticipa e sottolinea il carat tere illusorio e ingannevole di Giasone: Medee, la fille du roy, qui vid Jason de tele beauté de lignee royal e de si grant renomme que il lui sembla que bon mariage seroit pour elle et que rnieulx ne pourroit employer s' amour. . . elle lui bailla charmes et enchantemens, camme celle qui tous les savoit, et lui apprist toute la maniere comment et par quelle voye il conquerroit la toison d'or, par si que Jason lui promist la prendre a femme, sanz jamais autre avoir, et que loyale foy et amour a tousjours lui porteroit. Mais de ceste promesse lui menti Jason, car apres ce qu'il fu du tout avenu a son entente, il la laissa pour une autre, dont elle, qui plustost se laissast detraire que lui avoir fait ce tour, fu camme desesperee ne onques puis bien ne joye son cuer n' ot. (A Medea, la figlia del re, sembrò che Giasone, per la sua bellezza, per la sua discendenza regale e la sua grande fama, avrebbe potuto essere uno sposo ideale per lei, e che meglio non avrebbe potuto riporre il suo amore . . . Medea gli svelò magie e incantesimi, poiché li conosceva tutti, e gli insegnò in che modo conquistare il Vello d'Oro, a condizione che Giasone le promettesse di prenderla in moglie, senza mai averne un'altra, e di amarla fedelmente per tutta la vita. Ma Giasone con questa promessa le mentì: non appena ottenne quello che voleva, la lasciò per un'altra. Medea, che sareb be stata disposta a morire piuttosto che ingannarlo, sprofondò nella disperazione, e il suo cuore non conobbe mai più la felicità, II, LVI, pp. 382-3) La fedeltà amorosa e la lealtà di Medea, la sua generosità, si scontrano con la falsità di Giasone. La terribile Medea diven ta nella scrittura di Christine simbolo del sapere e della lealtà
6o
2. :\IEDEA, DOI\1\A DIVII\A
femminile nei confronti dell'altro, che non è solo fedeltà in amore, ma disponibilità totale dell'anima e del corpo. Attraverso il destino di Medea, prima di tutto e al di sopra di tutto, donna sapiente e in quanto tale, doppio del l'autrice49, Christine rielabora e corregge il mito, come dimo strano gli studi recenti di Renate Blumenfeld-Kosinskiso; essa intende mettere in guardia ogni donna dai rischi dell'amore, o per meglio dire, del troppo amare . Emerge il conflitto tra amore e sapere, già topos della tradizione antimatrimoniales1, che nello sguardo della scrittrice assume i tratti di una per dita definitiva di identità. Medea, donna sapiente, amò trop po e non si accorse della sua follia; nella costruzione di una genealogia femminile profondamente radicata nel passato, la caduta di una grande donna, di una "donna divina"52, è monito per tutte le altre. Meglio di qualsiasi ulteriore osser vazione, i versi conclusivi della storia di Medea nella Muta
cion de Fortune: Qui s'i vouldra mirer s'i mire, Mais, tel est aucune foiz mire D' autrui maladie garir, Qui puis fait soy mesmes perir! (vv. 14783-14786) (Vi si guardi chi voglia rimirarsi, l ma, succede al medico che, l per guarire qualcuno da una malattia, l egli stesso finisce per morire! )
Medea, immagine e doppio del sapere dell'autrice - i n un gioco di specchi senza fine dove, nel nome di una continua autorappresentazione, ogni grande donna raccontata da Christine riflette una parte di sé -, diventa l'exemplum forse da ammirare, certo da non imitare, per tutte le donne. Note r. D. Mimosa Ruiz, Medée antique et moderne. Aspect rituels et socio politiques, Les Belles Lettres, Paris 1980; dello stesso autore la voce Medea nd Dizionario dei miti letterari, a cura di P. Brunei, Bompiani, Milano
61
FIGURE FE.'d.'dl:-.:IU DEL SAPERE
I995, pp . 464-75; un'ampia panoramica è offerta anche da A. Caiazza, pubblicato in varie parti in "Dioniso", 59 (I989), pp. 9-85 , 6o (I990), pp. 82-n8, 63 (I993), pp. I2.I-4I, 64 (I994), pp. I55-66. 2.. Apollonia Rodio, Le Argonautiche, introduzione e commento di G. Paduano e M. Fusillo, traduzione di G. Paduano, Rizzoli, Milano I999 (I" ed. I986). 3· Ugualmente memorabile è stata l'interpretazione teatrale di !rene Papas nella Medea euripidea allestita per le Olimpiadi di Barcellona dd I992., per la regia di Nuria Espert . Numerosi gli allestimenti teatrali recen ti della Medea di Euripide, tra cui quello di Luca Ronconi, che ha affidato il ruolo di Medea a una voce maschile e quello di Jacques Lassalle, inter pretato da Isabelle Huppert. 4· N. Fusini, Il grande occhio di Medea, in Pier Paolo Pasolini. Le regole di un'illusione, a cura di L. Betti e M. Gulinucci, Associazione Pier Paolo Pasolini, Roma I99I, pp. 391-7. 5· M. Fusillo, La Grecia secondo Pasolini. Mito e cinema, La Nuova Italia, Firenze I996, p. I63. 6. A. Bdtrametti, Eros e maternità. Quel che resta del conflitto tragico di Medea, in Medea nella letteratura e nell'arte, a cura di B. Gentili e F. Perusino, Marsilio, Venezia 1000, pp. 43-65. 7· F. Grillparzer, Medea, a cura di M. Longo, traduzione di C. Magris, Marsilio, Venezia I994· Si veda anche il volume Medea: variazioni sul mito, Euripide, Grillparzer, Alvaro, a cura di M. G. Ciani, Marsilio, Venezia I999· 8. A. Chiarloni, Lo scandalo della ragione, in C. Wolf, I:altra Medea. Premesse a un romanzo, Edizioni e/o, Roma I999, pp. 105-I1 (già apparso come postfazione a C. Wolf, Medea. Voci, Edizioni e/o, Roma I996), a p. I06. 9· Wolf, Medea. Voci, cit., p. 6I; si veda anche C. Wolf, Da Cassandra
Medea: fortuna di un mito,
a Medea. Sollecitazioni e motivi per la rielaborazione di due figure mitologi che, in Prospettive su Christa Wolf Dalle sponde del mito, a cura di G.
Schiavoni, Franco Angeli, Milano I998, pp. I6-31. IO. N. Loraux, Le madri in lutto, Laterza, Roma-Bari I99I, pp. 50 e 54· n. C. Isler-Kerényi, Immagini di Medea, in Medea nella letteratura e nell'arte, cit., pp. u7-38. I1. R. Girard, La violenza e tl sacro, Addphi, Milano I98o, p. 14. I3. G. Guastella, Il destino dei figli di Giasone, in Medea nella lettera tura e nell'arte, cit., pp. I39-75· I4. Attraverso Ovidio (Metamorfosi, VI, I-I45), si veda per esempio la Philomena attribuita a Chrétien de Troyes (Chrétien de Troyes, Romans, La Pochotèque, Paris I994, pp. I2.2.5-67) e gli echi di questa terribile storia nel /ai di Maria di Francia Laiistic (Maria di Francia, Lais, a cura di G. Angeli, Luni, Milano-Trento 1()0()1). I5. Loraux, Le madri in lutto, cit., in particolare il cap. 6: Il lutto del l'usignolo, pp. 57-66. I6. G. Devereux, Femme et mythe, Flammarion, Paris I982, p. 31. I7. Chiarloni, Lo scandalo della ragione, cit., p. I07.
1. MEDEA, DOI'\1'\A DIVII'\A
18. P. Giannini, Medea nell'epica e nella poesia lirica arcaica e tardo in Medea nella letteratura e nell'arte, cit., pp. 13-17. 19. A. Moreau, Le mythe de ]ason et Medée. Le va-nu-pied et la sorci ère, Les Belles Lettres, Paris 1994, cap. m. 10. In un altro episodio Medea, per vendicarsi di Pdia l'usurpatore dd trono che doveva essere di Giasone, istiga le sue figlie a smembrare il vecchio padre, per potergli restituire la giovinezza, con l'unico risultato di farlo morire in maniera orrenda. 11 K. Kerényi, Figlie del Sole, Bollati Boringhieri, Torino 1991 (titolo originale Tochter der Sonne, Zurigo 1944). 11. Omero, Odissea, Einaudi, Torino 1989 (1" ed. 1963). 13. M. Detienne, J. P. Vernant, Les ruses de l'intelligence. La mètis des Grecs, Flammarion, Paris 1974. 14. Moreau, Le mythe de ]ason et Medée, cit., p. 195. 15. Cfr. il bel saggio Medea, edited by J. ]. Clauss and S. l. Johnston, Princeton University Press, Princeton 1997. 16. Moreau, Le mythe de ]ason et Medée, cit., a p. 195. 17. Cfr. l'introduzione di B. M. W. Knox al volume Euripide, Medea, traduzione e cura di L. Correale, Feltrinelli, Milano 1995; si veda anche Euripide, Medea, introduzione e traduzione di M. G. Ciani, commento di D. Susanetti, Marsilio, Venezia 1997. 18. Euripide, Medea, traduzione e cura di L. Correale, cit ., p. 71. 19. Lucio Anneo Seneca, Medea. Fedra, introduzione e note di G. G. Biondi, traduzione di A. Traina, Rizzoli, Milano 1996, vv. 670-684. 30. lvi, vv. 414-415 e vv. 417-419. 31. Ovidio, Le Metamorfosi, a cura di E. Oddone, Bompiani, Milano 1988, VII, 194-106. 31. Ovidio, Lettere di Eroine, introduzione, traduzione e note di G . Rosati, Rizzoli, Milano 1989. 33· Per un ampio sguardo d'insieme, si vedano i saggi in Storia delle donne in Occidente, dir. da G. Duby e M. Perrot, II: Il Medioevo, a cura di C. Klapisch-Zuper, Laterza, Roma-Bari 1990. 34· R. Morse, The Medieval Medea, D. S. Brewer, Cambridge 1996. 35· R. H. Bloch, Medieval Misogyny, The University of Chicago Press, Chicago-London 1991; M. Vincent-Cassy, Péchés de /emme à la /in du Moyen Age, in La condici6n de la mujer en la Edad Media, Madrid 1986, pp. 501-17. 36. G. Boccaccio, De Mulieribus Claris, a cura di V. Zaccaria, Monda dori, Milano 1967, pp. 84 e 85. Sulla figura di Medea in Boccaccio, Chau cer e Christine de Pizan si veda C. M. Meale, Legends o/ Good Women in the European Middle Ages, in "Archiv fiir das Studium der Neueren Spra chen und Literaturen", 144, 1, 1991, pp. 55-70. 37· Guillaume de Lorris, Jean de Meun, Le Roman de la Rose, chro nologie, préface et établissement du texte par D. Poirion, Garnier-Flam marion, Paris 1974. 38. J. Le Fèvre de Resson , Les Lamentations de Matheolus et Le Livre de Leesce, édition critique par A. G. Van Hamd, Paris 1891. arcaica,
FIGURE FE.'d.'dl:-.:IU DEL SAPERE
39· Ovzde Moralisé, ed. C. De Boer, M. De Boer, J. Th. Van Sant, Amsterdam 1931. 40· Benoit de Sainte-Maure, Roman de Trote, extraits édités, présentés et traduits par E. Baumgartner et F. Vieillard, Le Livre de Poche, Paris 1998. 41. Le Fèvre de Resson, Les Lamentations de Matheolus et Le Livre de Leesce, cit. 41. T. Fenster, M. C. Erler, Poems o/ Cupid, God o/ Love: Christine de Pizan's «Epistre au Dt'eu d'Amours» and «Dit de la Rose», E. ]. Brill, Lei den 1990; Christine de Pizan, Le Livre du débat de deux amans, in B. Alt mann, The Love Debats Poems o/ Christine de Pi:r.an, University Press of Florida, Gainesville 1998; Epistre Othea, ed. G. Parussa, Droz, Genève 1999; Le Livre de la Mutacion de Fortune, ed. S . Salente, Picard, Paris 1959, 1964, 1966; La Cité des Dames l La Città delle Dame, a cura di P. Caraffi, ed. di E. J. Richards, Luni, Milano-Trento 1997; Cent ballades d'Amant et de Dame, Lay de Dame, ed. J. Cerquiglini, 101!8, Paris 1981. 43· P. Caraffi, Autorità femminile e ri-scrittura della tradizione: "La Cité des Dames" di Christine de Pi:r.an, in Tradizione letteraria, iniziozione, genealogia, a cura di C. Donà e M. Mancini, Luni, Milano-Trento 1998, pp. 63-81. 44· Christine de Pizan, Epistre au Dt'eu d'Amours, cit., w. 437-444 . 45· Christine de Pizan, Le Livre de la Mutacion de Fortune, cit. 46. M. Quilligan, Allegory and the textual body: Female Authority in Christine de Pizan's 'Livre de la Cité des Dames', in "Romanic Review", 79, 1988, pp. 2.2.2.-48, e The Allegory o/ Female Authority, Cornei! University Press, Ithaca-London 1991; Caraffi, Autorità femminile e ri-scrittura della tradizione, cit.; R. Blumenfeld-Kosinski, Christine de Pizan and the Misogy nistic Tradition, in "Romanic Review" , 81/3, 1990, pp. 179-91; G. McLeod, Poetics and Antimisogynist Polemics in Christine de Pizan 's "Le Livre de la Cité des Dames", in Reinterpreting Christine de Pizan, ed. by ]. Richards,
University of Georgia Press, Athens-London 1991, pp. 37-47. 47· Tutte le citazioni della Cité des Dames sono tratte da Christine de Pizan, La Città delle Dame, cit. 48 . Medea e Didone sono vicine anche nella Epistre au Dz'eu d'A mours, cit., w. 437-444 e 445-460; nel Debat de deux amans, cit., pp. 49109, w. 1459-1468 e 1481-1491; nel Livre de la Mutacion de Fortune, cit., w. 14301-14786 e w. 18159-18198, e nelle Cent ballades d'Amant et de Dame, Lay de Dame, cit., w. 67-84 e w. 85-95. Si veda M. Desmond, Reading Dido. Gender, textuality and the Medieval 'Aeneid', University of Minneso ta Press, Minneapolis-London 1994. Per la storia o meglio le storie di Didone attraverso i secoli, si può vedere P. Bono, M. V. Tessitore, Il mito di Didone. Avventure di una regina tra secoli e culture, Mondadori, Milano 1998. 49· K. Brownlee, Le proJ'et «autobiographique» de Christine de Pizan: histoires et /ab/es du moi, e A. Paupert, «La narracion de mes aventures»: des premt'er poèmes à "J;Advision", l'élaboration d'une écriture autobiogra phique dans l'reuvre de Christine de Pizan, entrambi in Au champ des escriptures, cit., pp. 5-13 e 51-71.
1. MEDEA, DOI':I':A DMI':A
so. R. Blumenfdd-Kosinski, Christine de PiZtJn: Mythographer and Mythmaker, in Reading Myth. Classica/ Mythology and Its Interpretations in Medieval French Literature, Stanford University Press, Stanford 1997, pp. 171-2.17. 51. G. McLeod, K. Wilson, A clerk in nome only - A clerk in all but nome. The misogamous tradition and «lA Cité des Dames», in The City o/ Scholars. New Approaches to Christine de PiZtJn, ed. by M. Zimmermann and D. De Rentiis, Walter de Gruyter, Berlin-New York 1994, pp. 67-76. 52.. L. Irigaray, Donne divine, in Me/usino. Mito e leggenda di una donna serpente, Utopia, Roma 1986, pp. 134-50.
3
Tawaddud, Teodor e il sapere delle fanciulle
1. Tra le figure del sapere femminile nella letteratura medie vale spagnola, risalta la protagonista della Historia de la don cella Teodor, la cui vicenda è narrata in un racconto di gran de diffusione scritto a partire da un testo arabo che circolò ad Al-Andalus, poi inserito nelle Mille e una Notte con il titolo di Storia della schiava Tawaddud1• La versione casti gliana, che risale alla seconda metà del XIII secolo, è conser vata in cinque manoscritti del XV secolo, e in diverse edizio ni a stampa cinquecentesche2• TI racconto godette poi di una fortuna notevole nei secoli successivi, con numerosi rifaci menti spagnoli, tra cui una commedia di Lope de Vega, ver sioni francesi, portoghesi, maya e una brasiliana modema3. Ecco l'intreccio in breve: un mercante compra una gio vane schiava, la conduce nella sua casa e le fa insegnare a leer y escreuir e todas las sciencias que deprender pudiesse (a leggere e a scrivere e tutte le scienze che poteva apprendere, p. 103 ) . Da lì a poco il mercante perde tutti i suoi averi e chiede consiglio alla fanciulla che, dopo aver riflettuto, gli suggerisce di venderla al re per una cifra molto alta: diecimi la doblas d'oro fino. n re, stupefatto da una tale richiesta, ma anche affascinato dalla bellezza della fanciulla, la fa esa minare da tre saggi, che devono mettere alla prova il suo sapere: un medico, un giurista e un letterato. Dopo aver sconfitto i saggi, Teodor chiede come unica ricompensa di essere restituita al suo padrone, a cui deve tutto, e che nella versione manoscritta deciderà di sposarla: e bes6 al rrey las
manos e la tierra ante! rrey e /uese con su seiior el mercador. E casose con él e fueron muy rricos dende en adelante4 (e baciò le mani al re e la terra davanti a lui e se ne andò con
FIGURE FE.\1�11:-;IU DEL SAPERE
il suo signore, il mercante. E si sposò con lui e furono da allora in poi molto ricchi). n motivo della doncella sabia che deve confrontarsi in una disputa con le più alte autorità del tempo è presente sia nella tradizione ebrea che in quella cristiana: già Menéndez y Pelayo aveva confrontato il motivo con l'episodio di Salomo ne e la regina di Saba (Libro dei Re, III, m)s; nella letteratura medievale castigliana non mancano d'altra parte altri esempi di figure femminili sapienti, come Tarsiana nel Libro de Apo lonio (XIII secolo) e la fanciulla muy leida e de buena palabra, protagonista di un racconto esemplare contenuto nel Libro del caballero Zz/ar6 (prima metà del XIV secolo) . La Historia de la doncella Teodor si inserisce inoltre in una tradizione più ampia di opere intorno al sapere, di vasta diffusione nel XIII secolo, in particolare durante il regno di Alfonso X el Sabio (1256-1284) , sovrano protettore di letterati e artisti ed egli stes so intellettuale, autore e compilatore. n punto di partenza di queste opere è il dialogo tra un rappresentante del potere, che può essere un re, un imperatore, un conte e una figura di sapiente, come nel Sendebar e nel Calila e Dimna. In alcuni casi il dialogo assume la forma della disputa, e lo sfondo è quello della corte. La struttura della domanda-risposta, e la relativa brevità di questi testi, sul modello degli ]oca mona chorum, facilitavano l'apprendimento delle idee esposte spes so con enigmi; inoltre si trattava di una forma molto flessibi le, aperta, che si prestava nella trasmissione del testo all'in corporazione di nuovo materiale?. Nel Dialogo de Epicteto y el emperador Adriano 8, per esempio, un fanciullo viene inter rogato dall'imperatore Adriano, figura modello del sapere, su vari argomenti, tra cui problemi teologici, questioni sulla natura umana e sulla origine del peccato. n Capitulo de Segundo /il6so/o 9 presenta invece una cor nice narrativa più complessa e dai forti tratti misogini. Segun do vive a lungo lontano dalla famiglia per studiare; ad Atene apprende che non esiste al mondo una donna casta, e la prima donna che egli vuole mettere alla prova è sua madre. Ritorna a casa, travestito da pellegrino e non viene ricono sciuto; per il tramite della cameriera della madre , convince 68
3· TAWADDUD, TEODOR E IL SAPERE DELLE FA�CILLLE
quest'ultima ad accettare le sue avances, ma una volta nel letto, le svela la sua vera identità e l'altra, colta da orrore, si uccide. n filosofo, maledicendo la sua lingua, fa un voto di silenzio. L'imperatore Adriano viene a sapere di questo stra no filosofo muto per scelta e cerca di convincerlo con ogni mezzo a infrangere il suo silenzio, ma invano; alla fine gli chiede almeno di scrivere su una tavoletta e Segundo in que sto modo risponde alle domande dell'imperatore, brevemente e con saggezza. Le risposte di Segundo verranno poi raccolte e conservate in un libro ritenuto preziosissimo. Uno dei modelli femminili più vicini a Teodor è sicura mente quello di Caterina d'Alessandria. Caterina d'Alessan dria fu la più celebre fanciulla sapiente dell'agiografia cristia na; martire durante il regno dell'imperatore Massenzio (IV sec.), Caterina fu venerata a partire dall'epoca delle crociate e rappresentata come protettrice delle vergini, degli studenti, dei filosofi e delle balie. La sua storia deve essere probabil mente considerata come risposta cristiana alla popolarità di lpazia, celebre scienziata e matematica di Alessandria, vissu ta tra il 370 e il 41 5 e uccisa dai cristiani per non essersi voluta convertire. Dalla vulgata latina derivano nume rose versioni tra cui la Legenda Aurea di Jacopo da Varagine; Christine de Pizan racconta la storia di santa Caterina nel III Libro della Cité des Dames (1405) . La leggenda narra che Caterina, dal greco kataros, puro, era una fanciulla straordinariamente bella che viveva ad Ales sandria, dove aveva studiato filosofia e le arti liberali. Dopo la morte del padre si convertì al cristianesimo, e si rifiutò di continuare a offrire sacrifici agli idoli pagani. L'imperatore Massenzio, affascinato dalla sua bellezza e dalla sua eloquen za, la sottopose a una disputa con i più saggi filosofi dell'E gitto, che a loro volta si convertirono. Furioso, l'imperatore offrì a Caterina la salvezza, se si fosse concessa a lui e avesse rinunciato alla sua religione; Caterina rifiutò e venne impri gionata senza cibo né acqua per diversi giorni; nonostante il digiuno, poiché nutrita da un angelo o in altre versioni da una colomba, si mantenne fresca come una rosa. Massenzio allora, con sadica insistenza, decise di sottoporla alla tortura
FIGURE FE.\1:-JI:-;ru DEL SAPERE
della ruota dentata, che sarebbe diventato poi il suo attributo iconografico10, ma la ruota non la sfiorò nemmeno, poiché un angelo del Signore la spezzò con una spada. Allora la giovane venne decapitata e dalla sua ferita uscì latte al posto del san gue, poi gli angeli trasportarono la martire sul monte Sinai. TI sapere di una fanciulla che si deve confrontare con degli oppositori maschili, la purezza virginale, la bellezza e il desiderio frustrato che diventa crudeltà sono strettamente connessi, e ben lo sa interpretare Christine de Pizan, che include la storia di santa Caterina nella Cité des Dames: Quant l' empereur ouy ceste pucelle qui tant estoit belle, noble et de grant auctorité ainsi parler, il fu tous esmerveillez et ne lui sceut que dire, mais moult entendoit a la regarder. Si envoya par tout querre les plus sages philosophes que on sceust par la terre d'Egypte, qui de philosophie adone moult estoit renommee, tant que vers lui furent assemblez bien ·l· [ . . ] Le tirant Maxence, qui moult convoitoit la benoite Katherine pour sa beauté, la print moult a blandir affin que il la tournast a sa voulenté. Mais quant il vid que riens ne lui valoit, il se tourna aux menaces et puis aux tourmens, et la fist batre moult durement et puis mettre en chartre [ . . . ] L'empereur requist Katherine que elle fust sa femme, et quant il vid que elle estoit refusante a toutes ses peticions, a la parfin donna sa sentence que elle fust decollee. .
(Quando l'imperatore sentì parlare così questa fanciulla che era tanto nobile, bella e di grande autorità, rimase meravigliato e non seppe rispondere, ma la guardava intensamente. Mandò a cercare dappertutto i più saggi filosofi dell'Egitto, terra allora celebre per la filosofia, e ne giunsero ben cinquanta [ . . ] Il tiranno Massenzio, che ardeva di desiderio per la benedetta Caterina a causa della sua bellezza, cominciò a blandirla, per piegarla alla sua volontà. Ma quando vide che non c'era nulla da fare, passò alle minacce, poi ai tormenti; la fece picchiare ferocemente, quindi fu imprigionata [ . . ] L'imperatore chiese a Caterina di essere la sua sposa, ma quando si accorse che lei rifiutava ogni sua profferta, diede l'ordi ne di decapitarla, III, III, pp. 43 6-7 e pp. 43 8 -9)11 .
.
La storia di Caterina ha diversi punti di contatto con quella di Teodor: si tratta in entrambi i casi di una fanciulla bella e
3· TAWADDUD, TIODOR E IL SAPERE DELLE FA�CILLLE
sapiente, dall'eloquenza straordinaria, che si trova in una posizione di estrema disparità nei confronti di una figura maschile socialmente superiore contro cui può opporre solo la forza della propria parola, attraverso una disputa con i suoi ministri. TI discorso sul sapere è anche un discorso sul potere e sull'autorità. La Storia di Tawaddud presenta una novella a cornice molto simile a quella di Teodor. C'era una volta a Baghdad un ricco signore che possedeva ogni cosa, tranne quella che desiderava di più: un figlio. Dopo molte preghiere, viene accontentato: gli nasce un figlio maschio, che cresce sano, bello e viene istruito al meglio: «imparò il sublime Corano e le prescrizioni dell'Islam, le dottrine della fede dalle basi incrollabili, la scrittura, la poesia, l'aritmetica; imparò a tira re l'arco e fu unico nel suo tempo, il più bello dell'epoca e del secolo» (n, p. 499)11• Bello e colto, ma assai sventato, quando il padre muore, il giovane, di nome Abu'l-Hasan, sperpera il patrimonio ereditato e non gli rimane che una concubina, dalla straordinaria bellezza ed eloquenza: 2.
Questa non aveva pari per grazia, bellezza e perfezione, forme e statura. Era istruita nelle arti e nelle lettere e aveva tutte le qualità che piacciono; superava tutta la gente del suo tempo e della sua epoca, era più famosa di una pietra miliare per le sue seduzioni e vinceva le belle in teoria e in pratica, aveva il passo flessuoso e la figura slanciata; alta cinque piedi, sotto stabile influsso di buona stella. Le sue tempie erano come la luna nuova del mese di shaa bàn, le sue sopracciglia due curve allungate, i suoi occhi somiglia vano a quelli della gazzella, il naso era come il filo della spada, le sue guance sembravano convalli di anemoni, la bocca il sigillo di Salomone, i denti collane di perle, il suo ombelico poteva contene re un'oncia di pomata di benzoino, la sua vita era più sottile del corpo di un amante estenuato dalla passione e reso infermo dalla dissimulazione, mentre i suoi lombi erano più grevi di due lune (II, p. soo) . La concubina, che si chiama Tawaddud ( "affezione " ) , gli suggerisce di condurla dal califfo Harun ar-Rashid e di chie71
FIGURE FE.\1�11:-;IU DEL SAPERE
dere per lei diecimila dinàr. n califfo ammira l'eloquenza della splendida concubina e convoca per esaminarla i sapien ti del regno. Tawaddud non solo risponde a tutte le doman de che le vengono rivolte, ma a sua volta interroga ognuno dei saggi, che invece non sanno rispondere, di volta in volta strappando così affermazioni di stupore e smarrimento come quella che segue: «Attesto davanti a Dio, o Principe dei cre denti, che questa fanciulla conosce meglio di me il diritto canonico e le altre scienze ! » (II, p. 513 ) . Oppure: «0 Signore dei credenti, io attesto in tuo cospetto che questa fanciulla è più sapiente di me, in medicina e nelle altre cose, e io con lei non ce la posso fare ! » (II, p. 526). E ancora: «Sia temi tutti testimoni, alla presenza di questo consesso, che essa è più sapiente di me e di qualsiasi sapiente ! » (II , p. 538). Dopo aver vinto tutti i saggi, la schiava chiede inspiegabilmente di essere restituita al suo padrone, che in fin dei conti non la merita1', a cui viene accordata una rendita mensile e che viene accolto tra i commensali del re: «Egli visse con la sua schiava Tawaddud la vita più deliziosa» (II, p. 539). Nella cristianizzazione del testo, l'azione si sposta da Baghdad a Babilonia e poi a Tunisi, Tawaddud diventa Teo dor ("dono di Dio"), schiava di origini cristiane e spagnole, scompare la figura del padre e del mercante viene detto esplicitamente che è di origini ungheresi, ciò che permette un nuovo orientamento del racconto. Se Tawaddud era una concubina, Teodor è una vergine, una doncella, un cambia mento fondamentale e coerente con l'ideologia del tempo, in cui la sessualità era considerata nell'occidente cattolico un dovere da compiere esclusivamente ai fini riproduttivi e all'interno del matrimonio14. Nella scala immaginaria delle virtù, le donne erano rappresentate proprio attraverso l 'uso della propria sessualità: in basso le donne sposate, a metà le vedove, in alto, più vicino a Dio, le verginiJ5. La verginità autorizza la parola, come una garanzia di verità non conta minata e di forza interiore, in contrasto con la fragilità del corpo. La seduzione, che Tawaddud considerava tra le sue arti - «Se canto e ballo seduco, se mi adorno e mi profumo uccido; in conclusione sono arrivata a un punto che possono
72
3· TAWADDUD, TIODOR E IL SAPERE DELLE FA�CILLLE
conoscere solo le persone "saldamente radicate nella scien za"» (II, p. 502) - in Teodor assume la funzione di un trave stimento, astuzia ammessa solo per raggiungere un obiettivo superiore, la libertà per sé e il suo padrone dalla povertà. n mercante infatti, che assume dei tratti più gradevoli rispetto al testo arabo, aveva comprato la fanciulla e, avendo riconosciuto in lei la nobiltà, l'aveva istruita: E conociendo en
su gentil disposicion e criança que deuia ser /i.fadalgo, hizole mostrar a leer y escrueir e todas las sciencias que deprender pudiesse (E riconoscendo in lei la nobiltà dai modi e dall'e ducazione, le fece insegnare a leggere e a scrivere e tutte le scienze che poteva apprendere, p. 103). La giovane si applica talmente da raggiungere un livello molto elevato: La qual se
dio tanto a la virtud y estudio que sobrepu.fo a todos los hom bres e mugeres que en aquel tiempo /uessen, assi en sciencia como en musica y otras in/initas maneras de arte (La quale si impegnò così tanto nello studio, da superare tutti gli uomini e le donne dell'epoca, nelle scienze, come nella musica e in altre infinite arti, p. 103 ) . Quando il mercante perde tutte le sue immense fortune, è al sapere e ai consigli di Teodor che si rivolge, nella speranza che gli sappia indicare la migliore soluzione: Por que mucho ruego, /zja mia senora, que vos me
querdys consejar de lo que a vuestro entendimiento mas le parescerd que yo deua hazer (Per questo vi prego, figlia mia e signora, che mi vogliate consigliare cosa vi sembra meglio che io debba fare, p. 104) . Teodor riflette a lungo: in cuor suo cerca il modo per poter restituire il dono che il suo signore le aveva fatto, istruendola alla perfezione. Si profila da subito la gratitudine provata da Teodor per il mercante: E
desque vuo bien pensado e mirado en su entendimiento el cobro que podia dar a su senor, el qual la hauia criado e gasta do con ella de sus thesoros en la mostrar todo lo que sabia . . .
(E dopo aver riflettuto e pensato al modo per ricompensare il suo signore, che l'aveva educata e aveva investito i suoi tesori per lei, per insegnar!e tutto ciò che sapeva . . . , p. 104) . Una gratitudine confermata alla fine del racconto, quan do la giovane chiede al re come dono di essere restituita al suo antico padrone, a cui deve tutto: que la venda sea ningu73
FIGURE FE.\1:\U:-;IU DEL SAPERE
na que de mi tiene fecha a Vuestra Alteza, porque, Seiior, el ha gastado por mi quanto tenia e el me puso a deprender todo esto que yo sé (che la vendita fatta a Vostra Altezza sia nulla, poiché, Signore, egli ha speso i suoi averi per me, per inse gnarmi tutto ciò che io ora so, p. I33 ) . Un dono, eco del dono obbligante di arturiana memoria16, che il re non può fare a meno di accordare, anche se a malincuore: E quando
el rey esto oyo a la donzella, peso/e mucho por ella la merced que demando, que el bien pensaua que ya era suya. Y pues que ya lo auia mandado, no se pudo desdezir (E quando il re udì le parole della fanciulla, fu molto dispiaciuto del dono che gli aveva chiesto, poiché egli pensava che fosse ormai sua. Ma visto che lo aveva concesso, non poté negarlo, p. I32) . Teodor suggerisce al mercante di andarle a comprare gioielli, stoffe preziose e tutto ciò con cui se afeytan las mugeres, perché lei si possa agghindare, e poi di condurla dal re e di offrirgliela per diecimila doblas d'oro. n mercante segue il consiglio della fanciulla e va da un suo carissimo amico moro, Mahuma, che lo rifornisce di tutto ciò di cui aveva bisogno, passaggio che testimonia la tolleranza reci proca tra la comunità cristiana e quella musulmana17. Una volta vestita e preparata, la fanciulla (donzella) viene condot ta dal re e sembra una donna, la più bella al mondo: E quan
do la donzella Teodor /ué vestida e a/eytada, parescia la mas hermosa e mas gentil e bella que se pudiese fallar en el mundo (E quando Teodor fu vestita e preparata, sembrava la più graziosa, e la più nobile e la più bella al mondo, p. Io7) . La bellezza viene utilizzata come finzione consapevole per convincere un re sensibile al fascino femminile, el qual se
contentaua mucho de ver genti/es mugeres e hermosas donzel las (che traeva piacere nel vedere nobili donne e graziose fanciulle, p. IO?) , del valore di Teodor, basato su un sapere straordinario. n mercante presenta la fanciulla al re, assicu randogli che il suo sapere senza pari è dovuto allo studio, per cui egli ha investito un grande tesoro: Seiior, no lo tengays a rnarauilla porque yo os demando tan gran precio por esta donzella; ca hauéis de saber que sabe tantas rnane74
3· TAWADDUD, TIODOR E IL SAPERE DELLE FA�CILLLE
ras de sciencias, que yo creo que no ay sabio que la pueda vençer, hombre ni muger. Porque yo, Seiior, despendi con ella gran tesoro por la fazer enseiiar lo qual ella deprendi6, e tiene muy bien estu diado de todas maneras de sciençias que pueden ser escritas e sabios letrados puedan saber por todo el mundo, asi hombres como mugeres. (Signore, non vi meravigliate se vi chiedo una somma così alta per questa fanciulla; dovete sapere che conosce un numero tale di scienze, che credo non ci sia saggio, uomo o donna che sia, che la possa battere. Poiché io, Signore, ho speso per lei un grande tesoro per farle insegnare tutto ciò che ha appreso, e conosce molto bene tutte le scienze che possono essere scritte e che i saggi letterati conoscono in tutto il mondo, uomini o donne che siano, p. 108) D re, quando Teodor alza il velo che le copriva il viso, rimane prima di tutto colpito dalla sua bellezza: E alli vido el rey la
gran /ermosura e beldad que la donzella tenia. E le pareci6 la mas hermosa que visto hauia en toda su vida e plugole mucho con su vista (E il re vide lo splendore e la grande bellezza della fanciulla. E gli sembrò la più bella che avesse mai visto in tutta la sua vita e si appagò della sua vista, p. 108), e solo in un secondo tempo dalla sua eloquenza. La bellezza femmi nile è ammessa solo come finzione temporanea, e per questo deve essere accompagnata da una serie di "antidoti", che ne neutralizzano la pericolosità. Tra questi la frequenza dei gesti e delle posizioni del corpo che indicano umiltà e sottomissio ne, come lo sguardo rivolto a terra e l'imbarazzo dettato dal pudore, anche qui secondo le regole imposte dai vari manua li di comportamento indirizzati alle giovinette, che si interse cano e si sovrappongono con il linguaggio della gestualità feudale: abax6 sus ojos a tierra (abbassò lo sguardo a terra, p. 104) , le respondi6 con muy gran verguença e h umilmente (gli rispose con grande umiltà e vergogna, p. 108), abax6 su cabe
ça e puso sus ojos con muy gran verguença abaxo /asta la tierra (abbassò il capo e abbassò lo sguardo verso terra con grande vergogna, p. u7) ; respondi6le muy humilmente e con gran ver guença (gli rispose molto umilmente e con grande vergogna, p. 12o) ; que a ella era gran verguença responder (rispondere 75
FIGURE FE.\1:\U:-;IU DEL SAPERE
per lei le faceva sentire grande vergogna, p. 124) ; leuant6se la
doncella delante del rey con gran reuerencia e besole las manos e las pies (la fanciulla andò davanti al re e con un grande inchino gli baciò le mani e i piedi, p. 1 3 1 ) ; e ella le besò las pies e las manos (e gli baciò i piedi e le mani, p. 1 33 )18• Un'altra scena importante da questo punto di vista è quando il secondo esaminatore di Teodor, maestro nelle sette arti liberali, le rivolge una domanda che riguarda la sessualità: Dime, donzella, qual es el mejor dormir con la mujer amenudo, o quando estd en razon? (Dimmi, fanciulla, quando è meglio dormire con una donna, spesso, o quando è stabilito? ). La reazione della fanciulla è di imbarazzo e dif ficoltà: En oyendo esto, la donzella abax6 su cabeça e puso sus ojos con muy gran verguença abaxo /asta la tierra (Sentendo ciò, la fanciulla abbassò il capo e rivolse con grande vergo gna lo sguardo a terra, p. 117) . Nella scena corrispondente in Tawaddud, l'imbarazzo della fanciulla è motivato unicamente dalla presenza del califfo, e non vi è ombra di un qualsiasi possibile senso di colpa legato alla sessualità: «Disse il medi co: - Parlami del coito -. A queste parole la fanciulla abbas sò la testa, provando vergogna per un senso di rispetto verso il califfo. Poi disse: - Per Iddio, o principe dei credenti, non sono incapace di rispondere ma mi vergogno; del resto ho la risposta sulla punta della lingua !» (p. 525) . Per motivare il suo silenzio, Teodor invece rivendica la sua giovane età e la condizione di vergine: " . . . mas que sepa Vuestra Alteza e la noble caualleria que me es verguença hauerle de responder a la tal razon, por quanto yo soy pequeiia e de pocos dias e virgen, que nunca en mi vida conosci varon en juego ni en veras, ni en sueiios nunca houo que ver comigo. " Estonces al rey plugo mucho de la verguença de la don zella e de su respuesta e mand6le que respondiesse e no houiesse verguença alguna (p. 117). (" . . . ma che Vostra Altezza e la nobile corte sappia che mi vergo gno a rispondere a una domanda simile, perché sono giovane, di pochi anni e vergine, e non ho mai conosciuto un uomo in vita mia, né per scherzo, né sul serio, e né in sogno ebbe mai a che
3· TAWADDUD, TIODOR E IL SAPERE DELLE FA�CILLLE
fare con me." Allora il re fu molto compiaciuto della vergogna della fanciulla e della sua risposta e le ordinò che rispondesse senza vergognarsi.) n risalto che viene dato alla verginità della fanciulla rafforza il contrasto tra la sua fragile figura, e il prepotente mondo maschile che lei sfida e che sa sconfiggere.
3· La storia della schiava Tawaddud è stata definita da Oau dine Gerresch, che data il racconto agli inizi del Xlll secolo, un'enciclopedia del sapere islamico19 dai forti tratti popolari, che deve innanzitutto commuovere e divertire10, mescolanza di sapere religioso e profano, secondo la tradizione dell'a dab11. Nel racconto, che si presenta come l'esposizione di un sapere universale, Tawaddud annuncia al califfo di padroneg giare una lunga serie di discipline, che comprendono sia le scienze religiose, che quelle del corpo, che le arti: Signore, conosco la grammatica, la poesia, il diritto, l'interpretazione del Corano, la filologia; conosco l'arte musicale, la dottrina religiosa, l'aritmetica, la geometria, la geodesia, le leggende degli antichi. So a memoria il sublime Corano, e l'ho letto secondo le sette, dieci e quattordici scuole di lettura; conosco il numero dei suoi capitoli e dei suoi versetti, delle sue sezioni, metà, quarti, ottavi e decimi, il numero delle prostrazioni prescritte nella sua recitazione, il numero delle sue lettere. So quali sono i versetti abrogati e quelli abroganti, quali capitoli furono rivelati alla Mecca e quali alla Medina, i casi che diedero occasione alle rivelazioni. Conosco le tradizioni canoni che, per studio e trasmissione, quelle che risalgono ai compagni del Profeta e quelle attestate dalla generazione successiva. Mi sono occupata di scienze esatte, geometria, filosofia, medicina, logica, retorica, composizione; ho imparato a memoria molti testi scientifici, sono dedita alla poesia, suono il liuto, so accompagnarlo col canto, e conosco la tecnica del rilasciare e pizzicare le corde (II, p. 502). n califfo è stupefatto di fronte a tanto sapere, e scrive al governatore di Bassora di mandargli Ibrahim ibn Sayyàr an Nazzam, celebre teologo realmente esistito (morto tra 1'835 e l'845) , e gli ordina di convocare «recitatori del Corano, cano-
77
FIGURE FE.\1�11:-;IU DEL SAPERE
nisti, medici, astrologi, scienziati, geometri, filosofi. Ibrahfm poi era il più dotto di tutti» (n, pp. 502-3) . TI califfo ha il nome di Harun ar-Rashfd, e anche in que sto caso si tratta di un sovrano realmente esistito (morto nell'8o9) della dinastia abbaside, figura quasi leggendaria e protagonista di numerosi racconti delle Mille e una Notte. Era un sovrano che amava la poesia, la musica, la letteratura e che aveva riunito nella sua corte di Baghdad un gran numero di artisti, poeti, scrittori, teologi, musicisti; inoltre si era circondato di jariya, giovani schiave con un alto livello di sapere nelle scienze e nelle arti, come la poesia e la musica, il canto, la danza. Gerresch segnala l'esistenza di una vera e propria scuola a Bassora, dove le giovani schiave ricevevano la propria educazione prima di essere inviate a Baghdad; le jariya erano molto richieste e potevano essere vendute per cifre astronomiche12, in misura proporzionale ai loro talenti. Alla luce di ciò, risulta meno stupefacente la cifra che Abu '1-Hasan chiede per Tawaddud. Anche C6rdoba aveva un grande mercato di schiavi e le donne ben istruite, abili nella poesia e nella musica, erano valutate molto. Ibn Hazm, una delle più grandi figure intellettuali della Spagna musulmana dell'xi secolo, racconta come nell'harem le donne gli aveva no insegnato il Corano e la poesia: «Furono le donne a inse gnarmi il Corano, a farmi recitare i suoi versi, ad iniziarmi all'esercizio dello scrivere. Né io ho mai avuto mai altra cura né ho rivolto il mio ingegno ad altro, giunto che fui all'età matura, se non a conoscere la vita femminile osservandone e studiandone le manifestazioni»13 . In tutta Al-Andalus vi erano donne istruite e poetesse, come è stato dimostrato dagli studi più recenti14 e Tawaddud può essere considerata anche come l'esempio dell'alto livello di educazione femmi nile raggiunto e diffuso. Tawaddud non è l'unica fanciulla colta delle Mille e una Notte: nella Storia del re Omar an-Numàn tutti i personaggi femminili di un certo rilievo rispondono a questo modello: Sofia, concubina del re e che poi si scopre essere cristiana, sua figlia Nuzhat az-Zamàn, che in seguito a una serie di sventure sarà venduta come jariya e interrogata dai quattro
3· TAWADDUD, TIODOR E IL SAPERE DELLE FA�CILLLE
grandi cadt' di Damasco; Ibriza, dall'eloquenza straordinaria, e valorosa come un'amazzone; le cinque fanciulle cristiane istruite dai migliori sapienti dell'epoca affinché apprendano «la filosofia e le belle lettere, l'arte di rivolgere la parola ai sovrani e la maniera di stare in loro compagnia, la poesia e il parlar sentenzioso e ammonitore» (I, p. 322) . La Storia di Ali Shar e della schiava Zumurrud presenta poi curiosamente una situazione molto simile a quella del racconto di Tawaddud, anche nell'intreccio. Alì è il figlio di un ricco e anziano mer cante, che muore !asciandogli in eredità un immenso patri monio, ma il giovane, dopo il periodo di lutto, in breve tempo dilapida tutta l'eredità e quando, al mercato, vede Zumurrud, una schiava bellissima e di enorme sapere - «non ti meravigliare della sua bellezza che svergogna la luce del sole, e non delle squisite poesie che conosce a memoria; essa, oltre a tutto, sa recitare il magnifico Corano secondo le sette scuole di lettura, sa riferire le tradizioni canoniche secondo le tradizioni autentiche, scrive in sette stili di calligrafia, conosce le scienze più di un gran dottore, e la sua mano è superiore all 'oro e all 'argento, perché lavora tende di seta e le vende . . . » (n, p. 247 ) -, non ha il denaro per comprarla. Ma il giovane è bellissimo, «ha chioma ricciuta e guancia rosata e sguardo incantatore», e Zumurrud, che poteva decidere a chi essere venduta, si invaghisce di lui e lo sceglie come suo nuovo padrone. Poiché Alì non ha i denari necessari, sarà lei a fornirglieli, così come sarà lei, nel lungo racconto, a procu rare in ogni occasione la fortuna di entrambi. Altri esempi di sapere femminile emergono nella Storia dei due visir, in cui la schiava Anfs-al-Gialfs «conosce bella scrittura, grammatica, lingua, commento al Corano, fonti del diritto, religione, medicina, astrologia, e suona gli strumenti musicali» (I, p. 21 9 ) ; nel Racconto di al-Asmai a Harun ar-Rashid sulle donne e sulle loro poesie tre fanciulle partecipano a una gara poeti ca; così nella Storia delle donzelle di vari colori e della loro tenzone, in cui sei giovani schiave «belle di viso, istruite alla perfezione, conoscitrici del canto e degli strumenti musicali» (n, p. 285) si devono misurare tra loro in una disputa2s; nel racconto intitolato Disputa sostenuta da una dottoressa sui
79
FIGURE FE.\1:\U:-;IU DEL SAPERE
rispettivi meriti dei bei giovinetti e delle belle ragazze una donna sapiente - «la donna più acuta, più intelligente, più dotta, più ingegnosa, e più raffinata che abbia mai conosciuto [. . ] la sua casa era frequentata da una società di teologi, giu risti, scienziati e letterati, che le proponevano casi di diritto canonico, dibattendo con lei questioni controverse» (n, p. 471) - discute con un "colto personaggio" sulle rispettive qualità dell 'uno e dell'altro sesso. Insomma, una folta serie di donne colte, intelligenti, raffinate, e non per questo meno belle16, e con una grande libertà di movimento e d'azione, pur essendo schiave, tanto che André Miquel definisce la rac colta un chant à la gloire de la /emmé7. Nel linguaggio all'infinito18 delle Mille e una Notte, Tawad dud è anche una tra le tante immagini speculari, myse en abimé9, di Shahrazàd, protagonista della novella a cornice della raccolta e formidabile artista della narrazione3°. Com'è noto, Le Mille e una Notte hanno origine dal dolore e dalla morte: il re Shahryar, dopo aver scoperto che la moglie lo tra diva con uno schiavo e dopo averli eliminati entrambi, decide di unirsi ogni notte con una vergine e di decapitarla ali' alba del mattino seguente. L'orrore dura tre anni, finché nel regno non rimane nessuna fanciulla, tranne le figlie del visir: .
Or questo visir aveva due figliole, belle e leggiadre, a nome la maggiore Shahrazàd e la minore Dunyazàd; la maggiore aveva letto i libri, le storie, le gesta dei re antichi, e le notizie dei popoli pas sati, tanto che si dice avesse raccolto mille libri di storie attinenti alle genti antiche, ai re del tempo che fu, e ai poeti (I, p. 7) . Shahrazàd si offre come ennesima sposa, ma chiede di essere accompagnata dalla sorella minore, Dunyazàd. Non è un particolare di secondaria importanza poiché sarà proprio la sorellina, attivando un'alleanza che è biologica ma soprattut to di genere, a chiederle di raccontare una storia: Quindi il visir condusse al re la figliola, e questo al vederla si ralle grò: - Mi hai condotto, - disse, - quel che mi occorreva? - Sì -. Ma allorché il re volle unirsi a lei, ella si mise a piangere, e, interro gata, disse di avere una sorellina da cui voler prender commiato. n So
3· TAWADDUD, TEODOR E IL SAPERE DELLE FA�CILLLE
re mandò a cercarla; ella venne e abbracciò la sorella, sedendo poi a pié del letto. Dopo che il re ebbe preso la verginità di Shahrazàd, sedettero tutti a conversare e la sorella minore disse: - Sorella, rac contaci una storia con cui trascorrere la veglia di questa notte. Volentieri, - ella rispose, - se me lo permette questo compiuto sovrano -. E all'udir ciò, il re, cui una certa eccitazione impediva di prender sonno, annuì, lieto di poter ascoltare una storial1• Quando giunge il mattino, e Shahrazàd interrompe la narra zione, è ancora la sorella che le dà man forte: « - Quant'è bello, piacevole e dolce il tuo narrare ! Al che rispose Shah razàd: - Questo è ben poco rispetto a quello che vi racconte rò la notte prossima, se sarò in vita e se il re mi ci farà resta re. Ora, il re si disse in cuor suo: "Giuro che non la ucciderò finché non avrò ascoltato il resto del suo racconto"» (I, p. 15). Shahrazàd è dunque riuscita nel suo intento: creare l'incante simo della narrazione e la curiosità che deriva dalla sospen sione del racconto, il desiderio che il racconto continui all'in finito. La scena si ripete la notte successiva: «Sopraggiunto il mattino, Shahrazàd smise la narrazione consentitale, e all'am mirazione espressale dalla sorella rispose affermando che il racconto della notte successiva sarebbe stato ancora più inte ressante. Così il re decise anche questa volta di non uccider la, per sentire il resto della sua narrazione meravigliosa» (p. 20 ) . Dopo molte e molte notti, Shahryar inizia a mostrare qualche segno di cambiamento: «Non ho mai visto il re in tutto questo tempo così gaio e di buon umore come stanotte, onde spero che la tua faccenda con lui abbia a finir bene» (p. 563). La parola, le parole di Shahrazàd aprono nella mente oscurata del sovrano un varco di luce: si fa strada in lui l'idea di aver sbagliato qualcosa nel suo truculento banchetto di vergini. « - O Shahrazàd, tu m'induci a rinunziare al mio regno e pentirmi di aver senza riflettere ucciso donne e fan ciulle; conosci ancora altre storie di uccelli? - Sì, - rispose lei» (I, p. 578) . Shahryar inizia a riconoscere la grandezza della sua ultima sposa: « - O Shahrazàd, questo tuo racconto è stato per me un nuovo mònito e ammaestramento» (I, p. 581) . TI sovrano è come rieducato da Shahrazàd, che impone la sua regola e sostituisce alla morte il racconto, che a sua -
81
FIGURE FE.\1:\U:-;IU DEL SAPERE
volta genera vita31• Alla fine delle notti Shahryar guarisce dalla sua ferocia e non ha più bisogno di sangue innocente per placare la propria ira funesta. Shahrazàd rompe la spirale dell'odio contro le donne, che è una malattia, salva se stessa e le altre, e riporta l'armonia e la pace in un regno gravemen te colpito dalla follia del suo re. L'ultima notte: n giubilo si propagò nel palazzo reale e si diffuse per la città. Fu
una notte da non computarsi tra quelle delle creature, e il suo colore fu più bianco del giorno. Al mattino il re, giubilante e al colmo del benessere, mandò a convocare tutte le truppe, fece omaggio al suo visir, padre di Shahrazàd, di una nobile veste ono· rifica, e gli disse: - Che Allàh ti protegga, dal momento che mi hai dato in moglie la tua nobile figlia, che ha fatto sì che mi pentissi dell'uccisione delle figlie della gente. Io ho riscontrato che è since· ra, pura, casta e sagace, e Allàh mi ha concesso da lei tre bambini. Lode a Dio per la profusa graziaH. Si capisce come il mondo islamico, a differenza di quello occi dentale in cui Shahrazàd è stata rappresentata in maniera superficiale come simbolo di seduzione e di sessualità esotica e vagamente pruriginosa, la consideri una figura portatrice di civiltà e di ragione sulla violenza34, un'eroina politica, una libe ratrice, e così viene interpretata dagli autori del XX secolo35. L'intelligenza, il dialogo, la sensibilità, la fantasia, la letteratura, allontanano la violenza e la morte. A proposito della «parente la della scrittura con la morte» Michel Foucault scriveva: n racconto o l'epopea dei Greci aveva lo scopo di perpetuare l'im·
mortalità dell'eroe, e se l'eroe accettava di morire giovane era per· ché la sua vita, così consacrata e magnificata dalla morte, passasse all'immortalità [ . ] Il racconto di Schèhèrazade è il contrario accanito dell'assassinio, e lo sforzo ripetuto ogni notte per riuscire a mantenere la morte fuori dal cerchio dell'esistenza36 • .
.
La letteratura ha in questo caso una funzione terapeutica, di consolazione, di cura . Shahrazàd, come Tawaddud, come Teodor, sono esempi di grande sapere in una fragile figura di donna che ha come unica forza, quella vera, la propria parola e la propria intelligenza.
3· TAWADDUD, TIODOR E IL SAPERE DELLE FA�CILLLE
4· Tawaddud viene esaminata da dieci saggi: i primi tre la interrogano in materia religiosa, poi si susseguono un medi co, un astrologo, un filosofo, un letterato; infine dovrà dimo strare il suo talento nel giocare a scacchi, a tric-trac e nella musica. L'ispirazione ideologica della disputa, e rimando per questo agli studi specifici sul tema, è quella della scuola sha /ita, dominante in Egitto e in Siria all'inizio del XIII secolo. In ogni prova, Tawaddud dimostra una precisione e un sape re straordinari, accompagnati da una grande lucidità e una memoria stupefacente. Per avere un'idea più precisa, un esempio dalla disputa con il lettore del Corano: - Quale di voi è il professore di lettura del Corano, il dotto nelle sette scuole di lettura, nella grammatica e nella lingua? - Si alzò alle sue parole il lettore e le sedette davanti, dicendo: - Hai letto il libro di Dio altissimo, acquistando piena conoscenza dei suoi ver setti, delle parti abroganti e di quelle abrogate, dei punti chiari e di quelli ambigui, dei capitoli rivelati alla Mecca e di quelli rivelati a Medina? Hai compreso la sua interpretazione e l'hai imparata secondo le varie catene di trasmettitori e secondo le scuole di let tura fondamentali? - Sì. - rispose. - Dimmi, proseguì il dottore, quante sono le sure del Corano, e quante le decime parti, quanti sono i versetti, quante le lettere, quante le prostrazioni? Quanti profeti sono nominati dal Corano? Quante sono le sure rivelate alla Mecca e quante quelle rivelate a Medina? Quanti animali volanti vi sono ricordati? - Signore, - rispose, - le sure del Corano sono cento e quattordici, di cui settanta sono meccane e quaranta quattro medinesi. Le sue decime parti sono seicento e ventuno. I versetti sono seimiladuecento e trentasei; le sue parole sono settan tanovemilaquattrocento e trentanove. Le lettere sono trecentoventi tremilaseicentosettanta. Il recitatore riceve dieci benefici per ogni lettera. Quanto alle prostrazioni, sono quattordici. Quanto ai pro feti nominati nel Corano, sono venticinque, cioè . . . (pp. 513-4) . Poiché il sapere di Tawaddud è di tipo enciclopedico, ovvia mente risponde con altrettanta precisione anche al medico che le pone ogni sorta di quesito, dalla natura dell'uomo, alla composizione del corpo umano, ai sintomi delle malattie -, all'astrologo, al filosofo, al letterato, sfida e vince i maestri di scacchi, di carte e di tric-trac, per completare quindi il
FIGURE FE.\1:\U:-;IU DEL SAPERE
proprio trionfo con un'esibizione canora, durante la quale si accompagna con il liuto «mandando in visibilio i presenti» (p. 539). Dopo ogni disputa, Tawaddud interroga a sua volta ognuno degli esaminatori e, come è prevedibile, non riceve risposta alle sue domande. Ogni sapiente si deve spogliare dei propri abiti: «il Principe dei Credenti ordinò che il dotto fosse spogliato dei vestiti e del turbante dai lunghi capi rica denti» (I, p. 511) , gesto simbolico che dimostra la rinuncia ai segni esteriori della propria carica. Anche Teodor descrive la propria sciencia come un sape re enciclopedico, che comprende un vasto elenco di discipli ne descritte minuziosamente: Seiior Rey, vos deuéys saber que el primer saber que yo deprendì es la ley de Dios e sus mandamientos . . . e deprendì mas el arte de la estrelleria e las planetas e los curso e mouimientos dellas . . . e deprendì mas de medicina e çurugia, e todo lo tengo bien estudia do y probado; e deprendì mas la sotil geometria e gramatica e logica e la natura della; e deprendì mas el arte de la poesia e musi ca, e sé tanger todos estormentos . . . (p. 109) (Signore e Re, dovete sapere che il primo insegnamento che ho appreso è la legge di Dio e dei suoi comandamenti . . . e ho impara to l'arte dell'astrologia e della conoscenza dei pianeti, e le orbite che essi seguono . . . e ho imparato la medicina e la chirurgia, che ho studiato a fondo e sperimentato; e ho imparato la difficile geo metria, la grammatica e la natura della logica; e ho imparato l'arte della poesia e della musica, e so suonare ogni tipo di strumento . . . ) n lungo elenco prosegue con il canto e la danza,
cantar, e
baylar e dançar, e con altre abilità come la tessitura, il ricamo, la lavorazione delle pietre preziose, dell'oro e dell'argento e persino l'arte della miniatura, ylluminar libros. Da Tawaddud a Teodor, il sapere coranico lascia spazio a quello cristiano, che si presenta nella versione castigliana in misura molto ridotta, mentre il sapere profano viene mantenuto e ampliato. Teodor viene esaminata da tre saggi: il primo esperto di reli gione, il secondo di logica e medicina, astrologia e filosofia, il
3· TAWADDUD, TIODOR E IL SAPERE DELLE FA�CILLLE
terzo è un ebreo, Abraham, esperto in diritto, grammatica, logica e nelle arti liberali. TI sapere esposto, come nel raccon to di Tawaddud, è di tipo maschile e ufficiale, ed è solo con siderando questo aspetto che si possono comprendere una serie di risposte intorno per esempio alla natura della donna che, riconducendo a una visione riduttiva e a volte misogina, non fanno altro che riflettere l'ideologia del tempo. Nella di sputa con il secondo saggio, maestro di arti liberali, dopo aver esposto la dottrina degli umori, tra i consigli di tipo medico, Teodor deve rispondere a questa domanda: "Qual es la cosa que mas enuegesce al hombre antes de tiempo?" Respondiò la donzella: "El dormir mucho con mugeres. Ca dize Aristoteles, fablando de las luxuriosos, que toda su obra era pon çoiiosa, porque las hombres dauan la mejor sangre de su cuerpo, e que las mugeres dauan la peor que tenfan". (p. 116) (''Qual è la cosa che invecchia l'uomo prima del tempo? " La fan ciulla rispose: "Dormire molto con le donne. Aristotele scrive, par lando dei lussuriosi, che tutto il loro influsso è velenoso, poiché gli uomini danno il miglior fluido del loro corpo e le donne danno il peggiore che hanno".) Una volta dimostrata la sua condizione di verginità, e quindi di imbarazzo nell'affrontare certi argomenti, come si è visto sopra, però Teodor affronta, sempre dal punto di vista maschile , una disquisizione sulle pratiche sessuali più adatte, ricalcando in questo caso i trattati medicil7 dell'epoca, per poi ritornare, nella tirata sulle età delle donne, al più crasso registro misogino, che riemerge anche in alcune domande del terzo saggio, Abramo, che le chiede: "Que cosa es el hombre?" La donzella le respondi6: "Ymagen de Nuestro Seiior Dios". El sabio le pregunt6: "Donzella, que cosa es la muger?" La donzella le respondiò: "Arca de mucho bien e de mucho mal, ymagen del h ombre, bestia que nunca se farta". (p. 125) ( ''Che cos'è l' uomo? " La fanciulla gli rispose: "L'immagine di nostro Signore Iddio." li saggio le chiese: "Fanciulla, che cos'è la
FIGURE FE.\1:\II:-;ru DEL SAPERE
donna?" La fanciulla gli rispose: "Fonte di molto bene e di molto male, immagine dell'uomo, bestia mai quieta".) Oppure: El sabio le preguntò: "Donzella, qual es la cosa mas aguda que nauaja?" La donzella le respondiò: "La lengua de la muger quan do està ayrada". (p. 128) (Il saggio le chiese: "Fanciulla, qual è la cosa che è più appuntita di un coltello? " La fanciulla rispose: "La lingua di una donna arrabbiata".) La versione castigliana enfatizza inoltre la distanza tra il sapere maschile, di corte, e il potere che ne deriva, e la fan ciulla, disprezzata da subito come semplice e ignorante: E
estonces el primero de los tres sabios habl6 primero con la donzella e dixole asi por manera de desden, teniéndola por simple e nescia m primo dei tre saggi si rivolse alla fanciulla in maniera sprezzante, ritenendola ingenua e ignorante, p. no) . li secondo saggio, come abbiamo visto sopra, la mette intenzionalmente a disagio con domande sulla sessualità e il terzo saggio, Abramo, è indisponente e presuntuoso, quasi violento: Dize la estoria que desque vido el tercero sabio que los otros dos eran vençidos por vna doncella tan pequefia, que houo por ello gran pesar e terrible enojo e touo en su coraçon que se hauian dado para poco, porque se dexaron asi vençer de aquella donzella tan simple e tan pequefia nifia de tan pocos dias; e t6uolos por muy nesçios e de poco saber, porque el bien pensaua de la vençer. E leuant6se muy soberuio en pie e dix6le assi: "Tu, donzella, responderme has a todo lo que te preguntare. Cumple que te aper cibas a responderme derechamente, que tu has de saber que no so yo tan simple como eran los otros maestros con quien tu has dispu tado e tan malamente vençido con tus argumentos falsos". (p. 120) (La storia narra che quando il terzo saggio vide che gli altri due erano stati vinti da una così giovane fanciulla, ebbe grande dispia86
3· TAWADDUD, TIODOR E IL SAPERE DELLE FA�CILLLE
cere e un terribile risentimento, pensando che si erano arresi con poco, poiché si erano lasciati vincere da quella fanciulla così sem plice e di così pochi anni; e li ritenne molto ignoranti e di scarso sapere, e riteneva di poterla sconfiggere. Si alzò in piedi e con fare superbo le si rivolse così: "Tu, fanciulla, devi rispondermi a tutto ciò che ti chiederò. Devi riuscire a rispondermi correttamente, per ché devi sapere che non sono tanto sempliciotto come gli altri maestri che ti hanno esaminata e che hai vinto malamente con tuoi falsi argomenti".) Davanti a tanta arroganza e all'accusa di chissà quali trucchi magici, argumentos /alsos può alludere a un sapere demonia co, Teodor lancia una sfida, che assume qui una connotazio ne molto diversa che nel testo arabo; visto che l'altro si reputa così sapiente (tan grande e discreto sabio, p. 122) da disprezzare chi l'ha preceduto, gli propone un patto: "E la conuenencia sea en esta manera: que si vos venciéredes a mi, luego en esse punto me desnude e me disponga e dispoje de todos mis paiios e la camisa e todo quanto sobre mi està, de manera que quede del todo desnuda assi como el dia en que nasci, e yo vos lo dé todo, e sea todo vuestro; e si por ventura vendere yo a vos, que vos faga yo esso mismo, e que vos me deys todos vuestros paiios por manera que quedéys desnudo como el dia en que naci stes, si yo os ganare." E con esta razon que dixo la donzella, plugo mucho al sabio judio, porque la pensaua amenguar e auergonçar, creyendo que la tenia vençida, e respondi6 que le plazia (p. 122) . ("E che il patto sia il seguente: se voi mi vincerete, in quello stesso istante mi denuderò, togliendomi tutti gli abiti e la camicia e tutto quello che ho, in modo da rimanere del tutto nuda, come il giorno in cui sono nata, e tutto vi darò, e che sia tutto vostro; e se per caso io vi vincessi, farete lo stesso, e mi darete tutti i vostri abiti in modo da rimanere nudo come il giorno in cui nasceste, se io avrò la meglio su di voi." E le parole pronunciate dalla fanciulla piacquero molto al saggio ebreo, perché riteneva di umiliarla e farla vergogna re, pensando di averla già vinta, e rispose che era d'accordo.) n gesto simbolico di spogliarsi dei segni esteriori della pro
pria autorità diventa nel racconto castigliano il segno dell'af-
FIGURE FE.\1:-dl:'\IU DEL SAPERE
fronto e dell'umiliazione davanti a tutta la corte; come è pre vedibile e, vista l'antipatia di Abraham, come ogni lettore si aspetta, Teodor vince anche il terzo saggio, e la scena assu me dei toni comici, con il sapiente che perde ogni presun zione e si butta in ginocchio ai piedi di Teodor, la quale in un primo momento esige a gran voce che si mantenga fede al patto, e poi cede di fronte all'offerta di denaro. La fan ciulla, che non sente il bisogno di interrogare ogni saggio dopo essere stata esaminata come aveva fatto Tawaddud , dimostra di dominare l'unico vero sapere, in contrasto con la corte, contenitore vuoto di un sapere che non c'è più. Note 1. La storia della schiava Tawaddud, in Le mille e una notte, a cura di Gabrieli, Einaudi, Torino 1997 (I• ed. 1948), 4 voll., II, pp. 499-540. 2. I manoscritti sono stati studiati da H. Knust che ne ha pubblicato un'edizione in Mittheilungen aus dem Eskurial, Litterarischen Vereins in Stuttgart, Tiibingen 1879, pp. 507-17 e pp. 613-30; W. Mettmann ha curato un'edizione critica basata sulla versione a stampa del 1498 (Toledo) con frontata con altre successive, e da cui cito, in La historia de la donzella Teodor. Ein spanisches Volksbuch arabischen Ursprungs, Akademie der Wis senschaften und der Literatur, Mainz 1962; M. Parker trascrive il mano scritto g, BN Madrid 17853, senza correzioni, in The Story o/ a Story Across Cultures. The Case o/ the "Doncella Teodor», Tamesis, London 1996, pp. 33-60; si veda anche Narrativa popular de la Edad Media. La doncella Teo dor. Flores y Blanca/lor. Paris y Vtima, ed. di N . Baranda e V. lnfantes, Akal, Madrid 1995, pp. 47-83. 3· Un ampio panorama della fortuna della Teodor è offerto dalla monografia di Parker, The Story o/ a Story Across Cultures. The Case o/ the "Doncella Teodor», cit. 4· Ed. Parker, p. 38. 5· M. Menéndez y Pelayo, La Doncella Teodor: un cuento de "Las mi/ y una noches», un libro de corde/ y una comedia de Lope de Vega, in Home naje a don Francisco Codera, Zaragoza 1904, pp. 483-su. 6. Libro del caballero Zz/ar, edici6n, introducci6n y notas de J. Gonza lez Muela, Castalia, Madrid 1982; si veda M. J. Lacarra, El arquétipo de la mujer sabia en la literatura medieval, in "Foro Hispanico", 5, 1993, pp. u-21. 7· F. G6mez Redondo, Historia de la prosa medieval castellana, vol. I: La creaci6n del discurso prosistico: el entramado cortesano, Catedra, Madrid 1998, soprattutto le pp. 470-510. Si veda anche M. ]. Lacarra, F. L6pez Estrada, Origenes de la prosa, Ediciones Jucar, Madrid 1993. 8. Si veda la recente edizione di H. O. Bizzarri, Dùilogo de Epicteto y el emperador Adriano, Iberoamericana, Madrid 1995. F.
88
3· TAWADDUD, TEODOR E IL SAPERE DELLE FA:-.ICIULLE
9· Knust, Mittheilungen aus dem Eskurial, cit., pp. 498-506. Io. R. Giorgi, Dizionari dell'arte. Santi, Electa, Milano 1001. n . Christine de Pizan, La Città delle Dame, a cura di P. Caraffi, edi zione dd testo originale a fronte a cura di ]. Richards, Luni, Milano-Tren to I9981• I1. Cito da La storia della schiava Tawaddud, in Le mtlle e una notte, cit. Nelle citazioni a seguire dalle Mille e una notte, indicherò solo volume e pagine tra parentesi nd testo. I3. Si veda il bd saggio di A. Miqud, Tawaddud la servante, in Sept contes des Mtlle et une Nuits ou Il n'y a pas des contes innocents, Éditions Sindbad, Paris I98I, pp. I5-49, a p. 13: «Tawaddud triomphe, certes, et elle l'a bien mérité, mais elle entraine dans ce triomphe son jeune maitre fort peu sympathique, débauché, qui n'avait jamais eu la moindre idée cles mérites de sa servante, qui n'avait meme jamais songé que les plaisirs qu'il allait chercher au dehors pussent ne pas soutenir la comparaison avec ce qu'il avait chez lui, à commencer par la beauté: car Tawaddud est pétrie de charmes, longuement et précisément évoqués par le conteur. La vietai re du jeune homme, c'est celle d'une chance qui a nom Tawaddud, camme, ailleurs, Le Chat Botto>. I4. M. E. Lacarra, Partimetros de la representaci6n de la sexualidad /emenina en la literatura medieval castellana, in "Foro Hispanico" , 5, I993, pp. 13-43· I5. C. Frugoni, La donna nelle immagini, la donna immaginata, in G. Duby, M. Perrot, Storia delle donne in Occidente, n: Il Medioevo, a cura di C. Klapisch-Zuber, Laterza, Roma-Bari I990, pp. 414-57. I6. Un saggio "classico" sul motivo dd dono obbligante è senz'altro J. Frappier, Le moti/ du «don contraignant» dans la littérature du Moyen Age, in Amour courtois et Table Ronde, Droz, Genève I973, pp. 115-64 (trad. it. in Il romanzo, a cura di M. L. Meneghetti, il Mulino, Bologna I988, pp. 34787) . I7. C. Bremond, B. Darbord, Tawaddud et Teodor: /es enjeux ludiques du savoir, in L'Enciclopedismo medievale, a cura di M. Picone, Longa Edi tore, Ravenna I994, pp. 153·73 I8. C. Casagrande, La donna custodita, in Duby, Perrot, Storia delle donne in Occidente, II: Il Medioevo, cit., pp. 88-I18; J. C. Schmitt, Il gesto nel Medioevo, Laterza, Roma-Bari I990. I9. C. Gerresch, Un récit des "Mille et une Nuits»: "Tawaddud», petite encyclopédie de l'Islam médiéval, in "Bulletin de l'Institut Français d'Afri que Noire" , 15, I, I973, pp. 57·I75· 10. Bremond, Darbord, Tawaddud et Teodor: /es enjeux ludiques du savoir, cit. 11. Cfr. Miqud, Tawaddud la servante, cit. 11. Gerresch, Un récit des "Mille et une Nuits», cit., pp. 114 ss. 13. Ibn Hazm, Il collare della colomba, a cura di F. Gabrieli, ES, Mila no I996, a p. 75 14. T. Garulo, Diwan de las poetisas de al-Andalus, Hiperi6n, Madrid I986; M. ]. Rubiera Mata, Poesia Femenina Hispanotirabe, Castalia, Madrid
FIGURE FE.'d.'d.I:-\IU DEL SAPERE
I989; Mahmud Sobh, Poetisas artibigo-andaluzas, Diputaci6n Provincia! de Granada, Granada I984. 2.5. Si veda il saggio di A. Miquel, Le Yéménite et ses six /emmes esclaves, in Sept contes des Mille et une Nuits, cit., pp. 165-89. 2.6. Mi riferisco all'idea ancora cosl diffusa che sapere e bellezza diffi cilmente coincidono in una donna; su questo tema si veda F. Mernissi, [}Harem e l'Occidente, Giunti, Firenze 2.000, in particolare il cap. VI: In Occidente, le donne intelligenti sono brutte, pp. 7I-82.. 2.7. Miquel, Tawaddud la servante, cit., p. 2.8. 2.8. M. Foucault, Scritti letterari, Feltrinelli, Milano I997 (I" ed. I984) . 2.9. L. Diillenbach, Il racconto speculare. Saggio sulla mise en abyme, Pratiche, Parma I994· 30. A. Kilito, L'occhio e l'ago. Saggio sulle "Mille e una notte", li Melangolo, Genova I994· 31. Le mille e una notte, cit., I, p. IO. 32.. A. Cavarero, Tu che mi guardi, tu che mi racconti. Filosofia della narrazione, Feltrinelli, Milano I997· 33· Le mille e una notte, cit., IV, pp. 6I5-6. 34· Si veda Mernissi, [}Harem e l'Occidente, cit.; Chahrazad non è marocchina, Sonda, Milano-Torino I993 e La terrazza proibita. Vita nell'ha rem, Giunti, Firenze I994· 35· A. Borruso, Dall'India a Parigi, Franco Angeli, Milano 2.001 . 36. M. Foucault, Scritti letterari, Feltrinelli, Milano I997 (I" ed. I984), pp. 3-4· 37· Lacarra, Partimetros de la representaci6n de la sexualidad /emenina cit ., pp. 2.3-43 e Representaciones de mujeres en la literatura espanola de la Edad Media (escrita en castellano), in Breve historia /eminista de la literatu ra espanola, Anthropos, Barcelona I995, 4 voli., n, pp. 2.I-68.
90
4
Tarsiana, nobile giullaressa
1. In tutto il Libro de Apoloniot (XIII secolo) , magnifica mescolanza di un avventuroso intreccio ellenistico e delle rappresentazioni psicologiche e realistiche del mester de cle recia, viene dato grande risalto alla scrittura e alla parola, legate all'educazione, alla cultura, al sapere dei vari perso naggi. Questo aspetto, presente già nella versione latina1, è ulteriormente sottolineato in quella medievale castigliana, dove assume i tratti tipici della clerecfa3, che si riconoscono nei personaggi principali - Apollonia, Luciana, Tarsiana -, ma anche in altri secondari, come i due medici che soccor rono Luciana e la curano, e di cui è sottolineata e descritta con molta precisione la scienza medica (284-324) . Apollonia, principe di Tiro, aspira alla mano della figlia del re Antioco, avendo sentito parlare di lei, e per averla deve risolvere un enigma, che cela la relazione incestuosa tra il re e sua figlia. n sapiente Apollonia comprende subito di cosa si tratta, ma è costretto a fuggire per non essere ucciso, nel primo di una serie di viaggi per mare, sfondo che accompagna, separa e ricongiunge i vari personaggi, in sinto nia con il modello del romanzo bizantino. n primo vero ritratto di Apollonia è quello dell'intellettuale4 che consulta i libri, per verificare l'esattezza della sua risposta: 31
Encerr6se Apolonio en sus camaras priuadas, do tenié sus escritos e sus estorias notadas. Rez6 sus argumentos, las fazanyas passadas, caldeas e latines, tres o quatro vegadas.
32
En cabo, otra cosa non pudo entender que al rey Antioco pudiese responder. 91
FIGURE FE.\1:\U:-;IU DEL SAPERE
Cerro sus argumentos, dex6se de leyer, en laçerio sin fruto non quiso contender. (Apollonia si chiuse nei suoi appartamenti, l dove aveva i suoi libri e le storie commentate. l Lesse ancora gli enigmi e le antiche imprese, l caldee e latine, tre o quattro volte. ll Alla fine non riuscì a trovare nient'altro l da poter rispondere al re Antioco; l chiuse i libri, smise di leggere, l non voleva proseguire una fatica senza frutti.) In fuga, Apollonio fa naufragio e approda, solo e senza più nulla, a Pentapoli, dove è accolto dal re Architraste; egli, diversamente da Antioco, volentieri gli dà in sposa sua figlia Luciana, che aveva consolato Apollonio con la musica e il canto. Ma la felicità non dura a lungo: Apollonio deve rimettersi in viaggio e Luciana, che lo accompagna, sulla nave muore nel dare alla luce una bambina, morte che risul terà essere solo apparente, ma essenziale per la sua uscita di scena. Luciana, sepolta in mare, viene soccorsa da due sapienti medici, e ricomparirà solo alla fine del romanzo. Ma la separazione dei vari personaggi non termina qui: Apollo nio affida la figlia Tarsiana a due tutori, a Tarso, poi riparte in pellegrinaggio. Tarsiana, che cresce bella e sapiente, susci ta presto l'invidia della matrigna, doppio negativo della madre assente, che cerca di farla uccidere da un sicario. Di nuovo un colpo di scena: sopraggiungono dei pirati, che sul momento salvano la giovane, e che poi la venderanno come schiava, a Mitilene, dove viene comprata dal tenutario di un bordello. Tarsiana si salva dalla prostituzione solo grazie all a sua abilità come musicista e si improvvisa giullaressa, cantan do nelle piazze e guadagnando il denaro necessario a soddi sfare l'avidità del suo padrone. Apollonio giunge, nella stessa città, dopo diversi anni, distrutto dal dolore e in uno stato di profonda malinconia; per cercare di alleviare la sua pena, riportarlo alla vita e ai suoi doveri di re, Antinagora, princi pe della città, manda a chiamare la giullaressa Tarsiana, che egli conosceva e stimava profondamente. TI sapere di Tarsia na e la sua arte riescono a distogliere dal silenzio malinconi co il re triste, premessa all'agnizione. Da qui in poi si avvia 92
4· TARSIA:-.IA, :-.IOBILE GIULLARESSA
un procedimento inverso di ricomposizione: Apollonia rico nosce in Tarsiana la figlia creduta morta, poi ritroverà anche Luciana e il romanzo si conclude con un lieto fine. In questo intreccio complesso, sono di grande rilievo le figure femminili che, autorevoli nella parola e nell'arte, o silenziose, imprimono il movimento alla narrazione. 2. L'Apolonio esordisce su un silenzio femminile fatale: quel lo della figlia di Antioco che, come nel mito di Enomao e lppodamia, nella Manekine di Philippe di Beaumanoir, o nel !ai Deus amanz di Maria di Francias, è desiderata dal padre. Di lei non viene detto neanche il nome, e tacerà, su consiglio della sua nutrice, coprendo la colpa incestuosa del re: 8
La duenya por este fecho fue tan enuergonçada Que por tal que muriese non querìa corner nada; mas huna ama viega que la ouo criada fiçol creyer que non era culpada. [. .] 10 Demas yo uos conseio, e u6s creyer me lo deuedes, al rey vuestro padre v6s non lo enfamedes; maguer grant es la pérdida, mas val que lo calledes que al rey e a u6s en mal preçio echedes. .
(Per questo si sentì così piena di vergogna, l che non voleva man giare nulla, e lasciarsi morire; l ma una vecchia nutrice, che l'aveva allevata, l le fece credere di non essere colpevole. l1[ . . ] Inoltre vi consiglio, e mi dovreste dare ascolto, l di non disonorare il re vostro padre: l per quanto grande sia l'offesa, meglio è tacerla, l che gettare il disprezzo sul re e su di voi.) .
Privata dell'identità - quella di figlia: es el nombre derechero en amos en/ogado (il giusto nome è per entrambi cancellato, ud) -, non può neppure lasciarsi morire, cancellando con un atto estremo la violenza. n suo silenzio - deve tacere, per non accusare il re-padre incestuoso - e la sua mancanza di coraggio la rendono complice dell'infamia: un fulmine del demonio li distruggerà entrambi (248d). Per impedire che la figlia possa sposarsi, il crudele Antio-
93
FIGURE FE.\1:-JI:-;ru DEL SAPERE
co sottopone i pretendenti a una prova impossibile da supe rare: essi devono risolvere un enigma, la cui soluzione rivela l'incesto, rendendo indicibile la risposta. Infatti, tutti coloro che si sono misurati in questa prova, hanno perso la vita:
Autàn muchos por aquesto las cabeças cortadas; l sedtàn, sobre las puertas, de las almenas colgadas (Molti, a causa di ciò, ebbero la testa tagliata: l queste rimanevano appese ai merli, s opra le porte , 16ab) . Questa immagine così c rudele e arcaica6 fa pensare al primo romanzo di Chrétien de Troyes (XII secolo) , l'Erec et Enide, e ai cavalieri sconfitti da Mabo nagrain, le cui teste erano conficcate su pali aguzzi: Mes une grant mervoille voit Qui poYst faire grant peor Au plus riche conbateor, Ce fust Tiebauz li Esclavons, Ne nus de ces que nos savons Ne Opiniax ne Fernaguz: Car devant ax sor pex aguz Avoit hiaumes luisanz et clers E voit de desoz les cerclers Paroir testes desoz chascun. Mes au chief des pex an voit un Ou il n'avoit neant ancor Fors que tant solemant un cor. (vv. 5770-5782) (Ad un tratto scorge uno spettacolo l che avrebbe potuto atterrire l il guerriero più ardito, l fosse Tebaldo lo Schiavone l oppure Ospi nel o Ferraù l o chiunque altro che conosciamo. l Davanti a loro, su pali aguzzi l erano infissi degli elmi chiari e lucenti l e sotto il bordo di ciascuno di essi l spuntava una testa d'uomo. l In fondo alla fila dei pali, l uno era ancora vuoto l e portava appeso un corno.)7 Una scena molto simile appare nel romanzo Le sette princi pesse, di Nezami, poeta persiano contemporaneo a Chrétien. Uno dei racconti della parte centrale del romanzo, quello della "Figlia del re del quarto continente" , narra la storia di una principessa bellissima e sapiente:
94
4· TARSIA:-.IA, :-.IOBILE GIULLARESSA
Ma oltre la bellezza e il dolce sorriso, ella possedeva l'ornamento della sapienza, aveva appreso cognizioni di ogni genere, aveva ver gato carte d'ogni ramo di scienza, aveva letto tutti i libri d'incanti del mondo, le malie e le cose occulte. Aveva sul volto abbassato il velo delle sue trecce, e rifuggiva alla legge maritale: chi è senza pari nella propria cerchia come potrebbe accordarsi con un com pagno?8 Come Turandot, essa sottopone i suoi pretendenti a una serie di terribili prove che, se non superate, saranno fatali per loro e le loro teste ornano la porta della città: Senza riuscire a ottenere il proprio intento, un certo numero di bei giovani perì: nessuno aveva trovato scampo da quella via coperta di teste troncate. Ogni capo che troncavano ai principi, lo espone vano alla porta della città, al punto che per le molte teste con vio lenza tagliate teschio su teschio restò ostruita la porta9. Nell'enigma, e nell'indovinello come sua derivazione non tra gica, l'interrogante detiene un sapere a cui l'interrogato acce de se dà la giusta soluzione, dimostrando di essere all'altezza di entrare a far parte dell'universo dell'altro. Nella cultura ar caica questo livello di competizione era associato alla magia: «Per l'uomo primitivo il potere e l'osare qualche cosa signifi ca forza, ma il sapere qualche cosa significa forza magica. Per lui ogni conoscenza non comune è in fondo una scienza sacra, un segreto e magico sapere [ ] TI corso regolare delle cose, disposto e stabilito dagli dei, custodito dal culto [ ] più che da ogni altra cosa è continuato e protetto dalla cono scenza degli uomini intorno alle cose sacre e ai loro nomi segreti, insomma intorno all'origine del mondo»10• Nell'enig ma tragico che apre tutta la storia e che si può considerare tra gli enigmi capitali, cioè quelli la cui non soluzione com porta la morte, come quello della Sfinge, l'interrogante è un essere crudele, Antioco, che protegge con una domanda a cui non è possibile dare risposta - perché la risposta significa comunque morte certa - la sua eccessiva endogamia n, l'amo re incestuoso per la figlia. Apollonia accede alla conoscenza di questo segreto risolvendo l'enigma, ma rischia ugualmente . . .
. . .
95
FIGURE FE.\1:\U:-;IU DEL SAPERE
la morte per la slealtà di Antioco, ed è questo il pretesto nar rativo necessario allo sviluppo di tutta la storia. n fantasma dell'incesto11 aleggia su tutto il romanzo, che si sviluppa nel nome dell'assenza delle madri13. Centrale nel primo episodio, viene evocato e negato con decisione nel secondo, in cui si parla in maniera speculare e contraria del re Architraste che ama la figlia come un padre e non come un amante e che volentieri la darà in sposa al re straniero; riemerge come pericolo da evitare negli episodi successivi. Quando Antinagora vede Tarsiana per la prima volta, sente per lei una forte attrazione: 395
El senyor Antinagora, que la villa tenié en poder, vio esta catiua de muy gran paresçer; ouo tal amor della que sen querié perder, prometi6les por ella diez pesas de auer.
(Antinagora, il signore che regnava sulla città, l vide la bellissima prigioniera, l la desiderò tanto che quasi perse il giudizio, l e per averla offrì dieci libbre.) L'autore aveva usato la stessa espressione per definire l'amo re incestuoso di Antioco nei confronti di sua figlia: tanto que se querzà por su amor perder (al punto da perdersi a causa sua, 6d) . Entrambe attrazioni pericolose? Antinagora ha una figlia della stessa età di Tarsiana: Diome Dios huna /zja, tén gola po casar; l a todo mì'o poder querriala guardar (Dio mi ha dato una figlia ora in età da marito; l con tutte le mie forze vorrei proteggerla, 414ab) : l'allusione ad un incesto simbolico suona anche come un segnale che le relazioni al di fuori delle norme sociali stabilite possono essere molto peri colose. Antinagora e Tarsiana si uniranno in matrimonio, ma solo quando Tarsiana avrà recuperato la sua identità nobile e gli verrà data ufficialmente in sposa dal padre Apollonia. Infine, nell'ultimo episodio, l'incontro tra Tarsiana e Apollo nia, in cui l'uno non conosce l'identità dell'altro, l'incesto è evocato ancora una volta ed evitato per un soffio: Tarsiana, di fronte alla tenace resistenza di Apollonia a tornar en ale gria ( 526b) , e a nulla sono valsi la musica e gli indovinelli, gli
4· TARSIA:-.IA, :-.IOBILE GIULLARESSA
butta le braccia al collo. n re reagisce e la colpisce brutal mente in volto, facendole sanguinare il naso: 528 6uosse ya con esto el rey a enssanyar, ouo con fellonia el braço a tornar; 6uole huna ferida en el rostro a dar, tanto que las narizes le ouo a ensangrentar. (Per questo il re diventò furioso, l da fellone alzò la mano contro di lei l e la colpì in volto, ferendola, l tanto che le sanguinò il naso.) Questo atto violento rompe la sintonia che si stava creando tra i due, che avrebbe potuto essere amorosa, facendo esplo dere il lamento della fanciulla, e di conseguenza il reciproco riconoscimento. 3· Una delle scene più patetiche e violente della prima parte dell'Apolonio è anche quella in cui l'eroina Tarsiana, vittima dell'invidia della matrigna, viene sorpresa all'alba da uno schiavo pagato per ucciderla. L'aggressione è raccontata in pochi versi incisivi, dove la dolcezza dei gesti di Tarsiana, ignara, contrasta fortemente con la figura rude e blasfema del sicario: 375 Por amor, el astroso, de sallir de laçerio madurg6 de manyana e fue para 'l ciminterio; aguz6 su cuchiello por fer mal ministerio, por matarla rezando los salmos del salterio. 376 La duenya, gran manyana, como era su costumbre, fue para 'l çiminterio con su pan e con su lumbre; aguis6 su ençienso e encendi6 su lumbre, comenc6 de rezar con toda mansedumbre. 377 Mientre la buena duenya leyé su matinada, salli6 el traydor falso luego de la çelada, prisola por los cabellos e sac6 su espada: por poco le ouiera la cabeça cortada. (Per il desiderio di uscire dalla povertà, il miserabile l si alzò di buon mattino e si diresse verso il cimitero. l Affilò il coltello per un cattivo incarico: l ucciderla mentre recitava i salmi del salterio. 97
FIGURE FE.\1:\U:-;IU DEL SAPERE
Il Molto presto, com'era sua abitudine, la fanciulla l andò al cimi tero, con un lume e un po' di pane; l preparò l'incenso e accese il lume, l cominciò a pregare con grande dolcezza. ll Mentre ella stava leggendo le preghiere del mattino, l il traditore uscì dal nascondiglio, l la prese per i capelli ed estrasse la spada: l poco
mancò che le tagliasse la testa.) Scena impressionante, che rievoca il manmo o il sacrificio delle fanciulle che nelle tragedie cadevano sotto il coltello del sacerdote - Ifigenia, Polissena, Macaria, le figlie di Eret teo . . . - e la cui mone prendeva la forma di una cerimonia nuziale, di un "matrimonio nell 'Ade"14. Da Ifigenia alle figlie di Eretteo, alle Coronidi, sono sempre vergi ni radiose che devono essere sacrificate. E quel sacrificio è sempre un'oscillazione fra il suicidio e la cerimonia nuziale. Nell'anno, che significa la totalità della natura, vi sono « 8iorni nefasti e tenebrosi» in cui si tagliano le gole alle fanciulle. E quello il modo, l'unico modo conosciuto dagli uomini, per fare loro traversare la frontiera dell'invisibile e consegnarle nelle mani dei vendicatori divini, che le aspettano subito oltre la soglia. Questi vendicatori hanno «desi deri deliranti e tirannici» di quei corpi e li assediano tenacemente, eppure non riescono a farsi strada nel visibile sino a «congiungersi con quei corpi e penetrarli». Sono allora gli uomini che devono venire incontro a questa rabbiosa impotenza dei daimones, abban donando i corpi esanimi delle fanciulle su quella linea di confine che attraversa gli altari. È l'origine di ogni erotismo nerd5. Un erotismo nero che non ha mai cessato di affascinare la fantasia di autori e di pubblico, sona di incantamento, o forse piacere, suscitato dalle storie di innocenze perseguitate, a causa della loro bellezza e della loro vinù. Così molti seco li dopo Justine, frutto della genialità funesta del Marchese De Sade, che riprende, sviluppandolo, un tema già molto diffuso e su cui si erano cimentati non pochi scrittori prima di lui - da Prévost a Richardson, a Marivaux -, quello delle «disgrazie sulla vinù», che sarà di nuovo molto apprezzato in tutto l'Ottocento16• Ciò che vi è forse di particolarmente originale, e al tempo stesso terrificante, nel sistema sadiano è
4· TARSIA:-.IA, :-.IOBILE GIULLARESSA
l 'inversione di valori, per cui la virtù diventa un elemento negativo, freno da infrangere: Nell'inversione di valori che è alla base del sadismo, il vizio rap presenta l'elemento positivo, attivo, la virtù l'elemento negativo, passivo. La virtù esiste come freno da rompere [ . . ] Sicché natu ralmente, condizione del piacere sadico è l'esistenza della virtù, proprio come nella moralità ortodossa è necessaria la presenza del l' ostacolo da superare, del male da vincere17. .
Anche Tarsiana nel Libro de Apolonio si presenta come una fanciulla innocente, innocenza da lei proclamata in quello spazio minimo di tempo che le concede il suo carnefice per poter pregare: 382 S6 en tierras agenas sin parientes criada, la madre perdida, del padre non sé nada, io, mal non meresciendo, he a ser martiriada. Senyor, quando lo tu sufres s6 por ello pagada. (Sono in terra straniera, cresciuta senza genitori: l ho perso mia madre, di mio padre non so nulla; l io, non meritando il male, devo essere uccisa. l Signore, se tu lo tolleri, io lo sopporterò.) Immagine di una vergine sul punto di essere sacrificata, mar tiriada, è questa la prima di una serie di situazioni che l'eroi na dovrà affrontare, e superare da sola, in piena sintonia con numerose altre protagoniste di racconti popolari , romanzi, fiabe e leggende devote. 4· Le traversie di una fanciulla vergine e innocente costretta ad affrontare una serie di prove che il destino le riserva, è infatti un motivo di grande diffusione, che Aleksandr Vese lovskij, nel saggio introduttivo alla sua edizione critica della Novella della figlia del re di Dacia (Pisa 1866) , definiva come quello della " fanciulla perseguitata": Fra i tipi simbolici di cui si dilettava la fantasia nel medio evo non è nessuno che fosse più simpatico o che godesse maggiore popola99
FIGURE FE.\1:-JI:-;ru DEL SAPERE
rità della fanciulla perseguitata, forse perché corrispondeva alla pessima condizione della donna medievale, senza diritti sociali, sempre esposta agli arbitri dei suoi, alle voglie di chiunque era più forte di lei, gettata da uno amore all'altro secondo portava la for tuna, come la figlia del Soldano del Boccaccio o la bella Camilla del cantare plebeo; poi, venendo a maritarsi, osteggiata dalla suo cera, custodita gelosamente dal consorte, come la Griselda o la Flamenca del romanzo provenzale; oppressa inoltre dalla credenza popolare che la Chiesa appoggiava e che ne faceva un essere infe riore all'uomo, il suo principio tentatore, pessimo strumento nelle mani del genio del male, un essere infine sulle cui spalle si aggra vava da secoli il peccato commesso dalla prima parente [ ] Cre scenzia e Uliva, Genoveffa e Hirlanda, Florencia e Santa Gugliel ma, la figlia del re di Dazia e la regina di Polonia, la Cenerentola e la Marion del Bosch del racconto piemontese - sono tutte diver genze dello stesso tipo, con più o meno varietà nelle circostanze, secondo che la fanciulla venga perseguitata dal padre o dalla suo cera, dalla matrigna o dal fratello del marito assente18• . . .
Un unico, lungo filo congiunge queste innocenti; tuttavia, pur nell'ingiustizia e nell'assurdità delle persecuzioni, la sof ferenza diventa necessaria come ostacolo da superare, e per dare un maggiore risalto finale alla vittoria della virtù sul male, proprio come in un racconto agiografico1 9. Veselovskij riconosce nella Novella della figlia del re di Dacia lo schema di una leggenda devota, la storia di santa Uliva10, che si ritrova anche in una ricca tradizione letteraria, tra cui, per esempio, La Manekine di Philippe de Beaumanoir e, seppure con varianti, la storia di Costanza nel The man o/ Law's Tale (I.:uomo di legge) , nei Canterbury Tales di Chaucer. TI ritratto di Costanza tracciato da Chaucer è significati vo in questo senso; riprende infatti il modello di una perfe zione femminile ideale, modello elaborato instancabilmente da predicatori e moralisti, dal XII secolo in poi11• La bellezza, priva naturalmente di orgoglio - che ossessione la bellezza femminile , è accompagnata da bontà, umiltà, pietà, carità: -
This was the commune voys of every man: «Oure Emperour of Rome - God hym see! -
100
4· TARSIA:-.IA, :-.IOBILE GIULLARESSA
A doghter hath that, syn the world bigan, To rekene as wel hir goodnesse as beautee, Nas nevere swich another as is shee. I prey to God in honour hire susteene, And wolde she were of al Europe the queene. In hire is heigh beautee, withoute pride, Yowthe, withoute grenehede or folye; To alle hire werkes vertu is hir gyde; Humblesse hath slayn in hire al tirannye. She is mirour of alle curteisye; Hir berte is verray chambre of hoolynesse, Hir hand, ministre of fredam for almesse»12• (vv. 155-168) (La voce che correva sulla bocca di tutti era questa: "Il nostro imperatore, Dio lo protegga, ha una figlia così bella e buona, che da che il mondo è mondo, non si è vista l'eguale né per bellezza, né per bontà. Dio la mantenga in onore, e possa essere un giorno la regina dell'Europa intera. La sua straordinaria bellezza è senza orgoglio, la sua gioventù non conosce capricci e non ha grilli per la testa. Ogni sua azione ha per guida la virtù, ed umiltà, in lei, ha distrutto ogni superbia. È un vero specchio di gentilezza: nel suo cuore alberga la pietà, e la sua mano è ministra di libertà e di ele mosina.) 23 Nella storia di Costanza agli elementi del romanzo ellenistico - lo schema generale della giovane che intraprende un viag gio in mare per raggiungere il suo futuro sposo, traversie che ritardano la meta, lieto fine - si mescolano immagini marti rologiche, come la verginità salvata in extremis da interventi divini e una certa insistenza sulla religiosità e le conversioni che accompagnano Costanza nel suo percorso. Ogni motivo di persecuzione, poi, tende a duplicarsi, sottoli neando maggiormente il paradosso dell'innocenza perse guitata: due esposizioni dell 'eroina in mare , due accuse calunniose, due suocere malvage, due tentativi di violenza risolti da interventi divini. Le persecuzioni paiono necessarie a rafforzare l'immagine di una virtù che vince, nonostante tutto, che supera ogni genere di difficoltà e ne esce comun-
101
FIGURE FE.\1:\II:-;ru DEL SAPERE
que integra. Nell'eterna contrapposizione tra Eva e Maria, in contrasto con questa eroina così perfetta, la sultana rappre senta l 'altra, incubo di un femminile impuro , violento , distruttivo, demoniaco. L'attacco è contro di lei, e contro tutte le figlie di Eva: O Sowdanesse, roote of iniquitee ! Virago, thou Semyrame the secounde! o serpent under femynynytee, Lik to the serpent depe in belle ybounde! O feyned womman, al that may confounde Vertu and innocence, thurgh thy malice, Is bred in thee, as nest of every vice! O Sathan, envious syn thilke day That thou were chaced from oure heritage, Wel knowestow to wommen the olde way ! Thou madest Eva brynge us in servage; Thou wolt fordoon this Cristen mariage. Thyn instrument so - weylawey the while! Makestow of wommen, whan thou wolt bigile. (vv. 358-371) (0 Sultana, radice d'iniquità, virago, nuova Semirarnide, serpente dall'aspetto di donna, donna simile al serpente che è incatenato giù nel profondo dell'inferno, femmina ingannatrice; in te, nido d'ogni vizio, si accoglie tutto ciò che corrompe la virtù e l'inno cenza per mezzo della malizia. E tu, o Satana maledetto, dal gior no che fosti cacciato dal nostro regno, ben sai la via per giungere alla donna. Tu facesti sì che Eva ci trascinasse nella schiavitù, e ora tu sconcludi questo matrimonio cristiano. Quando non vuoi com parire, ahimè, tu ti servi, pei tuoi malvagi fini, della donna.)14
Una ripetizione ossessiva caratterizza anche la novella di Alatiel (Decameron, II, 7), tutta all'insegna del rovesciamen to. Ogni traversia di Alatiel, infatti, ha una conclusione ero tica, in una serie senza fine di prove sessuali, ribaltando così lo schema del romanzo bizantino - e si è parlato di parodia o comunque di comicità nell'Alatiel2s secondo il quale la verginità materiale della protagonista si conserva tale sino -
102
4· TARSIA:-.IA, :-.IOBILE GIULLARESSA
alla fine, anche dopo molte avventure. La reintegrazione di Alatiel invece avviene solo grazie a un imbroglio finale: E essa che con otto uomini forse diecemilia volte giaciuta era, alla to a lui si coricò per pulcella, e fecegliele credere che così fosse; e reina con lui lietamente poi più tempo visse. E perciò si disse: «Bocca basciata non perde ventura, anzi rinnuova come fa la luna»16. La storia di Alatiel, come quella di Griselda (Decameron , X, 20)17, si svolge all'insegna del silenzio, dell'impossibilità di comunicare con le parole e nel momento in cui essa recupe ra la parola è solo per raccontare una storia diversa da quel la realmente vissuta, «parola alienata»18, eco passiva di una menzogna, anche questa costruita da altri (il cortigiano Antioco) . Mai protagonista, mai agente, muta e travolta dagli eventi, bellezza irresistibile, ma pericolosa: tutti i suoi aman ti, in ogni ripetizione di quello che è lo stesso copione, non le sopravvivono. Silenzio dunque come segno di sottomissione ubbidiente delle donne, silenzio su cui gravava l'autorità delle parole di san Paolo: «Le donne nelle vostre assemblee tacciano, poiché non è loro permesso di parlare; stiano invece sottomesse, come dice la Legge. Se vogliono imparare qualcosa, interro ghino i loro mariti a casa, poiché è turpe per una donna par lare in assemblea» (I Cor. 34-36)19. Controllo e custodia delle donne, attraverso il silenzio e il divieto di parlare in pubbli co, spazio maschile; la parola femminile diventa trasgressiva nel momento stesso in cui esce dallo spazio chiuso, domesti co, della casa e diventa parola difettosa, deviante che può condurre anche al rogo. È basato su questa logica del controllo lo schema in cui l'eroina è travolta, non può reagire, vittima silenziosa e tota le, trascinata dagli eventi, senza possibilità di scelta. Tuttavia, all'interno di questo motivo folclorico individuato così chia ramente da Veselovskij, è possibile distinguere delle varianti; accanto alle vittime "totali" , vi sono le eroine che si ribella no al caso, in uno sforzo di determinare attivamente il pro-
1 03
FIGURE FE.\1�11:-;IU DEL SAPERE
prio destino e di opporre il proprio personale rifiuto. La parola e il sapere femminile sono gli strumenti con cui que ste figure femminili eroiche, come Tarsiana nell'Apolonio, oppongono resistenza agli eventi. 5· Per Tarsiana prendere la parola, il non tacere, diventa determinante per la sua vita e la capacità di raccontare e raccontarsi risulta fondamentale per lo sviluppo dell'azione. Tarsiana, a cui la balia Licoride, a sua volta narratrice, rivela le vere origini solo in punto di morte (quartine 3 56-363) narra la historia calamitatum suarum (storia delle sue disgra zie) diverse volte, in situazioni distinte ed ogni volta viene sottolineata la sua eloquenza e capacità di convincimento. a) Tarsiana è aggredita ingiustamente dal sicario di Dionisa, Teofilo, e gli chiede almeno un po' di tempo per pregare; è proprio questo dilatarsi della scena sul suo lamento, che per mette e rende plausibile l'intervento dei pirati che la libere ranno, per così dire, dal pericolo (376-386) . b) Tarsiana è condotta dai pirati al mercato di Mitilene, dove viene venduta a un homne malo, sennyor de soldaderas (un uomo malvagio, sfruttatore di donne, 396a) , che la con duce al bordello. Tarsiana è una merce ancora più preziosa, perché vergine, mai toccata o contaminata da altri, e la sua verginità viene offerta a caro prezzo. n principe della città, Antinagora, che l'aveva vista al mercato e non era riuscito ad averla per sé, sarà il primo cliente. Ancora un'immagine sacrificale: la vittima - definita huér/ana mesquina (povera orfana, 405b) - abbigliata con grande pompa per la cerimo nia che è in un certo senso nuziale, diventa l'agnello, mentre l'altro è immaginato come un lupo vorace: romaneciò el lobo solo con la cordera (solo rimase il lupo con l'agnello, 4o6b) . Tarsiana riesce però a fargli cambiare idea, raccontandogli la sua storia e le sue origini. Sono proprio queste origini nobili (que de linatge sodes, de buena parte venides, 412b) insieme al parallelo con la figlia che egli non vorrebbe mai vedere in quelle condizioni a «calmarlo» (amanssado, 411b). Antinagora rinuncia, e offre del denaro a Tarsiana, per riuscire a difen dersi dagli altri uomini che sarebbero venuti dopo di lui: 104
4· TARSIA:-.IA, :-.IOBILE GIULLARESSA
quando non fosse riuscita a convincerli con le parole, avreb be potuto comprarli. Ma non ne avrà bisogno: tutti quelli che vanno da lei, rinunciano, !asciandole ugualmente del denaro. L'accento è posto sull'abilità di Tarsiana nel trarsi d'impaccio, difendendo la propria verginità morale e ma teriale, nel non permettere che gli uomini le «sporchino» (enconar, 403d) l'anima: mas tanto /ue la duenya sauia e ado nada l que gan6 los dineros e non /ue violada (ma la dama fu così saggia e gentile l che guadagnò i denari senza subire violenza, 418cd). c) Tarsiana propone al lenone un altro modo di guadagnar si la vita, più redditizio e più onorevole. L'autore rivolge grande attenzione alle capacità dialettiche della fanciulla: Dixo la buena duenya un serm6n tan tenprado (La nobile signora fece un discorso molto misurato, 422a) . El serm6n de
la duenya /ue tan bien adonado l que /ue el coraç6n del gar çon amansando (Le parole della dama furono così persuasi ve, l che il cuore dell'uomo ne venne soggiogato, 425ab) . Tarsiana diventa giullaressa: con una viola va al mercato e canta e, una volta di più, racconta la sua storia. La gente è conquistata e l'aiuta ancora più volentieri, ben sapendo in che mani si trova. Di nuovo l'autore sottolinea l'abilità con cui Tarsiana riesce a trarsi d'impaccio: 432 Tan bien sopo la duenya su cosa aguisar que sabìa a su amo la ganançia tornar. Reyendo e gabando con el su buen catar, s6pose, maguer ninya, de follia quitar. (La dama seppe condurre la cosa talmente bene, l che riusciva a portare il guadagno al suo padrone. l Ridendo e scherzando, con il suo aspetto grazioso, l riuscì a togliersi dai guai, malgrado la giovane età.)
d) Tarsiana è ancora artefice del proprio destino nel momen to in cui riesce con la sua arte a distogliere Apollonia dal suo silenzio malinconico, e poi quando si ribella al colpo ricevuto: il lamento di Tarsiana - che è nuovamente il rac conto della sua storia infelice - conduce all'agnizione: la fan105
FIGURE FE.\1:\II:-;ru DEL SAPERE
ciulla e il principe triste si riconoscono come padre e figlia e da questo punto in poi la storia si ricompone, avviandosi alla conclusione. 6. Il sapere di Tarsiana si rivela fondamentale in alcune situazioni chiave . Se essa si salva dalla prostituzione, è solo perché l'educazione ricevuta l'ha resa maestra complida, e può improvvisarsi joglaresa, suonando la viola per la strada e al mercato. Tarsiana ha frequentato una scuola ed ha appre so perfettamente le discipline delle a rti liberali, tra cui la musica (di cui si mostra maestro anche il padre Apollonia, e in misura minore, meno perfezionata, la madre Luciana) .
350 Criaron a gran viçio los amos la moçuela. Quando fue de siete anyos diéronla al escuela; apriso bien gramatiga e bien tocar viuela, aguz6 bien, como fierro que aguzan a la muela. (I tutori allevarono la fanciulla nell'agiatezza. l Quando ebbe sette anni la mandarono a scuola; l imparò bene la grammatica e a suo nare la viola, l aguzzò l'ingegno, come il ferro si fa aguzzo alla mola.)
352 Quando a xn anyos fue la duenya venida, sabìa todas las artes, era maestra complida; de beltad, companyera non auyé conoscida, auyé de buenas manyas toda Tarso vencida. (Quando la giovane compì dodici anni, l padroneggiava tutte le arti, con vera maestria. l Per bellezza non ve n'erano uguali: l con le sue belle maniere aveva conquistato tutta Tarso.)
353 Non queryé nengun dfa su estudio perder, ca auyé uoluntat de algo aprender. Maguer mucho lazdraua, cay6le en plaçer, ca preciauase mucho e querié algo ualer. (Non voleva perdere un solo giorno di studio, l tanto grande era la sua voglia di imparare. l Per quanto faticasse molto, le venne a piacere: l si stimava parecchio e desiderava valere qualcosa.)
106
4· TARSIA:-.IA, :-.IOBILE GIULLARESSA
Una consapevolezza di sé, una volontà di eccellere, di valere, dove il valore passa attraverso la cultura e l'intelletto, e la conoscenza dei segreti del mondo, magnificamente simboleg giato dalla capacità di proporre indovinelli (Tarsiana) e di risolverli (Apollonia) , più che da virtù guerriere, come forza, coraggio e violenza. Emerge l'identificazione tra autore e personaggi, in cui c'è spazio per una figura femminile sapien te, senza che essa debba essere ritenuta una eccezione, o che debba assumere tratti virili. Semmai ne viene sottolineata la bellezza, la stima di sé e la coscienza della necessità di un'applicazione costante nello studio. Nello stesso tempo traspare dalla sua arte e dalla sua musica l'origine nobile, una nobiltà che si riconosce. Così, quando Tarsiana sceglie di diventare joglaresa , pur sapendo che questo non appartie ne alla sua condizione di principessa, lo fa per evitare una condizione peggiore, quella di prostituta. n fatto di conosce re la musica, di per sé segno di cultura "alta" , perché com presa tra gli insegnamenti dello studium universitario, non significa che fosse lecito suonare per un pubblico, e soprat tutto a pagamento3°. Se poi si aggiunge a ciò l'idea che lo spazio del femminile era l'interno, il domestico, casa o castel lo che fosse, rispetto a un esterno, pubblico e maschile, si può capire quanto ambigua fosse l'immagine di una donna che suona e canta in una piazza; immagine ambigua, facil mente identificabile con la prostituzione, bollata da anatemi, associata nell'iconografia alla figura seducente di Salomé e delle sirene incantatrici31• Tarsiana, consapevole di apparte nere a un nobile lignaggio, duenya so de linatge (491a) , sa bene che quel tipo di mester non è adatto alla sua condizio ne, racconta chiaramente ad Apollonia di aver scelto quella strada per evitarne una peggiore e che egli non si deve con siderare offeso dal divertimento che lei potrebbe procurargli: 490 Por mi solaz non tengas que eres aontado, sy bien me conoscieses, tenerte yes por pagado, qua non so juglaresa de las de buen mercado, nin lo é por natura, mas fagolo sin grado. (Da me non ti verrà diletto di cui ti debba vergognare, l se mi
107
FIGURE FE.\1:\U:-;IU DEL SAPERE
conoscessi bene, saresti contento: l io non sono una giullaressa da poco, l non mi appartiene per natura, lo faccio mio malgrado.)
7 · Uno dei motivi fondamentali deil'Apolonio è il dolore del
re, una malinconia32 dai tratti fortemente negativi, che non ha nulla di eccezionale e tantomeno geniale, anzi è regressiva e selvaggia, poiché fa dimenticare regalità e cortesia. Nel mondo antico la malinconia e ra considerata una malattia dovuta all'eccesso di atrabile o bile nera. In un sistema di analogie che fa capo alla teoria degli umori, ripre sa e sviluppata nel Medioevo e nel RinascimentoH, alla malinconia vengono associati la terra, il freddo, il secco, la notte. Aristotele, invece, in Problemata XXX ne aveva data una lettura positiva, interpretando questo eccesso non come una malattia, ma come uno stato eccezionale per natura, quello dell'uomo di genioH·. Questa oscillazione tra patologia e genialità rimarrà sostanzialmente invariata nelle varie epo che: il malinconico è considerato da una parte l'eccezione del genio e dell'artista, dall'altra un soggetto da controllare e normalizzare attraverso lo sguardo del medico e dell'inquisi tore (per esempio nel caso delle streghe)35. È comunque qualcuno che ha perduto la totalità armonica o, se si preferi sce, che ha distrutto l'immagine di Dio36, e il cui corpo è diventato come una prigione per l'anima, che per liberarsi desidera la morte. Separazione, perdita, distanza, freddo, profondità della terra, tenebre, morte: questi i tratti che distinguono il malinconico, attirato da un sole nero37, pro fondo abisso senza ritorno. La storia di Apollonio di Tiro presenta gli stessi tratti: una tristezza senza fine come reazione alle perdite subite , il raffreddamento interiore, il silenzio e l'isolamento, la con centrazione e il desiderio di morte, lati importanti della figu ra di Apollonio, che si mantengono invariati nelle numerose versioni, sia medievali, che successive. Nel Roman d'Apollonius de Tyr38, per esempio, l'opposi zione luce/tenebre, vita/morte è molto esplicita: et ne desire
/ors que de mourir en tenebres [ .] le prince de ceste cité et roy de tout le pais d'environ luy prie qu'il ysse de tenebres et . .
108
4· TARSIA:-.IA, :-.IOBILE GIULLARESSA
viengne en clarté (e non desidera altro che scomparire nelle tenebre [ . . . ] il principe di questa città e re di tutto il paese lo prega di uscire dalle tenebre e venire alla luce, p. 139); His hors de tenebres et viens a clart� et viens mengier (Esci dalle tenebre e ritorna alla luce, e vieni a mangiare, p. 140) . La risposta di Apollonia esprime tutto il suo desiderio di morte:
je, qui suis tourmenté par grans maleuretez, ne po"oye ne boire ne menger, ains ne vueil plus vivre (io, che sono tormentato da grandi sventure, non potrò né bere, né mangiare, al con trario, non desidero più vivere, p. 140) . Di Apollonio si dice:
Ne pou"ions nous /aire misericorde ne secours a cest homme qui se mect a mort? (Non potremmo aiutare e soccorrere que st'uomo che si sta uccidendo? , p. 143). Nel Patraiiuelo di Juan de Timoneda (1567)39 la Patraiia Oncena - patraiia significa sentenza, favola o racconto narra di Apollonio, che estaba muy triste, tanta honra recibe y de tanta tristeza le veo rodeado (è molto triste, riceve gran di onori, ed è tutto preso da grande tristezza, p. 123) , e sprofonderà definitivamente in una sobrada tristeza (p. 141 ) , per ritirarsi nella parte più isolata della nave: el Rey Apolo
nio luego se retir6 en el mds escuro retraimiento de la nave [. . . ] y que sin eso les mandaba, a pena de la vida, que ningu no /uese osado de entrar adonde él estaba sin que él primero no les llamase (il re Apollonio si rifugiò nel luogo più buio e appartato della nave [ . . ] e che aveva loro ordinato, a .
rischio della vita, che nessuno osasse entrare dove egli si tro vava senza prima essere chiamato, p. 140) . Tra le versioni inglesi, il Pericles, Prince o/ Tyre di Shake speare (1607). Sulla nave, il re Pericle si è rifugiato in un ostinato silenzio: Our vessel is of Tyre; in it the king, A man who far this three months hath not spoken To anyone, nor taken sustenance But to prorogue is grief. (Questa nave è di Tiro e c'è, a bordo, il re. l Da tre mesi non parla l né mangia se non quel tanto l per restare cosciente del suo dolore.)+0 109
FIGURE FE.\1:-JI:-;ru DEL SAPERE
La malinconia è quasi una presenza amica di Pericle, fa parte della sua vita, una «triste compagna assidua»: Why should this change of thoughts, The sad companion, dull eyed melancholy, Be my so used a guest as not an hour In the day's glorious walk or peaceful night, The tomb where grief should sleep, can breed me quiet? (Perché questo improvviso l cambiamento d'umore e perché non mi lascia l la malinconia, triste compagna assidua l dagli occhi mesti, tanto che non ho pace l neppure per un'ora del giorno più splendente l o della quiete notte che seppellisce la pena del sonno?)41
Nell'Apolonio la malinconia del re assume le caratteristiche di un comportamento anticortese, non nobile, che non si addice a un re, il quale dimentica i doveri che il proprio ruolo di s ovrano implica, rimprovero che gli viene mosso in due momenti diversi della sua vita e da due figure femminili sapienti che, una doppio dell'altra, una madre dell'altra, sanno consolarlo e guarirlo con la loro arte: Luciana e Tarsiana. 8. Apollonia, dopo aver sfidato le ire di Antioco, per aver risolto l'enigma che ne celava il rapporto incestuoso con la figlia41, ed essere stato quindi costretto a fuggire, fa naufra gio. Unico sopravvissuto, riesce a raggiungere la riva, a Pen tapoli. Ha perso tutto. Ospite del re che riconosce sotto l'apparenza malridotta la nobiltà di Apollonia, egli mostra tutta la sua pena. La principessa Luciana lo rimprovera , ricordandogli i suoi doveri di nobile: 168 «Amigo, dixo ella, façes grant couardfa non te saber conponer entre tal compannya. Semeia que non amas gozo nin alegrfa; tenémostelo todos a muy gran villania. 169 Si lo fazes por pérdida que te es auenida, si de linage eres, tarde se te oluida,
no
4· TARSIA:-.IA, :-.IOBILE GIULLARESSA
es toda tu bondat en fallencia cayda, pocol' mienbra al bueno de la cosa perdida. 170
Todos dizen que eres omne bien ensenyado, veyo que es el rey de ti mucho pagado; el tu buen continente que hauìas mostrado con esta gran tristeza todo lo as afollado.
(«Amico», disse lei, «commetti una gran viltà, l poiché non ti sai comportare in tale compagnia. l Pare che non apprezzi né allegria, né gioia: l a tutti ciò sembra una grande villania. ll Se fai così a causa di una perdita subita, l e se appartieni a un lignaggio, trop po tardi dimentichi; l tutta la tua nobiltà è caduta in errore, l il nobile poco si cura di ciò che è perduto. Il Tutti dicono che sei un uomo di nobili maniere, l ben vedo che il re è contento di averti qui; l il bel modo di fare che avevi mostrato, l ora è tutto guastato da questa grande tristezza.) Le parole di Luciana, che collegano la tristezza alla villania,
l'alegria alla nobiltà, rinnovano la sofferenza di Apollonia, che narra tra lacrime e sospiri ciò che gli era accaduto. Ed è proprio il re Arcitraste, in modo simmetrico e contrario ad Antioco nel primo episodio, a chiedere alla principessa di consolare l'ospite straniero, di restituirgli la gioia perduta, senza esitare: v6s me pensat d'él si a mi bien queredes. ll
Fiziéstelo llorrar, auédeslo contristado, l pensa! como lo torne des a/egre e pagado (prendetevi cura di lui, se mi amate. Il Lo avete fatto intristire e piangere, l pensate a come render lo di nuovo allegro e soddisfatto, 176d e 177ab). Luciana si prepara per quella che sarà una gara raffinata, preludio all'innamoramento: accorda il suo strumento, poi lascia cadere il mantello, e inizia a suonare, strappando esclamazio ni di stupore e di meraviglia: Los altos e los baxos, todos
della diziàn. l La duenya e la viuela tan bien se abinién l que lo tenién ha /azannya quantos que lo vehién (Tutti facevano commenti su di lei. l La principessa e la viola erano tutt'u no, l chi lo vedeva pensava a una meraviglia, 18oabc) . Apollonia, clérigo entendido+3, afferma che la fanciulla non si deve considerare ancora maestra complida (maestra III
FIGURE FE.\1:\U:-;IU DEL SAPERE
perfetta, 183d) e dichiara di poterla superare con la sua arte; a sua volta si esibisce, non senza prima aver chiesto una corona: dixo que sin corona non sabrié violat; l non quertà, maguer pobre, su dignidat baxar ( disse che non avrebbe potuto suonare senza corona, l non voleva, benché povero, sminuire la sua dignità, 18 5cd) . Apollonia non dimentica di essere re, ha un forte senso del lignaggio e delle gerarchie e neanche per un momento vuole essere scambiato per un volgare musicante da poco44. Poco prima, a tavola, per la stessa ragione non si era voluto sedere accanto a nessuno degli altri giovani, per non rinunciare al suo diritto di re:
Apolonio non quiso con ninguno posat; l mandasse, en su cabo, hun escanyo ponet; l de derecho del rey non se quiso toller (Apollonia non volle stare vicino a nessuno, l chiese di sedere per conto proprio: l non volle rinunciare ai diritti del re, 159abc) . Attraverso la musica e il recupero simbolico della regali tà perduta, lentamente la tristezza di Apollonia passa: /ue de la tristeza ya quanto amansando (187b). L'arte di Luciana e la sua persona riescono a guarire il re triste. Alla musica come terapia, si intreccia qui il motivo della musica che infiamma d'amore. Luciana si innamora di Apollonia quando lo ascol ta suonare e cantare, un innamoramento repentino e intenso, sottolineato dall'imbarazzo della dama, dalla sua gioia, da una profonda emozione: 188 Alç6 contra la duenya vn poquiello el çeio, fue ella de vergiienza presa hun poquelleio. Fue trayendo el arguo egual e muy pareio, abés cabié la duenya de gozo en su pelleio. 189 Fue leuantando hunos tan dulçes sones, doblas e debayladas, temblantes semitones. A todos alegraua la boz los corazones; fue la duenya toquada de malos aguigones. (Alzò lievemente il viso verso la dama, l lei si sentì un po' colta da vergogna; l egli muoveva l'arco in modo costante, l e la giovane provava una gioia incontenibile. ll Produsse dei suoni così dolci, l
112
4· TARSIA:-.IA, :-.IOBILE GIULLARESSA
accordi e variazioni, vibranti semitoni. l La sua voce rallegrava a tutti il cuore: l la dama ne venne toccata profondamente.) Apollonia diventerà il maestro di musica di Luciana, e tanto arde in lei l'amore, che finisce in un letto, ammalata: Tanto
/ue en ella el amor ençendiendo l /asta que cay6 en el lecho muy des/laquida (197cd) . Motivo letterario ampiamente diffu so nell' antichità classica, e poi ripreso nel Medioevo, la malattia d'amore veniva considerata dai trattatisti medici come un disturbo apparentato alla malinconia. L'amore è una passione che consuma il corpo, quando non è ricambia ta, e i medici sono completamente impotenti. La guarigione è legata al soddisfacimento del desiderio, l'unione con l'esse re amato. TI poeta arabo di Spagna Ibn Hazm scrive nel suo trattato Il collare della Colomba (XI secolo) : L'amore, che Dio ti esalti, è una malattia ribelle, che ha la sua cura in se stessa, secondo come uno la tratta: è una dolce infermità e una malattia agognata, in cui chi ne è malato non vuol guarire, e chi ne è infermo non desidera riaversi; essa rende bello all'uomo ciò da cui prima ripugnava, e facile quel che gli era difficile, al punto da mutare il carattere e l'innata natura+S. Gli esempi letterari sono infiniti. Basti pensare a Eco e Nar ciso nelle Metamorfosi di Ovidio (III, 339- 510) : Eco si consu ma per Narciso, che a sua volta viene divorato dalla passio ne per la propria immagine. Nella versione medievale (XII secolo) , Amore è una forza terribile , piena di rage, una malattia che sconvolge e può essere monale: Amors est rage et derverie Ki toute gent enserre et lie. Amors escaufe, Amors esprent, Amors deçoit, tra1st et ment. Amors ocit, Amors destraint, Amors noircist viaire et taint, Amors atrait, Amors enlace, Amors met gent en fole trace, Amors les fait tant cevaucier
113
FIGURE FE.\1:\Il:-\IU DEL SAPERE
Qu'il n'ont rnes voie ne sentier. (vv. 161-170) (Amore è furore e follia l che prende e lega ogni persona. l Amore brucia, Amore infiamma, l Amore inganna, tradisce e mente. l Amore uccide, Amore stringe, l Amore oscura il viso e lo sbianca, l Amore attrae, Amore allaccia, l Amore su folle traccia li mette, l Amore li fa tanto cavalcare l che smarriscono la loro via.)46 Nel lai di Maria di Francia Guigemar, il cavaliere è ferito due volte, alla gamba e al cuore, e solo la sua dama lo può guarire: Mes ki ne mustre s' enferté, A peine en peot aveir santé. Arnur est plaie dedenz cors E si ne piert n1ent defors. [. . .] Arnur li dune hardernent, Il li descovre sun talent: «Darne, fet il, jeo rneorc pur vus ! Mis quors en est rnut anguissus: Si vus ne me volez guarir, Dune m' estuet il en fin rnurir. J o vus requeor de driierie: Bele, ne rn'escundites mie! » (vv. 481-484 e vv. 499-504) (Ma chi non rivela la propria malattia, l difficilmente riesce a gua rire. l Amore è una ferita interiore l e nulla traspare esternamente. [ . . ] l Amore gli dà coraggio, l ed egli le rivela i suoi sentimenti: l «Signora, le dice, io muoio per voi ! l Il mio cuore è pieno d'ango scia: l se non volete guarirmi, l dovrò allora morire. l Vi chiedo di amarmi: l bella, non opponetemi un rifiuto ! »)47 .
Sospiri, pallore, tremore in tutto il corpo, accelerazione del polso in presenza dell'essere amato, angoscia, un sentirsi morire: questi i sintomi della malattia d'amore. Amore, che cattura l'anima e la tiene prigioniera, senza !asciarle un atti-
4· TARSIA:-.IA, :-.IOBILE GIULLARESSA
mo di respiro, come leggiamo in un altro capolavoro della letteratura medievale, Flamenca: Amors es mals ques al cor te E ten l'arma presa e dausa que nom pot aver nulla pausa; e, quan que pense ni sai ni lai, ades en un luec si retrai et ades engalmen tormenta e non es ora c' om no.I senta; et autre mal an qualques ora de repausar, tart o abora+8. (vv. 3006-3014) (L'amore è una malattia che colpisce il cuore, l e tiene l'anima pri gioniera e costretta l senza tregua; l e per quanto si sforzi di pen sare ad altro, l sempre la riconduce allo stesso oggetto, l e sempre la tormenta e con la stessa intensità, l e non c'è momento in cui non soffra; l le altre malattie lasciano qualche ora l di sollievo, prima o poi.)
Nell'Apolonio i medici accorsi al capezzale di Luciana nulla possono per sconfiggere la malattia: mas non hi /allaron nin guna maestria l nin arte por que pudiesen purgar la maletia (ma non trovarono nessuna tecnica, l né arte con la quale sconfiggere la malattia, 198cd) . Tutti temono per la sua vita. Luciana guarirà solo quando il re suo padre le concederà di sposare Apollonia: Luego /ue abaxando a la duenya el mal (Poi la malattia della signora si placò via via, 239d) . 9· Molti anni sono passati. La perdita della sposa e della figlia, entrambe credute morte, hanno fatto lentamente spro fondare Apollonia nella tristezza più cupa: sienpre fue en tri
stiçia hi en vida lazdrada; l siempre tray6 de ldgrimas la cara remojada (Sempre fu triste e sofferente, l sempre il suo volto era bagnato di lacrime, 326bc) . Dalla morte di Luciana il re si era come trasformato, aveva dimenticato tutta la sua corte sia ed era irriconoscibile: Los sus dichos corteses auiyalos ya oluidados. l Fazzànse desta cosa mucho marauyllados (l suoi
115
FIGURE FE.\1:-JI:-;ru DEL SAPERE
modi tanto cortesi, li aveva dimenticati, l e questo suscitava grande meraviglia, 3 3ocd) ; De toda tu /azienda te veyemos
camiado; l abés te connoscemos, tanto eres demudado; l ale grarte non puedes, andas triste e pesado (In tutto il tuo essere ci sembri cambiato, l quasi non ti riconosciamo, tanto sei diverso; l non puoi rallegrarti, sei triste e pieno di dolore, 333abc) . Dopo aver vagato a lungo, Apollonia decide di tornare a Tiro, per morire ed essere sepolto tra i suoi parenti. A metà del viaggio, il mare in tempesta lo costringe con i suoi com pagni ad approdare a Mitilene. Apollonia, che non vuole più vivere, si rifugia nell'angolo più buio della nave: En cabo de
la naue en hun renc6n destaiado, l ech6sse en hun lecho el rey tan deserrado (Nel fondo della nave, in un angolo appartato, l si gettò in un letto, il re tanto triste, 46oab) . Con il cuore
attraversato dal dolore, non vuole più bere né mangiare, è ormai freddo e insensibile a tutto, come fosse già morto: 479 Mas ss6 por mis pecados de tal guisa llagado que el corac6n me siento todo atrauesado; desque beuir non puedo e s6 de todo desfriado de cielo nin de tierra veyer non é cuydado. (Ma sono ferito così tanto dalle mie sciagure, l che me ne sento attraversato tutto il cuore: l non riesco a vivere, mi sento del tutto freddo, l non m'importa di vedere né cielo, né terra.) Apollonia è ammalato di troppo dolore: come in una scena di teatro dalle tinte cupe, sepolcrali, il re , in penombra, rimane muto e ostinato nella sua decisione di morte lenta. Ha proibito a tutti di rivolgergli la parola, pena un'assurda punizione: 466 Menazados nos a que aquell que li fablare, de corner nin de beuer nada le ementare, perdera el hun pie de los dos que leuare, por auentura amos, si mucho lo porfiare. (Ci ha minacciati che colui che gli parlasse, l gli menzionasse qual116
4· TARSIA:-.IA, :-.IOBILE GIULLARESSA
cosa da bere o da mangiare, l perderebbe subito uno dei due piedi l e persino tutti e due, se insistesse oltre.) I compagni di Apollonia raccontano ad Antinagora, principe della città, salito sulla nave a ricevere gli stranieri, che il nobile re Apollonia, uomo di lettere più che d'armi, modello di generosità e cortesia, non esiste più; egli è ammalato di malinconia e regredito a uno stato quasi animalesco, primor diale. L'uomo che Antinagora si trova davanti gli sembra vil lano e senza cuore: dezirle he que me semeia villano descoraz nado (468d). La lunga barba che gli ricade sul petto, segno di dolore e di lutto, è anche misura della sua crudeltà: Violo con fiera barba que los pechos le cobrié (lo vide, la barba incolta che copriva il petto, 469c) , dove fiera significa feroce, terribile, e rinvia a uno stato di animalità primitiva. Antina gora rimprovera Apollonia per il silenzio privo di cortesia con cui viene ricevuto: Apolonio, mal te sabes guardar; l deu yéste de otra guisa contra mi mesurar (Apollonia, non cono sci le maniere: l dovresti comportarti diversamente nei miei confronti, 472cd) e lo invita a uscire dall'oscurità della nave, come da quella in cui è immersa la sua anima: saldriés desta tiniebra (usciresti da questa tenebra, 476b) ; perderds esta tri stiçia e esta crueldat (perderai questa tristezza e questi crudi modi, 477d) . Tiniebra, tristiçia e crueldat, in opposizione alla luce della vita e della alegria, sono le parole chiave che caratterizzano questa parte importante dell'Apolonio. Antinagora, per aiutare Apollonia e guarirlo dalla malin conia, manda a chiamare Tarsiana, la cui arte è vitale e piace vole, quasi taumaturgica; essa viene ricevuta con grande rispetto per il suo sapere, la maestria: la maestria vuestra tan gran e tan conplida l agora es la ora de seyer aparesçida (la vostra grande, eccellente maestria l ora è il momento di manifestarla, 486cd) . Poco prima Antinagora aveva osservato: 483 En la çibdat auemos huna tal juglaresa - furtada la ouieron -, enbiaré por éssa. Si ella non le saca del coraçon la quexa, a null omne del mundo nol' fagades promesa.
117
FIGURE FE.\1:\U:-;IU DEL SAPERE
(In città abbiamo una certa giullaressa, l una che è stata rapita, la manderò a chiamare; l se lei non gli toglierà il dolore dal cuore, l nessun altro ci riuscirà.) Nessun altro, quindi, sarebbe stato in grado di distogliere Apollonia dal suo isolamento taciturno e melanconico, pro prio come Apollonia era stato l'unico a poter sciogliere, con la sua maestria, l'enigma di Antioco. Dopo avergli racconta to la sua storia e le sue nobili origini, Tarsiana lo invita a mutare le proprie intenzioni, e lei lo potrà guarire:
494 E tu, si desta guisa te dexares morir, siempre de tu maliçia auremos que dezir, Camya esta posada si cobdiçias beuir; io te daré guarido si quisieres ende sallir. (E tu, se ti lasciassi morire così, l sempre si parlerà della tua cru deltà; l cambia i tuoi modi, se vuoi vivere, l e se vuoi uscirne, io ti curerò.) Se la musica e il canto falliscono, gli indovinelli49 conducono all'agnizione , con un primo recupero della parola, e poi creando la tensione necessaria al reciproco svelamento. Negli indovinelli che Tarsiana, maestra complida (3 52b) , propone ad Apollonia vi è un gioco alla pari tra due intelligenze che si misurano, allo stesso livello, «comme si une seule intelligence se contemplait dans un miroir»s0• Quando Tarsiana propone ad Apollonia gli indovinelli, lo lega a sé con un'astuzia: accetterà l'oro del re solo se egli riuscirà a rispondere alle sue demandas (503). Gli indovinelli che Tarsiana rivolge ad Apol lonia riguardano l 'identità di questi, sono evocativi di momenti della sua vita e si riferiscono in sei casi su nove all'acqua e al mare, che fa da sfondo simbolico e quasi perso nificato a tutta la vicendas1 • La reale soluzione di questi indo vinelli non è ovviamente quella specifica di ognuno di essi, ma quella finale, riguardante l'identità di Apollonia e di Tar siana. TI nome di Apollonia non era segreto e Antinagora, udendolo, aveva riflettuto così: Como yo creyo, si non ss6 tra stornado l tal nombre suele Tarsiana auer mucho vsado (Mi n8
4· TARSIA:-.IA, :-.IOBILE GIULLARESSA
pare, se non mi sbaglio, l che Tarsiana abbia fatto spesso questo nome, 468ab) . In questo incontro, in cui nessuno conosce apparentemente l'identità dell'altro, poiché nessuno dei due si rivela, vi è un lento avvicinamento e riconoscimen to reciproco nell'arte: entiendo bien que vienes de linatge gra nada, l ouiste en tu dotrina maestro bien letrado (si capisce bene che sei di lignaggio illustre, l hai avuto per la tua arte un buon maestro, 496cd) e Tarsiana ad Apollonia: paresçe bien que eres clérigo entendido (è evidente che sei una perso na molto colta, 51ob). Questo riconoscimento viene accelerato dal colpo violento e scortese di Apollonia, gesto che confer ma la perdita di nobiltà di Apollonia, ma che offre a Tarsiana la possibilità di rivelarsi, e ad entrambi di evitare un incesto sempre incombente. Riconoscendosi entrambi si reintegrano socialmente, Apollonia esce dal suo isolamento malinconico e Tarsiana riacquista la sua vera identità. TI sapere di Tarsiana guarisce Apollonia e restituisce al mondo il re saggio che egli era stato. Note 1. Libro de Apolonio, a cura di P. Caraffi, Pratiche, Parma 1991 (rist. Luni, Milano 2001), a seguire abbreviato con: Apolonio. 2. l. Lana, Il posto della cultura nella «Storia di Apollonia re di Tiro», in "Atti dell'Accademia delle Scienze di Torino" , 109, 1975, pp. 393-4.15 e Studi su "Il romanzo di Apollonia re di Tiro", Giappichelli, Torino 1975; cfr. anche M. Mazza, Le avventure del romanzo nell'Occzdente latino. La "Historia Apollonii regis Tyri", in Le trasformazioni della cultura nella tarda antichità, Atti del Convegno tenuto a Catania, 27 sett.-2 ott. 1982, Jouven ce, Roma 1985, II, pp. 597-645. 3. Per una bibliografia dettagliata sulla clerecia e sul Libro de Apolo nio rimando alla Nota Informativa del Libro de Apolonio, cit ., pp. 28-30. 4· M. Alvar, Apolonio, clérigo entendido, in Symposium in honorem pro/ Martt' de Riquer, in "Quadems Crema", Barcelona 1984. 5· Si veda il cap. I, in questo stesso volume, a pp. 13 ss. 6. A. D. Deyermond , Motivos /olkl6ricos y técnica estructural en el Libro de Apolonio, in "Filologia ", 13, 1968-69, pp. 121-48. 7· Chrétien de Troyes, Erec e Enide, ed. di P. F. Dembowski, trad. e note di C. Noacco., introd. di F. Zambon, Luni, Milano-Trento 1999. 8. Nezami, Le sette prindpesse, intr. e trad . di A. Bausani, Rizzoli, Milano 1982, p. 211 . 9· lvi, p. 215 .
119
FIGURE FE.'d.'dl:-.:IU DEL SAPERE
IO. J. Huizinga, Homo ludens, il Saggiatore, Milano I983, a p. I58; anche A. Jolles, Forme semplici, Mursia, Milano I98o. IL Per una bella ricostruzione del legame tra enigma, esogamia e incesto a partire dalla versione latina, si veda G. Chiarini, Esogamia e ince sto nella "Historia Apollonii regis Tyri", in "Materiali e discussioni per l'a nalisi dei testi classici", 10-n, 1983, pp. 267-92. I2. T. H. E. White, The taboo o/ Antioch: incest and its consequences in the "Libro de Apolonio", in A. M. Beresford (ed.), "Quien hubiese tal ventura ": Medieval Hispanic Studies in Honour o/ A/an Deyermond,
Department of Hispanic Studies, Queen Mary and Westfield College, London 1997, pp. 57-66. I3. Si veda Caraffi, Introduzione a Libro de Apolonio, cit., e M. Libo rio, La cancellazione delle madri, in Trame parentali. Trame letterarie, a cura di M. Del Sapio Garbero, Liguori Editore, Napoli 2000 , pp. n-22. I4. N. Loraux, Come uccidere tragicamente una donna, Laterza, Roma Bari I988. I5. R. Calasso, Le nozze di Cadmo e Armonia, Adelphi, Milano I988, pp. 329·30. I6. M. Praz, La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica, Sansoni, Firenze I966, in particolare il cap. m: All'insegna del Divin Mar chese, pp. 83-I69. I7. Ivi, p. 98. I8. A. N. Veselovskij, La /avola della fanciulla perseguitata, in A. N. Veselovskij, D. A. F. de Sade, La fanciulla perseguitata, a cura di D'A. S. Avalle, Bompiani, Milano I977, pp. 37· IOI, a p. 40. I9. Sulla reciproca influenza tra agiografia e narrazione, si veda C. Delcorno, Modelli agiografici e modelli narrativi. Tra Cavalca e Boccaccio, in La novella italiana. Atti del Convegno di Caprarola, I�24 settembre Ip88, Salerno Editore, Roma I989, pp. 337-63. 20. RAppresentazione di Santa Uliva, in Sacre rappresentazioni dei seco li xrv; xv e XVI, a cura di A. D'Ancona, Firenze I872; per le versioni popo lari cfr. l Calvino, Fiabe Italiane, Einaudi, Torino I956 (la storia di Uliva compare al n. 7I). 21. C. Casagrande, La donna custodita, in Duby, Perrot, Storia delle donne in Occidente, II: Il Medioevo, cit., pp . 88-128 e, a cura della stessa autrice, Prediche alle donne del secolo XIII, Bompiani, Milano I978. 22. Cito da Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales, ed. a cura di L. D. Benson, Boston I987, Oxford 1988 e riprodotta a fronte in Geoffrey Chaucer, Opere, a cura di P. Boitani, Einaudi, Torino 2000, 2 voll. 23. Geoffrey Chaucer, I racconti di Canterbury, intr. e note di A. Brilli, trad. di C. Chiarini e C. Foligno, Rizzoli, Milano 1978, pp. I37-38. 24· !vi, p. I42. 25. C. Segre, Comicità strutturale nella novella di Alatiel, in Le strutture e il tempo, Einaudi, Torino I974, pp. I54-9; l'analisi di Segre offre, tra l'altro, un ampio resoconto delle varie interpretazioni dell'Alatiel, a cui rimando. 26. Giovanni Boccaccio, Decameron, a cura di V. Branca, Einaudi, Torino I98o, p. 257.
120
4- TARSIA�•M, �OBILE GIULLARESSA
27. Si veda il CAP. 1 in questo stesso volume, pp. 18-19. 28. G. Mazzacurati, AkJtiel ovvero gli alibi del desiderio, in Forma e ideologia, Liguori, Napoli 1974, pp. 25-65. 29. San Paolo, Le Lettere, a cura di C. Carena, con uno scritto di M. Luzi, Einaudi, Torino 1999. Si veda M. Alexandre, Immagini di donne ai primi tempi del/4 cristianità, in G. Duby, M. Perrot, Storia delle donne in Occidente, I: L'Antichità, a cura di P. Schmitt Pantel, Laterza, Roma-Bari 1990, pp. 465-513. 30. J. C. Musgrave, Tarsiana and ]ugkJria in the "Libro de Apolonio", in Medieval Hispanic Studies presented to Rita Hamilton, edited by A. Deyer mond, Tamesis, London 1976, pp. 129-38; D. Devoto, Dos notas sobre el "Libro de Apofonia", in "Bulletin Hispanique", 74, 1972, pp. 292-330. 31. C. Frugon� LA donna nelle immagim; 14 donna immaginata, in Sto ria delle donne in Occidente, voi n, Il Medioevo, cit., pp. 424-57; si veda anche V. Gigante Lanzara, Il segreto delle sirene, Bibliopolis, Napoli 1986 e C. Grossinger, Picturing Women in LAte Medieval and Renaissance Art, Manchester University Press, Manchester-New York 1997. 32. M. E. Lacarra, Amor, musica y mekJncolia en el "Libro de Apolo nio", in Actas del I Congreso de 14 Asociaci6n Hispdnica de Literatura medieval, Santiago de Compostela, 2-6 diciembre 1985, PPt:, Barcelona 1988, pp. 369-79· 33· Sulla teoria degli umori e la malinconia, rimando a R. Klibansky, E. Panofsky. F. Saxl, Saturno e 14 malinconia, Einaudi, Torino 1983; si veda anche LA Malinconia nel Medioevo e nel Rinascimento, a cura di A. Brilli, Quattro Venti, Urbino 1982. 34· Aristotele, LA "melanconia" dell'uomo di genio, a cura di C. Ange lino ed E. Salvaneschi, Il Melangolo, Genova 1981, pp. 11 e 27: «Perché tutti gli uomini eccezionali, nell'attività filosofica o politica, artistica o let teraria, hanno un temperamento mekJnconico - ovvero atrabiliare - alcuni a tal punto da essere persino affetti dagli stati patologici che ne deriva no? . . essendo diversa l'azione dell'atrabile, che può essere assai fredda e assai calda, diversi sono anche gli atrabiliari; . . . proprio in virtù del suo eccesso, tutti gli atrabiliari - i "melanconici" - sono persone eccezionali non per malattia ma per natura)), 35· Cfr. in proposito il bel saggio di M. Galzigna, L'enigma della malinconia. Materiali per una storia, in "Aut-Aut" , 195-196, 1983, pp. 75-97. 36. Ne parlava Robert Burton in Anatomy o/ Melancholy (1621); cfr. per questo R. Burton, Anatomia del/4 Malinconia, a cura di J. Starobinski, Venezia, Marsilio 1983 e Malinconia d'Amore, a cura di A. Brilli e F. Marucci, Rizzoli, Milano 1981. 37· J. Kristeva, Sole Nero. Depressione e mekJnconia, Feltrinelli, Mila no 1988. 38. Alcune delle numerose versioni francesi sono raccolte nd volume Le Roman d'Apollonius de Tyr, édition, traduction et présentation de M. Zink, 10/r8, Paris 1982; per una storia delle versioni e rimaneggiamenti in area francese, si può vedere M. Delbouille, Apollonius de Tyr et !es débuts du roman /rançais, in MékJnges ol/erts à Rita Lejeune, Duculot, Gembloux 1969, t. n, pp. U7-204·
121
FIGURE FE.'d.'dl:-.:IU DEL SAPERE
39· Juan de Timoneda, El Patranuelo, edici6n de R. Ferreres, Castalia, Madrid I97I. I numeri tra parentesi si riferiscono alle pagine corrispon denti di questa edizione. 40. W. Shakespeare, Pericles, Prince o/ Tyre, a cura di G . Melchiori, Mondadori, Milano I987, Atto v, Scena I. 41. lvi, Atto I, Scena II. 41. c . c. Phipps, El incesto, UJS adivinanZtJS y kJ musica: disenos de kJ geminaci6n en el "Libro de Apolonio", in "El Crotal6n. Anuario de Filolo gia Espaiiola", I, I984, pp. 8o7-I8. 43· Sulla clerecia di Apollonia si vedano M. Alvar, Apolonio, clérigo entendido, cit.; F. Rico, La clereda del mester, in "Hispanic Review", 53, I98s, pp. I · 13 e pp. 117-so. In particolare su questo episodio, C. Alvar, De Apolo a Orfeo. A proposito del "Libro de Apolonio", in "Vox Romanica", 48. I989, pp. I6S·71. 44· D. Devoto, Dos notas sobre el Libro de Apolonio, in " Bulletin Hispanique", 74, I971, pp. 191-330. 4S· Ibn Hazm, Il colkJre del/4 colomba, a cura di F. Gabrieli, ES, Milano I996, p. 14 (I• ed. Laterza, Bari I949). 46. Il "kJi" di Narciso, a cura di M. Mancini, Pratiche, Parma I989. 47· Maria di Francia, Lais, a cura di G. Angeli, Pratiche, Parma I991. 48. FkJmenca, texte établi, traduit et présenté par J. C. Huchet, 101!8, Paris I988. 49· D. Clark, Tarsiana riddle's in the "Libro de Apofonie/', in Medieval Hispanic Studies presented to Rita Hamilton, cit., pp. 31-43. so. M. Zink, Introduzione a Le roman d'Apollonius de Tyr, 101!8, Paris I981, pp. I3-61, a p. 18. SI. V. Marmo, Il "Libro de Apolonio": note di sintassi e di semantica testuale, in "Annali dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli" , 31, 1990, pp. 53·97·
122
5
Christine de Pizan e Boccaccio: silenzio e crudeltà
1.
Nella complessa e sapiente architettura della Cité des Dames, è stata studiata ormai da tempo l'importante influen za di Boccaccio, sia del Decameron che del De Mulieribus Claris1• Boccaccio, che influenza anche nella struttura l'opera - se si pensa la Cité des Dames come una raccolta di raccon ti inseriti in una novella a cornice secondo il modello orien tale1 - è citato varie volte: Bocace l'italien, Ci dit Bocace, o più semplicemente Bocace3 . Per quanto riguarda le novelle riprese dal Decameron, l'autrice nomina esplicitamente oltre che l'autore, anche l'opera: Bocace raconte en son Livre de
Cent Nouvelles - Bocace raconte ou Livre de cent Nouvelles compte Bocace ou Livre de Cent Nouvelles Christine cita con tinuamente Boccaccio, come se ne riconoscesse l'autorità, che invece nega attraverso la riscrittura degli stessi racconti4. In questa straordinaria opera di riscrittura, di costruzione, oltre che della Città, di una nuova tradizione e di una genea logia femminiles, Christine obbedisce ad un principio di selezione delle novelle, verso quelle che meglio si adattano al suo discorso. Dal Decameron sceglie solo tre novelle: Bernabò da Genova, II, 9 ; Tancredz: prenze di Salerno, IV, 1; I fratelli del l'Isabetta, IV, s; a queste bisogna aggiungere un'allusione alla novella di Guglielmo Rossiglione e Guglielmo Guardastagno (IV, 9 ) , che si risolve in D'une autre raconte Bocace a qui son
mari /ist menger le cuer de son ami qui oncques puis ne men gia (Boccaccio racconta di un'altra dama, a cui il marito fece mangiare il cuore del suo amico, e che poi non mangiò mai più, Città 6, II, LX, pp. 402-3) e la novella di Griselda (X, m) che Christine conosce dalla versione di Petrarca (Seniles7, 17, 123
FIGURE FE.\1:-JI:-;ru DEL SAPERE 3) tradotta in francese da Philippe de Mezières, nel Livre de la vertu du sacrement du mariage. Innanzitutto occorre considerare la ricontestualizzazione dei racconti: la novella di Bamabo fa parte della II giornata del Decameron in cui la narratrice racconta delle vicende drammatiche con un lieto fine: . . . nella quale sotto il reggi
mento di Filomena, si ragiona di cht: da diverse cose infestato, sia oltre alla sua speranza riuscito a lieto fineB. Le novelle di Tancredi e di Elisabetta fanno parte della IV giornata del Decameron, con Filostrato come narratore, che ragiona di
coloro li cui amori ebbero infelice fine. Ecco dunque un primo, importante cambiamento: Chri stine inserisce la storia della moglie di Bamabo (Città, n, LTI) in un gruppo di tre racconti, insieme a quello di Griselda (II, L) e di Fiorenza di Roma (II, LI) , dedicati all'esperienza di mogli eroiche, per confutare l'accusa misogina secondo la quale: . . . sur tous les vices que hommes, et mesmement les livres, dient estre en femmes, crient tous d'une voix sur elles que variables et inconstans sont, muables et legieres et de fraisle courage, flechis sans comme enfans, ne qu'il n'y a aucune fermeté. ( . . . gli uomini, così come i libri, sono tutti d'accordo nel dire che sopra tutti gli altri vizi le donne sono volubili e incostanti, mutevo li e leggere, di fragile temperamento, accondiscendenti come bam bini, e senza nessuna forza, Città, II, XLVII, pp. 334-5) Nella Città le storie di Ghismonda e di Lisabetta fanno parte di un gruppo di racconti su donne fedeli in amore anche fino alla morte - nell'ordine Didone, Medea, Tisbe, Ero, Sigismonda, Elisabetta, la dama di Fayel, la castellana di Vergy, Isotta e Deianira -, per controbattere l'accusa misogina che le donne in amore: . . . quoy que elles promettent y sont moult pou arrestees en un lieu et de pou d' amour et a merveilles faulses et faintes, et que tout ce leur vient de la legiereté de leur courage.
124
S· CHRISTI:\E DE PIZA:\ E BOCCACCIO: SILE�•JZIO E CRt:DELTA
( . . . per quanto facciano promesse, sono incostanti, poco innamo rate, false e bugiarde, e che tutto questo deriva dal loro carattere leggero, Città, n, LIV, pp. 376-7) Tutti questi racconti fanno parte del II libro, dove è Rettitu dine che parla, il che presuppone una continuità discorsiva meditata, intorno ad alcuni motivi fondamentali e in nome di un cambio di genere della scrittura, da maschile a femmi nile9: a) la tirannia patriarcale, principale causa degli eventi e la crudeltà degli uomini che la rappresentano, anche se cer tamente è importante sottolineare che non si tratta di tutti gli uomini; lo smembramento del corpo maschile, e in altri racconti di quello femminile, è espressione di questa tiran nia; b) il troppo amare (trop amer) delle donne - amore-pas sione che conduce a volte alla morte, senza incostanza né capriccio (sanz varier) - e la forza straordinaria della figura femminile, sempre al centro del racconto e silenziosa, o per meglio dire nell'impossibilità di parlare. Inoltre bisogna considerare che tutti e tre questi intrecci dovevano essere molto noti al pubblico; infatti essi apparten gono a due gruppi di racconti di grande diffusione: La /emme de Bernabo al ciclo della gageure, analizzato con particolare attenzione dagli studiosi di letteratura ingle se, per via della versione shakesperiana - il Cymbeline - e così definito da Gaston Paris, che classificò le numerose ver sioni nella prima delle sue lezioni al "Collège de France" dedicate ai romans d'aventures, lavoro poi pubblicato sulla rivista "Romania" nel 190310• Gaston Paris dimostra l'enorme diffusione di questo racconto in cantari, miracles, poemi, ballate, romanzi, per esempio il Comte de Poitiers (fine XII secolo) o il Guillaume de Dole o Roman de la Rose di Jean Renart (inizi XIII secolo) . I racconti di Ghismonda e di Elisabetta, anche se con sfumature diverse, possono essere inclusi nel grande ciclo del "cuore mangiato "11, storie intorno al cuore dell'amante ucciso, offerto in dono o come pasto. La connessione stretta con questo motivo è confermata dai riferimenti alle storie di Guglielmo Rossiglione e Guglielmo Guardastagno e alla
125
FIGURE FE.\1�11:-;IU DEL SAPERE Dama di Fayel, che rinviano a loro volta al Roman du Caste
lain de Coucy et de la dame de Fayel12• Christine sceglie alcune storie notissime al pubblico a lei contemporaneo, di forte carica emozionale, perché il suo discorso sia più efficace: vuole dimostrare le conseguenze di una società dalle rigide regole patriarcali , tiranniche e crude li, in cui una donna, sottomessa alle leggi di parentela, diventa merce di scambio senza alcun diritto di parola13. È all'interno di questa costellazione che diventa pericoloso e fole (non per scrupoli di tipo religioso o moraleggiante, ma perché si rischia la vita) abbandonarsi alle dolcezze di un amore teneramente condiviso: non esiste questa libertà, né all'interno della società cortese, né al di fuori di essa. 2. Comprendiamo meglio il racconto della moglie di Barna bo se lo leggiamo in parallelo con quello di G riselda. Il senso della storia di Griselda nella Cité des Dames (II, L) va cercato proprio in quel rovesciamento di una figura lettera ria che piaceva così tanto al pubblico14 exemplum in Boc caccio e poi in Petrarca e in molti altri della costanza, della pazienza muliebre a fronte delle umiliazioni più feroci , insomma della "brava moglie" - per mostrare esattamente il punto di vista opposto, quello femminile: fino a che punto può giungere la crudeltà. La contestualizzazione delle storie di Griselda, di Fiorenza e della moglie di Barnabo è per questo molto significativa: esse sono tutte vittime di mariti capricciosi, superficiali e violenti, e le loro storie vengono raccontate subito dopo la descrizione della crudeltà insensa ta di alcuni imperatori, assassini e torturatori (II, 48 e II, 49) . L'associazione tra questi mariti, Nerone, stupratore e assassi no della propria madre, e Gaiba, incredibilmente crudele (cruel sans mesure, p. 342) , è immediata. Barnabo, in particolare, si fa ingannare da una calunnia, da una parola falsa e non esita, come sappiamo, a condanna re a morte la propria moglie, senza neanche darle la possibi lità di parlare. Egli è definito fol (non d'amore, ma di rab bia) , beste, e degno di morire allo stesso modo: vous estes digne de mort, car vous n 'aviés mie preuve souffisant (voi -
126
S· CHRISTI:\E DE PIZA:\ E BOCCACCIO: SILE�ZIO E CRt:DELTA
siete degno di morte, poiché non avevate prove sufficienti, pp. 368-9) . Nel racconto di Ghismonda, che deve l a sua grande dif fusione a quella che Guido Almansi definisce una "fascinosa ambiguità"1s, la parte dell'anziano marito geloso del triango lo cortese tocca a Tan credi - di cui viene sottolineata l'età avanzata, si parla di viellece (vecchiaia, p. 392), envie/li (invecchiato, p. 394) e vieillart (vecchio, p. 398). Egli è ecces sivamente legato alla figlia di un amore che non è quello di un padre (/ole amour, p. 392) , non le dà un nuovo marito e per questo è responsabile degli avvenimenti. Definito da Ghismonda cruel pere (padre crudele, p. 396) , Tancredi è paragonato a un serpente: Tu ressembles un serpent qui occist l'omme et puis le pleure (Sembri un serpente che prima ucci de e poi piange la sua vittima, Città, II, LIX, pp. 398-9). Crudeli (crueulz /reres, p. 402) sono anche i fratelli di Lisabetta, e Pasolini16 ha saputo cogliere molto bene questa loro crudeltà sadica, alla quale oppone l'impotenza della fan ciulla, e il suo doloroso e assoluto silenzio. Essi hanno la stessa responsabilità di Tancredi e la causa è l'avarizia: Derechef compte Bocace ou Livre des Cent Nouvelles que en la cité de Messine en Ytalie ot une jeune fille nommee Lisabeth, laquelle .iij. freres que elle avoit par leur escharceté, retardoient de la marier. (Boccaccio racconta nel Decameron anche di una giovane che si chiamava Elisabetta e viveva in Italia, nella città di Messina. I suoi tre fratelli per avarizia tardavano a maritarla. Città, II, 6o, pp. 398-9) L'elemento materiale riemerge alla fine del racconto, quando Lisabetta, pur di riavere il vaso di basilico, che i fratelli le avevano sottratto, offre loro ma inutilmente, la sua parte di proprietà: Et pour toute grace requeroit que rendu lui fust et que elle leur quittoit, mais que elle le reust, sa part de tous autres biens. (Supplicò i fratelli di restituirglielo, promettendo loro di rinunciare 127
FIGURE FE.\1:\II:-;ru DEL SAPERE alla sua parte di proprietà, ma che lei lo potesse avere indietro, Città, II, LX, pp. 403·4) 3· Lo smembramento del corpo dell'amato sottolinea la crudeltà maschile. Tancredi, folle di gelosia, attraverso l'e strazione del cuore di Guiscardo esprime un desiderio di castrazione del giovane di cui si sente rivale:
Le marchis se parti a tant de Sismonde, mais non pas pour ce appaysié vers Guiscart, ains le lendemain le fist occire. Et com manda que le cuer du ventre lui fust esrachez, lequel cuer le pere mis t en une couppe d'or, et par un sien secret message l' envoya a sa fille et lui manda que il lui envoyoit ce present pour lui faire joye de la riens que elle plus amoit, ainsi que elle l'avoit fai t joyeux de la riens que il plus tenoit chere. (Allora il marchese lasciò Sigismonda, certo non ammansito nei confronti di Guiscardo, anzi, il giorno dopo lo fece uccidere e ordinò di strappargli il cuore dal petto. Poi fece mettere il cuore in una coppa d'oro e lo fece portare alla figlia da un uomo di fiducia, con un messaggio: le inviava questo dono per recarle gioia con ciò che lei più amava, così come lei l'aveva reso felice in ciò che più aveva caro, Città, II, LIX, pp. 396-7) In una versione più antica del racconto del cuore mangiato,
il Lai d'Ignaurè7 (inizi del XIII sec.) , pur con una forte com ponente parodica, dodici mariti gelosi uccidono il bel cava liere lgnaure, e offrono alle loro mogli come pietanza preli bata il cuore e il membro di colui che era stato l'amante di tutte loro: Che dist li uns: "Les ordes gloutes Ont creantet a juner toutes Duske a cele eure c' on sara S'il ert mors u eschapera. Au quart jor prendons le vassal Tout le daerrain membre aval Dont li delis lor soloit plaire, si en fache on un mangier faire;
128
S· CHRISTI:-;E DE PIZA:-; E BOCCACCIO: SILE:-JZIO E CRL"DELTÀ
le cuer avoec nous meterons. Douse escueides en ferons, par engien, lor faisons mangier, car nous n' en poons mius vengier! " (vv. 537-548) (Così disse uno: "Le sozze ingorde l hanno deciso tutte di digiu nare l fino al momento in cui non sapranno l se egli è morto o se scamperà. l Il quarto giorno prenderemo al vassallo l l'estremo membro inferiore, l da cui erano solite trarre diletto, l ne faremo preparare una vivanda; l vi aggiungeremo poi il cuore. l N e fare mo dodici porzioni, l con l'inganno le facciamo mangiare loro, l poiché miglior vendetta non ne possiamo trarre! ") Si stabilisce così una stretta e atroce relazione tra l'atto del cibarsi e l'atto sessuale. Nella novella di Guglielmo Rossi glione (Dee. , IV, 9) questa relazione è confermata dalle paro le perverse di Guglielmo: Né me ne meraviglio se morto vi è piaciuto ciò che altra cosa più vi piacque (p. s68 ) . Nella Vida provenzale del trovatore Guillem d e Cabe staing, considerata la fonte dei racconti sul cuore mangiato, leggiamo: E quand vene un dia, Raimons de Castd-Roussillon trobet passan Guillem de Cabestaing ses grand compaignia, et aucis lo, et fez li traire lo cor dd cors e fez li taillar la testa, e la testa d cor fez portar en son alberc. Lo cor fez raustir e far a pebrada e fez lo dar a manjar a la moiller8. (E un giorno Raimon de Castd Rossillon trovò Guillem de Cabe staing che passava senza grande scorta, e l'uccise, e gli fece strap pare il cuore dal corpo e gli fece tagliare la testa, e fece portare la testa e il cuore al suo castello. Fece arrostire e condire con pepe il cuore, e lo fece dare da mangiare alla moglie.)
TI cuore è sede del coraggio, dell'anima, ma anche dell'amo re; così nelle parole di Ghismonda: tres doulx cuet; heberge de tous mes plaisirs (dolcissimo cuore, dimora di tutti i miei piaceri, Città, II, LIX, p. 396) . Nella lirica trobadorica il cuore
129
FIGURE FE.\1:\U:-;IU DEL SAPERE è associato indissolubilmente al corpo: cor e cors19. Ed è con le parole di un perfetto amante conese che Guiscardo offre a Ghismonda il suo amore: Si me povez commander, tres chiere dame, tous voz bons plaisirs, sanz nulle doubtance, comme a celui qui cuer et corps offre a obeir a tous voz bons commandemens de toute ma puissance. (Potete comandarmi, carissima dama, in ogni vostro nobile piace re, e senza esitare: per quanto è in mio potere, offro il mio cuore e il mio corpo per obbedire a tutti i vostri ordini, Città, II, LIX, pp. 390-1) E Ghismonda a Tancredi: Certes, trop eust eu le cuer villain de refuser dame de tel parage, si devez suppleer ce meffait sur lui et non pas sur moy. (Certo, troppo si sarebbe dimostrato villano, rifiutando una dama del mio rango. È per questo che dovete risparmiare lui, e non me, pp. 394-5)
È il cuore di Elisabetta, e non Lorenzo apparso in sogno, come in Boccaccio, che le fa intuire l'accaduto: le cuer lui en disoit mal (e in cuor suo aveva un brutto presentimento) et celle, a qui le cuer disoit toute l'a venture (lei, che in cuor suo aveva capito tutto l'accaduto, Città, II, LX, pp. 400-1) . Se lo smembramento dei corpi maschili segna l'atto crude le della vendetta, che sia questa operata da un padre, dai fra telli o da un marito, il cuore e la testa degli amanti diventano oggetti di devozione. Ghismonda lava con le sue lacrime il cuore dell'amato e gli parla dolcemente e a lungo; Lisabetta conserva la testa di Lorenzo in un vaso di basilico, che bagna continuamente con le sue lacrime, fino a morime. A sottoli neare con maggiore enfasi la relazione diretta tiranno-smem bramento, Christine attribuisce ai fratelli la decapitazione di Lorenzo le corps recouvri de terre et prist la teste de son ami que ses /reres avoient tranchee (ricopri di terra il corpo del suo amico e prese solo la testa, che i suoi fratelli avevano tagliato, -
130
S· CHRISTI:\E DE PIZA:\ E BOCCACCIO: SILE�ZIO E CRt:DELTA
Città, II, LX, pp. 400-1)
che in Boccaccio viene invece attua ta dalla fanciulla, con l'aiuto di una fantesca: -
Di che più che altra femina dolorosa, conoscendo che quivi non era da piagnere, se avesse potuto volentier tutto il corpo n'avrebbe portato per dargli più convenevole sepoltura; ma veggendo che ciò esser non poteva, con un coltello il meglio che poté gli spiccò dallo 'mbusto la testa, e quella in un asciugatoio inviluppata, e la terra sopra l'altro corpo gittata, messala in grembo alla fante, senza essere stata da alcun veduta, quindi si diparti e tornossene a casa sua (Decameron, p. 53 0) . Questa immagine ricorda piuttosto l'esempio di Giuditta, di cui Christine parla nella Città (II, XXXI ) , eroina che salva il suo popolo uccidendo Olofeme, e il cui smembramento è autorizzato dal fatto che si tratta di un pericoloso nemico. Christine non avrebbe mai ammesso lo smembramento del corpo dell'amato compiuto dalla sua innamorata. In altri luoghi della Città troviamo esempi dello stesso genere: Artemisia (n, XVI, pp. 262-3) che fa cremare il corpo del marito morto e ne inghiotte le ceneri e Argia (II, XVII) , che cerca il marito sul campo di battaglia e nonostante il suo corpo e il suo volto siano per metà decomposti, lo bacia e lo stringe, senza repulsione né orrore. È possibile che questi racconti di smembramento di corpi maschili siano anticipa tori delle storie delle martiri che Giustizia racconterà nel III libro20: il corpo femminile, centrale in tutta l'opera, diventa corpo smembrato nella violenza del martirio; lo stesso potere tirannico esercitato sul corpo delle martiri, e legato quasi sempre a un desiderio sessuale frustrato del tiranno verso la sua vittima, viene associato a quello che si abbatte sul corpo maschile degli amanti. In particolare , Tancredi, che si sente rifiutato, usa il cuore strappato dal corpo dell'amante della figlia per procurarle una vera e propria tortura emozionale.
4· Christine colloca al centro del racconto il personaggio femminile, a cominciare dalla rubrica di ogni racconto: LII. De la /emme Bernabo le Genevois (Storia della moglie di Bamabo il Genovese) ; LIX De Sismonde, /ille du prince de .
131
FIGURE FE.\1:-JI:-;ru DEL SAPERE Salerne (Storia di Sigismonda, figlia del principe di Salerno); LX. Cy dit de Lisabet et d'autres amantes (Storia di Elisabetta e di altre donne innamorate)21• La narrazione enfatizza mag giormente l'autonomia femminile, e lascia cadere completa mente quegli elementi più direttamente collegabili ad una certa misoginia del discorso tradizionale, per esempio la bel lezza di Ghismonda che in Boccaccio è causa dell'eccessivo amore che il padre prova nei suoi confronti: Tancredi, principe di Salerno, fu signore assai umano e di benigno ingegno, se egli nell'amoroso sangue nella sua vecchiezza non s'a vesse le mani bruttate; il quale in tutto lo spazio della sua vita non ebbe che una figliuola, e più felice sarebbe stato se quella avuta non avesse. Costei fu dal padre tanto teneramente amata, quanto alcuna altra figliuola da padre fosse giammai. . . Era costei bellissi ma del corpo e del viso quanto alcuna altra femina fosse mai. . . (Decameron, p. 472). Una natura carnale della donna, che Boccaccio riporta alla
concupiscentia, alla naturale e colpevole inclinazione della donna verso la lussuria: Sono adunque, si come da te generata, di carne e si poco vivuta, che ancor son giovane, e per l'una cosa e per l'altra piena di con cupiscibile disidero . . . La concupiscentia di Boccaccio è trasformata da Christine in joliveté, termine piuttosto ambiguo, ma legato al joi trobado rico, alla gaieté di un amore privo di senso di colpa: Et puis que je vy que vous aviés deliberé de jamais ne me marier et, me sentant jeune et stimulee de ma joliveté, m'en amouray de cestui. (Quando vidi che avevate deciso di non farmi risposare, sentendo mi giovane e spinta dal desiderio, mi innamorai di lui, Città, II, LIX, pp. 394·5) Inoltre, Christine cancella nel racconto della moglie di Bar naba tutti i passaggi "antifemministi ", come le riflessioni sulla perfezione dell'uomo e la volubilità delle donne:
S· CHRISTI:\E DE PIZA:\ E BOCCACCIO: SILE�ZIO E CRt:DELTA
lo ho sempre inteso l'uomo essere il più nobile animale che tra' mortali fosse creato da Dio, e appresso la femmina; ma l'uomo, sì come generalmente si crede e vede per opere, è più perfetto; e avendo più di perfezione, senza alcun fallo dee avere più di fermez za e così ha, per ciò che universalmente le femine son più mobili, e il perché si potrebbe per molte ragioni naturali dimostrare, le quali al presente intendo di lasciare stare (Decameron, p. 287).
TI cambiamento di sesso nella figura del serpente, messo in relazione diretta con la donna in tutto il discorso misogino medievale12, secondo l'analogia Eva-serpente, va anch'esso in questa direzione: è un uomo, Tancredi, che rappresenta il pericolo, e non una donna23. Con questa scelta, Christine polemizza direttamente con Ovidio: Et dit cellui Ovide, et semblablement les autres, quant assez ont blasmees sur celles choses les femmes, que ce qu'ilz en mettent en leur livres, tant de meurs decevables d'elles camme leurs mauvai stiez, que ilz les font pour le bien publique et commun, adfin de aviser les homrnes de leur cautelles pour mieulx les eschever, si camme du serpent mucié soubz l'erbe. (Ovidio, come gli altri, dopo aver biasimato così le donne, afferma che ciò che hanno scritto nei loro libri, dei cattivi costumi come della malvagità delle donne, era per il bene pubblico e comune, al fine di avvertire gli uomini a cautelarsi, per meglio evitarle, come si fa con il serpente nascosto nell'erba, Città, II, XLIV, pp. 376-7) Ancora, Christine lascia cadere tutti gli elementi che in Boc caccio si riferiscono ad una società primitiva, naturale, ad una nostalgica età dell'oro, in nome di una civiltà e di un progresso che nasce principalmente dalle mani delle donne. Penso alla grotta, al giunco e a tutti quei tratti primitivi24 sostituiti da una topologia cortese. Che si tratti di discorso cortese, lo dimostra poi la presenza del motivo trobadorico del celar2s, del segreto, allo stesso tempo discrezione e rinun cia della vanità che deriva dallo sguardo degli altri, norma fondamentale dell'amore cortese, e reazione alla maldicenza dei lauzengiers, alla quale Christine è particolarmente sensi bile26. Ghismonda parla così: 133
FIGURE FE.\1:\U:-;IU DEL SAPERE N e te vaulsist il pas mieulx que ta lasse filie vesquist a sa plaisan ce, secretement amant un bon homme, que veoir par ta cruaulté si dure mort a ta grant douleur, laquelle mort fera la chose, qui secrete estoit, apparoir magnifeste? (Non sarebbe stato meglio permettere che la tua disgraziata figlia vivesse secondo il suo desiderio, amando in segreto un uomo nobi le, che assistere alla sua dura morte causata dalla tua crudeltà, con tuo grande dolore e che la cosa, che era segreta, sia resa nota a tutti? Città, II, LIX, pp. 398-9) Nel racconto di Lisabetta è sottolineata l'importanza dello sguardo degli altri, dei vicini, quasi lauzengiers: Et a brief dire, tant mena celle vie sur ce pot que il avint que aucuns voisins apperceurent comment, sanz cesser, celle sur ce pot plouroit a la fenestre, et aux freres le dirent, qui l'espierent et virent la merveille de son deuil. (Elisabetta passava tanto tempo vicino a quel vaso, che i vicini finirono per accorgersi che lei piangeva incessantemente alla fine stra, su quel vaso. Lo riferirono ai fratelli, che la spiarono e videro l'immensità del suo dolore, Città, li, LX, pp. 402-3) Lo sguardo di Ambrogio nel racconto della moglie di Bama bo è dello stesso genere, intrusivo, che spia e poi calunnia: tant agaita la dame par nuit que il la vid toute nue (spiò tanto la donna, di notte, che riuscì a vederla tutta nuda, Città, II, LII, pp. 362·3). D a una parte, dunque, uno sguardo maschile violento e invasivo, la parola eccessiva della calunnia del lauzengier e l'incapacità di essere discreti, di ritrarsi, dall'altra la donna costretta al silenzio, perché non può fare altro. Non ha altra scelta, che sia Griselda, Ghismonda (che parla per tacere per sempre) o Lisabetta. Ma, se la libertà può essere cercata in una morte eroica (è il caso di Ghismonda o Lisabetta) , altra forma estrema di ribellione, è anche possibile in una parola ritrovata, come quella della moglie di Bamabo che formula la sua accusa rivolgendosi direttamente al marito e al suo calunniatore, senza aver bisogno dell'autorità maschile del 134
S· CHRISTI:-iE DE PIZA:-i E BOCCACCIO: SILE:-JZIO E CRL"DELTÀ
sultano, altro esempio importante di riscrittura rispetto a Boccaccio. Et comment, ce dist Sagurat, estes vous bien certain que cest homme cy couchast avec vostre femme, pourtant se il vous rappor ta aucunes enseignes? Estes vous si bestes que vous ne doyez savoir que par assez de voyes frauduleusement il povoit savoir la façon du corps d'elle sans y avoir couchié? Et l' avez pour celle cause faicte mourir? Vous estes digne de mort, car vous n' aviés mie preuve souffisant. (E come - disse Sagurat - potete essere sicuro che quest'uomo sia stato con vostra moglie? Anche se vi ha portato alcune prove, siete forse così stupido da non sapere che ci potevano essere diversi modi disonesti per conoscere le forme del suo corpo, senza aver giaciuto con lei? E per questo l'avete fatta morire? Voi siete degno di morte, poiché non avevate prove sufficienti.) E così si rivolge ad Ambrogio: Faulx traitre desloyal, dis la verité! Dis la verité, sanz ce que, pour la dire, tu te faces tourmenter. Car dire la te convient, et c'est chose certaine que de ce que tu as dit mens par ta faulse gorge. (Falso traditore, sleale! Confessa! Confessa, prima che ti costringia mo con la tortura. Ti conviene parlare: abbiamo le prove che tutto quello che hai raccontato è falso, Città, II, LII, pp. 368-9 e 370-1) Contro la calunnia maschile, il discorso vero di una donna; così Christine scrittrice, artista della parola, corregge Boc caccio con una nuova versione di questi racconti, esemplari di un'idea differente del mondo, della storia, della letteratu ra e della realtà. Note 1. A. Jeanroy, Boccace et Christine de Pt'ztJn: le "De Claris Mulieribus" principale source du "Livre de la Cité des Dames", in "Romania" , 48, 1922, pp. 93-105; C. Bozzolo, Il "Decameron" come /onte del "Livre de la Cité des Dames'', in Miscellanea di Studi e Ricerche sul Quattrocento Francese, a cura di F. Sirnone, Giappichelli, Torino 1967, pp. 3-24; L. Dulac, Un mythe
135
FIGURE FE.'d.'dl:-.:IU DEL SAPERE didoctique chez Christine de Pizan: Sémiramis ou la veuve héroi"que, in Mélanges de Philologie Romane o/ferts à Charles Camproux, Centre d'Etu des Occitanes, Montpellier 1978, pp. 315-43; P. Philippy, Establishing Authority: Boccaccio's "De Claris Mulieribus" and Christine de Pizan 's "Livre de la Cité des Dames", in "Romanic Review", 77, 1986, pp. 167-93; M. Quilligan, Translating dismemberment: Boccaccio e Christine de Pizan,
in "Studi sul Boccaccio", 2.0, 1991-92., pp. 2.53-66. 2.. Cfr. lo studio di G. Paris, Les contes orientaux dons la littérature /rançaise du Moyen Age, in La poésie du Moyen Age. Leçons et lectures, Hachette, Paris 1895, pp. 75-108; V. Sklovskij, La struttura della novella e del romanzo, in Teoria della prosa, Einaudi, Torino 1976, pp. 73-99; M. Picone, Tre tipi di cornice novellistica: modelli orientali e tradizione narrati va medievale, in "Filologia e Critica", 13, 1988, pp. 3-2.6. 3· K. Brownlee, Il "Decameron" di Boccaccio e Christine de Piztm, in "Studi sul Boccaccio", 2.0, 1991-92., pp. 2.33-51. 4· M. Quilligan, Allegory and the Textual Body: Female Authority in Christine de Pizan's "Livre de la Cité des Dames", in "Romanic Review" 78, 1988, pp. 2.2.2.-48 e Id., The Allegory o/ Female Authority, Cornell Uni versity Press, Ithaca-London 1991; J. Cerquiglini-Toulet, Fondements et /ondations de l'écriture chez Christine de Pizan. Scènes de lecture et Scènes d'incarnation, in The City o/ Scholars. New Approaches to Christine de Pizan, edited by M. Zimmermann and D. de Rentiis, De Gruyter, Berlin New York 1994, pp. 79-96; P. Caraffi, Autorità Femminile e Ri-scrittura della Tradizione: "La Cité des Dames" di Christine de Pizan, in Tradizione letteraria, iniziazione, genealogia, a cura di C. Donà e M. Mancini, Luni,
Milano-Trento 1998, pp. 63-81. 5· Si veda il volume Christine de Pizan. Una città per sé, a cura di P. Caraffi, Carocci, Roma 2.003. 6. Christine de Pizan, La Città delle Dame, introduzione, traduzione e note a cura di P. Caraffi, edizione di J. Richards, Luni, Milano 1997. A seguire abbreviato con: Città. 7· Si possono leggere le due versioni in Giovanni Boccaccio, France sco Petrarca, Griseldo, a cura di L. C. Rossi, Sellerio, Palermo 1991. 8. Giovanni Boccaccio, Decameron, a cura di V. Branca, Einaudi, Torino 1980. 9. E. J. Richards, Sulla natura delle donne e la scrittura di genere, in Christine de Pizan. Una città per sé, cit., pp. 99-n5; Politics, gender & genre. The politica! thought o/ Christine de Pizan, edited by M. Brabant, Westview Press, San Francisco-Oxford 1992.; K. Brownlee, Le projet «auto biographique» de Christine de Pizan: histoires et /ables du moi, e A. Pau pert, «La narracion de mes aventures»: des premiers poèmes à "I.:Advision". L:élaboration d'une écriture autobiographique dans l'ceuvre de Christine de Pizan, in Au champ des escriptures, � Colloque international sur Chri
stine de Pizan (Lausanne, 18-2.2. jiullet 1998), Études réunies et publiées par E. Hicks avec la collaboration de D. Gonzalez et P. Simon, Champion, Paris 2.000, pp. 5-2.3 et pp. 51-90; P. Caraffi, Christine de Pizan e la scrittura di genere, in "Medioevo Romanzo", 2.4, 2.000, pp. 141-8.
S· CHRISTI:\E DE PIZA:\ E BOCCACCIO: SILE:-.IZIO E CRUDELTÀ
10. G. Paris, Le cycle de la «Gageure», in "Romania", 32, 1903, pp. 481-551; si veda anche G. Almansi, Il ciclo della scommessa. Dal Decameron al Cymbeline di Shakespeare, Bulzoni, Roma 1976. n. L. Rossi, Il cuore, mistico pasto d'amore: dal «Lai Guirun» al «Decameron», in "Studi provenzali e francesi", 82, 1983, pp. 28-128; M. Di Maio, Il cuore mangiato. Storia di un tema letterario dal Medioevo all'Otto cento, Guerini, Milano 1996; si veda anche Il testo moltiplicato, a cura di M. Lavagetto, Pratiche, Parma 1982. 12. Il romanzo del castellano di Coucy e della dama di Fayel, a cura di A. M. Babbi, Pratiche, Parma 1994. 13. J. Richards, La libertà della città e delle dame, in "Medioevo Romanzo", 24, 2000 , pp. 114-26. 14. Si veda CAP. 1, p. 22, nota 21. 15. «Le ragioni di questo eccezionale successo sembrano piuttosto da ricercarsi nella fascinosa ambiguità del racconto, nel suo essere non chiaro, non esplicito, ma avvolto in una fitta rete di riferimenti allusivi a un sottofondo di motivazioni e di istinti i quali, pur tendendo verso la superficie narrativa, non vengono mai definitivamente chiariti e resi comunicabili», G. Almansi, L'estetica dell'osceno, Einaudi, Torino 1974, p. 162. 16. Decameron, scritto e diretto da P. P. Pasolini, musica di P. P. Faso lini ed E. Morricone, 1971. 17. I..:amante prigioniero, a cura di M. Di Febo, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2002. 18. Vida de Guilhelm de Cabestaing, in Biographies des troubadours: textes provençaux du XIII et XIV siècles, J. Boutière & A. H. Schutz, Privat, Toulouse 1950. 19. C. Di Girolamo, "Cor" e "cors": itinerari mertdionali, in Capitoli per una storia del cuore, a cura di F. Bruni, Sellerio, Palermo 1988, pp. 2148; H. J. Neuschafer, Il caso tipico e il caso particolare: dalla "vida" alla novella, in Il racconto, a cura di M. Picone, il Mulino, Bologna 1985, pp. 299•308. 20. Quilligan, The Allegory o/ Female Authority, cit., pp. 179-81. 21. Bozzolo, Il Decameron, cit., p. 13. 22. H. Bloch, Medieval Misogyny, University of Chicago Press, Chica go-London 1991; G. Duby, Dames du XII siècle. III. Ève et !es pretres, Édi tions Gallimard, Paris 1996; C. Frugoni, La donna nelle immaginz; la donna immaginata, in G . Duby, M. Perrot, Storia delle donne. Il Medioevo, a cura di C. Klapisch-Zuber, Laterza, Roma-Bari 1990, pp. 424-57. 23. Brownlee, Il "Decameron" di Boccaccio e Christine de Pizan, cit., p. 250. 24. J. C. Miihlethaler, Problèmes de récriture: amour et mort de la princesse de Salerne dans le "Decameron" (IV, r) et dans "La Cité des Dames" (II, Jp), in Une Femme de Lettres au Moyen Age, articles inédits réunis par L. Dulac et B. Ribémont, Paradigme, Orléans 1995, pp. 209-20. 25. E. Kohler, Sociologia della /in 'amor, Liviana, Padova 1976, pp. 25, 101, 110 e M. Mancini, La lode e il segreto: sul "celar" dei trovatori, in M.
13 7
FIGURE FE.'d.'d.I=-:IIJ DEL SAPERE Mancini, Meta/ora feudale. Per una storia dei trovatori, il Mulino, Bologna 1993. pp. 187·2.05. 2.6. Fenster, Christine de Pizan et la médisance, in Au champ des escriptures, cit., pp. 461-77.
Nella collana
Biblioteca Medievale 1.
La Tavola Ritonda
2. Christine de Pizan,
La città delle dame
3·
Il caso Belibasta
4·
Giganti, incantatori e draghi. Byline dell'antica Rus'
5· Fulgenzio,
Commento all'Eneide
6. Jordi de San t Jordi, 7. Ausiàs March, 8.
Pagine del canzoniere
La battaglia di Ma/don
9· Waltharius, 10. Hàfez, n.
L'amoroso cerchio
Epica e saga tra Virgilio e i Nibelunghi
l/ libro del Coppiere
Robert Henryson,
Il Testamento di Cresseida
12. Etienne de Fougères, 13.
l/ libro degli stati del mondo
Gervais du Bus, Chaillou de Pestain,
14. Lazamon,
Le gesta di Artù
15.
Libro de Apolonio
16.
Tristano Riccardiano
17. Chrétien [de Troyes] , 18.
Aucassin e Nicolette
19.
Daurel e Beton
Guglielmo d1nghilterra
20. Leonor L6pez de C6rdoba,
Memorie
21.
Canzoni di crociata
22.
Pianto sulla distruzione di Rjazan'
23. Diego de San Pedro, 24. Maria di Francia, 25. Il
Roman de Fauve!
Carcere d'amore
Lais
Sogno della Croce
26. Lorenzo de' Medici,
Rappresentazione di San Giovanni e Paolo
27. Riccardo di San Vittore,
I quattro gradi della violenta carità
28. Renaut de Beaujeu,
Il bel cavaliere sconosciuto
29 . Douin de Lavesne,
Trubert
30. Sanri,
Viaggio nel regno del ritorno
31.
Fatrasies
32. Benedeit, Il 33·
Viaggio di San Brandano
Sir Perceval di Galles
34· Jean Renart,
L'immagine riflessa
35· Wolfram von Eschenbach, 36.
Vita di Barbato
37·
Sir Orfeo
38. La saga dei
Titurel
Volsunghi
39· Lotario di Segni,
Il disprezzo del mondo
40. Chuanqi. Storiefantastiche Tang 41.
Auberée
42.
Il gufo e l'usignolo
43· Gil Vicente,
Farsa di Ines Pereira
44· La farsa di Maistre Pathelin 45· La sposa 46. Jakemes,
4 7.
La
delle spose Il romanzo del castellano di Coury e della dama di Fayel
canzone di Guglielmo
48. Havelok il danese 49· La saga di Eirlk 50.
Hildebrandslied
51.
Razdn de amor
52. Arnaut Daniel, 53· Guglielmo IX, 54·
il rosso
L'aur'amara �rs
Poesia d'amore nella Spagna medievale
55· Rudolf von Schlettstadt, 56. Baudouin de Condé, 57. Raimon Vidal, 58.
Storie memorabili
Il mantello d'onore
Castia-Gilos
Il cavaliere e l'eremita
59· Hélinant de Froidmont, 6o.
Il cantare di Igor'
61.
Il /ai di Narciso
62.
Perla
I versi della morte
63. Suhravardi, L'angelo purpureo 64. Evagrio Pontico, Gli otto spiriti malvagi 65. Richard de Fournival, Il bestiario d'amore 66. Jean Bodel, Il miracolo di San Nicola 67. Walter Map, Svaghi di corte (2 voli.) 68 .
La
battaglia di Quaresima e Carnevale
69 . Gormond e Isembart 70. Tertulliano, Gli ornamenti delle donne 71. Nizam al-Mulk, L'arte della politica 72. Juan Rodrlguez del Padr6n, Schiavo d'amore 73- Ballate magiche svedesi 74· I trovatori e la crociata contro gli Albigesi 75· Chrétien de Troyes, Erec e Enide 76. Cantarifiabeschi arturiani 77· Binduccio dello Scelto, Libro de la storia di Troia 78 . Sir Tristrem 79 .
La
lettera delprete Gianni
So. Ponula Gaia 81. Il Gododdin 82. Afanasij Nikitin, Viaggio in tre mari 83. Bernart de Vemadorn, Canzoni 84. Audigier. Il cavaliere sul letamaio 85. Jaufre Rudel, L'amore di lontano 86. Folquet de Marselha, Poesie 87. Farid al-din 'Attar,
La
Rosa e /'Usignuolo
88. Maria di Francia, Ilpurgatorio di san Patrizio In preparazione:
89. Beowu/f 90. Sendebar. Il libro degli inganni delle donne
Biblioteca Medievale l Saggi Piero Boitani, La
I. 2.
narrativa del medioevo ingkse
Tmdizione letteraria, iniziazione, genealogia, a cura di C. Donà, M. Mancini
3· Carlo Saccone, Viaggi
e visioni di re, sufi, profeti
4· Mario Mancini, La gaia 5· Maria Tasinato, La
6.
scienza dei trovatori
curiosità
John R. R. Tolkien,
Il medioevo e ilfantastico
7· Alessandro Bausani,
Il "pazzo sacro" ne//1s/am
8.
L'alfabeto simbolico degli animali
Francesco Zambon,
9· La
regalità,
a cura di C. Donà, F. Zambon
IO.
Christine de Pizan. Una città per sé,
n.
Poetica medievale,
I2.
Figure femminili del sapere,
a cura di
a cura
di P. Caraffì
P. Bagni, M. Pisroso a cura di
P. Caraffi
In preparazione: I3. Laura Auteri,
Regine e cavalieri allo specchio
I4. Andrea Fassò,
Il sogno del cavaliere