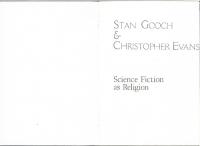Science fiction 8883198433, 9788883198434
145 57 595KB
Italian Pages 248 [245] Year 2003
Recommend Papers

- Author / Uploaded
- Franco Monteleone (editor)
- Cecilia Martino (editor)
File loading please wait...
Citation preview
STUDI SUL CINEMA
Collana diretta da Paolo Amalfitano, Silvia Carandini, Francesco Fiorentino
5
I LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE SIGISMONDO MALATESTA
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
G. CANOVA, G. CREMONINI, M. FADDA, V. FORTUNATI, F. LA POLLA, C. PAGETTI, P. ROUYER, R. RUNCINI, V. SOBCHACK, M. SPANU, M. WALTER BRUNO
Science Fiction a cura di FRANCO MONTELEONE CECILIA MARTINO
BULZONI EDITORE
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
TUTTI I DIRITTI RISERVATI È vietata la traduzione, la memorizzazione elettronica, la riproduzione totale o parziale, con qualsiasi mezzo, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico. L’illecito sarà penalmente perseguibile a norma dell’art. 171 della Legge n. 633 del 22/04/1941 ISBN 88-8319-843-3 © 2003 by Bulzoni Editore 00185 Roma, via dei Liburni, 14 http://www.bulzoni.it e-mail: [email protected]
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
SCIENCE FICTION
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
INDICE
Introduzione di Franco Monteleone .......................................................................
p. 11
Nota bibliografica ..................................................................................................................
»
27
ROMOLO RUNCINI La locomotiva e l’elfo. Tecnica e fantasia nel cinema di fantascienza .............................................................................................................................. »
29
GIORGIO CREMONINI Fantastico fantascienza fantapolitica
.................................................................
»
55
..............................................................................
»
65
CARLO PAGETTI Il futuro immaginario della fantascienza. Vivere un altro presente ..........................................................................................................................................
»
77
VITA FORTUNATI Il virtuale come ultima frontiera del possibile utopico e fantascientifico ........................................................................................................................
»
97
PHILIP ROUYER Le sang de la nouvelle chair. Le gore dans la Science Fiction*
.......
» 113
GIANNI CANOVA Ci sono i bagni nel cyberspazio? Paradossi ed epifanie del virtuale ..........................................................................................................................................
» 135
FRANCO L A POLLA L’alieno dai mille volti. Mito e SF
9
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
INDICE
MARCELLO WALTER BRUNO SF & SFX. Il ruolo degli effetti speciali
...................................................................
» 145
MASSIMILIANO SPANU Epifania del Dio virtuale e sua straordinaria scomparsa ..................
» 165
MICHELE FADDA «Where Am I?» Gli incerti epiloghi dello sguardo e dell’identità nella SF hollywoodiana contemporanea ..........................................................
» 185
VIVIAN SOBCHACK Love Machines. Spielberg/Kubrick, Artificial Intelligence and other Oxymorous of SF Cinema* ..............................................................................
» 209
* I saggi in lingua straniera sono seguiti dalla traduzione italiana
10
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
INTRODUZIONE di FRANCO MONTELEONE
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
Scrivo queste pagine avendo negli occhi le immagini del bombardamento di Baghdad trasmesse dalle televisioni di tutto il mondo; immagini che hanno più di un punto in comune con il tema di questo libro e con gli interventi degli studiosi chiamati a occuparsi di fantascienza cinematografica, all’ombra della quiete mediterranea de «La Villarosa» di Ischia, il 14 e 15 marzo 2002. Tutto l’ultimo decennio del secolo scorso, a ben vedere, è stato dominato da un eccesso di rappresentazione visiva, mai del tutto metabolizzata, della violenza. Si è trattato quasi sempre di eventi bellici: la guerra del Golfo, la Somalia, la Cecenia, lo strazio della ex Jugoslavia, il conflitto israelo-palestinese, per finire con l’attacco terroristico alle Twin Towers. È una nuova forma di «reale», caratterizzato da overdose mediatica, strettamente connesso con la crescente spettacolarizzazione delle tecnologie distruttive che hanno finito, da un lato, per provocarne una vera e propria saturazione ma anche, dall’altro, per rinnovare, con nuovi timori, il sentimento profondamente perturbante di un «altrove» tutt’altro che metaforico, più vicino nello spazio e nel tempo, e forse per questo ancora più spaventoso. È il segno di un ulteriore stadio di quella metamorfosi delle situazioni percettive che si dispiega ormai in tutta la sua invadenza in ogni anfratto dell’esperienza contemporanea, sempre più pervasa dal disorientamento, e che il cinema ha puntualmente registrato nel corso della sua storia. È infatti dai tempi dei fratelli Lumière che il cinema si è incaricato di trasferire, nel buio di una sala, il sentiment di questa progressiva metamorfosi. È stato proprio il cinema, più della stessa letteratura di fantascienza, che ha accompagnato alcuni degli accadimenti di maggiore rilevanza del secolo scorso (due guerre mondiali, Hiroshima, il pericolo comunista, la contrapposizione dei blocchi, l’incontrollabilità della scienza, la pervasività dell’informatica, l’emer-
13
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
FRANCO MONTELEONE
genza ambientale, il diffondersi delle nuove malattie epidemiche, etc.) creando opere che hanno celebrato il rito dell’attesa della catastrofe finale, il rito della morte cosmica, della fine del tutto, prima ancora che le immagini postmoderne della neotelevisione stabilissero nuove gerarchie della realtà rappresentata. Ma c’è di più. Nei giorni in cui stavo completando la rilettura definitiva e la sistemazione editoriale delle relazioni che occupano il volume si è inaugurata l’imponente mostra sulla «Maestà di Roma», allestita alle Scuderie del Quirinale, a Villa Medici e alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Valle Giulia. La mostra offre una documentazione davvero eccezionale sul ruolo che ebbe Roma, fin dai primi anni dell’Ottocento, nella formazione dell’arte e degli artisti europei. Uno dei più giganteschi (5 metri per 7) e anche uno dei più popolari quadri dell’intera storia dell’arte occidentale può finalmente essere ammirato nella città dove esso fu eseguito tra il 1837 e il 1858. L’Ultimo giorno di Pompei, di Karl Pavlovic Brjullov, va certamente considerato un archetipo moderno della rappresentazione universale della catastrofe, e del terrore che essa suscita. Con profetica intuizione Gogol’, in Arabeschi, scrisse che la concezione di quest’opera «appartiene completamente al gusto del nostro secolo (il «secolo degli effetti», da lui stesso così definito), il quale, come presentendo il suo terribile frazionamento, cerca di riunire tutti i fenomeni in gruppi generali e sceglie le formidabili crisi che possono appartenere alla coscienza di intere masse». La rappresentazione di un evento lontano ma terribile – presagio della caduta dell’impero – esprimeva la crisi dei valori tradizionali che stava cominciando a scuotere l’uomo moderno e dava inizio a quella moda pittorica dei temi catastrofici, così intimamente legata al crollo delle grandi civiltà (da La caduta di Babilonia di John Martin a Destruction di Thomas Cole), che evolverà agli inizi del Novecento in ulteriori rappresentazioni, questa volta proiettate nel futuro, nate dallo sviluppo della tecnologia e dai macelli della Grande Guerra. Benché apparsi nei primi anni del XIX secolo, questi dipinti sembrano anticipare in maniera impressionante gli «effetti speciali» di tanti kolossal cinematografici. Il quadro di Brjullov, ispirato da un melodramma, ispirerà a sua volta il romanzo del secolo, Gli ultimi giorni di Pompei di Edward Bulwer-Lytton, creando una vera e propria mitologia della
14
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
INTRODUZIONE
paura collettiva e della fine assoluta, da cui poi il cinema attingerà uno dei suoi alimenti più saporiti È quindi il ricordo di paure storicamente accertate che accende la fantasia degli artisti, ben prima che le visioni avveniristiche indotte dall’immanenza della tecnologia, nel passaggio fra i due secoli, forniscano il primo materiale immaginativo agli scrittori e ai cineasti. In seguito, attraverso l’artificiosità che gli è propria, il cinema sposta dal passato al futuro, da questo ad altri mondi, dal reale al metafisico, il suo punto di vista e il suo linguaggio espressivo. E, come la letteratura, anche il cinema eredita dall’arte, ampliandola a dismisura, la capacità di utilizzare effetti scopici di reminescenza o alterazione del reale. Il dato da non sottovalutare è che questo spostamento avviene simultaneamente ad altre trasformazioni epocali. Tutte le vecchie e nuove tecniche narrative con le quali è stato rappresentato, fuori di noi e dentro di noi, il terrore dell’ignoto, dell’imprevedibile, del mostruoso, sia nell’arte figurativa che nel cinema di fantascienza, sono infatti nate dal medesimo crogiuolo della modernità, e ne rappresentano un aspetto fondante. Non a caso queste tecniche hanno avuto una decisa accelerazione, nei linguaggi e nei contenuti, solo quando scienza e filosofia hanno disvelato nuovi e più angosciosi territori dell’inquietudine. Anche il Tempo, non diversamente dallo Spazio, è ormai lo specchio oscuro in cui cerchiamo di scorgere i tratti dell’identità di noi stessi e dell’altro, sia esso alieno o divinità. Con una differenza essenziale rispetto all’arte figurativa dei primi decenni dell’Ottocento: questa rappresenta il terrore di eventi realmente accaduti, mentre la narrativa e il cinema di Science Fiction (d’ora in avanti ovunque SF) rappresentano il terrore che nasce da congetture non ancora verificate. Ma, attenzione, sono congetture «scientificamente possibili» e quindi, come osserva Paul Davis nel suo libro Come costruire una macchina del tempo, cariche di una profonda valenza euristica, destinate come sono ad alimentare tanto l’impresa tecnico-scientifica quanto la riflessione sul senso della nostra esistenza e sulle ragioni della nostra convivenza civile. Oggi, a partire dal seno stesso della scienza, vengono recuperati aspetti che la fisica tradizionale aveva cercato di espungere: l’incertezza, l’indeterminazione, il disordine, la presenza ineliminabile ed essenziale del soggetto. Come ha osservato Giuseppe O. Longo, al
15
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
FRANCO MONTELEONE
convegno triestino «ScienceplusFiction» del 2000, le nostre teorie, in fisica come in geometria, in sociologia come in economia, in matematica come in biologia sono sempre più rette da epistemologie instabili e fluide. Non si vuole più indagare soltanto l’ordine e la regolarità, ma anche la turbolenza e il caos. Dall’epoca in cui veniva considerato ancora una lanterna magica delle emozioni è infatti il cinema che, oltre a commuovere e divertire, comincia già a spaventare, a mostrare ogni possibile baratro, a proiettare in mondi sconosciuti il sentimento dell’angoscia moderna. E lo fa, da un lato, ispirandosi alle nuove congetture con cui la scienza accompagna la nascita del mondo contemporaneo, dall’altro, utilizzando la tecnica impiegata in tutte le rappresentazioni moderne della congettura, quella che ne determina – dai tempi di Georges Méliès – le ragioni strutturali della sua forza spettacolare: l’«effetto speciale». Se esso nasce nell’Ottocento, sotto la spinta di un anelito creativo che percepisce i fremiti di un mondo che sta radicalmente mutando, si consolida tuttavia solo nel secolo successivo, a mutazione avvenuta, come strumento indispensabile della narrazione per immagini in una società ormai pienamente di massa. La molteplicità delle sue straordinarie varianti avrà un’influenza enorme su sceneggiatori e registi, spingendoli ad avventurarsi su scenari narrativi sempre più spettacolari e ambiziosi; ma contribuendo anche a dilatare oltre ogni limite, nel corso del tempo, il simbolismo spesso virtuale della produzione cinematografica di SF, che in più di qualche caso ha finito per mostrare esiti espressivi a dir poco manieristici. D’altronde è in questo manierismo, che definirei neoellenistico, che va rintracciato uno degli elementi che caratterizzano tutto il cinema della postmodernità, anche se è soprattutto il cinema fantascientifico che soggiace in modo particolare ai suoi imperativi. Esso ben rappresenta quella «cultura della metamorfosi» di cui spesso parla Franco La Polla, contraddistinta da una tendenza culturale (ellenistica appunto) assolutamente attuale, che ha completamente trasformato statuti e linguaggi del cinema classico (anche di fantascienza): se per molto tempo il plot narrativo è stato dominato da una visione antropocentrica, il cinema della postmodernità sembra averla del tutto accantonata per sostituirla con una nuova visione, multicentrica e aurale, di tipo bizantino. Un risveglio della concezione antropocentrica, nel cinema di fantascienza, si annuncia
16
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
INTRODUZIONE
forse con il prossimo film tratto da Cronache marziane di Ray Bradbury. Ma non è affatto escluso che, su questo testo arcinoto, non vengano ugualmente compiute scorrerie postmoderne di sofisticatezze tecnologiche, addirittura con il consenso dello scrittore. Tutto il cinema contemporaneo di SF appare sempre meno rivolto a un processo di conoscenza e sempre più orientato verso l’esperienza sensoriale, metamorfica appunto, fondata sull’emozione fisica, tale da provocare nello spettatore una percezione sintetica, per l’artificialità dell’immagine su cui si basa, ed eccentrica, per lo spostamento dell’esperienza scopica in un ambito esterno all’osservatore. D’altro canto il proliferare dell’immagine virtuale ha finito per mettere in crisi il concetto stesso di corporeità provocando un fastidioso senso di smarrimento dell’identità. Confesso di avere spesso provato un senso di profonda angoscia, di vera e propria alienazione, durante la visione di molta SF postmoderna, a cominciare probabilmente da un capolavoro indiscusso come Blade Runner. Anche le tradizionali categorie di giudizio sono ormai insufficienti. Esse non si addicono a un sistema iconico che non viene definito in base a concetti come vero o falso, bello o brutto, ma in base alla capacità di essere più o meno adeguato rispetto a nuove funzioni che gli si chiede di svolgere. È la tattilità la nuova tipologia di approccio alle immagini sintetiche e agli effetti speciali realizzati dalla tecnologia: una tattilità che va oltre la banale sensorialità del toccare ma che implica, molto più «virtualmente», la sola contiguità epidermica dell’occhio e dell’immagine; ovvero la fine della distanza estetica dello sguardo e l’inizio, come aveva suggerito in un suo saggio Gianni Canova, di un nuovo regime basato sulla contiguità prossemica fra l’occhio e il suo oggetto. Contiguità che ha già sancito la (definitiva?) trasformazione del «corpo» e che, ancora una volta, in senso più generale, dimostra quanto sulle forme della creatività incidano, oggi più che mai prepotentemente, le innovazioni della tecnica, le necessità del mercato, le tendenze del gusto. Non c’è nulla come il cinema di SF che attesta l’incidenza delle nuove forme di produzione sui percorsi che hanno contribuito a fondare gli statuti di una estetica nuova: il primo Matrix, di Andy e Larry Wachowski, ne costituisce da questo punto di vista uno degli esempi più straordinari, perché qui la tecnologia digitale (in maniera ben più pre-
17
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
FRANCO MONTELEONE
gnante che nel banale e retorico «reloaded») si piega non solo all’esigenza del racconto, ma soprattutto a quella di realizzare immagini di una perfezione assoluta. Per vedere qualcosa di ancora più avanzato bisognerà probabilmente attendere una auspicabile riduzione cinematografica di Pattern Recognition, il nuovo romanzo di William Gibson, dove la fisicità degli oggetti più trendy del mondo contemporaneo gareggia con quella prodotta dall’impatto degli aerei sulle torri gemelle (dal cui disastro la storia prende l’avvio). E del resto, già ora la Rete consente di misurarsi con una notevole quantità di siti che propongono videogame d’ispirazione bellica, in cui la virtualità raggiunge livelli, appunto, di tipo fantascientifico. Il percorso concettuale, che il lettore troverà nel susseguirsi delle relazioni raccolte nel volume, affronta l’insieme di tutti questi aspetti del dibattito contemporaneo sulla SF attraverso una rigorosa analisi dei «testi», senza mai correre il rischio di utilizzare semplificazioni categorizzanti. Gli interventi rappresentano infatti quanto c’è di meglio nella letteratura sull’argomento. Gli autori scansano abilmente il pericolo di restituire una immagine del cinema di SF legata a un vecchio concetto di «evasione» dalla realtà e si concentrano invece opportunamente sul tentativo di descrivere la neorealtà della fantascienza cinematografica postmoderna così com’è, formata dai linguaggi e dagli effetti speciali consentiti dalle nuove risorse tecnologiche, dominata dall’ansia cognitiva di capire per quale strada vada incamminandosi il destino della condizione umana. Più che il genere avventuroso, storico o poliziesco, la SF nasce infatti da eventi che hanno generato effetti profondi sull’immaginario sociale e quindi sulla trasformazione antropologica del nostro stesso modo di vedere il mondo. È il tema della prima relazione introduttiva di Romolo Runcini che, dopo essersi soffermata su un rapido excursus storico, mette in evidenza gli elementi antitetici sui quali si fonda la natura complessa e contraddittoria della SF: il simbolo della modernità, la «locomotiva», e la sua controparte fantastica, l’«elfo». Questi è l’essere della foresta, figura mitologica della cultura celtica e ingrediente narratologico del gothic romance settecentesco, il quale proietta ombre inquietanti – spettri, streghe, diavoli di un medioevo «alla moda» – sul destino di una società avviata al progresso ma che non ha eliminato
18
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
INTRODUZIONE
dalla sua sensibilità l’incombere minaccioso di quelle presenze. L’elfo esprime la condizione selvaggia, dunque non ancora umana, che delinea la dimensione fantastica del «perturbante» (sulla quale aveva insistito Freud) come alterazione della percezione ordinaria e rassicurante della realtà. La SF fonda tutta la sua carica eversiva proprio su tale percezione distorta, che ha come referente immediato il «disagio della civiltà» indotto dall’incedere del mondo moderno. Il senso di alienazione causato dalla perdita dell’identità individuale, tipica del processo di massificazione dell’età moderna e di virtualizzazione di quella postmoderna, trova nella rappresentazione fantastica – come sostiene nel suo intervento Giorgio Cremonini – la propria risoluzione catartica, nel duplice senso di appagamento del «desiderio-sogno» e di esorcizzazione della «paura-incubo». L’innesto della scienza nella fantasia procede ad attualizzare (non senza degenerazioni spettacolari incoraggiate dalle tecnologie digitali) antichi meccanismi prometeici di eversione, utilizzati per fronteggiare i limiti della condizione umana e le sue ineliminabili fobie. A sua volta, la fantasia, sostenuta dalla scienza, interviene a deformare la realtà, o meglio la «presunzione di realtà», attraverso l’espediente retorico della metafora che fa del fantastico, più che un genere, una tipologia di racconto. Anche nella fantapolitica, inoltre, avverte Cremonini, il modello narrativo che trionfa è di nuovo quello di una ritorsione globale alla sfida di un potere che ha sostituito la conoscenza. Dal canto suo, Franco La Polla – tra i curatori del Colloquio di Ischia – approfondisce ulteriormente le attinenze tra i paradigmi scientifici e la dimensione fiction nel cinema degli ultimi decenni, dove l’arcaicità delle forme narrative, di chiara derivazione letteraria, si combina con l’ipermodernità della tecnologia. «È dal mito – egli dice – che la SF trae i modelli culturali per costruire le sue storie». E non importa che si tratti di Ulisse o Prometeo, poiché la fantascienza partecipa in ogni caso dell’atemporalità del mito. Caratteristica che spiega ottimamente il successo del genere in tempi postmoderni, poiché nulla meglio di un genere fondato sull’atemporalità, è esattamente ciò che «una cultura del rifiuto della storicità stava aspettando di scoprire o comunque di rivalutare perché coincidente con la propria episteme». Di nuovo in primo piano, dunque, il paradosso ontologico di questo genere cinematografico, ovvero un ibrido di tendenze tra lo-
19
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
ro diametralmente opposte: una SF che parte dal fantastico e dalle sue creazioni utopiche e proiezioni distopiche per arrivare, nel corso degli anni, ad accentuare sempre più la componente tecnico-meccanica e ridefinire, così, i confini quantomeno mentali di una probabile era post-organica. Essa sovverte in modo definitivo quell’equilibrio tra realtà e finzione che, del resto, era già stato reso precario dalle prime tecnologie audiovisive del secolo scorso. In realtà l’immaginario fantascientifico non fa altro che proiettare nel domani ciò che tutti noi stiamo vivendo oggi. Il futuro è quindi adesso. Il futuro è nel presente, avverte Carlo Pagetti che, della SF cinematografica, svela i retroscena letterari o, per meglio dire, il corpus narrativo da cui molti film traggono tutt’ora ispirazione. Scientific romances e cinema di fantascienza condividono lo stesso punto di partenza, ovvero la percezione del futuro, avvertito nel corso degli anni come una entità temporale sempre più prossima al presente. Pagetti osserva acutamente che il futuro si colloca all’incrocio tra la consapevolezza della storia presente, delle sue articolazioni, dei suoi pericoli, e la proiezione «in chiave di sogno o di incubo» di una narrazione che tende a diventare elusiva, ad assumere la pulsione privata di un desiderio, ad accogliere premonizioni autobiografiche. È a questa tensione sensoriale, del tutto interna all’esperienza degli autori e degli spettatori, che va attribuito gran parte del carattere sensazionale ed emotivo di questo cinema, al di là degli stimoli visivi indotti dagli effetti speciali, che possono restituire solo in parte la plasticità delle descrizioni narrative. Sulla nuova dimensione spazio/temporale si sofferma anche Vita Fortunati. Lo spazio diventa tempo là dove scompaiono tutti i possibili limiti associati all’idea di fisicità, con conseguenze fondamentali sulla definizione dell’oggetto «fantascientifico» e sul modo con cui esso viene percepito. È davvero possibile, ella si chiede, che il virtuale rappresenti l’ultima possibile utopia? Un interrogativo urgente, che l’autrice complica chiamando in causa i concetti più importanti legati alla nozione di fantascienza, primo fra tutti la mutata rappresentazione del journey, contrapposta a quella del trip, cioè dell’immersione profonda in ogni bruciante esperienza cognitiva. L’ennesimo ossimoro di cui si nutre tutta la SF, lo spazio virtuale, imprime un radicale cambiamento all’esperienza del viaggio (must narrativo di cui la «macchina del tempo» rimane emblema indi-
20
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
scusso) che da un mondo esterno fisicamente tangibile si riversa all’interno di un cyberspazio del tutto artificiale e autoreferenziale ove scompaiono anche gli ultimi residui di organicità, ovvero i «bagni» descritti con fine ironia metaforica nella relazione di Gianni Canova. Spazi diversi ma identici, agibili e insieme rappresentabili, dove deliri di onnipotenza si alternano all’angoscia della spersonalizzazione che i simulacri digitali infliggono all’identità degli umani. È l’eclissi definitiva della distanza sia spaziale che temporale, un tema caro a Canova, che sancisce l’annullamento dei confini tra «dentro» e «fuori», tra passato e presente, tra presente e futuro: la proiezione nel futuro come metafora fantastica del possibile (aggiungerei, della «congettura» possibile) si riversa drammaticamente nel presente che diventa esso stesso un effetto speciale. Ciò che è cambiato, egli dice, non è tanto lo sguardo o il punto di vista dello spettatore, ma è soprattutto il rapporto, la relazione, la modalità di connessione che si dà tra il soggetto e l’oggetto. Seguendo, al contrario, una prospettiva storica che delinea la parabola evolutiva del rapporto tra fantasia, tecnologia e umanità, Walter Bruno insiste sul tema cruciale degli effetti speciali distinguendone sei tipi, con altrettanti sottogeneri di SF (scenografica, prostatica, ottico-meccanica, visiva, animatronica, digitale), sintomatici non solo di un modo nuovo di intervenire sull’immaginario collettivo e individuale, ma anche di una capacità nuova di pensare, di percepire la realtà e di interpretarla, determinata da innovazioni tecnologiche sempre più pervasive e inglobanti; l’ultima delle quali è proprio la rivoluzione digitale. Attraverso le immagini neoreali che «vivono» di pura virtualità, essa ha infatti rivelato nell’evoluzione del genere fantascientifico – come già accennato – l’ennesima eclissi postmoderna, quella del «corpo». L’impatto della SF con le tecnologie digitali, a un tempo creativo e distruttivo, è il punto di vista enfaticamente dissacrante da cui prendono spunto anche altre due relazioni. In particolare quella di Massimiliano Spanu si chiede se la mutazione tecnologica in atto sia davvero in grado di ribaltare cosmologie narrative e mitologie di classico riferimento. La sua analisi ripercorre le tappe di questa trasformazione immaginifica e popolare diffusasi a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso. L’eclissi di quello che Spanu chiama il «Dio vir-
21
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
FRANCO MONTELEONE
tuale» (ovvero l’esibizione dell’icona computerizzata) è il risultato di una coincidenza epocale tra le tecnologie digitali e le nuove capacità percettive, neurofisiologiche, dell’uomo tecnologico. In un eccesso di visibilità (iperrealtà) si produce un effetto contrario di mimesi, quasi a voler nascondere quanto in precedenza appariva ostentato, cioè l’effetto tecnologico già definito da Canova il «paradosso scopico della virtualità». L’ambito della SF hollywoodiana contemporanea consente invece a Michele Fadda, accanto a raffinate irruzioni nelle sue stagioni adolescenziali di consumatore di fumetti americani, un approccio maggiormente attento alle complesse questioni dell’identità, da sempre presenti nei personaggi di questo cinema. È nella tradizione stessa del cinema fantascientifico la capacità, come nessun altro genere cinematografico, di aver tante volte indicato il destino più autentico della rappresentazione identitaria. Virtualità, simulazione, intelligenza artificiale, tutte le nuove frontiere della tecnologia fantascientifica, giocano un ruolo di primo piano nella concezione postmoderna del «doppio»: esso travalica l’aspetto puramente identitario (doppia personalità) per assumere caratteri di sconcertante concretezza (clone tecnologico). A questo processo si aggiunge – nello specifico contesto hollywoodiano – la tensione ad accentuare il paradigma dell’«identità americana» che Fadda individua nell’incerto finale di A.I. Artificial Intelligence, giudicato privo di coerenza in quanto emblema sovrano dell’attuale dimensione esistenziale dello spaesamento; giudizio in verità non condiviso da Vivian Sobchack. Il film di Steven Spielberg/Stanley Kubrick è infatti l’oggetto privilegiato del suo bellissimo intervento, nel quale la studiosa californiana spinge a fondo i registri del sentimento e della razionalità per restituirci una riflessione esemplare sui meccanismi che sovrintendono alle trasformazioni del reale. L’immaginazione tecnologica utilizzata dai due registi non è altro, in fondo, che una disperata dichiarazione di nostalgia, dove l’elemento del rimpianto è proprio l’immaginazione, destinata nel nostro tempo ad essere espropriata da un futuro concepito come già passato. In tal senso risultano altamente simboliche quelle che Vivian Sobchack chiama le «macchine dell’amore» di A.I., ovvero Gigolò Joe e David, «manichini» da lei definiti «culturalmente significativi». Nella loro tragica serietà è contenuto tutto il nonsense esistenziale contemporaneo, cioè la perdita dolorosa dell’iden-
22
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
INTRODUZIONE
tità individuale, robotizzata e clonata. Appare evidente come il ruolo di tanti protagonisti robotici, presenti nel cinema di SF di ieri e di oggi, esprima da sempre la dolente condizione di un corpo vuoto, abbandonato e profanato, denaturalizzato dalla sua stessa virulenza tecnologica. Pur nella sostanziale differenza dei registri narrativi che distinguono le vicende dei due protagonisti, Joe e David sono infatti uniti da un medesimo destino: la perdita della loro umanità, subìta e compianta, senza che ciò comporti però alcuna rassegnazione. Con il suo contributo su David Cronenberg, Philip Rouyer riscopre lo stretto legame che – per la verità da sempre – unisce fantascienza e orrore. Si tratta tuttavia di un orrore «aggiornato», descritto in tutte le sue efflorescenze anatomiche, in tutti i suoi liquami organici. Rouyer affronta lo spettacolo gore, o splatter che dir si voglia, offerto dalle nefandezze tanto care al regista canadese e che, al di là di una superficiale ostentazione degli effetti sanguinolenti dei corpi martirizzati, sembra richiamare ben altri massacri reali squadernati, più che mai negli ultimi tempi, dall’informazione televisiva. Nei film di Cronenberg si ritrovano in fondo, anche se con diversi effetti di fisicità, gli stessi corpi profanati di cui parla Vivian Sobchack. A cambiare è lo schema narrativo dell’oltraggio che, nella relazione Rouyer, è visibile, nauseante, esteriorizzato fino all’eccesso, volutamente teatrale, mentre in quella di Sobchack è assolutamente invisibile, interiore, quasi impalpabile, anche se percepito attraverso un disagio esistenziale non meno inquietante delle mostruosità di Cronenberg. Aver fatto il punto sulla stato più avanzato della ricerca, in una materia resa così incandescente anche per la sufficienza con cui viene considerata da molta parte della critica, è stato il principale merito di questo Colloquio di cinema organizzato dall’Associazione Malatesta nei suoi appuntamenti di Ischia. Si è tentato, in primo luogo, di tracciare i contorni di nuove cartografie, di nuove mappe dell’angoscia, non più solo evocata di fronte alle scoperte scientifiche bensì plasmata dalle invenzioni della tecnologia. Perché anche i progressi della tecnica, sembrano dire i nostri autori, come i postulati della scienza, rimandano agli interrogativi sulle nostre origini: «cosa c’era prima del Big Bang, cosa ci sarà alla fine?». Ma, soprattutto, in quale segmento della propria traiettoria cosmica si trovi oggi l’uomo, stret-
23
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
FRANCO MONTELEONE
to tra la rimessa in causa di vecchie certezze e la dolorosa acquisizione di nuove incertezze. Se è vero, come da molti è stato osservato, che 2001 Odissea nello spazio segna una linea di confine assai netta tra il vecchio e il nuovo racconto fantascientifico, credo non sia azzardato affermare che sono ancora i modelli proposti dalla cosmologia e dall’astrofisica ad essere quelli più vicini al senso delle origini e ai miti che l’hanno accompagnato. Si potrà aggiungere che il positivismo meccanicistico e cibernetico ne rappresenta, certo, un complemento indispensabile dal punto di vista creativo, ma le domande sono ancora sempre le stesse: «da dove veniamo, dove stiamo andando, in che relazione siamo con gli altri?». Proprio il «mito», al quale giustamente si era richiamato La Polla, è ricco di motivi che mostrano le difficoltà del sé di capire se stesso, le fragilità dei confini che bisogna pur tracciare fra l’«io» e l’«altro». Carl Gustav Jung, più di Sigmund Freud, è dunque il «veggente» moderno, il creatore di fiabe e di miti della civiltà industriale, che può esserci maggiormente utile per capire i movimenti sotterranei della SF più recente. In secondo luogo, è sotto gli occhi di tutti quanto la neuropsicologia, la genetica, la neurochimica, gli studi sull’intelligenza artificiale e la psicologia analitica e clinica siano alla base dei sedimenti dell’esistenza mentale sempre più al centro dell’indagine creativa degli autori di SF. Le modalità tecnologiche della rappresentazione dei plot narrativi non esauriscono la supremazia di un campo di osservazione che, ancora una volta, resta eminentemente cognitivo, almeno nei casi di maggiore eccellenza dei prodotti cinematografici, tra i quali personalmente colloco senza alcun dubbio A.I. Tutti i generi narrativi, da sempre, hanno dato vita a modelli culturalmente alti o bassi, a seconda del punto di vista in cui decideva di collocarsi il loro autore; ma soprattutto a seconda dell’esito finale che egli intendeva raggiungere. La SF non fa eccezione. In terzo luogo, va osservato che, per quanto in maniera assai cauta e dimessa, nella quasi totalità delle relazioni affiora comunque la questione dell’identità americana. Non è un caso. Se è vero che viviamo un’epoca profondamente neoellenistica, oggi Bisanzio è al di là dell’Atlantico. I simboli non sono quisquilie: ad essere distrutte sono state le torri gemelle, non la Tour Eiffel. Quanto allora dell’ideologia americana, che non esaurisce certo tutta l’identità della nazio-
24
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
INTRODUZIONE
ne, ma che ne rappresenta la parte più visibile, è presente nella SF d’oltreoceano, ovvero nella SF tout court? Sarebbe stato tuttavia interessante se a questo interrogativo qualcuno dei relatori avesse dato una risposta esauriente. È noto che l’ideologia americana è tra le poche ad essere «quotata in borsa», come la sua lingua, la sua cultura, il suo costume, i suoi prodotti. Eppure, tranne pochi accenni, nelle relazioni del Colloquio l’argomento non ha avuto il risalto che avrebbe meritato. Non ho la competenza per affrontare l’argomento, mi limito a registrare solo un’assenza, forse non del tutto casuale, nel panel degli interventi. Senza voler fare della cattiva sociologia, la verità è che il cinema, tutto il cinema, soggiace in maniera assoluta al suo rapporto con la società, con il gusto corrente, con il ruolo egemonico della nazione che lo esprime. L’America postmoderna è, in tal senso, una miniera privilegiata di storie, di stimoli, di umori, di narrazioni; e il cinema degli Stati Uniti è ancora il messaggio più accettato del loro dominio imperialistico. I cosiddetti «grandi racconti», dei quali Jean François Lyotard segnala la scomparsa nella narratività europea, è ancora l’America a produrli, se non altro con le guerre e con le tecnologie. Non è riduzionismo creativo, ma la forma attuale della creatività, che è soprattutto americana. Non c’è nulla di cui scandalizzarsi. L’impero ha le sue bassezze ma anche le sue grandezze. E l’ellenismo, nessuno vorrà contestarlo, è stato un periodo splendido di fioritura letteraria e artistica: la fantascienza nel cinema ci richiama forse a quella lontana stagione nel momento in cui ne dispensa le sue ultime creazioni.
Il volume raccoglie gli interventi relativi al Colloquio di cinema «Science Fiction» svoltosi all’Hotel La Villarosa di Ischia il 14 e 15 marzo 2002, organizzato dalla Associazione Sigismondo Malatesta con il Patrocinio dell’Amministrazione Provinciale di Napoli e del Comune di Porto d’Ischia, a cura di Franco La Polla, Franco Monteleone, Paolo Amalfitano.
25
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
NOTA BIBLIOGRAFICA
AA.VV., Mostri al microscopio. Critica del cinema catastrofico, Marsilio, Venezia 1980. J. BAXTER, Science Fiction in the Cinema, Tantivy Press/Barnes, London-New York 1970. J. BROSNAN, Future Tense. The Cinema of Science Fiction, St. Martin’s Press, New York 1978. S. BUKATMAN, Terminal Identity. The Virtual Subject in Postmodern Science Fiction, Duke UP, Durham and London 1993. D. GIFFORD, Science Fiction Film, Studio Vista/Dutton Pictureback, London 1971. W. JOHNSON (ed.), Focus on the Science Fiction Film, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1972. G. KING, T. KRZYWINSKA, Science Fiction Cinema. From Outerspace to Cyberspace, Wallflower, London 2000. B. L ANDON, The Aesthetics of Ambivalence. Rethinking Science Fiction Film in the Age of Electronic (Re)Production, Greenwood Press, Westport 1992. P. LUCANIO, Them or Us. Archetypal Interpretations of Fifties Alien Invasion Films, Indiana UP, Bloomington & Indianapolis 1987. K. NEWMAN, Apocalypse Movies. End of the World Cinema, St. Martin’s Griffin, New York 2000. C. PENLEY, E. LYON, L. SPIGEL, J. BERGSTROM (eds.), Close Encounters. Film, Feminism, and Science Fiction, University of Minnesota Press, Minneapolis-Oxford 1991. C. PENLEY, NASA/TREK. Popular Science and Sex in America, Verso, London-New York 1997. R. ROBERTS, A New Species. Gender and Science in Science Fiction, University of Illinois Press, Urbana and Chicago 1993. J.H. RUSHING, T.S. FRENTZ, Projecting the Shadow. The Cyborg Hero in American Film, The University of Chicago Press, Chicago & London 1995. P. SCHELDE, Androids, Humanoids, and Other Science Monsters. Science and Soul in Science Fiction Films, New York UP, New York and London 1993.
27
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
FRANCO MONTELEONE J.S. SHAPIRO, Atomic Bomb Cinema. The Apocalyptic Imagination on Film, Routledge, New York and London 2002. C. SHARRETT (ed.), Crisis Cinema. The Apocalyptic Idea in Postmodern Narrative Film, Maisonneuve Press, Washington 1993. J. SICLIER, A. S. L ABARTHE, Images de la science fiction, Ed. Du Cerf, Paris 1958. V. SOBCHACK, Spazio e tempo nel cinema di fantascienza, BUP, Bologna 2002. M. SPANU (ed.), Spazio, Lindau, Torino 2002. M. SPANU, Science plus Fiction. La fantascienza tra antiche visioni e nuove tecnologie, Lindau, Torino 2000. J.P. TELOTTE, Replications. A Robotic History of Science Fiction Film, Illinois UP, Urbana-Chicago 1995.
Per uniformare le citazioni filmografiche si è fatto riferimento al Dizionario dei film 2002 Il Mereghetti, scegliendo tuttavia di eliminare i segni di interpunzione, spesso discordanti, presenti nei titoli, anche per comodità di lettura. Nelle relazioni in italiano l’espressione Science Fiction è stata abbreviata in SF. Essa viene invece mantenuta nei testi originali, francese e americano, di Rouyer e di Sobchack dal momento che in quelle due lingue essa è l’esatto corrispettivo della parola italiana «fantascienza». Infine, la nota bibliografica è da intendersi come essenziale e comunque relativa alla sola fantascienza cinematografica. Nello stenderla si è tenuto conto unicamente di volumi critici a carattere generale sulla fantascienza o su alcuni ampi aspetti di essa. (N.d.C.)
28
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
LA LOCOMOTIVA E L’ELFO. TECNICA E FANTASIA NEL CINEMA DI FANTASCIENZA di ROMOLO RUNCINI
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
La fantascienza, come tutti i generi e sottogeneri narrativi – a differenza della cosiddetta letteratura «alta» che vanta piena libertà, dove troviamo insieme capolavori e cianfrusaglie senza etichette – è un modello narrativo ben codificato nella sua struttura e nella sua prospettiva. Interno ed esterno, scrittura e argomento debbono poter corrispondere, nel momento in cui si configura l’idea del racconto di fantascienza, alle norme di libera fantasia dello scrittore e di congrua riflessione sullo stato della scienza. Nell’incontro fra letteratura e scienza, pur emergendo istanze coordinate di giustizia (utopia) e di libertà (distopia), ad armare la coscienza dell’uomo alla conquista della verità – l’ignoto, un territorio da esplorare – non è più un sogno, il richiamo dell’Eden, ma un progetto. È sulla potenza dell’armamentario tecnologico, non sulla volontà individuale, che la comunità umana – nella veste dello scrittore di SF – avverte, per la prima volta, di esser pronta a confrontarsi con l’Universo. La strumentazione tecnologica fa ora da base strutturale per ogni futura esperienza soggettiva e collettiva, conseguendo lo stravolgimento di prospettiva del piano di realtà dove al punto d’incidenza dell’antico rapporto interindividuale – il rapporto d’interessi personali e sociali – si affianca e poi si sostituisce quello della mediazione del sistema-macchina nell’orientamento sempre più ampio e complesso dell’interazione quotidiana. Come il genere gotico o avventuroso, storico o poliziesco, la SF nasce da un evento che ha sortito effetti profondi nell’immaginario sociale del tempo. Ma l’assimilazione di un evento sociale in un fatto letterario non è immediata e richiede, nella sua specifica elaborazione tematica e lessicale, almeno tre condizioni: a) la presenza emergente o latente dell’evento preso in esame; b) l’esistenza di un
31
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
ROMOLO RUNCINI
modello narrativo capace di contenerlo o, diversamente, l’invenzione di un nuovo modello pronto a identificarlo; c) l’istanza di un pubblico (classe egemone o subalterna) inteso ad affrontare o esorcizzare l’evento. Queste tre norme – credibilità, rappresentatività, fruibilità dell’evento – costituiscono il quadro di riferimento essenziale dello scrittore, necessario all’assunzione del fatto sociale in fatto letterario. In tal modo l’evento, accreditato come argomento nel genere letterario a esso rispondente, diventa la chiave di lettura di qualsiasi testo che ottemperi alle norme suddette. Naturalmente tali norme, sempre soggette alla doppia valenza dell’abilità dello scrittore e della tendenza di mercato, possono sfumarsi in regole più flessibili verso l’alto o verso il basso, ma non perderanno mai il loro intrinseco valore di codice letterario del genere predisposto, pena la sua estinzione. In campo cinematografico queste norme di funzionalità narrativa dei generi sono anche più evidenti e vengono osservate con più rigore rispetto a quelle letterarie. Alla nascita del film – in quanto opera composita di comunicazione espressiva e di organizzazione industriale – presiede la necessità di inquadrare il suo tema, nei repertori di classificazione e diffusione del prodotto da lanciare sul mercato, già all’origine dell’idea progettuale, nello script prima ancora del copione e dunque con largo anticipo sull’effettiva realizzazione del film. Bisogna dire che l’apparizione del cinematografo fu in se stessa un evento di novità sconvolgente e premonitoria. Nato sotto l’aureola di allegria e spensieratezza nel ruolo di intrattenimento da boulevard, dovette ben presto assumere la funzione di controllo produttivo della sua più o meno nobile mercanzia potenziando – a causa dei costi sempre più elevati dell’intero sistema di lavorazione (teatri di posa, macchinari, tecnici, registi, attori, comparse) – la propria originaria struttura dilettantesca per trasformarla in una vera impresa industriale. Le prime case cinematografiche, la Pathé e la Gaumont in Francia, la Biograph e la Vitagraph (Armat-Edison) in USA riuscirono a sviluppare e diffondere la loro produzione, dopo il grande successo dei documentari dei fratelli Lumières e dei primi film di Georges Méliès, solo valutando e sondando in anticipo l’area di risorse della domanda merceologica e provvedendo in merito. È il cinema dunque
32
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
LA
LOCOMOTIVA E L’ELFO.
TECNICA
E FANTASIA NEL CINEMA DI FANTASCIENZA
a metter subito in evidenza, nel suo passaggio di secolo dall’Ottocento al Novecento, come la sfrenata concorrenza industriale delle nazioni europee, che le getterà nella fornace della guerra mondiale, finirà per spingere il libero, anarchico capitalismo imprenditoriale alla rovina, sostituendolo con la formazione organizzata dei monopoli e con una programmazione manageriale a vasto raggio. Negli anni tra le due guerre la concentrazione burocratica nelle attività produttive, che segna l’avvento della società di massa, la settorializzazione scientifica e lavorativa, il mercato mondiale, l’influsso diretto dei primi potenti mass media porteranno la letteratura e il cinema insieme a denunciare lo svuotamento e la scomparsa dello spazio socio-economico dell’individuo, ossia la caduta dello stesso simbolo di ogni libertà d’azione della borghesia, il self made man. Ma la premonizione della «settima arte», che abbraccia così un secolo di Storia, riguarda non solo le modalità di evoluzione tecnologica del mondo, bensì anche la trasformazione antropologica del nostro stesso modo di vedere il mondo. La segmentazione in parti brevi e continuamente alternate dell’immagine cinematografica corrisponde – data la velocità di scorrimento della pellicola – alla portata delle funzioni fisiologiche della percezione visiva, dunque al bisogno di coinvolgere lo spettatore nell’atto stesso di osservazione e rilevamento della realtà fenomenica. Gli occhi di un lettore di libri si muovono costantemente verso destra seguendo il piano di scrittura statuito nella civiltà occidentale (verso sinistra nella civiltà araba, ebraica, orientale), si attivano cioè come ricognitori di segni statici predisposti in uno spazio chiuso. Per il cinema l’atto di visione è opposto a quello della scrittura, non descrive ma (tranne i reportages in diretta) costruisce la realtà. Pertanto il linguaggio filmico non sarà più lineare e estensivo, ma intensivo, intermittente, pari alla capacità dell’occhio umano di cogliere simultaneamente la forma e il colore, il sopra e il sotto di una cosa. Questo nuovo linguaggio testimoniale e creativo comporta una mutazione profonda di registro nel rapporto uomo-mondo: l’occhio attivo non è più quello umano ma quello dell’obiettivo della macchina da presa, mentre gli occhi dello spettatore restano fermi, pronti a ricevere. Così la segmentazione in frammenti scenici della pellicola filmica e del relativo copione cinemato-
33
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
ROMOLO RUNCINI
grafico costituisce la base progettuale della grande invenzione di questo linguaggio per immagini, il montaggio. Dal punto di vista storico è nel grande laboratorio linguistico e figurativo delle Avanguardie novecentesche, dagli anni Dieci agli anni Trenta, che il cinema, arte minore, doveva restituire alla figura emblematica della metafora una rinnovata possibilità di riappropriarsi del rapporto estetico fra convenzionalità e rappresentatività del segno creativo. Ma la vecchia metafora analogica, l’anàlogon naturale, andava sempre più rapidamente perdendo il suo potere evocativo di riferimento col mondo reale sotto l’incalzante sviluppo della tecnica industriale protesa al dominio totale dei livelli operativi, amministrativi e comunicativi della società. La Natura, come atavico anàlogon dell’uomo della civiltà rurale, fungeva – dal Rinascimento all’Illuminismo – da valido, tradizionale supporto del soggettivismo umanistico in quanto speculare al suo mondo organico, centro assoluto di produzione di senso, debitamente contrapposto al mondo meccanico, subalterno, del fare. Nella seconda metà del Settecento proprio la grande Encyclopédie des Arts et des Métiers (1751-72) aveva dato una spallata a questa concezione elitaria, che fu democratizzata e assunta dalla borghesia trionfante con la Rivoluzione francese a simbolo dei principi di libertà, eguaglianza, fraternità. Sul piano della comunicazione la metafora analogica, in quanto doppio della realtà, rispondeva sempre e comunque all’istanza di valorizzazione del senso estetico come forma intransitiva, estranea alla banalità del reale. La realtà della Natura, come oggetto assoluto, garantiva e legittimava la menzogna dell’Arte quale specchio illusorio della vita. Nella fase di capitalismo avanzato – quella dei monopoli e della prima automatizzazione del macchinario industriale – con la nascita e lo sviluppo impetuoso di nuovi mezzi di comunicazione, dalla fotografia a colori alla stampa in offset, al cinema che con le proprie sale cittadine sta insidiando il teatro, il rapporto fra soggetto e oggetto sul piano informativo acquista punti di vista e prospettive diverse dal passato, ben più penetranti e dirompenti, nell’ambito della collettività, di quelli tradizionali del vecchio sistema delle Arti. L’anàlogon dell’uomo non è più la Natura bensì la macchina: non è la creatività demiurgica ma la riproducibilità tecnica. Il mondo meccanizzato ricostruisce se stesso sul piano dell’Arte attraverso la fram-
34
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
LA
LOCOMOTIVA E L’ELFO.
TECNICA
E FANTASIA NEL CINEMA DI FANTASCIENZA
mentazione di elementi adattabili, interscambiabili, entro un mosaico di forme e colori perpetuamente rinnovabile e dichiaratamente privo di senso. La tecnica «eterno ritorno dell’identico» (Heidegger, 1947) diventa il nuovo strumento di scrittura del mondo, la molla di una tensione sociale senza tregue né finalità. All’anàlogon naturale si è dunque sostituito l’anàlogon artificiale, tecnologico. Ed è proprio il cinema che, con l’assunzione delle tecniche riproduttive, recuperando la soggettività dell’artista in una scrittura composita, polivalente, globale (racconto fotografico, teatrale, musicale), assicura al segno filmico la dovuta distanza semantica dal senso comune e con ciò l’autonomia espressiva di primo modello generativo dell’arte moderna. Il nuovo metodo della reversibilità del segno – la sua manipolabilità figurativa come la creta e i colori, la sua non diretta consumabilità, il suo linguaggio «altro» rispetto a quello delle pratiche sociali come a quello dei modelli vetero-artistici – consente al cinema di passare (grazie agli effetti tecnici dell’inquadratura, della carrellata, della dissolvenza, etc.) a una struttura di comunicazione regolata dai profitti di mercato, pur conservando il nuovo potere di nominazione sul sistema degli oggetti nella scelta deliberata del regista entro il complesso e variegato orizzonte dei materiali impiegati. Ciò accade appunto per la scoperta del montaggio come atto meccanico produttivo dell’immagine in movimento ricavata dall’accumulo di frammenti iconici; modello di visualizzazione dinamica di una realtà inerte, incomunicabile, innervata solo dalle scelte progettuali dell’artista e resa viva, attuale nell’invenzione dell’artificio tecnologico; atto di scomposizione spazio-temporale della figura nel suo habitat fenomenico e sua conversione e ricomposizione eidetica in uno spazio e tempo irreali che le conferiscono però, con la nuova ars combinatoria, autenticità di presenza. Con il montaggio si ha il più alto grado di formalizzazione dell’immagine, di cui le tecniche pittoriche, narrative, poetiche e musicali delle Avanguardie novecentesche si varranno come del primo linguaggio espressivo multimediale dell’età contemporanea. Ora un corretto inquadramento genealogico del cinema di fantascienza, inteso a identificarne le origini, la struttura narrativa e le motivazioni di fondo, non può che rinviare al genere già costituito in ambito letterario il quale, di fatto, lo precede. Pertanto, se possia-
35
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
ROMOLO RUNCINI
mo tralasciare le origini leggendarie di una fantascienza fatta di mostri, di paesi meravigliosi oltre le montagne, di attese messianiche dal mare – un profilo letterario nato con Una storia vera di Luciano di Samosata nel II secolo d.C., seguito poi dagli innumerevoli testi utopici di More, Rabelais, Cyrano de Bergerac, Campanella, Vairasse, Bacon, Fénelon, Mandeville – e soprattutto ricordando la scarsa affidabilità dei mezzi di trasporto indicati per il raggiungimento di città ideali o regni paradisiaci (cicogne, angeli, demoni o, più semplicemente, sogni) dovremo riandare almeno al decennio terminale della metà del XIX secolo in Inghilterra, tra il 1840 e il 1850, allorché la Rivoluzione industriale si è pienamente affermata in questo Paese prima che altrove. È l’età della «railway mania», quando il treno non è più una curiosità da baraccone ma è già entrato, con l’entusiasmo delle classi medie e le leggi innovative del Parlamento (1835-45), nel quadro di un sistema ferroviario stabile e funzionante con cui si inaugurano le insegne di potenza del Progresso, presto celebrate nella città di Londra con la Great Exibition (1851) fatta per esaltare fra la gente il primato della tecnica nella felice età vittoriana. Questa varietà ormai numerosa di commercianti, impiegati, funzionari che crede nel Progresso e apprezza la lettura di giornali e di libri (resa più ampia e disponibile dai pacchi di quotidiani nazionali e volumi trasportati per ferrovia) è il pubblico, destinato a seguire i percorsi attuali e incisivi della narrativa britannica, che dalle speranze e delusioni di Dickens, della Gaskell, di Thackeray porteranno alle visioni futuribili di Herbert George Wells. Ma all’entusiasmo di questa gente, che prende a viaggiare in treno per le dolci campagne del Sussex o per le larghe vallate del South Wales spingendosi talora agli altopiani scozzesi, fa riscontro un acceso rifiuto della ferrovia da parte di artisti e intellettuali che vedono oltraggiato il paesaggio della Natura. Al proposito John Ruskin dichiarava apertamente di detestare le ingombranti ferrovie poiché avevano tagliato fuori e calpestato alcuni dei più deliziosi scenari campestri. Dickens descriverà in Hard Times (1848) altri scenari devastati e devastanti come le miniere di carbone e le fabbriche metallurgiche dove i grossi pistoni di macchine sempre in azione ossessionano col rumore e col fumo ben più dei fantasmi e delle streghe dei romanzi gotici.
36
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
LA
LOCOMOTIVA E L’ELFO.
TECNICA
E FANTASIA NEL CINEMA DI FANTASCIENZA
La spinta al Progresso si fa comunque strada nell’immaginario sociale dell’Inghilterra vittoriana. È la conquista ufficiale del mondo che lavora e produce da parte della borghesia che non governa ma domina economicamente il Paese. Attraverso il treno – e lo stesso Dickens sarà affascinato dalla potenza di questo utile mostro disegnato nei suoi racconti ferroviari, The Signalman e Mugly Junction – l’idea del viaggio, da termine peregrino, astratto, associato solo alla funzione educativa del giovane aristocratico che partiva per il Grand Tour nel Sud del Continente, diventa, per una larga fascia della media e piccola borghesia, un’opportunità concreta di trasferirsi per qualche tempo fuori città. Il viaggio, quello moderno e affidabile del treno (con tutti gli incidenti che possono accadere per questo potente mezzo di locomozione pesante e veloce) è sempre una ricerca del diverso, un incontro e un confronto con gli altri. Sul viaggio s’impernia tutta la narrativa di Jules Verne, il quale anticipa con la sua fervida passione tecnologica talune forme e strutture di mezzi aerei e navali, aprendo un vasto orizzonte di memorie su esplorazioni scientifiche e archeologiche. Ma è a Wells, al suo famoso scientific tale, The Time Machine (1895), che dovremo riferirci se vogliamo davvero incontrare il primo autentico racconto di fantascienza. Qui non c’è l’enorme proiettile di cannone, con uomini a bordo, sparato dalla Terra alla Luna a rappresentare una macchina immaginaria per il futuro trasporto spaziale, ma una piccola sfera metallica, dotata di una strumentazione tecnologica operativa che la rende autonoma per la sua spinta propulsiva, un veicolo che gira su se stesso tanto velocemente e vorticosamente da scomparire dalla realtà circostante uscendo così dal cronotopo spazio-temporale e liberarsi dalla legge di gravità. La sfera, sottraendosi alle norme e condizioni fisiche del nostro pianeta, viaggerà nel passato e nel futuro incontrando scenari di vita preistorici e avveniristici che apriranno a loro volta nuove prospettive di ricerca nel viaggio verso l’ignoto da cui, in campo narrativo, sorgeranno le affascinanti avventure lanciate alla scoperta di mondi perduti e civiltà delle macchine. Con questa macchina tecnologica, energeticamente attrezzata a fini produttivi – ben lontana dai brillanti automi meccanici di Vaucasson, che divertivano la Corte di Luigi XIV – con questa macchina capitalistica, posta idealmente al ser-
37
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
ROMOLO RUNCINI
vizio del sistema industriale, nasce il paradigma iconico e verbale della SF. Sul piano storico la prima macchina capace di assumere in sé l’energia dello sforzo animale moltiplicata meccanicamente è senza dubbio la locomotiva a vapore: la sua forza energetica accumulata e compressa per la spinta propulsiva viene originariamente calcolata in horse power. Il meccanismo inerziale messo in moto dalla funzione termoregolatrice del motore e dalle valvole di scarico del gas rendono la locomotiva una macchina autonoma nel suo sistema di trazione e di corsa; il suo impiego su scala industriale, riproducendo e superando di gran lunga l’antica potenza degli animali domestici al lavoro, esclude ormai l’idea antropomorfica di un prolungamento artificiale della muscolatura umana e rivela la nuova macchina come apparato tecnologico produttivo a se stante, a suo modo vitale nella considerazione organicista dell’evoluzionismo romantico sostenuto e diffuso dalla Naturephilosophie. Di fatto la vecchia locomotiva «Rocket», dell’ingegner Stephenson, diventerà un simbolo vivo di potenza tecnica e nazionale nel lungo corso dell’immaginario vittoriano. La potenza della macchina, la sua autonomia funzionale e operativa, il suo credito vitalistico, finiscono poi col tempo per lasciare spazio ai timori di una eventuale perdita del suo pieno controllo sociale. Sono i timori di Wells – e prima ancora di Carlyle, di Dickens, di Morris – il quale in The Time Machine intravede il pericolo di un duro scontro di classe fra i beati Eloi (gli imprenditori) e i selvaggi Morlocchi (gli operai), e in The Island of Doctor Moreau (1897), seguendo il rapido sviluppo della strumentazione medica, coglie la minaccia di esperimenti disumani praticabili da ricercatori senza scrupoli. I timori per il conflitto sociale (già avvertiti da Disraeli con Sibyl, or The Two Nations, 1842) nonché per gli scienziati pazzi costituiranno, possiamo dire, lo sbocco di una lunga produzione editoriale di area fantascientifica che, dalla narrativa al cinema, è giunta più o meno gloriosamente fino a noi. L’impatto della macchina sulla scrittura letteraria e filmica è dunque ambiguo: la sua potenza ci esalta e ci minaccia; il suo lato oscuro rinvia, per contrasto, a elementi e fattori irrazionali che agiscono nel vissuto umano ma non possono, non debbono intaccare la macchina.
38
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
LA
LOCOMOTIVA E L’ELFO.
TECNICA
E FANTASIA NEL CINEMA DI FANTASCIENZA
La seconda figura emblematica della SF, quella che ho indicato, dopo la locomotiva, come enigma dell’elfo, sta qui a indicare il motivo per cui questo genere letterario e artistico non è riducibile all’esperienza unica e totalizzante della Tecnica, pena la sua irrimediabile caduta nel cronachismo della divulgazione scientifica. Lo scrittore di fantascienza, che ha scoperto nella razionalità e potenza della macchina il fattore evolutivo (e lacerante) della modernizzazione sociale, che ne ha colto con timore l’indipendenza operativa, l’automatismo, fino a proiettarla in un mondo parallelo, deve valersene non già come oggetto di studio, ma come ingrediente narratologico, come ipotesi, opportunità da non prendere sul serio, da non considerare in senso didascalico, ma da utilizzare ai fini della sua creatività. È proprio dalla fantasmagoria degli spettri gotici e dickensiani narrati nella notte di Natale davanti al caminetto acceso; dalla florida e luminosa cristallizzazione di fiori e d’insetti nel tappeto vegetale della pittura preraffaellita; dalle saghe e leggende scozzesi e irlandesi sulla vita del piccolo popolo di gnomi, coboldi ed elfi vaganti negli anfratti erbosi delle foreste; è dal brulicare di figure minute e umbratili avvolte nel mistero di un mondo antichissimo, fuori del tempo, indicato dalle fiabe nel tradizionale incipit – «C’era una volta…» – che la SF riceve un vasto patrimonio di cultura popolare dove magia, incantesimo e superstizione vibrano all’unisono per il riscatto ideale e ideologico della Natura. Questo mondo ancestrale che la clerisy britannica intende difendere per una intima esaltazione della bellezza, con tanto ardore e impegno da farne la via maestra di una prossima interiorizzazione della realtà, la borghesia vittoriana e benthamista vuole invece annetterlo ideologicamente a suo parametro politico quale mondo delle origini arcaiche propriamente celtiche della Old Merry England, prima di essere legata alle sorti dinastiche dell’aristocrazia. La scoperta della tradizione celtica serve così alla borghesia come autorevole legittimazione ad appropriarsi culturalmente dello spirito del tempo, che diventa sentimento nazionale, mentre lascia libera la monarchia di riscattare il proprio onore e prestigio ripristinando i rituali di antiche e fastose cerimonie militari e civili. L’«invenzione della tradizione» – di cui per l’antico lessico della scrittura celtica il poeta James Macpherson, scozzese, aveva dato esempi popolarmente assai diffusi con i canti del bardo Ossian, in
39
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
ROMOLO RUNCINI
Fingal (1762) e Temora (1763), prontamente denunciati come falsi dal solerte dottor S. Johnson – costituisce, com’è stato detto, il frutto testimoniale della prima forma di organizzazione politica e culturale dell’opinione pubblica a evidente motivo di dominio ideologico. In questo orizzonte confuso e contraddittorio l’elfo entra autorevolmente come personaggio autentico del mondo fiabesco anglo-gaelico, una leggenda ancora viva che offre alla scrittura fantastica l’avvio più enigmatico e inquietante per i sentieri sotterranei della psiche. Dalla leggenda celtica la figura dell’elfo passa a diventare uno stereotipo popolare di antiche presenze magiche, lo spirito dei boschi, che l’immaginario sociale finisce per proiettare in un mondo parallelo a quello storico, un mondo elementare e selvaggio, oscuro e intimo, con rituali suoi propri in cui si fissano scenari e desideri infantili di libertà, solidarietà e fantasia, lontani dall’apparato etico-religioso vigente impostato sulle norme di piena responsabilità dell’adulto necessarie allo sviluppo moderno della nazione britannica. L’elfo, che per artisti e scrittori è un campo aperto, inesplorato di verità sapienzali e bellezze della Natura – elementi congrui, stabili di una vocazione esistenziale pronta a far da diga all’irruente fiume della modernità – farà parte di una sensiblerie naturista largamente diffusa nelle classi medie, che hanno accettato il pittoresco come cultura della stravaganza facendone occasioni di moda nell’arredamento, nei giardini, nelle gite turistiche dei week end. Insomma l’elfo è una maniera di guardare il mondo con leggerezza, senza l’impegno quotidiano del lavoro; è un ornamento naturale/culturale della scrittura, della pittura, come la «grottesca», alla fine del Rinascimento, era stata esempio di ibridismo umano/teriomorfico/vegetale a cornice di porte o di grandi affreschi. La SF, ultima fase diegetica del fantastico, assumerà anch’essa la figura dell’elfo come esempio di carattere morbido e umbratile della condizione umana da porre a confronto o a contrasto con la rigidità e rigorosità del sistema-macchina essenzialmente improntato alle norme della logica razionale. Così sarà la reazione pulsionale del nostro corpo, l’emotività, quel tocco di leggerezza nel gesto e nel tono rivelatore della sensibilità di fronte agli eventi, a distinguere l’uomo – posto ormai sotto l’insegna di una civiltà che minaccia l’autenticità della Natura – dall’altro da sé, dalla perfetta clonazione degli
40
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
LA
LOCOMOTIVA E L’ELFO.
TECNICA
E FANTASIA NEL CINEMA DI FANTASCIENZA
androidi. L’elfo, quale contrassegno della animalità selvaggia di una spirito autoctono della foresta, offre dunque alla SF un’ampia risorsa naturale di immagini e sensazioni disposte a mantenere in campo il giusto equilibrio fra Tecnica e Fantasia. La prima locomotiva che irrompe sullo schermo di una seduta d’intrattenimento cinematografico nel Boulevard des Capucins a Parigi è quella di Louis Lumière, L’arrivée d’un train (1896) che sbalordisce e spaventa la piccola folla assiepata nel tendone circense e la costringe a scappare. Verità, finzione? Il cinema comincia così, alla radice di ogni forma di curiosità e conoscenza. Georges Méliès, che dai documentari dei fratelli Lumières, inventori del Cinematografo, passa a brevi film sceneggiati su imprese spaziali ispirate, con una certa malizia, ai poemi avventurosi di Jules Verne, introduce nella nuova Arte il gusto e i percorsi accidentati del racconto; dal 1898 al 1900 compone Faust e Margherita, Pigmalione e Galatea, La fiamma magica, Il maniero del diavolo, Il diavolo in convento, brevi incursioni nel mondo mitologico e magico delle oleografie popolari, figurine di Epinal in movimento. Nel 1902 appare il capolavoro Voyage dans la lune (Il viaggio nella Luna) che unisce le due grandi opere di Jules Verne Dalla Terra alla Luna (1865) e di Herbert G. Wells, I primi uomini sulla luna (1901) giocando sull’enfasi descrittiva dello scrittore francese e sul rigore tecnico dell’inglese. Nel 1911 gira con estro umoristico Il barone di Munchausen assai apprezzato più tardi dai surrealisti. Méliès è considerato il padre della fantascienza filmica. Nel 1919 esce in Germania Il gabinetto del dottor Caligari di Robert Wiene, un racconto tenebroso di sapore hoffmanniano condotto su un fermo scenario teatrale nello sconvolgente, asimmetrico stile espressionista. Qualche anno dopo, nello stesso stile tormentato fin dalle fondamenta dei muri di case e stanze ecco Il dottor Mabuse (1922) di Fritz Lang. Con la ripresa della figura wellsiana del «dottore pazzo» (dottor Moreau) il primo, Caligari, è un illusionista cialtrone dedito a soggiogare con l’ipnosi le persone che entrano nella sua tenda dei misteri, allestita in un parco di divertimenti, e riesce a farne dei criminali – qui è il caso emblematico di un certo Cesare – pronti a uccidere al suo servizio. L’atmosfera chiusa degli ambienti stretti e oscuri in cui si perpetuano questi incontri conferisce
41
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
ROMOLO RUNCINI
al racconto l’immagine fascinosa e inquietante di una grossa ragnatela dove le mosche (la gente) vengono irretite e mangiate dal mostro che attende. Il secondo, Mabuse, un altro cialtrone enigmatico, è lui il criminale ma non uccide; il suo scopo è assai più ambizioso in quanto vuole distruggere l’economia della nazione per diventarne il padrone assoluto. Mestatore di idee e abile trasformista – si presenta come banchiere, poi come psichiatra e in altri ruoli – Mabuse affascina e soggioga la gente che incontra, e lo ascolta, finendo per corromperla e legarla con vari ricatti alla sua banda di criminali. I due subdoli protagonisti finiranno male; rappresentano entrambi la terribile situazione di crisi all’indomani della catastrofica sconfitta della Germania guglielmina. La Repubblica di Weimar si è appena insediata nella nazione ridotta economicamente all’estremo mentre l’idea di riscatto e di vendetta, per la «pugnalata alla schiena» sull’esercito che voleva ancora combattere, accende gli animi di gente disperata pronta a seguire ovunque i proclami e le promesse dei partiti di destra, i quali incalzano con forza i comunisti, assenti all’eco patriottica, insinuando contro i rossi e gli ebrei l’accusa di aver compiuto l’infame gesto. Fra questi partiti c’è il Nazionalsocialismo che avrebbe tentato, l’anno dopo Il dottor Mabuse, un colpo di Stato in una birreria di Monaco. Non si può certo parlare qui di senso profetico per Wiene e per Lang – il quale coglie più da vicino l’aspetto drammatico della caduta del marco e della progressiva miseria delle classi subalterne – dal momento che di fatto numerosi meneurs politici della destra arringavano le folle medio-borghesi nelle piazze cittadine denunciando l’onda rossa e la necessità di difendere la Germania, mentre socialisti e comunisti si sbranavano fra di loro e la «Costituzione segreta» (fra militari, industriali e nazionalisti) arruolava giovani disoccupati nelle leghe paramilitari. Questi due film anticipano non solo l’avvento di Hitler al potere ma – attraverso la simulazione delle tecniche ipnotiche furbescamente usate con buon profitto da un mago o da un superuomo sulle folle – anche il prossimo avvenire di un popolo che al richiamo suggestivo di un arrogante e bellicoso «profeta» si lascia defraudare della propria intelligenza per seguirlo nella fondazione e nella difesa del mito apocalittico e crudele del III Reich.
42
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
LA
LOCOMOTIVA E L’ELFO.
TECNICA
E FANTASIA NEL CINEMA DI FANTASCIENZA
Ma ben oltre il piano di questa evidente «strategia della tensione», oltre l’alea invadente e minacciosa della politica, dunque oltre i fermenti della quotidianità, è con Metropolis (1927) di Lang che la fantascienza filmica raggiunge una prospettiva di piena apertura al futuro, coniugando utopia e distopia in una visione grandiosa e allucinante del «mondo nuovo» instaurato dal sistema tecnologico delle macchine. Anche qui, proprio come in The Time Machine, è proiettata la netta divisione classista della prossima società, con una città superiore (dei borghesi) e una città inferiore (dei proletari); ma ciò che viene messo in evidenza è l’enorme grandezza del macchinario industriale: ruote e pistoni colossali in movimento costante, leve, manometri, piastre di controllo, e i gesti meccanici ripetitivi degli operai, e il terribile Moloch, l’immensa fornace per la fusione dei metalli. È il regno della Tecnica. Il robot di acciaio a figura femminile (che poi diventerà una donna nel corpo sinuoso di Brigitte Helm) mostra di sapersi muovere e di agire con energia e precisione preconizzando così l’automatismo delle fabbriche. Nel «mondo nuovo» l’individuo da solo non è più in grado di decidere, di operare: tutto è dominato dall’alto dei sistemi industriali e finanziari, che si avvalgono di una numerosa forza-lavoro, ben ordinata e integrata consensualmente all’apparato produttivo. Così Lang mette in scena, al momento giusto, la società di massa. Negli anni fra le due guerre forieri di grandiosi e tumultuosi eventi – diffusione dei monopoli merceologici e finanziari, seconda fase dell’industrialismo, burocratizzazione statale e aziendale, emergenza delle classi medie, Hitler al potere in Germania, avanzata del nazifascismo in Europa, guerra di Spagna (1936-39) – la SF trova una diretta opportunità di esprimere le istanze di smarrimento generale, di fuga utopica in avanti verso mondi lontani e forse migliori, o di frustrazione distopica per la situazione presente. Entusiasmo e paure per il futuro si concentrano, soprattutto in USA, con la nascita esplosiva dei pulp magazines, riviste popolari riccamente illustrate che parlano di viaggi interplanetari, di scienziati pazzi, di mirabili invenzioni tecnologiche e di fine del mondo. Nel nome di un prestigioso operatore culturale, Hugo Gernsback, escono numerose pubblicazioni più o meno curate da lui stesso: Weird Tales (1926), Amazing stories (1928), Wonder stories (1932), The Shadow (1933),
43
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
ROMOLO RUNCINI
Astounding stories (1933), Doc Savage (1934), The Spider (1938), Unknown (1940), con avventure spettacolari raccontate da scrittori di circostanza, ma anche da Howard Philips Lovercraft, Edgar Wallace, Rice Burroughs. In sintonia con un tale fervore fantascientifico il cinema statunitense produce opere di notevole valore, come Frankenstein (1931) di James Whale con un inquietante Boris Karloff che interpreta il ruolo della creatura mostruosa e The Bride of Frankenstein (La moglie di Frankenstein, 1935) pure di Whale e con la stessa maschera di Karloff. Nel 1933 esce una pietra miliare della SF, King Kong, di Ernest B. Schoedsack che unisce il mondo selvaggio a quello civilizzato, la giungla malese all’Empire State Building di New York. E in La fine del mondo, sempre del 1933, questa immensa metropoli americana appare sopraffatta e spazzata via da un maremoto. Con Il dottor X (1932) di Michael Curtiz, una storia di orrore cittadino, intrigante e spietata, e con Dr. Cyclops (Il dottor Cyclops, 1939) ancora di Schoedsack, riprendono i motivi angoscianti e crudeli del «dottor Moreau». Lo scienziato pazzo è una figura costante, emblematica di questi anni poiché al rapido sviluppo tecnologico in tutti i campi della scienza le si affiancano la follia delle tensioni politiche e sociali, nonché le frustrazioni personali di individui caratterialmente instabili. Così è per The Invisible Man (L’uomo invisibile, 1933) di James Whale, tratto dal romanzo di Wells, e per i due grandi film di Tod Browning, l’inquietante, grottesco, feroce Freaks (1932) e The Devil-Doll (La bambola del diavolo, 1936), un insidioso confronto tra scienza e fede; mentre con Things to Come (La vita futura Nel 2000 guerra o pace) di William Cameron Menzies, dello stesso anno, si aprono per tutti nuovi e più diretti profili minacciosi sul futuro. Gli anni Quaranta sono quelli del secondo conflitto mondiale, anni in cui con il potente film di Charlie Chaplin, The Great Dictator (Il grande dittatore), la cinematografia mondiale segue l’impegno ideologico e patriottico o il suo contrario, l’evasione. La SF non figura in nessuno dei repertori cinematografici, almeno fino al termine del decennio, dal momento che gli orrori della guerra e la scoperta dei campi di sterminio nazisti hanno ammutolito qualsiasi reazione.
44
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
LA
LOCOMOTIVA E L’ELFO.
TECNICA
E FANTASIA NEL CINEMA DI FANTASCIENZA
La ripresa trionfale del film di fantascienza si avrà negli anni Cinquanta; una rimonta con tanta ricchezza di temi e stilemi del genere, e successo di pubblico, da sbalordire qualunque storico del cinema. Sono questi gli anni della paura della «bomba» e della sfida mondiale tra due ideologie radicali, liberalismo e comunismo, incentrate in due grandi nazioni potentemente armate, USA e URSS. È iniziato il periodo della Guerra Fredda che avrà nei popoli e nei governi di tutti i Paesi ritmi di vita quotidiana di alta tensione. Due mondi si confrontano, si studiano, si pungolano tra loro destreggiandosi spesso sul filo del rasoio. Insieme alla rinascita della fantascienza il clima di sospetto generato da incomprensioni, tranelli, allarmi, dalle lunghe pratiche del check point nelle stazioni di confine fra Ovest ed Est disseminate in vari Continenti, e lo sbarramento totale del muro di Berlino, avviano una lunga serie di romanzi e film di spionaggio dai risvolti polizieschi sempre enigmatici. Ma è la SF il genere che rappresenta con maggiore ampiezza e profondità lo stato di spaesamento di fronte all’ambiguità e alla minaccia globale degli eventi. Proprio nel 1950 esce, di George Pal, Destination Moon (Uomini sulla Luna), storia di un audace viaggio spaziale, con astronave che alluna regolarmente e testimonianza delle scoperte degli astronauti secondo i valori delle mappe del tempo. Il film, che utilizza alcuni interessanti «effetti speciali», ebbe un Oscar. Dall’America intanto passavano in Europa sempre più numerose e a volte allarmanti «visioni» di UFO che piloti di aerei, montanari sperduti, impiegati dal colletto bianco comunicavano a Centri di studio più o meno scientifici. Così nel 1951 escono The Day the Earth Stood Still (Ultimatum alla Terra) di Robert Wise, di forte potenza espressiva; When Worlds Collide (Quando i mondi si scontrano) di Rudolph Maté, prodotto da George Pal, che ottiene buoni risultati tecnici ma che si basa su una trama piuttosto inconsistente; The Thing From Another World (La «cosa» da un altro mondo) di Christian Nyby, dove le folgoranti azioni di ricerca del mostro e della sua difficile cattura offrono buon gioco e buone immagini all’emozione. Sulla scia di un vecchio, celebre film di Harry Hoyt, The Lost World (1925), dal romanzo fantastico di Arthur Conan Doyle, nel secondo dopoguerra ritorna il problema dei cattivi rapporti di dominio e sfruttamento che l’uomo intrattiene con la Natura, la quale
45
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
ROMOLO RUNCINI
sa difendersi con grandi e potenti effetti: ecco nel 1953 The Beast from 20.000 Fathoms (Il risveglio del dinosauro), di Eugène Lourié, dove il mostro, dopo lo scoppio di una bomba atomica al Polo Nord, esce dal sonno millenario e si precipita, manco a dirlo, a New York infilandosi nel parco divertimenti di Coney Island fra grida e fuggifuggi generali. L’anno dopo esce in Giappone, e presto lanciato e osannato in Occidente, Gojira (Godzilla) di Inoshiro Honda, un mostro – Godzilla, naturalmente – destinato a far felici i bambini del dopoguerra bisognosi di favole nuove, esorbitanti, complesse come il mondo enigmatico che li circonda, ma soprattutto con orchi e draghi alla moda; di fatto questo mostro diventò un giocattolo, un pupazzo meccanico che sostituì per i bimbi l’orsacchiotto da portare a letto. Nel 1954 si passa ancora dal mostro tecnologico a quello naturale con Creature From the Black Lagoon (Il mostro della Laguna Nera, nuova e ben riuscita versione del tema «la bella e la bestia») di Jack Arnold che girerà anche Tarantula (Tarantola, 1955) e Monster on the Campus (Ricerche diaboliche, 1958). In quest’anno un altro film con tutti gli ingredienti del genere – dall’astronave al mostro – lancia un allarme per il futuro: This Island Earth (Cittadino dello spazio) del bravo Joseph M. Newman. Annus mirabilis è il 1956 allorché usciranno tre capolavori consolidati del cinema di fantascienza: Forbidden Planet (Il pianeta proibito) di Fred McLeod Wilcox, The Quatermass Xperiment (L’astronave atomica del dottor Quatermass) di Val Guest e Invasion of the Body Snatchers (L’invasione degli ultracorpi) di Don Siegel, testimonianze superbe di un mistero insondabile celato negli spazi silenti del Cosmo, ma anche – in specie quest’ultimo – echi di sospetti e paure per la minaccia di infiltrazioni nemiche nello schieramento compatto dell’America maccartista. Altri allarmanti disaster movie – mostri naturali e tecnologici, insetti e veicoli spaziali d’ogni specie e tipo – volteggeranno come spade di Damocle sul collo degli spettatori per tutti gli anni Sessanta. Con Psycho (Psyco, 1960) e The Birds (Gli uccelli, 1963) Alfred Hitchcock lascia la sua flemma britannica per avvertirci del pericolo di considerare la normalità di un uomo semplicemente dalle apparenze e la normalità della Natura come un atto dovuto. Roger Corman, da parte sua, traduce l’orrore e la perversità dei racconti di Ed-
46
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
LA
LOCOMOTIVA E L’ELFO.
TECNICA
E FANTASIA NEL CINEMA DI FANTASCIENZA
gar Allan Poe in buon linguaggio cinematografico. The Village of the Damned (Il villaggio dei dannati, 1960) di Wolf Rilla inizia la serie dei bambini alieni portatori di sciagure e di morte per gli adulti. Di fatto la società sta mutando troppo in fretta e le generazioni, tra padri e figli sempre più lontani, non riescono più a intendersi. La minaccia di scienziati pazzi si allarga oltre la sfera umana con l’invasione, nella Terra del «dopobomba», di colti ed efficienti primati divenuti ormai professionisti in vari campi di ricerca: è Planet of the Apes (Il pianeta delle scimmie, 1968) di Franklin J. Schaffner, una distopia zoologica nella storia dell’umanità. Stanley Kubrick, che aveva esordito in questo decennio con il mirabile Dr. Strangelove (Il dottor Stranamore, 1963), allegra, anzi feroce satira del maccartismo USA visto in chiave nazista, realizzerà poi nel 1968 il più importante film di SF, 2001 A Space Odyssey (2001 Odissea nello spazio) che oltrepassa per potenza espressiva e impianto scientifico il genere stesso, utilizzando problematiche antropologiche e filosofiche nella ricerca delle profonde radici biologiche e culturali dell’umanità. Sarà un caso, ma proprio in quell’anno esplodeva il movimento di rivolta giovanile contro il conformismo istituzionale e ideologico. Gli anni Settanta non erediteranno da questo grandioso film metafisico le prospettive tematiche indicate restando ancorati ai sussulti del cinema catastrofico e alla serie degli animali, piuttosto che dottori, impazziti. A 2000 la fine dell’uomo (1970) di Cornel Wilde, e Battle for the Planet of the Apes (Anno 2670 Ultimo atto, 1973) di J. Lee Thompson, massacri proiettati nel futuro, seguiranno disastri più ravvicinati anzi contemporanei come Earthquake (Terremoto) del 1974 di Mark Robson, The Towering Inferno (L’inferno di cristallo) di John Guillermin, prodotto da Irwin Allen, devastante incendio di un grattacielo di New York, e Quintet (1979) di Robert Altman, un gioco mortale di sopravvivenza in una Terra invasa e attanagliata dai ghiacci polari. Con Il gatto a nove code (1970) di Dario Argento, un giallo inquietante dopo l’esordio de L’uccello dalle piume di cristallo (1969), spunterà una vera gattomania con Eye of the Cat (Il terrore negli occhi del gatto, 1970) di Joseph Stephano, La morte negli occhi del gatto (1973) di Antonio Margheriti, La notte dei mille gatti (1975), di Harry Stewart, Il gatto dagli occhi di giada (1977) di Antonio Bido. Altri animali folli si affiancheranno, da Dogs
47
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
ROMOLO RUNCINI
(1976) di Burt Brikensoff, una muta di cani arrabbiati, a Frogs (1971) di George McCowan, dove le rane lasciano gli stagni per la città, a Bug (Bug insetto di fuoco, 1975) di Jeannot Szware, che ripropone nell’attualità una delle sette piaghe d’Egitto. E così via. Non mancano i remake di King Kong e Godzilla. Dopo il tenebroso film di Roman Polanski, Rosemary’s baby (Rosemary’s Baby Nastro rosso a New York, 1965) la vena satanica di parte cattolica continua con l’inquietante The Exorcist (L’esorcista, 1974) di William Friedkin che ebbe almeno tre seguiti, e con il tragico Carrie (Carrie Lo sguardo di Satana, 1976) di Brian De Palma. Ma ci sarà anche una SF ottimista come La Planète sauvage (Il pianeta selvaggio, 1972) un film di animazione di René Laloux con disegni di Roland Topor, dove la città dei buoni prevale su quella dei cattivi, e Close Encounters of the Third Kind (Incontri ravvicinati del terzo tipo, 1977) un UFO con equipaggio di alieni simpatici, di un giovane regista straniero, Steven Spielberg, il quale aveva esordito negli USA con un film senza trama, sconvolgente e bellissimo, Duel (1971), e aveva dato un contributo di successo alla serie degli animali pazzi con Jaws (Lo squalo, 1975). A imprimere un più forte impulso all’analisi profonda della nuova condizione umana soggetta – dopo la rivoluzione culturale del ‘68, presto domata e reintegrata nel sistema – agli obblighi del consumismo e alla violenza giovanile è ancora una volta Kubrick con A Clockwork Orange (Arancia meccanica) del 1971, dal romanzo omonimo di Anthony Burgess, in un linguaggio duro, veloce, capace di illustrare la crudeltà delle nuove generazioni ormai senza ideali e la formale spietatezza delle istituzioni consacrate al ristabilimento dell’ordine. Con il grandioso e brillante Star Wars (Guerre stellari, 1977) di George Lucas nasce una fantascienza fiabesca, una Fantasy tecnologica con forti «effetti speciali» e con un’ambientazione decisamente innovativa del «mondo nuovo», in cui uomini, androidi e mostri di altri pianeti convivono cordialmente e si confrontano sportivamente in una guerra infinita contro i terribili nemici in nero dell’Impero del male. È come un’anticipazione della irruente ondata migratoria in Europa dei popoli africani e asiatici sfruttati e affamati dal vecchio imperialismo e insieme un annuncio della campa-
48
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
LA
LOCOMOTIVA E L’ELFO.
TECNICA
E FANTASIA NEL CINEMA DI FANTASCIENZA
gna infinita contro il terrorismo islamico recentemente lanciata dal Presidente degli USA Bush jr. in tutto il nostro pianeta. Concludono il decennio due film di grande potenza espressiva e ideologica: Alien (1979) di Ridley Scott, dove l’incontro con l’altro, il mostro (costruito dal geniale Carlo Rambaldi) tocca momenti di altissima tensione fra crudeltà e disgusto; e Apocalypse Now (1975) di Francis Ford Coppola, una visione spaventosa della guerra in Vietnam strutturata sulla trama del classico romanzo di Joseph Conrad, Cuore di tenebra, in cui emerge l’avidità predatoria dello spirito dell’imperialismo incarnato nel feroce personaggio di Kurtz, qui interpretato da un inquietante e indomabile Marlon Brando. Gli anni Ottanta e Novanta risultano in prospettiva intrinsecamente omogenei nella produzione cinematografica di SF che appare per lo più come una serie di variazioni sui temi degli anni precedenti. A caratterizzare l’inconsistenza di contenuti di questi due decenni è la figura di un personaggio spaventoso che li attraversa tutti riducendo il racconto della paura – quel panico generato dallo smarrimento collettivo di fronte ai troppo rapidi mutamenti politici, sociali e tecnologici – a semplice immagine infantile del babau. Il personaggio è Freddy Krueger, alto allampanato crudele, dotato di dieci lame affilate ben incorporate nelle sue fortissime mani, che scattano al momento giusto per straziare le sue vittime. Questo nuovo villain, un cattivo in servizio permanente – incarnato nell’attore Robert Englund – protagonista assoluto della serie A Nightmare on Elm Street (Nightmare Dal profondo della notte, 1984) di Wes Craven, è passato con vari registi, al n° 2 Freddy’s Revenge (La rivincita, 1985) al n° 3 Dream Warriors (I guerrieri del sogno, 1987), al n° 4 The Dream Master (Il non risveglio, 1988), al n° 5 The Dream Child (Il mito, 1989), al n° 6 The Final Nightmare (La fine, 1991), e al n° 7, con titolo davvero minaccioso, Wes Craven’s New Nightmare (Nightmare Nuovo incubo, 1994) girato dieci anni dopo dallo stesso Craven che lo aveva tenuto a battesimo. Del resto al n° 7 ci arriverà anche la leggenda tipicamente americana di Halloween che, sulla scia dell’ottimo film di John Carpenter, Halloween (Halloween la notte delle streghe, 1978) avrà presto un seguito con altri sei episodi diretti da registi minori ma con lo stesso malvagio e implacabile figuro, Mr. Michel Myers, fra il 1981 e il 1988.
49
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
ROMOLO RUNCINI
La mania del serial ripreso dalla televisione investe questi due decenni con ondate di replicanti, risultando più conveniente mantenere in vita gli stessi incubi e personaggi per farne miti da baraccone piuttosto che scoprirne o inventarne di nuovi. In questo periodo il cinema di SF si avvale della sterminata produzione di romanzi horror dello statunitense Stephen King, ossia di temi e personaggi già costruiti e accettati dal pubblico dei lettori di categoria, rinunciando a girare l’occhio per guardarsi attorno. D’altra parte, con l’avvento al potere in URSS di Michail Gorbaciov, che intendeva instaurare una formale trasparenza (glasnost) del sistema politico e amministrativo e realizzare una effettiva riduzione dell’armamentario nucleare bellico, la Guerra Fredda stava perdendo tensione e importanza. La clamorosa caduta del muro di Berlino (1989) mette la parola fine alle ideologie di sinistra. Un primo effetto benefico di questa lunga apertura alla pace, lo sblocco delle tensioni politiche, quindi una testimonianza viva del possibile incontro con il «diverso», è la bella fiaba di Spielberg, E.T. the Extra-Terrestrial (E.T. l’extra-terrestre,1982) in cui la mostruosità dell’alieno – un nuovo meraviglioso artefatto di Carlo Rambaldi – viene accettata, addomesticata e resa amichevole dall’innocenza e dalla gioia ludica dei bambini. L’eco del divertente Gremlins (1984) di Joe Dante – dove una folla di mostri-giocattolo, dal taglio di teneri orsacchiotti, si rivolta contro bambini e famiglie distruggendo mobili, arredi e quant’altro con una crudeltà pazzesca – rimbomba trionfalmente anche in Gremlins 2 The New Batch (Gremlins 2 La nuova stirpe, 1990) dello stesso Dante, quale segno del benefico calo di tensione e conversione della paura nell’umore grottesco. La situazione internazionale appariva ormai tranquilla con la scomparsa dell’Impero del male – crollato sotto una forte crisi economica da cui sorse una Russia impotente e povera – e fu solo turbata da una guerra regionale contro l’Iraq (1991) lanciata dal Presidente George Bush senior, che aveva ottenuto il contributo militare dell’Europa nella trionfale marcia su Baghdad, anche se il dittatore Saddam Hussein venne risparmiato, per essere additato come nuova insegna del male nel 2003. Il mondo era, per così dire, in pace e di conseguenza i mostri occorreva trovarli dentro e non più fuori di noi. Stephen King, per l’appunto, si prestava a questo nuovo biso-
50
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
LA
LOCOMOTIVA E L’ELFO.
TECNICA
E FANTASIA NEL CINEMA DI FANTASCIENZA
gno di congiungere il quotidiano con l’insolito, il noto con l’ignoto e fu dunque il romanziere più saccheggiato del cinema di SF. Dopo i primi approcci ai suoi libri avanzati da grandi registi come Kubrick, The Shining (Shining, 1980), Cronenberg, The Dead Zone (La zona morta, 1983), Carpenter, Christine (Christine la macchina infernale, 1983), seguì una nutrita serie di altri testi filmati da vari registi: Children of the Corn (Grano rosso sangue, 1984) di Fritz Kiersch, Silver Bullet (Unico indizio la luna piena, 1985) di Daniel Attias, It (1990) di Tommy Lee Wallace, The Dark Half (La metà oscura, 1993) di George A. Romero, The Mangler (La macchina infernale, 1995) di Tobe Hopper, e molti altri titoli. Accanto a queste trame romanzesche troviamo anche una serie di delitti sanguinosi, detta del Venerdì 13, giorno infausto per gli americani, che giunse dal 1984 al 1993 a ben nove film più altre serie tv, con cui ha sicuramente battuto il record di disgrazie accidentali. Il più recente Scream (1997) di Wes Craven, un intruglio micidiale fra il buffonesco e il criminoso, ha già un seguito e tornerà certo in serial. La voglia di paura espressa da Carpenter con Halloween (Halloween la notte delle streghe, 1978) The Fog (Fog, 1979) e in altri testi tutti calati nel domestico quotidiano prosegue con la violenza della guerriglia urbana Escape from New York (1997 Fuga da New York, 1981), poi con il perturbante, straordinario racconto scientifico, The Thing (La Cosa, 1982), fino all’ossessivo Cape Fear (Cape Fear Promontorio della paura, 1992) con uno scatenato, terrificante Robert De Niro. In questo stesso anno escono due film di profonda sensibilità psicologica e di potente richiamo: l’ottimo remake di un classico, Dracula, di Francis Ford Coppola e lo sconvolgente The Silence of the Lambs (Il silenzio degli innocenti) di Jonathan Demme, con un atroce e implacabile Antony Hopkins cha dà il volto all’ultima figura del mostro più attuale, il cannibale. Mummie, zombi, figure teriomorfe gigantesche o minuscole in bella evidenza, non mancano certo nel menu di questi anni di «pace» essendo i veri protagonisti delle favole del nostro tempo. Di fatto l’accanimento su ruoli e situazioni di paura estrapolati dal contesto storico evidenzia la perdita di contatto con la realtà finendo per ridurre lo spazio della reazione generale di shock a semplice gesto privato. Ben diverso è l’atteggiamento di quattro registi – Salvatores,
51
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
ROMOLO RUNCINI
Cronenberg e i fratelli Wachowski – testimoni responsabili della complessità ed enigmaticità della condizione umana ormai soggetta alle sempre più rapide e violente spinte della mutazione antropologica e culturale della nostra civiltà telematica. È ancora il gioco qui, la voglia di misurarsi, di partecipare in prima persona, nell’alea rischiosa di un confronto tra l’uomo e la macchina, il perno narrativo che porta alle grandi sfide dell’avventura tecnologica. Ma una volta entrato nella spirale irreversibile del linguaggio e della comunicazione digitale il soggetto umano non potrà esprimersi che attraverso i numeri quantificando e rendendo anonimo, anodino il rapporto spazio-temporale. La risemantizzazione in termini numerici di questo cronotopo caccerà inevitabilmente l’uomo nella trappola dell’attuale mondo labirintico, immateriale eppure pianificato globalmente e governato dal sistema telematico. Così da noi esce nel 1997 Nirvana, di Gabriele Salvatores, dove un giovane italiano (il bravissimo Diego Abatantuono) trovandosi in una città straniera accede a un programma d’intrattenimento del computer restando invischiato nel folle gioco mortale proposto, morendo e resuscitando più volte. Due anni dopo, nel 1999, in eXistenZ di David Cronenberg e in The Matrix (Matrix) di Andy e Larry Wachowski, veniamo calati nel mondo misterioso e turbolento del cyberspazio, gettati in balia di immagini spaventose e codici numerici di lettura e di sopravvivenza che alimentano la grande menzogna della virtual reality. Qual è il confine fra reale e irreale? Questo è davvero l’enigma radicale del nostro tempo. L’ossessiva ricerca della verità negli scrittori e nei registi più sensibili della SF, la voglia di comprendere la carnalità dei sentimenti frammezzo gli interessi privati e pubblici in conflitto entro un sistema sociale avviato alla smaterializzazione dei segni politici ed economici del potere, conduce costoro a riconoscere, oltre l’ostentato piano simbolico della realtà, l’opportunità di riprodurre la materialità del suo aspetto fenomenico in un linguaggio eccentrico, fuori dalle regole mimetiche, in cui si possano utilizzare livelli alti e bassi, lirismo e volgarità, la cui contaminazione riesca a esprimere e rappresentare nella più truce evidenza le attuali inquietudini del mondo. La locomotiva e l’elfo (tecnica e fantasia) sottendono ancora e sempre la costruzione di questo composito linguaggio verbale e ico-
52
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
LA
LOCOMOTIVA E L’ELFO.
TECNICA
E FANTASIA NEL CINEMA DI FANTASCIENZA
nico capace di corrispondere alle istanze di una conoscenza e rappresentazione dinamica e simultanea della fenomenicità del reale. Ma questo linguaggio, come tutte le cose, muta «nel tempo e nel pensier», facendosi costantemente specchio e antenna delle emozioni e delle idee sorte di fronte o contro i profondi mutamenti strutturali della società. Così la assidua ricerca della verità, approdata alla virtual reality (con cui è possibile calarsi nel lato oscuro dell’immaginario) mentre ripropone il linguaggio del corpo come ultima barriera contro la simulazione dello spettacolo mass medianico, ci rivela anche l’assurdità e l’inconsistenza di questo utopico progetto cosale dal momento che anche il corpo, il nostro autentico «oggetto» personale è contaminato dalla tecnologia, reso intercambiabile con i trapianti, le protesi e le più varie apparecchiature terapeutiche. Sotto tale prospettiva il bisogno di realtà, della «vera» realtà, ossia dell’autentico spinge Salvatores, Cronenberg e gli altri registi (e così Ballard, Burroughs e Dick, loro numi tutelari) a concepire la violenza di questo messaggio apocalittico contaminato fra puro e impuro, sacro e profano, come il solo modo di comunicare in via indiretta, eccentrica, l’avventura dell’uomo in un futuro ormai inglobato, oltrepassato dal presente, senza restar chiusi nell’immaginario omologato dell’ufficialità merceologica. Forse proprio questo linguaggio fantastico della SF – che ricorda il ruolo primario della metafora nell’età barocca – ci aiuterà a rappresentare la crisi del soggetto dinanzi alla caduta del suo piano di esperienza, a esprimere la paura e il dolore di perdere il contatto con la realtà, a comprendere il rapporto fra apparire ed essere, a dare un senso non definitivo alla struttura di un mondo dominato da simulacri. Oltre le soglie del Terzo Millennio la SF, come ultimo racconto fantastico, si rivela, dopo l’inevitabile esaurimento della prospettiva realistica giunta agli estremi del minimalismo, il solo genere artistico e letterario in grado di interrogare gli abissi del reale.
53
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
FANTASTICO FANTASCIENZA FANTAPOLITICA di GIORGIO CREMONINI
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
Alla ricerca di una definizione In un mondo che è sicuramente il nostro […] si verifica un avvenimento che non si può spiegare con le leggi del mondo che ci è familiare. Colui che percepisce l’avvenimento deve optare per una delle due soluzioni possibili: o si tratta di un’illusione dei sensi, di un prodotto dell’immaginazione, e in tal caso le leggi del mondo rimangono quelle che sono, oppure l’avvenimento è realmente accaduto, è parte integrante della realtà, ma allora questa realtà è governata da leggi a noi ignote […]. Il fantastico occupa il lasso di tempo di questa incertezza […], è l’esitazione provata da un essere il quale conosce soltanto le leggi naturali, di fronte a un avvenimento apparentemente soprannaturale 1.
Il primo problema che pone la definizione di Tzvetan Todorov è che, se dovessimo applicarla alla lettera, non solo il fantastico comprenderebbe ben pochi film e/o racconti, ma escluderebbe quasi tutti quelli indicati come appartenenti alla fantascienza e alla fantapolitica, visto che in entrambi i casi l’«incertezza» su cui si fonda ne è spesso esclusa. Questo potrebbe però essere solo un dettaglio tassonomico e marginale, se non fosse che la definizione di Todorov si basa sull’inserimento del fantastico per così dire in corso d’opera ovvero su quella che Roger Caillois chiama a sua volta «uno scandalo, una lacerazione, un’irruzione insolita, quasi insopportabile nel mondo della realtà» 2. Se Todorov esclude dal fantastico «il meraviglioso», Caillois non vi comprende la «sostituzione totale di un uni-
1 2
T. TODOROV, La letteratura fantastica, Garzanti, Milano 1981, pp. 28, 45. R. CAILLOIS, Nel cuore del fantastico, Feltrinelli, Milano 1984, p. 90.
57
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
GIORGIO CREMONINI
verso esclusivamente prodigioso all’universo reale» 3, che è poi la stessa cosa. In entrambi i casi si riconoscono inoltre reminiscenze trasgressivo-surreali, vicine alle parole che Sigmund Freud dedica al «perturbante»: La parola tedesca unheimlich [perturbante] è evidentemente l’antitesi di heimlich [confortevole, tranquillo, da Heim, casa], heimisch [patrio, nativo], e quindi familiare, abituale, ed è ovvio dedurre che se qualcosa suscita spavento è proprio perché non è noto e familiare. Naturalmente, però, non tutto ciò che è nuovo è spaventoso, la relazione non è reversibile; si può dire soltanto che ciò che è nuovo diventa facilmente spaventoso e perturbante […]. Bisogna aggiungere qualcosa al nuovo e all’inconsueto perché diventi perturbante […]. Spesso e volentieri ci troviamo esposti a un effetto conturbante quando il confine fra fantasia e realtà si fa labile, quando appare ai nostri occhi qualcosa che fino a quel momento avevamo considerato fantastico 4 (il corsivo è mio).
Il riferimento è in effetti essenziale, ma con le precisazioni offerte dallo stesso Freud sul fatto che la vita e l’arte non coincidono: Il perturbante che appartiene al mondo della finzione letteraria – e cioè della fantasia e della poesia […] – abbraccia un campo molto più vasto del perturbante che si sperimenta nella vita […]. Molte cose che sarebbero perturbanti se accadessero nella vita non sono perturbanti nella poesia, [mentre] nella poesia, per ottenere effetti perturbanti, esistono una quantità di mezzi di cui la vita non può disporre […]. La finzione crea nuove possibilità di sentimenti perturbanti che non hanno riscontro nella vita vissuta 5.
Un conto è, insomma, la percezione dell’avvenimento fantastico da parte di un personaggio che vive un’esperienza di fiction; un altro è quella che colpisce il lettore o lo spettatore, che vive una diversa esperienza estetica. Quest’ultima comprende l’osservazione di un effetto di spaesamento interno al testo, di un personaggio che Ivi, p. 92. S. FREUD, C. MUSATTI (a cura di) Il perturbante, Theoria, Roma-Napoli 1984, pp. 16-17, 61-62. 5 Ivi, pp. 73-74, 77. 3 4
58
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
FANTASTICO
FANTASCIENZA FANTAPOLITICA
percepisce come fantastico il mondo in cui vive; essa sposta quindi l’effetto all’esterno, dove lo spettatore potrebbe condividerlo, ma anche fruire di tutte le informazioni necessarie a comprenderne il perché; o viceversa può succedere che un personaggio non giudichi affatto perturbante il mondo in cui si muove – come accade nel «meraviglioso» – mentre questo effetto si ripercuote su uno spettatore posto di fronte a un mondo che non conosce. Il fantastico si percepisce insomma non «nel» testo, ma «attraverso» il testo: esso contraddice non la nozione di realtà del personaggio, ma la «presunzione di realtà» presente a priori nella mente dello spettatore. Questa non ha niente a che vedere con l’impressione di realtà del linguaggio cinematografico: è invece l’orizzonte cognitivo spazio-temporale e culturale in cui viviamo e sappiamo di vivere, tutto ciò insomma che riteniamo plausibile e pertinente alla nostra storia. Non a caso Irène Bessière indica nel fantastico una sorta di «dialogo del soggetto con le sue stesse credenze e le loro incongruenze» e di «ricerca, condotta da un punto di vista razionalista, sulle forme della razionalità» 6. Il fantastico è allora la creazione di un mondo che contraddice questa presunzione di realtà; è uno scarto di «competenze», nel senso che a questo termine dava Algirdas Julien Greimas (la «competenza» è «il volere e/o il potere e/o il saper-fare del soggetto che presuppone il suo fare performanziale» 7). La competenza non riguarda solo il nesso logico fra un’azione e i suoi attanti, ma anche o soprattutto la scelta di un modello linguistico-retorico di metaforizzazione del reale sospeso fra l’immagine narrativa e l’immagine che abbiamo della realtà. Se mi si passa la schematizzazione, nel discorso fantastico la scelta è metaforica, in quello realistico è metonimica (senza escludere ovviamente molte possibili commistioni, come nel caso del racconto onirico). In questa prospettiva il fantastico non è più un genere, ma un «modo», una strutturazione del discorso che compren6 I. BESSIÈRE, Le rècit fantastique. La poétique de l’incertain, Larousse, Parigi 1974, p. 12 (la citazione è tratta in realtà da R. CESARANI, Il fantastico, Il Mulino, Bologna 1996, p. 66). 7 A.J. GREIMAS, Del senso 2. Narrativa modalità passioni, Bompiani, Milano 1984, p. 49.
59
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
GIORGIO CREMONINI
de l’invenzione di un mondo che rompe molti dei suoi legami con la presunzione di realtà. Una competenza e un modo fantastici (un pensiero e la sua forma) recuperano come fondante l’elemento «fantasia» nella formalizzazione del mondo del racconto e si riflettono in tutti i generi in cui essa interviene a corrompere il «modo realistico», dalla fantascienza alla fantapolitica, dalla fiaba all’horror. Resta escluso solo quello che Todorov definisce «lo strano», che è una rottura solo temporanea del «modo realistico»: esso non fa infatti che rallentare il riconoscimento del rispetto della presunzione di realtà, ma senza contraddirla. La competenza fantastica rimanda a un soggetto consapevole di una trasformazione in atto nel mondo reale e la rappresenta attraverso una destabilizzazione dei codici e una loro traslazione evidente sul piano metaforico. La scelta rivela – e produce – un’insoddisfazione di fronte ai codici fissati nella e dalla presunzione di realtà; come tale, può di volta in volta esprimersi nelle forme di un desideriosogno o di una paura-incubo, secondo quella dicotomia che ci vede sempre all’inseguimento di un miglioramento del mondo in cui viviamo e al tempo stesso preda di paure più o meno coscienti e razionalizzabili. Nel «modo fantastico» l’inspiegabile o l’impossibile traducono metaforicamente i limiti di una realtà giudicata insoddisfacente e nella quale personaggi, narratori e spettatori si riconoscono solo parzialmente: in questo senso esso si apre a quella lettura in chiave di «crisi d’identità» – e quindi della conoscenza – che accompagna tutta la cultura moderna e post-moderna. Frankenstein & Sons La radice comune ai due termini fantastico e fantascienza, propria dell’italiano, lega quest’ultima a quel tipo di orizzonti cognitivi che comunemente chiamiamo appunto scienza, o tutt’al più tecnologia, cioè un insieme di processi che mirano alla conoscenza e al dominio della natura nelle sue varie forme (il mondo, la vita, l’uomo). È quindi inevitabile che alla scienza sia legata la crisi d’identità che attraversa la storia del moderno (ma il legame è presente anche nel nostro passato: si pensi alla tecnologia reinventata con successo
60
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
FANTASTICO
FANTASCIENZA FANTAPOLITICA
da Robinson Crusoe o, viceversa, al fallimento di Icaro). La storia non fa che fornire nuove vesti e nuove occasioni a una pulsione che è espressa in diversi miti e archetipi e risale all’albero della conoscenza del peccato originale: nel secolo scorso la psicoanalisi, la biologia molecolare e la biogenetica in primo luogo hanno costituito un approfondimento e un avvicinamento della conoscenza e del rapporto del soggetto con se stesso e con il mondo, ovvero un ampliamento della nostra presunzione di realtà; così facendo hanno disegnato una mente e un corpo la cui modificazione disegna nuove vie di fuga dal nostro controllo. Nella fantascienza la radice fantastica mette in opera da un lato una competenza laica, che significa critica della conoscenza, della razionalità e quindi dell’uomo, ma anche, dall’altro, una competenza magico-religiosa che sottrae il ruolo di soggetto all’uomo per trasferirlo a un soprannaturale di volta in volta minaccioso o riparatore. Non sempre la distinzione, che comunque attiene al senso e non al modo, è però chiara e netta. Prendiamo ad esempio il caso Frankenstein, che, come sottotitola la stessa Mary Shelley, non è che una variazione moderna del mito di Prometeo, ovvero di una sfida che attraverso la conoscenza l’uomo lancia di volta in volta a se stesso oppure al soprannaturale, cioè alla divinità. Il mito è un contenitore esemplare per le moderne forme della crisi della conoscenza, come dimostra l’uso che ha fatto cinquant’anni fa Günther Anders del termine «dislivello prometeico» per parlare dell’apocalisse nucleare 8: il legame di fondo è dato da un ancestrale terrore della conoscenza e delle trasformazioni cui questa dà origine. Nel mito e nelle sue riletture, ciò che attende i protagonisti dell’avventura cognitiva (ivi compresa la space opera) è a volte una punizione divina, a volte più laicamente una ritorsione, elemento fondante di tanta narrazione, conseguenza logica e apparentemente inevitabile di ogni superamento dei limiti iscritti nella presunzione di realtà del suo tempo.
8 G. ANDERS, L’uomo è antiquato, Il Saggiatore, Milano 1963. Il termine «dislivello prometeico» e il pensiero di Anders sono ripresi in tempi più recenti da U. GALIMBERTI, Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica, Feltrinelli, Milano 1999.
61
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
GIORGIO CREMONINI
Oggi la creatura di Frankenstein rivive nei cyborg e nei replicanti, solo perché il progresso scientifico-tecnologico ha spostato in avanti i suoi confini: che essa sia all’origine solo organica, cioè un collage di membra umane, e che i suoi discendenti robotici mescolino invece in varie percentuali organico e inorganico, risponde tutto sommato all’evoluzione tecnologica dei nostri progetti cognitivi e costruttori (personalmente preferirei nutrirmi con protesi artificiali, di metallo, plastica o porcellana, che non con i denti di qualcun altro: ma forse è solo questione di gusti); quello che cambia non è la sostanza del problema, ma il semplice spostamento dei confini fisici di una ricorrente e continua crisi di identità. Sulla scia di questa sfida all’insufficienza della nostra presunzione di realtà, troviamo gli orrori minacciosi di La mosca di David Cronenberg, ma anche la religiosa salvezza spielberghiana di Incontri ravvicinati del terzo tipo e di E.T. L’incontro con il soprannaturale di questi ultimi casi non è legato a una critica della conoscenza, ma a un intervento superiore esterno, soprannaturale e tale comunque da prescindere da ogni nostra scelta – veri e propri aliens from heaven.
Il mondo dopo la fine del mondo Una versione laica del fantastico è rinvenibile in quel movimento, tipico degli anni Sessanta e della Guerra Fredda, che chiamiamo fantapolitica. Qui le colpe non sono più ontologiche o esistenziali, rimandano a una scelta, insieme personale e collettiva, in cui il Potere non ha più risvolti soprannaturali, ma al contrario terribilmente umani: non è in gioco l’imitazione di Dio, ma la sopraffazione dell’uomo, dell’«altro uomo». In Il dottor Stranamore, forse il film più famoso del filone, un moderno e spietato mad doctor non fa che esaudire i desideri, nemmeno tanto nascosti, dei politici e militari per cui lavora. L’esperienza che ne nasce è terribile quanto l’affronto cognitivo a Dio. La paura di una precipitazione apocalittica della corsa agli armamenti ha generato dibattiti sul genocidio (Anders) o sul suicidio
62
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
FANTASTICO
FANTASCIENZA FANTAPOLITICA
collettivo dell’umanità (Jaspers 9), apportando a entrambe le tesi prove riconoscibili nella politica dei paesi coinvolti. Ma lo faceva chiamando in causa solo e semplicemente – cioè fuori di metafora – l’uomo. Come osserva Franco La Polla, di mostri americani se ne vedono pochissimi, almeno tra quelli conformi all’iconografia tradizionale. I mostri del periodo sono molto diversi, hanno fattezze umane, parlano la nostra lingua, non celano alcuna identità e hanno sicuramente vissuto l’infanzia e la giovinezza alla stessa nostra maniera, ricevendo la nostra educazione e sognando i nostri stessi sogni 10.
Nella fantapolitica, da Il dottor Stranamore a L’ultima spiaggia o A prova d’errore, non sono presenti mostri nel vero senso della parola: l’attenzione fantastica si sposta da un domani inteso come metafora fantastica del possibile a un domani inteso come metonimia conseguente e necessaria dell’oggi. Il discorso metaforico in quanto tale contempla una riflessione per traslazione-transfert, ma non necessariamente la modificabilità del suo oggetto di riferimento, mentre il discorso metonimico induce più facilmente, per la sua apparente concretezza, a credere in una modificazione possibile o, viceversa, negata. Nella fantapolitica il modello narrativo che trionfa è infatti quello di una ritorsione globale alla sfida di un potere che ha sostituito la conoscenza: è una dichiarazione di impotenza e/o di stupidità, non di subordinazione. Il soprannaturale, insomma, non c’entra. L’ossimoro amaro e crudele che chiude Il dottor Stranamore (la canzone We’ll Meet Again contro il proliferare dei funghi atomici, una vera e propria fusione di sogno e incubo, di desiderio e terrore) è forse la figura più convincente di una cultura che non sa più pensare la speranza e non sa più sperare nella ragione, ma non immagina nemmeno più divinità cui rivolgersi per trovare una giustificazione. Persino il monolito nero di 2001 Odissea nello spazio ha più la consistenza di un simbolo extra-narrativo all’interno di una storia senza tempo, che quello di un residuo alieno e soprannaturale.
9
1960.
K. JASPERS, La bomba atomica e il destino dell’uomo, Il Saggiatore, Milano
10 F. L A POLLA, Sogno e realtà americana nel cinema di Hollywood, Laterza, Roma-Bari 1987, p. 235.
63
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
GIORGIO CREMONINI
La parentesi della fantapolitica è un punto di non ritorno, come la fine del mondo che mette in scena. Dopo il risveglio che si è creduto di vivere grazie al disgelo e a un apparente disarmo, il fantastico e le sue metafore ritornano a un uomo che sopravvive comunque, magari per essere dominato dalle scimmie, suo doppio speculare, oppure per frugare fra i resti di una distruzione non totale. Dagli anni Trenta, gli anni della Depressione, riemergono i veri mostri, testimoni di una coscienza sempre più precaria e sempre meno autosufficiente, e il fantastico registra un passaggio di consegne da un uomo incompleto a un post-uomo che forza la componente, ibridamente naturale e artificiale, della mutazione. Ciò che rimane ai robot di A.I., ancora più meccanici, autosufficienti e incorruttibili dei cyborg, è il sogno di essere uomini e di venirne schiacciati, come ha sempre richiesto il mito di Frankenstein. Le colpe dei padri continuano a ricadere sui figli.
64
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
L’ALIENO DAI MILLE VOLTI. MITO E SF di FRANCO L A POLLA
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
In un suo recente studio sugli eroi nella produzione cinematografica del nostro tempo il critico junghiano britannico John Izod, il quale, nonostante sia a capo di un dipartimento di cinema, sembrerebbe più un analista avvezzo a pubblicare saggi su «The Journal of Analytical Psychology» che su «Film Comment», denuncia nell’introduzione, fra le altre cose, il fatto che «There is a striking imbalance between the effectiveness of filmmakers in awakening emotion and the lame attempts of academic screen analysts to write compellingly about it» 1. La frase pone alcuni problemi di interpretazione (dobbiamo intendere «analysts» nel senso di psicanalisti o di persone che sviscerano un argomento, e dunque, generalmente, di critici? E comunque perché «academic»? Psicanalisti o critici che non lavorano nell’università non possono forse soffrire della stessa défaillance?), problemi che tuttavia tralasceremo. Importa qui che, di chiunque si tratti, lo strale di Izod si appunta contro coloro che hanno utilizzato – e negli ultimi trent’anni sono stati in parecchi – Freud e Lacan nel leggere i film e il cinema nel suo insieme, laddove, è la tesi del libro, il magistero di Jung è l’unico adatto a un’impresa del genere. Per un discorso su mito e fantascienza Jung sembrerebbe infatti il riferimento teorico più adatto, magari sulla scorta della sistematizzazione fornita a suo tempo in The Hero with a Thousand Faces da Joseph Campbell 2, per il quale, com’è noto, la congerie di storie 1 «C’è un rimarchevole disequilibrio fra l’efficacia dei registi nel suscitare emozione e gli zoppicanti tentativi, da parte degli analisti cinematografici universitari, di scriverne in modo interessante». J. IZOD, Myth, Mind and the Screen. Understanding the Heroes of Our Time, Cambridge UP, Cambridge 2001, p. 2. 2 J. CAMPBELL, trad.it. L’eroe dai mille volti, Feltrinelli, Milano 1958.
67
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
FRANCO L A POLLA
mitologiche planetarie si può riassumere in un’unica, ancorché molto articolata, formula strutturale. Di più: in America è sorta da alcuni anni una vera e propria scuola sceneggiativa che fa capo a Christopher Vogler, autore del manuale The Hero’s Journey 3 (il cui solo titolo è eloquente del debito nei confronti di Campbell e il cui sottotitolo recita: Mythic Structure for Writers: si noti il singolare, «structure»), l’ultimo frutto della quale è il libro di Stuart Voytilla, Myth and the Movies 4. Scuola che, peraltro, ha fatto anche proseliti italiani, come dimostrano testi quali Come raccontare una grande storia e Archetipi mitici e generi cinematografici, ambedue di Luigi Forlai e Augusto Bruno 5. Ho ammassato qui alcuni dei nomi e dei titoli rappresentativi di quest’area metodologica perché è mia ferma intenzione non parlarne più nel prosieguo del discorso. Credo infatti che, come spesso avviene con le aree disciplinari «totali» (e dunque autoreferenziali), qualunque loro utilizzazione in chiave esegetica comporta una conferma delle premesse del metodo, ma non un solo centimetro in più nella conoscenza del rapporto fra mito e SF come fatto culturale. E una semplice frase come questa di Sigmund Casey Fredericks: «Insofar as SF asks the same questions as myth about the beginnings and ends of our race, our world, finally our entire universe, it blends mythopoeic qualities with the insights of modern science […] SF is a literature which results from the meeting between science and myth» 6, ci dice molto di più su questo rapporto che non l’intera teoria degli archetipi. E allora che cos’hanno un’astronave, un alieno, un mutante per imporci un confronto non solo con l’inventario del nostro materiale C. VOGLER, trad.it. Il viaggio dell’eroe, Dino Audino, Roma 1999. S. VOYTILLA, Myth and the Movies, Michael Wiese Productions, Studio City 1999. L. FORLAI, A. BRUNO, Come scrivere una grande storia, Dino Audino, Roma 1997; ID., Archetipi mitici e generi cinematografici, Dino Audino, Roma 1998. 6 «Nella misura in cui la SF pone le stesse domande del mito sugli inizi e le finalità della nostra razza, del nostro mondo, e in ultima istanza dell’intero universo, essa mescola qualità mitopoietiche con le intuizioni della scienza moderna […]. La SF è la risultante letteraria dell’incontro fra scienza e mito». S.C. FREDERICKS, Greek Mythology in Modern Science Fiction: Vision and Cognition, in W.M. AYCOCK e T.M. KLEIN (eds.), Classical Mythology in 20th Century Thought and Literature, Texas Tech Press, Lubbock 1980, p. 94. 3 4 5
68
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
L’ALIENO
DAI MILLE VOLTI.
MITO
E
SF
mitologico, ma anche con l’idea stessa di mito? Rispondere non è difficile, a patto che si chiarisca prima il significato della parola «mito». Nell’accezione della scuola junghiana esso assume un carattere arcaico e talvolta persino filologico che manca (o comunque non ne è la primaria caratteristica), poniamo, nella nozione elaborata da Furio Jesi, nel senso che se è vero che per gli junghiani la verità del mito è sempre presente perché nell’archetipo vive il futuro, in Jesi e nel suo maestro Karl Kerényi (che certo non difettava di preparazione filologica) il mito non è un passato che getta luce sul futuro ma un presente eternamente vivo, un’idea che si evolve nel tempo senza mai tradire se stessa, un modo di sentire e di immaginare che si adegua via via a tempi e costumi. Ma forse per meglio comprendere i termini del problema dovremmo uscire dall’ambito dello stretto studio mitologico, aprendo alla critica letteraria. Ad esempio, e come ricordavo qualche anno fa in un saggio per la rivista «Close Up» 7, la SF cinematografica non sfugge a quello che Frank Kermode 8 ha indicato come lo statuto generale di qualunque fiction: quello di dare un senso al mondo. Più precisamente, per il critico inglese, il mito è quel che accade alle fictions «ogniqualvolta esse non sono coscientemente considerate come tali». E continua: «Le fictions esistono per scoprire le cose, e cambiano in relazione al bisogno di dare un senso. I miti sono gli agenti della stabilità, le fictions gli agenti del cambiamento» 9. Tradotta in ambito fantascientifico, l’affermazione acquista una valenza particolare, ché tutto ciò che nel genere è codificabile in termini di modello tocca inevitabilmente la sponda mitologica, laddove ciò che invece non si lascia identificare come tale acquista senso ed insieme lo dà al mutamento epistemologico di cui fa parte. Insomma, per interessante che possa essere un volume come Them or Us. Archetypal Interpretations of Fifties Alien Invasion Films di Patrick Lucanio 10, siamo pur sempre davanti a una lettura astorica del fenomeno, al solito saccheggio nell’inesauribile – eppure 7 F. L A POLLA, Mito e Fiction, ovvero: dare un senso al mondo, dare un senso al film, in «Close Up» n. 2, Settembre 1997. 8 F. KERMODE, The Sense of an Ending, Oxford UP, Oxford 1967. 9 Ivi, p. 39. 10 P. LUCANIO, Them or Us. Archetypal Interpretations of Fifties Alien Invasion Films, Indiana UP, Bloomington & Indianapolis 1987.
69
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
FRANCO L A POLLA
limitato – magazzino della simbologia psicanalitica, che, un po’ come il dio aristotelico, pretende di porsi come motore immoto impartendo al mondo un senso precostituito. Diremo dunque che l’astronave è l’Argo di Giasone, che l’alieno è il centauro o l’amazzone nello sguardo del meravigliato viaggiatore, che il mutante è quello Zeus che può a piacere diventare cigno o pioggia d’oro? Troppo facile. Troppo facile scambiare l’immagine con la funzione. Più difficile – ma più remunerativo – tentare di capire le coordinate che fondano il mondo del mito, la specifica nozione di spazio e tempo (due componenti altrettanto primarie nella SF) che lo regolano. A differenza dalla fiaba – dove il tempo reale non sembra vigere perché due parole («in seguito») e un verbo («cammina, cammina» con quella iterazione che riassume in sé ore, forse giorni e certamente lunghi spazi) o una neutra e generica noncuranza («tanto tempo dopo») tagliano le gambe a ogni psicologia immolandola sull’altare del fatto, della trama – nel mito il tempo non compare, nemmeno in quella forma ridotta. Cronos esiste, sì, ed a lui soggiacciono tutti, uomini e dèi, ma nella tragedia o nella commedia di questi ultimi esso non entra mai in scena: Prometeo deve sopportare la sua tortura per l’eternità, così come Sisifo, Tantalo, i Titani e via dicendo. Il mito insomma è fondamentalmente una fuga dal tempo, un riscatto dalla Storia in fondo non diverso da quello anelato da Stephen Dedalus e, aggiungiamo finalmente, da quello che, consapevolmente o meno, vivono gli avventurosi eroi della SF. Nell’epoca dei primi esperimenti della scienza astronautica abbiamo visto film come World Without End (Mondo senza fine, 1956) di Edward Bernds mettere in scena viaggi nello spazio che diventano viaggi nel tempo da cui non si può più tornare a casa: un argomento, quello del ritorno a casa, che dal Mago di Oz a Thomas Wolfe (You Can’t Go Home Again) ha ossessionato la cultura americana. La mancanza, l’impossibilità del ritorno è di per sé un azzeramento della Storia, che peraltro trova riscontro teorico nelle ben note istanze eisteiniane sulle conseguenze per l’uomo di un viaggio alla velocità della luce. Trovo peraltro straordinariamente eloquente il fatto che, soprattutto in anni più recenti, la SF abbia spesso tentato di recupera-
70
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
L’ALIENO
DAI MILLE VOLTI.
MITO
E
SF
re la Storia anche in un quadro che non solo ne testimoniava l’assenza, ma che addirittura trovava interesse e mordente in quella stessa assenza. Si pensi alla quarta serie televisiva di Star Trek che va sotto il nome di Voyager e che vede un’astronave dispersa in un quadrante dell’universo dal quale è impossibile raggiungere la Terra nel normale arco della vita umana. L’equipaggio tenta comunque l’impresa incontrando per la sua strada alieni e avventure di ogni tipo. Queste ultime regolarmente adombrano una precisa e solida riflessione in merito a questo o quel problema della società e della cultura contemporanea in America (come del resto era stato anche per le altre serie precedenti). Niente di strano: parlare del presente facendo le viste di parlare del futuro è quel che pertiene alla migliore SF. Ma Voyager, ricordiamolo, non fa più parte della Storia e i membri dell’equipaggio obbediscono non solo ai dettati della Flotta Stellare di cui fanno parte e che per loro, in quanto militari sotto un comando, non possono comunque non continuare a vigere («sacerdos et miles in aeternum», verrebbe da dire, parafrasando l’adagio canonico), ma anche a una testarda volontà di considerarsi ugualmente «esseri storici». La cosa è tanto più paradossale se si tiene a mente la relatività postmoderna di parecchi assunti sviluppati nei vari episodi. In uno di questi – bellissimo – assistiamo alla ricostruzione di una pagina di storia astrale tramandata secondo l’ottica dei vincitori di una quérelle planetaria fra due o tre razze. Ma la ricostruzione, ottenuta attraverso sofisticate tecnologie visive di specifici fatti, è oggetto di osservazione da parte di diverse persone di quelle stesse razze, persone che, dislocate nel futuro, sono a loro volta «ricostruzioni dei ricostruttori» in una mise en abime inscenata a nostro beneficio, la quale ovviamente ribalta le conclusioni dello stadio precedente. Naturalmente da molto tempo siamo più che abituati al gioco metafictional, ma questa volta tale gioco non è semplice divertissement e nemmeno esercizio di decostruzione narrativa, di smontaggio della strutture della fiction: questa volta esso coincide con il senso stesso della narrazione, poiché solo attraverso di esso è possibile giungere alla verità che interessa il testo: cioè l’impossibilità di un’unica verità. Come dicevo, il ribaltamento e lo scramble della regolare prospettiva storica (o dovrei dire storicistica?) è operazione alquanto postmoderna che contrasta con quel recupero della Storia come ul-
71
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
FRANCO L A POLLA
tima dimensione di salvezza cui, almeno implicitamente, sembrano guardare i protagonisti della serie. In realtà, indipendentemente da modelli quali quello testé citato (ed è cosa nota che, nonostante il suo successo e la sua popolarità, Star Trek è un tipo di SF in controtendenza), la dominante metafisica della SF è comunque di carattere atemporale (o in ogni caso di un tempo misurato su un passo diverso da quello del lettore), anche quando, come appunto in Star Trek o nella saga di Asimov, si legge chiaro il tentativo di costruire una sorta di «storia alternativa», o per meglio dire, una «storia del futuro» nella quale il braccio temporale che separa l’epoca del lettore da quella dell’azione viene affrescato di fatti storici organicamente collegati e complessi, di guerre, trattati, eventi, tramonti e nascite di civiltà, ecc. In questo senso si può ben dire che, di pari passo con la teorizzazione einsteiniana, il tempo del mito è quello, radicalmente rivoluzionario, del viaggio nel tempo, dell’azzeramento dei confini temporali. Ma c’è un’altra categorizzazione possibile che lega strettamente SF e mito, e ci è ancora fornita da Fredericks quando lo studioso parla di SF prometeica e SF odisseica: «skeptical and cautious» la prima, mentre l’altra «emphasizes the openness of the universe to mankind’s speculative intelligence» 11. Il mito insomma, ben lungi dall’astrattezza precostituita dell’universo archetipo che vuole certa psicanalisi, fornirebbe alla SF modelli culturali sui quali costruire le proprie storie. Culturali, dico, e non formali, perché, esattamente all’opposto dell’ampio ma univoco inventario della critica mitologica, qui l’inventario (dato e non concesso che d’inventario si possa parlare) è ristrettissimo ma estremamente differenziato e variegato; e, soprattutto, l’indicazione suggerita da Fredericks implica riflessioni e atteggiamenti dell’intelligenza che mancano totalmente nell’esercizio meccanicamente comparativo della critica archetipa. Ma non vorrei dare l’impressione di essermi imbarcato in una crociata antipsicanalitica, antijunghiana e così via. La critica mitologica tradizionale mi è servita tutt’al più come elemento di contrasto
11
S.C. FREDERICKS, Op. cit., p. 101.
72
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
L’ALIENO
DAI MILLE VOLTI.
MITO
E
SF
per evidenziare la possibilità, il ruolo e il valore di altre voci e altre stanze nella ricerca di un collegamento fra SF e mito. La distinzione di Fredericks ci consente, poi, di caratterizzare la dominante della SF cinematografica contemporanea. Non c’è infatti dubbio che questa rientri in larga misura nell’ambito del prometeico, segnandone così il recupero dopo i fasti odisseici degli anni Cinquanta e Sessanta. Alla SF spaziale postbellica, che per un certo tempo ha convissuto con l’altra, è seguita negli ultimi vent’anni del secolo una forte presenza di quest’ultima, soprattutto attraverso il sempre maggior interesse nei confronti della robotica, vale a dire di una variante dell’archetipo modello frankensteiniano. Da Blade Runner (1982) in poi gli schermi hanno pullulato di androidi la cui finalità era in ultima istanza quella di avvertirci di quanto la carne sia ormai obsoleta e con essa, probabilmente, anche i valori umanistici che tradizionalmente – anche se forse non sempre veridicamente – le venivano associati. In altre parole, il modello frankensteiniano si è riproposto, ma con valori non poco ribaltati: originariamente ammonimento nei confronti di un’ambizione di conoscenza e potenza troppo vicine al divino, il modello è stato reimpiegato come esaltazione della creatura, spesso e volentieri dotata di una sensibilità quale quella che l’umano sembra da tempo avere perduto. Ovviamente alle spalle di tutto questo c’è il forte recupero della riflessione di Philip K. Dick, ma c’è anche e soprattutto quel mito prometeico che vuole il figlio degli dèi sia dopotutto migliore di loro, più amorevole, più comprensivo, più attento ai bisogni e al benessere delle creature inferiori. Prometeica o odisseica, comunque, credo si veda bene come la SF partecipa dell’atemporalità del mito. Ma è anche vero che nell’ultimo quarto di secolo l’intera cultura occidentale si è ampiamente compromessa con quello che Fredric Jameson ha chiamato un «indebolimento della storicità» 12. Questo, fra l’altro, può almeno in parte spiegare il perché del formidabile rilancio del genere fantascientifico nello scorcio finale dell’ultimo millennio: un genere fondato sull’atemporalità era esattamente quello che una cultura del rifiuto del-
12 F. JAMESON, Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism, in «New Left Review», n. 146, July-August 1984.
73
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
FRANCO L A POLLA
la storicità stava aspettando di scoprire o comunque di rivalutare perché coincidente con la propria episteme. Quando osserviamo ciò che accade in Terminator di James Cameron, oltre a una precisa allegoria della fuga in Egitto, come ci dice molto acutamente Gavriel Moses 13, noi percepiamo con Vivian Sobchack che la pellicola «comprende simbolicamente la “fine” del modernismo, del “futurismo”, della credenza nel “progresso”» 14: insomma, la fine della Storia; o per meglio dire, della nostra fiducia nella Storia, della nostra concezione storicistica del tempo e, con essa, delle strutture di riferimento che per un lungo momento del passato – press’a poco coincidente con la cosiddetta età borghese – hanno informato il nostro modo di pensare il tempo. Marginalmente c’è da chiedersi se la formulazione della Sobchack sia condivisibile o se invece essa non possa essere ribaltata. In Screening Space, infatti, ella afferma: «The inflated value of space and surface has led to a deflation of temporal value, to a collapse of those temporal relationships that formulated time as a continuous and unifying flow» 15. Che i due fenomeni siano avvenuti, non c’è alcun dubbio. Ma siamo sicuri che il rapporto di causa/effetto non funzioni all’inverso, che, insomma, non sia stata la «deflazione» del valore temporale a comportare l’«inflazione» di spazio e superficie? In parole povere, è nato prima l’uovo o la gallina? È vero infatti che l’insistenza sullo spazio e la superficie dalla New Hollywood in poi è stata un tratto caratteristico del cinema americano (si pensi all’importanza fondamentale delle superfici in The Long Goodbye, 1973, di Robert Altman, o alle dirette influenze dell’iperrealismo pittorico in Alice Doesn’t Live Here Anymore, 1974, e ancor più in Taxi Driver, 1976, ambedue di Martin Scorsese), ma è anche vero che il cinema stesso nel
13 G. MOSES, Natural Born Discourse: soggetto e linguaggi nel cinema americano contemporaneo, in F. L A POLLA (a cura di), Poetiche del cinema hollywoodiano contemporaneo, Lindau, Torino 1997. 14 V. SOBCHACK, Screening Space. The American Science Fiction Film, Ungar, New York 1987, p. 248. 15 «Il valore amplificato dello spazio e della superficie ha comportato una riduzione del valore temporale, un collasso di quelle relazioni temporali che definivano il tempo come un flusso continuo e unificante». Ivi, p. 272.
74
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
L’ALIENO
DAI MILLE VOLTI.
MITO
E
SF
suo insieme è un medium «deflativo» del valore temporale, nel senso che per sua natura – almeno da Griffith in avanti – esso vanifica e frammenta il flusso continuativo del tempo minando, sul terreno dell’immaginario, le basi stesse su cui è fondata la nostra tradizionale nozione di Storia. Questa, probabilmente, è la vera invasione aliena che vede un mostro giungere dal cielo (perché è nel cielo che stanno gli dèi del mito) e cancellare un caposaldo epistemico della nostra civiltà in una sorta di disaster movie apocalittico dove né lo spazio né il tempo sono più gli stessi. E un po’ come nel paradigmatico The Invasion of the Body Snatchers (1956) di Don Siegel, è bastato un momento di torpore suggerito dal dolce canto delle immagini sullo schermo perché, risvegliandoci, ci si sia ritrovati non solo invasi ma assimilati in un mondo che non è e non sarà mai più lo stesso di prima.
75
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
IL FUTURO IMMAGINARIO DELLA FANTASCIENZA. VIVERE UN ALTRO PRESENTE di CARLO PAGETTI
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
Nel suo ultimo studio critico, Scraps of the Untainted Sky (2000), Tom Moylan sottolinea che la fantascienza favorisce «il piacere del lettore nella scoperta e nella speculazione riguardo alla logica e alle conseguenze di un mondo immaginato» 1. Secondo Moylan, in questi casi, «l’esperienza della lettura non è dissimile da quella dell’ascolto di un radiodramma» 2, in cui l’ascoltatore filtra attraverso la mente i suoni che giungono via etere e li trasforma in immagini vivide, fatte di ricordi, fantasie, sequenze cinematografiche, brandelli di esperienza rielaborati per adattarsi a un «mondo immaginato», che è di solito collocato nel tempo futuro. Dietro a un radiodramma vi può essere, naturalmente, un romanzo, come è nel caso della famosa trasmissione radiofonica di Orson Welles, che si proponeva come un rifacimento di War of the Worlds di Herbert George Wells. Il tempo è diventato – anzi, è rimasto – il presente, ma il presente è ora il 30 ottobre 1938. Il luogo non è più situato vicino alla Londra imperiale della fin de siècle, ma nel New Jersey, non lontano da New York. E non sono più i quotidiani, come succede nel romanzo wellsiano, a dare le prime drammatiche notizie, ma è la voce di un annunciatore radiofonico: «Just a minute! Something’s happening! Ladies and gentlemen, this is terrific! This end of the thing is beginning to flake off! The top is beginning to rotate like a screw! The thing must be hollow!» 3. Basta un attimo: il futuro si sta per manifestare con violenza distruttiva. 1 T. MOYLAN, Scraps of the Untainted Sky. Science Fiction. Utopia. Dystopia, Westview Press, Boulder (Colorado) 2000, p. XVI. 2 Ibidem. 3 «Aspettate un minuto! Sta succedendo qualcosa! Signore e signori, è terrificante! L’estremità della cosa comincia a sfaldarsi! La cima comincia a ruotare come una vite! La cosa deve essere vuota!». H. KOCH, The Broadcast, in H. CANTRILL, The Invasion from Mars, Princeton U.P., Princeton (N.J.) 1982 [1966], pp. 15-16.
79
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
CARLO PAGETTI
Il corpus narrativo della fantascienza ha mostrato fin dalla sua rinascita novecentesca, favorita dai scientific romances di Wells, una straordinaria flessibilità e un’alta capacità di adattamento alle esigenze dei mass media. Simile a una delle creature aliene capaci di assumere qualsiasi forma, in quanto genere eminentemente plasmabile, aperto alle più disparate contaminazioni del gotico e del romance sentimentale, del western e del poliziesco, dell’utopia e del fantastico, la SF ha trovato un suo sbocco naturale sullo schermo probabilmente anche perché i suoi scenari futuribili fanno parte della vena inventiva del cinema, del suo carattere esplicitamente finzionale, della sua qualità onirica, esaltata dal buio della sala cinematografica, dal veloce passaggio delle sequenze, dal gioco degli effetti speciali. Da un certo punto di vista, il futuro è un copione che viene continuamente riscritto e modificato in base al suo ipotetico rapporto con il presente. Ogni lieve variazione nello schema dell’esistenza quotidiana innesca una serie differenziata di eventi producendo l’effetto di una valanga e iniziando un nuovo processo temporale: questo ci hanno mostrato numerosi film di fantascienza, a cominciare dal ciclo di Back to the Future, e innumerevoli romanzi di fantascienza, incentrati sugli effetti perversi del viaggio nel tempo. Nei due Terminator, il cyborg-Schwarzenegger proveniente dal futuro retrocede nel tempo per modificare – nel male e nel bene – il corso degli eventi che lo hanno prodotto, ma la sua missione è irta di ostacoli e si conclude comunque con la sua rottamazione. Anticipare il futuro è altrettanto difficile che modificare il presente. Il futuro è dunque, nella percezione contemporanea esaltata dalla fantascienza e, più in generale, dalla cultura dei media, un’entità eminentemente instabile, una costruzione intellettuale molto fragile, e perciò non dissimile da una proiezione cinematografica, dove, tra l’altro, il montaggio propone una successione di episodi che può essere facilmente cambiata, in modo da suggerire un significato diverso. L’abitudine, ben nota nel mondo del cinema, di girare epiloghi alternativi, favorisce il senso dell’arbitrarietà dell’intero processo immaginativo. Per capire come può essere diversa la percezione del futuro nel passaggio da un’epoca all’altra, basterà mettere a confronto la solenne conclusione di Things to Come (La vita futura Nel 2000 guer-
80
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
IL
FUTURO IMMAGINARIO DELLA FANTASCIENZA.
VIVERE
UN ALTRO PRESENTE
ra o pace, 1936) di William Cameron Menzies, sceneggiato da Wells, che si conclude con una solenne dichiarazione sull’immancabile destino di grandezza che attende l’umanità alla conquista delle stelle, e quella volutamente caotica, malgrado l’apparente happy ending, di Strange Days (1995) di Kathryn Bigelow, in cui l’ultima notte del millennio si consuma in una festa frenetica e multicolore. Del resto, se i grandi sistemi religiosi del passato concepivano un futuro già iscritto nella mente di Dio, anche la visione darwiniana, così fortemente avversa a una concezione provvidenziale e finalistica dell’universo, finiva per postulare un percorso evolutivo sostanzialmente lineare, proteso verso il raggiungimento di un più alto livello dell’intelligenza: We can so far take a prophetic glance into futurity as to foretell that it will be the common and widely-spread species, belonging to the larger and dominant groups, which will ultimately prevail and procreate new and dominant species […]. And as natural selection works solely by and for the good of each being, all corporeal and mental endowements will tend to progress towards perfection 4.
Anche quando sono in competizione tra di loro, i grandi sistemi del sapere ottocentesco cadono uno dopo l’altro nel secolo successivo; ed è interessante osservare quanto del nuovo senso di relatività e di incertezza epistemologica trovi un riscontro preciso in un genere spurio come la fantascienza o in uno strumento della comunicazione di massa come il cinema. È pur vero che si affermano ancora tentativi di dare un minimo di coerenza agli avvenimenti futuri, proiettandoli lungo un colossale arco temporale, caratterizzato da cicli evolutivi, in cui l’umanità passa dall’infanzia alla maturità, per poi decadere, morire e rinnovarsi in uno stadio successivo, come succe4 «Possiamo così gettare uno sguardo profetico nell’avvenire e predire che saranno le specie più comuni e più diffuse, appartenenti ai gruppi più grandi e dominanti di ogni classe, quelle che in definitiva prevarranno e procreeranno specie nuove e dominanti […]. E poiché la selezione naturale lavora esclusivamente mediante il bene e per il bene di ciascun essere, tutte le qualità del corpo e della mente tenderanno a progredire verso la perfezione». C. DARWIN, The Origin of the Species, Oxford U.P., Oxford 1998 [1859], p. 395; trad. it. L. FRATINI, C. DARWIN, L’origine della specie, Boringhieri, Torino 1990, p. 553.
81
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
CARLO PAGETTI
de in Last and First Men (L’Ultimo Uomo, 1930) di Olaf Stapledon o, subito dopo la Seconda guerra mondiale, nella saga di Isaac Asimov Foundation, dove si ipotizza addirittura l’esistenza di una disciplina scientifica, la «psicostoria», capace di prevedere e pianificare il futuro secondo linee razionali. Ma anche in questi casi, il tarlo della distruzione rode le fondamenta narrative: gli ultimi uomini del romanzo di Stapledon, dotati di poteri sovrannaturali e simili a divinità egizie, non possono che accettare la fine che li attende con l’esplosione del Sole, poiché sono comunque incapaci di valicare i confini del sistema solare, mentre la lunga serie di eventi che tracciano lo sviluppo della comunità interplanetaria di Asimov dovrà essere reinterpretata alla luce della scoperta che esiste una «seconda Fondazione», basata su principi molto diversi da quelli applicati dagli scienziati che organizzano e dirigono il mondo futuro, illudendosi che esso non presenti alternative. Sia Stapledon che Asimov, comunque, mettono in rilievo che qualunque proiezione futuristica è alimentata dai processi dell’immaginazione, ha un impianto favolistico che non esclude l’affermazione di una «verità» mitica, capace di parlare alla mente dei lettori. Nella Prefazione a Last and First Men Olaf Stapledon insiste sulle difficoltà a cui va incontro lo scrittore che vuole rappresentare il futuro, ma anche sul valore etico di tale esperienza narrativa, che si configura come «un saggio nella creazione di un mito» 5. Qui, come in altre opere degli anni Trenta, Stapledon combatte una sua personale battaglia per proporre un mito dei tempi a venire che si distingua dalle pulsioni millenaristiche, tutte radicate nel recupero di una identità nazionale incontaminata e ancestrale, dell’ideologia nazista. In un contesto più ampio, si potrebbe dire che Stapledon genera una creazione mitica del lontano futuro, capace di cogliere il carattere effimero e instabile dei progetti politici della sua epoca. I grandi sistemi totalitari, che lanciano i piani quinquennali o ipotizzano, come fece il nazismo, una trionfante e vittoriosa esistenza di mille anni, si rivelano anch’essi fragili e sottoposti al cambiare dei tempi e delle fortune economiche e militari, mentre le loro visioni dell’«uomo nuovo» insegnano a intere generazioni di in-
5 O. STAPLEDON, Preface to Last and First Men, Harmondsworth, Penguin Books 1973 (1930), p. 12.
82
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
IL
FUTURO IMMAGINARIO DELLA FANTASCIENZA.
VIVERE
UN ALTRO PRESENTE
tellettuali che bisogna dubitare delle utopie e delle teorie politiche troppo rigorose e perfette. L’anti-utopia, un genere strettamente imparentato con la fantascienza, esprime pienamente un atteggiamento di rifiuto nei confronti del nuovo millenarismo stalinista e nazista, che, nella sua sete di dominio, abolisce il futuro, ovvero lo cristallizza in un’immagine di violenza inaudita e perenne: «If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face – forever» 6. Peraltro, ogni visione del futuro è di per sé suscettibile di disparate interpretazioni, talché qualcuno è giunto a supporre che tra gli ispiratori dell’organizzazione terroristica Al Qaeda vi sia anche il mite Asimov, l’autore del ciclo narrativo di Foundation, dalla cui giovanile lettura Osama Bin Laden avrebbe tratto forse la convinzione di poter pianificare una serie di mosse nel futuro, innescando, con l’attacco alle Torri Gemelle di New York, una reazione a catena dalle conseguenze paradossalmente prevedibili 7. Tuttavia, gli eventi dell’11 settembre possono essere letti (o «ascoltati») anche nella prospettiva di un nuovo terribile radiodramma, che spalanca scenari apocalittici e mette in discussione l’ordinato dipanarsi delle circostanze. L’individuo sulle soglie del XXI secolo, già consapevole di come sia fragile la propria esistenza personale, scopre che intorno a lui agiscono forze devastanti, improvvisi bagliori di annientamento, esattamente come nel Crepuscolo degli Dei profetizzato dalla cultura decadente o dalla paranoia di massa che, negli anni Cinquanta del Novecento, accompagnò negli Stati Uniti il periodo più acuto della Guerra Fredda. Ora che le Twin Towers sono crollate, il territorio apocalittico del Ground Zero – una denominazione che ci riporta indietro nel tempo ai bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki – genera altri paesaggi futuri, altre topografie avveniristiche, altre rappresentazioni del tempo a venire. Ci si chiede, ad esempio, se sarebbe stata ancora possibile, dopo l’11 settembre, l’allegra copertina del «Maclean’s» (il maggior settimanale canadese in lingua inglese) in data 20 agosto 2001, su cui campeggia il profilo di un giovanotto fornito di gadgets e di vestiti ultramoderni, accanto al titolo: 6 «Se vuoi un quadro del futuro, immagina uno stivale che calpesta un volto umano – per sempre». G. ORWELL, 1984, Harmondsworth, Penguin Books 1964 [1949], p. 215. 7 G. FODEN, War of the Worlds, in «The Guardian Review», 24 August 2002, pp. 4-6.
83
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
CARLO PAGETTI
ZAP! It’s the future Paper and fabric cellphones Talking food boxes «Smart» shoes with tiny motors Self-focusing eyeglasses… Coming sooner than you think 8.
Sarebbe più facile oggi parlare di complicate tecnologie di intercettazioni elettronica, di bombe più o meno «intelligenti», di piani di colossali guerre future e di insidiosi contrattacchi batteriologici. Ma forse la narrativa e il cinema di fantascienza non sono neppure questo, dedicandosi piuttosto all’esplorazione di zone marginali, di storie personali, di risvolti bizzarri e talvolta comici. Il futuro è invenzione continua, scherzo e parodia del presente, progetto che non si può verificare e che sfugge di mano ai suoi goffi ideatori, al massimo territorio di desideri, privo di qualunque certezza e razionalità. In fin dei conti, è questa la lezione che ritroviamo nelle opere dello scrittore di fantascienza attualmente più celebrato, l’americano Philip K. Dick, morto nel 1982, in cui non cerchiamo certo alcuna autentica previsione scientifica, ma invece, appunto, il senso dello smarrimento derivante dalla incerta identità di individui sempre in balia degli eventi, anche quando credono di poterli controllare o addirittura predeterminare. Così, nel racconto Minority Report, che risale agli anni Cinquanta e che ha ispirato il recente film di Steven Spielberg, non solo il potere dei precogs «veggenti» viene usato per rafforzare uno stato di polizia, capace di colpire preventivamente ogni potenziale criminale, ma l’intero procedimento si rivela fallibile e manipolabile, tanto è vero che nelle sue maglie rischia di rimanere invischiato l’ingenuo scienziato che lo aveva creato. Peraltro, Spielberg cattura bene il senso ludico e nello stesso tempo banale della previsione del futuro in una delle sequenze a mio parere più efficaci del film, quando Anderton, che trascina con sé la precog Agatha attraverso un grande emporio commerciale del futuro, esegue alla let8 «Zac! Ecco il futuro. Cellulari di carta e di stoffa. Scatole di cibo parlanti. Scarpe alla moda fornite di motorini. Occhiali che focalizzano da soli l’immagine…Sono in arrivo prima che voi pensiate». Copertina di «Maclean’s», August 20, 2001.
84
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
IL
FUTURO IMMAGINARIO DELLA FANTASCIENZA.
VIVERE
UN ALTRO PRESENTE
tera le istruzioni della donna, fino a ritrovarsi sotto la pioggia con un ombrello aperto in mano, che lo nasconde agli occhi dei suoi inseguitori. In fin dei conti, le previsioni del tempo non fanno parte della nostra esistenza quotidiana? Non ci lamentiamo della loro imprecisione? Non regoliamo su di esse i nostri comportamenti? In Metamorphoses of Science Fiction (1985), Darko Suvin ha messo assai bene in rilievo l’insufficienza dei modelli estrapolativi applicati alla fantascienza, in quanto ancella della futurologia e dell’evoluzionismo scientifico 9, insistendo invece sull’importanza dei meccanismi narrativi di tipo analogico 10. Il novum cognitivo, che costituisce il nocciolo dell’estetica fantascientifica suviniana, produce distanziamento critico nel lettore, mentre gli consente di leggere la vicenda narrata alla luce di una dinamica rappresentazione del presente: «[…] il valore cognitivo di tutta la fantascienza, compresi i racconti di anticipazione, deve essere rintracciabile nei suoi riferimenti analogici al presente dell’autore, piuttosto che nelle predizioni discontinue e globali» 11. Il futuro inseguito dalla fantascienza non può essere altro che un presente modificato, ma pur sempre riconoscibile in base alle pulsioni che esso interpreta, anche quando contiene in sé la percezione di un cambiamento traumatico, o propone una frattura riguardo al presente investito dal vento della nostalgia e del rimpianto, ovvero suggerisce la qualità mitica di un luogo dove la scoperta e l’esplorazione di nuovi mondi rigenera lo spazio dell’avventura, con tutte le sue potenzialità fabulatorie (lo scienziato sperimentatore come Faust o Prometeo, l’astronauta come Ulisse). D’altra parte la fantascienza si presenta, di volta in volta, a seconda delle definizioni proposte dai vari studiosi, come una significativa variante dell’utopia: speculative fiction, futuristic fiction, fiction of the future, art of the conjecture 12. Anthony Burgess non ha mancato di notare le oscillazioni terminologiche a cui va incontro lo scrittore di 9 D. SUVIN, Le metamorfosi della fantascienza, Il Mulino, Bologna 1985 [1979], pp. 46-47. 10 Ivi, pp. 47 sgg. 11 Ivi, pp. 99-100. 12 Rinvio per una breve discussione sul termine a C. PAGETTI, Science Fiction, in V. FORTUNATI e R. TROUSSON (a cura di), Dictionary of Literary Utopias, Honoré Champion Editeur, Paris 2000, pp. 550-556.
85
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
CARLO PAGETTI
fantascienza inserendo in The End of the World (1982) una discussione tra un professore (che è anche autore di romanzi SF) e alcune sue allieve: Judy Gray said that the job of scifi, futfic really, was to prophesy. To get us ready for things going to happen in the future, right? No, said Penny Dreiser, it was to give us the future in the present, because none of us would get the real future future 13.
Anche se una delle radici della fantascienza moderna si situa certamente in quel vasto processo di divulgazione scientifica che seguì l’esposizione delle teorie darwiniane sulla selezione naturale contenute in On the Origins of the Species, è evidente che già la fine dell’Ottocento, e il clima apocalittico del Decadentismo, certificato dai scientific romances di Herbert George Wells, comincia a sostituire alla previsione razionale (o presunta tale) l’incubo visionario assai più vicino alla fantasticheria individuale o alla profezia biblica. Nel primo caso basterà pensare all’incipit di The Purple Cloud di Matthew Philiph Shiel (1895), in cui il risveglio del narratore avviene su una Terra apparentemente intatta se non per l’inesplicabile scomparsa di ogni essere umano; nel secondo, ad alcuni racconti di Wells, come Armageddon o The Star, in cui la fine dell’umanità appare come un evento di scarsa importanza nel grandioso scenario cosmico. È probabile che la cultura postindustriale degli albori del XXI secolo debba dichiararsi erede delle contrastanti immagini del futuro proiettate dalla fine dell’Ottocento, nel senso che al suo interno lottano almeno due anime, ovvero due visioni, ovvero due scenari, quello scientifico-tecnologico che consente di nutrire la speranza di nuove forme di immortalità in campo medico e biologico, di tecnologie avanzate che rendano più leggera o attraente la vita quotidiana, gli svaghi, i viaggi; e quello decadente, che presenta invece l’incubo della degenerazione, dell’apocalisse, della caduta degli dei, del-
13 «Jude Gray disse che il compito della fantascienza, in effetti futurascienza, era quello di fare profezie. Prepararci alle cose che sarebbero accadute nel futuro, giusto? No, disse Penny Dreiser, era quello di darci il futuro nel presente, perché nessuno di noi avrebbe potuto possedere il vero autentico futuro». A. BURGESS, The End of the World, Harmondsworth, Penguin Books 1983 [1982], p. 29.
86
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
IL
FUTURO IMMAGINARIO DELLA FANTASCIENZA.
VIVERE
UN ALTRO PRESENTE
le armi distruttive, della contaminazione biologica (sia essa dovuta alle radiazioni nucleari, o a morbi implacabili, l’aids, etc.). È forse questa la caratteristica saliente del nuovo millennio, schiacciato tra due alternative che sembrano convivere sullo stesso stretto sentiero dell’esistenza individuale e collettiva, come è successo nell’anno 2001, quando le prospettive futuristiche di un esaltante – e più o meno pacifico – progresso, avanzate ritualmente da esperti, scienziati, uomini politici, consultati dai media, sono state sostituite dalle riprese televisive apocalittiche dell’attacco alle Twin Towers. Non una realtà romanzata in un film o in un libro, ma una fantasia apocalittica che si è materializzata, attraverso i mezzi di comunicazione di massa, come se, appunto, un film avesse avuto il potere di uscire dallo schermo e di acquisire una sua vita indipendente, concreta, «oggettiva», tanto da penetrare nella coscienza dello spettatore con la folgorazione di una verità tanto assoluta quanto devastante. Di fatto, poi, fin dall’Ottocento, l’uso di uno strumento immaginativo come il romance (per usare la terminologia inglese), o del racconto di viaggi meravigliosi, finiva per introdurre in qualsiasi narrazione ispirata ai progressi e alle scoperte della scienza elementi di sorpresa e di inquietudine, che negavano le più serie premesse divulgative dichiarate, forse con un eccesso di zelo, da Jules Verne. In quanto a Wells, già in uno dei suoi primi saggi, The Discovery of the Future (1895), l’allievo di quel darwiniano di ferro che era T.H. Huxley, giungeva a conclusioni sconcertanti, immaginando l’esploratore del futuro come un archeologo, che, immerso nell’oscurità di un mondo sotterraneo, accende un fiammifero, proietta uno sprazzo di luce contro una parete, e riesce appena a scorgere segni misteriosi, indecifrabili, prima di piombare nuovamente nelle tenebre 14. Wells recupera questo momento così significativo nel suo primo scientific romance, The Time Traveller (1895). Il suo Viaggiatore, correndo disordinatamente in avanti sul suo mezzo di trasporto temporale, non
14 Dell’ampia bibliografia wellsiana, con particolare riferimento al rapporto tra i scientific romances, la visione del futuro, la fin de siècle, mi limito a segnalare: C. PAGETTI, I Marziani alla corte della Regina Vittoria, Tracce, Pescara 1986; P. PARRINDER, Shadows of the Future. H.G. Wells, Science Fiction and Prophecy, Liverpool U.P., Liverpool 1995; E. SHOWALTER, The Apocalyptic Fables of H.G. Wells, in J. STOKES (a cura di), Fin de Siècle/Fin du Globe, Macmillan, London 1992, pp. 69-84.
87
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
CARLO PAGETTI
avrà mai una visione panoramica, definitiva, del futuro. Dovrà ogni volta sforzarsi di offrirne una interpretazione, che ricolleghi il futuro al presente da lui conosciuto, senza perciò trovare mai una chiave di lettura definitiva, anzi, compiendo una serie di omissioni e di errori clamorosi. Così, ad esempio, nello scenario che occupa buona parte del romanzo, situato nella Londra dell’anno 802701, gli Eloi sono creature angeliche immerse nella natura edenica, ovvero, in una successione di ipotesi avanzata da Il Viaggiatore del Tempo, i pronipoti degradati e incapaci della borghesia vittoriana, e, infine, in una successiva versione, niente altro che il bestiame, la carne da macello, dei loro antichi servitori, la classe proletaria a sua volta degenerata nella condizione dei Morlocks mostruosi, simili a Lemuri i cui occhi non sopportano neppure la luce del sole. Eppure quei mostri cannibali, che il Viaggiatore del Tempo odia con tutte le sue forze e che, quando è assalito da essi, uccide senza pietà, sanno ancora come azionare i macchinari e sono interessati a quello splendido mezzo di locomozione che è la macchina del tempo 15. Fuggendo verso un futuro sempre più remoto, il Time Traveller incontra un paesaggio desolato, privo di vita, fino a giungere laddove la conclusione dell’esistenza stessa della Terra coincide con l’inizio di una forma primordiale di vita. Ancora una volta le immagini del futuro e i miti dell’origine finiscono per sovrapporsi e per convalidarsi a vicenda. Dunque il Viaggiatore wellsiano è destinato a scomparire, assorbito dai processi temporali, lontano dallo spazio della sua quotidianità, la casa dove ospitava gli amici. È un illusionista che sparisce alla fine dello spettacolo, avendo esaurito il suo bagaglio di trucchi, eppure lascia nell’aria la traccia impalpabile di una profezia che, come la letteratura stessa, si nutre di menzogne. Lo scrittore è un astrologo che usa i trucchi del linguaggio, per mostrare ciò che in realtà non vede o intuisce molto parzialmente. Del resto, come vedremo anche a conclusione di questo discorso, non è detto che la menzogna non sia l’unico modo per restituire un senso alla realtà. Così succede in un romanzo francese dell’inizio dell’Ottocento, Les Posthumes, rivalutato da Paul Alkon, in cui l’innamorato Fontlhete, che si è avvele-
15 Rinvio ai saggi compresi in G. SLUSSER, P. PARRINDER, D. CHATELAIN (a cura di), H.G. Wells’s Perennial «Time Machine», The University of Georgia P., Athens 2001.
88
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
IL
FUTURO IMMAGINARIO DELLA FANTASCIENZA.
VIVERE
UN ALTRO PRESENTE
nato disperando di poter sposare Hortense, prima di morire, essendo riuscito a far sua la donna, prepara 366 lettere che dovranno raccontare il suo viaggio a Londra, a Roma, a Firenze, riferendo eventi di un futuro a lui negato, in modo che Hortense lo creda ancora vivo 16. Dalla dimensione privata di Les Posthumes passiamo al discorso eminentemente politico della distopia novecentesca, in cui il futuro immaginato perde qualsiasi pretesa di oggettiva neutralità, e vuole essere esplicita riaffermazione di una ideologia capace di denunciare i guasti del presente e di individuare le responsabilità storiche e politiche di chi detiene il potere. In questa prospettiva si situano alcuni recenti interventi di Carl Freedman e dello stesso Suvin, che non esitano a rilanciare una funzione politica della fantascienza, una sua vocazione non soltanto di denuncia, ma anche di proposta e di alternativa rispetto all’assetto globale del mondo dopo la caduta del muro di Berlino 17. Creazione dell’immaginario, il futuro istituisce una rete di riferimenti al tempo e allo spazio, che ne riaffermano la storicità, senza escludere il ricorso al libero gioco della fantasia. Il futuro si colloca dunque all’incrocio tra la consapevolezza della storia presente, delle sue articolazioni, dei suoi pericoli, e la proiezione in chiave di sogno o di incubo di una narrazione che tende a diventare elusiva, ad assumere la pulsione privata di un desiderio, ad accogliere premonizioni autobiografiche. Le opere più vitali della fantascienza trasformano in esplicito gioco di variazioni il discorso sul futuro, contrapponendo percorsi differenti, scenari alternativi, soluzioni paradossali. Il viaggio verso il futuro dell’eroe fantascientifico, che si esplica narrativamente con modalità non dissimili da quelle che presiedono all’organizzazione del romanzo utopico, può avvenire in sogno (News from Nowhere di William Morris, 1885), grazie al risveglio avvenuto dopo un periodo protratto di sonno (When the Sleeper Wakes di H.G. Wells, 1901), tramite un mezzo di trasporto chiamato
16 P.K. ALKON, Origins of Futuristic Fiction, The University of Georgia P., Athens 1987, pp. 207 sgg. 17 C. FREEDMAN, Critical Theory and Science Fiction, Wesleyan U.P., Hanover (N.H.) 2000; D. SUVIN, Afterword: with Sobered Estranged Eyes, in P. PARRINDER (a cura di) Learning from Other Worlds. Estrangement, Cognition and the Politics of Science Fiction and Utopia, Liverpool U.P., Liverpool 2000, pp. 272-290.
89
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
CARLO PAGETTI
macchina del tempo, o anche in seguito a un fenomeno cosmico che apre squarci nel tessuto temporale (The Weapon Shops of Isher di A.E. Van Vogt, 1950). In realtà lo scrittore di fantascienza può anche fare a meno di questi espedienti e collocare direttamente l’azione in un futuro immaginario, che dovrà essere costruito nella sua stranezza, nel suo distacco dall’esperienza quotidiana del lettore, fin dalle prime righe del romanzo, come succede in alcune celebri antiutopie novecentesche, in cui l’ingresso del lettore nell’universo straniato del tempo a venire viene suggerito da alcuni dettagli concreti 18. E, continuando per questa strada, il futuro può anche apparire come un passato ricostruito attraverso alcuni documenti da un’epoca successiva, ancora più lontana dal presente. Così se L’Ultimo Uomo di Stapledon riepiloga le innumerevoli fasi della storia dell’umanità futura dal punto di vista privilegiato di chi è arrivato fino al gradino più alto della scala evoluzionistica e dunque tutto conosce, assai più soggettiva e parziale è la ricostruzione delle testimonianze del passato (ovvero di un futuro prossimo venturo rispetto alla percezione del lettore) operata da chi si situa in un tempo a venire remoto, ma turbolento e ancora in fieri, e si interroga su una fase conclusa del proprio passato, corrispondente appunto al futuro prossimo venturo del lettore, come avviene in Iron Heel di Jack London (1912) o in The Handmaid’s Tale di Margaret Atwood (1989). Così si apre un ulteriore quesito: a quale futuro, ovvero a quale presente, dovremo credere? E se il futuro viene visto come un processo in continuo sviluppo, aperto a diverse soluzioni nel corso del tempo, dovremo concludere che il «nostro» presente è, dopo tutto, irrilevante, perché esso genera sia un’era A (in Iron Heel quella della brutale repressione capitalista contro la classe operaia americana), sia un’era B (nello stesso romanzo, quella che celebra il trionfo del comunismo, essendo state sconfitte le forze del capitale)? Una buona parte della fantascienza americana ritiene più ottimisticamente che le premesse peggiori del futuro possano essere modificate attraverso l’assunzione di precise responsabilità individuali o sociali. Perfino il cyborg protagonista
18 Si leggano gli incipit raccolti da S. MANFERLOTTI in Anti-Utopia. Huxley Orwell Burgess, Sellerio, Palermo 1984.
90
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
IL
FUTURO IMMAGINARIO DELLA FANTASCIENZA.
VIVERE
UN ALTRO PRESENTE
di Terminator 2 Judgement Day (Terminator 2 Il giorno del giudizio, 1997) di John Cameron è pronto a distruggere la prodigiosa microchip che contiene la sua intelligenza artificiale, ben sapendo quante potenzialità distruttive si possano sprigionare dalla sua conoscenza. L’apparizione dell’abitante del futuro, che è percepito sempre come un essere straordinario, per molti versi assimilabile a un extraterrestre – anche i Marziani di The War of the Worlds di Wells, 1897, nella loro alienità, assumevano le sembianze di quegli uomini del futuro, dotati di potenti cervelli e di arti atrofizzati, secondo le caratteristiche fisiche che lo stesso scrittore aveva ipotizzato come inevitabile sviluppo del percorso evolutivo –, ha comunque un ruolo destabilizzante, perché pone i suoi interlocutori di fronte alla necessità di aprire gli occhi, di interrogarsi sul proprio destino. L’uomo del futuro è fornito di poteri straordinari (la telepatia nella già citata narrazione epica di Olaf Stapledon, Last and First Men), ma il destino di colui che sa leggere nel futuro è di solito tragico e si risolve o nell’angoscioso dilemma riguardante l’inevitabilità della propria morte (vedi anche Stochastic Man di Robert Silverberg e Leap forward di Robert Sawyer) o nell’attesa consapevole del momento della morte (The World Jones Made di Philip K. Dick, 1968). Proprio Dick conferma di essere il più interessante scrittore di fantascienza del Secondo dopoguerra, poiché propone una dimensione del futuro non statica, ma giocata continuamente sulla percezione soggettiva della realtà di cui partecipano i suoi personaggi e su una serie di scenari mutevoli e fondamentalmente arbitrari. Secondo lo scrittore americano, il futuro non si può prevedere né con l’aiuto di elaborati sistemi di calcolo statistico, né attraverso le facoltà straordinarie di alcuni individui. Semmai, come sottolinea ancora Dick nel romanzo The Three Stigmata of Palmer Eldritch (1965), il futuro è un’allucinazione prodotta da una droga potente, Chew-Z, tanto più simulato, quanto più esso appare, al primo impatto, credibile e convincente. Così, i personaggi dickiani che tentano di opporsi all’invasione aliena del super-capitalista Palmer Eldritch, una terrificante figura di cyborg, dotata di denti metallici, un braccio artificiale, occhi lenticolari, si rendono conto, in un episodio dopo l’altro, di vivere all’interno di uno scenario illusorio, in cui finisce per
91
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
CARLO PAGETTI
materializzarsi puntualmente il corpo mostruoso di Palmer Eldritch. Anche quando uno di essi riesce ad approdare a un lontano futuro, dove sembra che il cyborg sia stato eliminato, egli è costretto a rendersi conto che Palmer Eldritch è presente, anzi, ha beffardamente creato (come, appunto, uno scrittore di fantascienza postmoderno) uno scenario avveniristico: He wondered how he had gotten here to this future epoch. Or was this an illusion, too, constructed by the master hallucinator, Palmer Eldritch? […]. This was Palmer Eldritch imagining the future; these were meanderings of his brilliant, creative mind as he waited at his demesne on Luna for the effects of the intravenous injection of Chew-Z to wear off. Nothing more 19.
In effetti, la rappresentazione del futuro, fatta da Dick nelle opere degli anni Cinquanta e dei primi anni Sessanta, riflette soprattutto l’inquietudine dello scrittore americano rispetto ai processi storico-politici in corso: il futuro si conferma «figlio» delle paure del presente, più che delle sue anticipazioni o previsioni razionali, quando esso non è addirittura in grado di manipolare o di ricostruire artificialmente il tempo presente. In Time out of Joint (1959) di Dick, infatti, il rapporto tra presente e futuro viene rovesciato. È il futuro, come scopriranno lentamente alcuni personaggi, ad aver falsificato il passato, attraverso la ricostruzione di una cittadina degli anni Cinquanta, Old Town, in cui il protagonista, un geniale matematico vicino alla follia, viene confinato a sua insaputa, in modo che, senza neppure rendersene conto, continui a elaborare i calcoli che guidano le traiettorie dei missili lanciati contro la Luna nel corso di una guerra interplanetaria. Quando il futuro della fine del XX secolo (il futuro per i lettori e lo scrittore, che appartengono, essi sì veramente, alla fine degli anni Cinquanta) si materializza come autentico presente, esso non riflette alcuna immagine coerente di progresso, ma
19 «Si chiese come fosse arrivato lì, in quell’epoca lontana. O anche questa era un’illusione, concepita dal maestro delle allucinazioni, Palmer Eldritch? […]. Era Palmer Eldritch, che aveva immaginato quel futuro; erano i vagabondaggi della sua sua brillante mente creativa, mentre egli aspettava nella sua proprietà su Luna di smaltire gli effetti dell’endovenosa di Chew-Z. Nulla di più». P.K. DICK, The Three Stigmata of Palmer Eldritch, New York, Macfadden Books, 1966 [1965], p. 89.
92
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
IL
FUTURO IMMAGINARIO DELLA FANTASCIENZA.
VIVERE
UN ALTRO PRESENTE
solo confuse vicende di guerra e di distruzione. L’effetto è quello di produrre il senso di straniamento cognitivo che Darko Suvin ha individuato come il più potente meccanismo narrativo innescato dalla fantascienza: giunto alla conclusione di Time out of Joint, il lettore della fine degli anni Cinquanta ha imparato che il paesaggio della provincia americana intorno a lui è falso, come è comunque falsa, appena delineata, poco convincente, la fin de siècle immaginata dallo scrittore. Stretto tra due mondi della cui artificialità si è reso consapevole, non gli rimarrà forse, come accade al matematico di Time out of Joint, che regredire nel proprio passato. Non è certo un caso che uno degli scrittori che più hanno saputo apprezzare la fantascienza di Philip K. Dick, John Brunner, sia anche l’autore di un racconto che ha saputo cogliere in modo estremamente efficace sia le ambiguità ideologiche, sia le pulsioni utopiche, che sono insite nella rappresentazione del futuro. Il racconto è The Man Who Saw the Thousand Year Reich, pubblicato da Brunner in origine negli anni Sessanta. Qui, il ritrovamento del cadavere del generale nazista Wentschler, congelato nel ghiaccio sulle Alpi svizzere, viene spiegato al narratore da un misterioso personaggio che sembra conoscere i retroscena dell’intera vicenda. Durante la Seconda guerra mondiale, nel 1944, Wentschler viene avvicinato dall’Oberkommandant Kalkhaver, il quale gli spiega che il Reich ha costruito una macchina del tempo e che egli verrà spedito nel futuro in modo da verificare l’andamento della guerra e l’inevitabile trionfo della Germania hitleriana. Come in alcuni romanzi di «storia controfattuale», tra cui Fatherland di Robert Harris, si configura l’avvento di un futuro da incubo, basato sull’ipotesi della vittoria del Nazismo. In realtà (nella realtà del racconto di Brunner) Wentschler si ritrova, dopo il viaggio nel tempo, in una casa altoborghese, dove, con orrore crescente, si rende conto che i suoi ospiti sono razzialmente impuri (l’unico esemplare ariano fa il cameriere…), che possiedono opere d’arte «degenerate», che ascoltano musica «negra» e, guardando un telegiornale, scopre con orrore che i massimi gerarchi nazisti sono stati sottoposti a un programma di rieducazione alla fine di una guerra evidentemente perduta. Ultimo grottesco dettaglio: in bagno la carta igienica è contrassegnata dal simbolo della svastica… A questo punto Wentschler viene strangolato e il suo cadavere fatto spari-
93
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
CARLO PAGETTI
re in alta montagna, dove verrà ritrovato molti anni dopo. Si è trattato di un hoax, di uno scherzo architettato ai danni dei Nazisti da un ricco intellettuale di origine ebrea, Feuerstein, rifugiato in Svizzera, quando ancora le sorti della guerra sono effettivamente in bilico. Assieme ad alcuni complici egli ha rapito il generale nazista, facendogli credere all’esistenza della macchina del tempo. Il futuro ricostruito da Feuerstein è ugualmente posticcio delle fantasie naziste del Reich che avrebbe dovuto estendersi per mille anni, e non coincide con la «verità» storica conosciuta dal lettore e dallo scrittore. È pura invenzione, mossa da una finalità etica superiore, o piuttosto dalla rivendicazione che il futuro è aperto e nessuna ideologia lo può costruire a suo piacimento. La casa in cui si Wenschler è stato portato, non è altro che un set cinematografico, su cui alcuni attori, con l’aiuto di materiale appositamente preparato per essere trasmesso su un avveniristico schermo televisivo, stanno recitando una parte. Una volta terminata la recita con l’uccisione «terapeutica» di Wenschler, lo scenario si dissolve nel nulla e il futuro ritorna a essere un drammatico punto di domanda: It was over by dawn: the carefully constructed newsreel, incorporating footage from a science fiction film […], all the little taunts and the final sledge-hammer blow, were destroyed, and the actors went black to their daily lives. Not, of course, that they were professionals. They were simply people who had nearly as much much reason to hate the Nazis as the man who called himself Feuerstein, and not nearly as much money 20.
Dunque, il futuro di The Man Who Saw the Thousand Year Reich, in quanto messinscena di una visione avveniristica che si oppone ai sogni di dominio nazisti, è l’unico che merita di essere veramente vissuto. Lo scrittore – anche e forse soprattutto lo scrittore di 20 «All’alba era tutto finito: il telegiornale concepito con cura, e in cui erano state incorporate alcune sequenze tratte da un film di fantascienza, che nessuno aveva visto, perché le sue riprese erano state interrotte allo scoppio della guerra […] tutti i piccoli sberleffi e la mazzata finale, vennero distrutti, e gli attori tornarono alla loro vita quotidiana. Non che fossero attori professionisti, naturalmente. Erano semplicemente persone che nutrivano quasi gli stessi motivi per odiare i nazisti di quelli che aveva Feuerstein, e che non avevano tutto il denaro che lui possedeva». J. BRUNNER, The Man Who Saw the Thousand-Year Reich, in The Best of John Brunner, New York, Ballatine Books 1988, p. 214.
94
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
IL
FUTURO IMMAGINARIO DELLA FANTASCIENZA.
VIVERE
UN ALTRO PRESENTE
fantascienza – può rappresentare un’alternativa all’incubo del presente e, in questo modo, restituire all’utopia il senso di una speranza di riscatto di fronte ai fallimenti più clamorosi della Storia a lui contemporanea. Esiste sempre la possibilità di un altro presente, ovvero di un altro futuro. Nel racconto The Lucky Strike, pubblicato nell’anno orwelliano 1984, Kim Stanley Robinson immagina che, in seguito a un grave incidente e alla morte del suo equipaggio, la Fortezza Volante Enola Gay, che nell’agosto 1945, lanciò la prima bomba atomica sulla città giapponese di Hiroshima, sia sostituita da un altro aereo, The Lucky Strike. Il Capitano Frank January, che deve sganciare sul bersaglio l’ordigno, preso da scrupoli morali, ritarda volutamente l’operazione, e la bomba atomica esplode su una foresta, invece di annientare il centro urbano. January viene arrestato e condannato a morte da un tribunale militare, ma intanto anche il secondo bombardamento atomico su Nagasaki fallisce, il Giappone accetta comunque la resa, e, negli anni successivi, una potente organizzazione pacifista, che si ispira al sacrificio di January, convince le potenze mondiali a rinunciare alle armi nucleari. L’ordito della Storia viene radicalmente modificato. Cambiando un tassello cruciale nell’ipotetico presente del 1945, la fantascienza ha modificato il corso degli eventi successivi. Il futuro immaginario da essa creato potrà, a sua volta, contribuire a riscrivere il nostro presente.
95
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
IL VIRTUALE COME ULTIMA FRONTIERA DEL POSSIBILE UTOPICO E FANTASCIENTIFICO di VITA FORTUNATI
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
Vorrei tentare di investigare gli aspetti utopici o distopici delle nuove realtà virtuali per capire se il virtuale rappresenti veramente l’ultima possibile utopia 1. Ho scelto di articolare il mio intervento in tre punti: il primo intende sottolineare la differenza tra «modello» e «simulazione»; il secondo, indaga le caratteristiche della realtà virtuale come possibile utopia; il terzo, si focalizza sul cyborg come vera ultima frontiera dell’utopia, in quanto congiunzione dell’informatica con la biologia. Esiste a mio avviso una differenza concettuale tra «modello» e «simulazione». Le utopie del passato erano modelli possibili di organizzazione politica e sociale: speculazioni sui possibili laterali dell’esperienza, dove, partendo da un principio, l’utopista, come nel gioco degli scacchi, stabiliva lo schema del gioco 2. Il principio veniva esteso dall’utopista a tutti gli aspetti della realtà, provocando inevitabilmente una semplificazione della complessità del reale. Il modello, quindi, fissava in maniera rigida le combinazioni del gioco, le «mosse delle pedine», si presentava come modello per così dire «deterministico», che non lasciava spazio all’imprevisto e al deviante. Oggi, grazie alla nuova tecnologia virtuale, la «simulazione» è diventata, soprattutto nel campo delle scienze applicate, un approccio fondamentale per studiare, verificare, creare sistemi dinamici complessi 3. La simulazione permette, infatti, di fare interagire tra loro un 1 Per quanto riguarda alcune riflessioni sul virtuale vorrei ringraziare Elena Lamberti, i cui consigli e suggerimenti bibliografici mi sono stati di grande utilità nella stesura di questo saggio. 2 M. HOLQUIST, How to play utopia: some brief notes on the distinctiveness of utopian literature, in M. ROSE, (ed.), Science Fiction: A Collection of Critical Essays (1976), pp. 132-146. 3 C. FRANCESCHI, Invecchiamento e complessità. Una prospettiva evolutiva, in P. DONGHI (a cura di), La nuova Odissea, Editori Laterza, Bari 2002, pp. 81-99.
99
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
VITA FORTUNATI
certo numero di elementi, secondo regole predeterminate, creando modelli che hanno caratteristiche di flessibilità. Il potere euristico di questo approccio scientifico consiste nell’esplorare un numero altissimo di percorsi conoscitivi e di soluzioni, dove possono emergere proprietà forse nuove che non erano prevedibili. Quanto può essere utile, oggi, affrontare l’utopia come progettazione di realtà alternative attraverso questa metodologia? Le simulazioni presuppongono di indicare gli elementi e le regole di interazione tra di loro; nel caso specifico, se qualcuno volesse effettuare delle simulazioni di società utopiche, incontrerebbe un ostacolo o comunque un limite rappresentato dal fatto che dovrebbe utilizzare assunzioni che non possono che derivare in larga misura da un sapere tradizionale, legato alle varie teorie politiche e sociali che si sono stratificate nel tempo. L’aspetto che rende tale operazione ancora imperfetta deriva dal fatto che le simulazioni utopiche, oltre a utilizzare come abbiamo visto un sapere tradizionale, non possono non coinvolgere il «fattore umano». La percezione del mondo, delle situazioni, degli ambienti propria di ogni individuo è già, di per sé, un sistema dinamico complesso e unico, summa di elementi biologici e culturali, realtà stratificata difficile da rendere nel linguaggio informatico, se non attraverso semplificazioni «esemplari», definizione di «tipi» o «caratteri» necessariamente connotati e, quindi, «determinati» in termini di psicologia cognitiva. Naturalmente, è proprio sulla definizione dell’elemento umano che ruotano gli studi sull’intelligenza artificiale, impegnati a «rendere», «tradurre» nel linguaggio informatico i difficili concetti di sensibilità, percezione soggettiva, sentimento, storia e cultura di un individuo. Proprio il rapporto tra «umano» e «non umano» è, da sempre, uno dei temi centrali della SF, con rese spettacolari in campo cinematografico. È, infatti, uno dei temi cari a Kubrick (2001 A Space Odissey), che recentemente Spielberg ha riaffrontato nel discusso A.I. Artificial Intelligence. In quale misura la realtà virtuale si configura come una possibile utopia o distopia? Con il software, si possono creare realtà infinite, immaginare e programmare mondi ibridi giocati su più livelli temporali, tra presente, passato e futuro. Se nella utopia la creazione di un mondo alternativo nasceva sempre come critica al presente, nella creazione di questi mondi virtuali mi sembra prevalga l’a-
100
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
IL
VIRTUALE COME ULTIMA FRONTIERA DEL POSSIBILE UTOPICO E FANTASCIENTIFICO
spetto del gioco: un gioco da cui è stata eliminata una progettualità politica di ampio respiro. Molti hanno sottolineato, si pensi per esempio al libro di Furio Colombo Confucio nel computer 4, come «realtà virtuale» e «realtà» siano tra loro due mondi che ancora si contrappongono; il primo asettico, «artificiale», esente dagli aspetti arcaici del cosiddetto «mondo primario», il secondo pieno di odori e di violenza, dove sono ancora visibili le profonde differenze di classe, di cultura, di condizioni di vita. Due modelli di mondi che si contrappongono, ma che, nel tempo, finiscono inevitabilmente per contaminarsi: infatti, la realtà virtuale, a differenza dell’«altrove» utopico della tradizione, agisce sul presente producendo effetti complessi, condizionando non solo la psiche degli individui, ma anche gli eventi politico-sociali. A questo proposito, basta ricordare gli studi seminali di Marshall McLuhan e di Jean Baudrillard sulla potenza delle nuove tecnologie elettriche e elettroniche a partire dal secondo Novecento 5. Studi che hanno influenzato, inevitabilmente, anche una serie di produzioni cinematografiche che hanno caratterizzato, in particolare, la seconda metà degli anni Settanta e dei primi anni Ottanta. Esemplare, a questo proposito, è Videodrome (1982), di David Cronenberg, che presenta una società dominata dal mezzo televisivo, che penetra letteralmente gli individui, anestetizzati dalle tecniche medianiche del dottor Oblivion. Per continuare questa mia esplorazione sulle caratteristiche utopiche della realtà virtuale, mi sembra interessante partire proprio da una riflessione su quello che è il paradigma per eccellenza della tradizione utopica, ovvero il «viaggio» 6, il momento di iniziazione che porta a una trasformazione del soggetto che lo intraprende. Nella tradizione utopica il viaggio è un’esperienza formativa fondamentale, che presuppone un’avventura di tipo conoscitivo, dove prevale ancora l’aspetto attivo della conoscenza da parte del soggetto che 4 Cfr. F. COLOMBO, Confucio nel computer. Memoria accidentale del futuro, Nuova ERI Rizzoli, Milano 1995. 5 Cfr. M. MCLUHAN, Understanding Media. The Extensions of Man, Signet Books, New York 1964; J. BAUDRILLARD, Simulacre et Simulation, Collection Débats, Galilée, Paris 1981. 6 V. FORTUNATI, Scrittura di viaggio e scrittura utopica tra realtà e finzione, in R. BACCOLINI, V. FORTUNATI, N. MINERVA (eds.), Viaggi in utopia, Longo, Ravenna 1996, pp. 13-19.
101
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
VITA FORTUNATI
sta vivendo l’esperienza. Nel mondo virtuale l’idea di viaggio appare diversa, perché fortemente condizionata dalla tecnologia che la sottende. L’idea di viaggio è, infatti, associata al concetto di «immersione», di coinvolgimento psico-sensoriale, una sorta di trip che sottolinea l’aspetto spesso visionario e onirico della situazione che il soggetto si trova a vivere; egli vive, infatti, un’esperienza che lo trasporta in una realtà che lo avvolge in maniera «magica» o «perturbante», che gli fa vivere un sogno o un incubo. Questo trip è indotto ed è reso possibile da una tecnologia e, quindi, non è più necessariamente legato all’idea di «conoscenza» ma diventa, almeno in partenza, un viaggio «necessario», una soglia che «il viaggiatore» deve attraversare per accedere alla dimensione virtuale. Michael Heim, studioso nordamericano autore di numerosi libri sul virtuale, definisce, infatti, nel suo libro Virtual Realism la «VR» (Virtual Reality) come una tecnologia che «creates a very definite experience made possible by high-speed computers» 7. La realtà virtuale è, per Michael Heim: an immersive, interactive system based on computable information. These defining characteristics boil down to the three «I’s» of VR: immersion, interactivity, and information intensity. Immersion comes from the devices that isolate the senses sufficiently to make a person feel transported to another place. Interaction comes from the computer’s lightining ability to change the scene’s point-of-view as fast as the human organism can alter its physical position and perspective. Information intensity is the notion that a virtual world can offer special qualities like telepresence and artificial entities that show a certain degree of intelligent behaviour 8.
Il trip indotto dalla tecnologia virtuale agisce direttamente sul fruitore che è «trasportato» in un mondo altro, in modi diversi a se7 «crea un’esperienza definita resa possibile da computer velocissimi». M. HEIM, Virtual Realism, Oxford University Press, Oxford-New York 1998, p. 6. 8 «un sistema nel quale immergersi, interattivo, che si basa sull’informazione computazionale. Queste caratteristiche che lo definiscono si riassumono nelle tre «I» della Realtà Virtuale: immersione, interattività e intensità di informazione. L’immersione è ottenuta grazie ai dispositivi che isolano i sensi in modo tale da fare sentire, provare a una persona la sensazione di essere trasportata in un altro luogo. L’interazione deriva dalla capacità che il computer ha di modificare il punto di vista tanto velocemente quanto velocemente può l’organismo umano modificare la sua posizione fisica e la sua prospettiva. L’intensità di informazione è la nozione secondo la quale un mondo virtuale può offrire alcune qualità speciali come la telepresenza e le entità artificiali che denotano un certo grado di comportamento intelligente». Ivi, pp. 6-7.
102
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
IL
VIRTUALE COME ULTIMA FRONTIERA DEL POSSIBILE UTOPICO E FANTASCIENTIFICO
conda del dispositivo usato (dalla «telepresenza», all’elmetto HMD ovvero Head Mounted Device, alla Cave. O, nelle ultime rese cinematografiche, da devices inseriti direttamente nel cervello o nel corpo degli individui. Si pensi a film come The Matrix dei Wachowski Brothers o a eXistenZ di David Cronenberg). Naturalmente, un discorso a parte va fatto per i simulatori costruiti sfruttando la tecnologia virtuale ed utilizzati per «preparare» gli individui a operare in situazioni particolari o a interagire con sistemi dinamici complessi (per esempio i simulatori NASA, quelli usati per allenare il personale che verrà impiegato nelle centrali nucleari e altri). In quel caso l’obiettivo di formazione professionale determina il livello di «immersione» nel mondo virtuale, essendo queste esperienze mirate ad acquisire competenze specifiche. Un altro settore da investigare concerne l’immenso potenziale in termini di resa visiva che questa tecnologia ha aperto alla cinematografia fantascientifica e fantastica, che «trasporta» lo spettatore in mondi sofisticatissimi e permette la realizzazione di ambientazioni le cui caratteristiche spaziano da un immaginario carico di stratificazioni culturali, e quindi neobarocche o kitch, a uno minimalista ed essenziale. L’aspetto che interessa qui è, invece, il parallelo con il «possibile utopico e fantascientifico»: l’idea di immersione, di trip, diventa l’elemento concettuale da contrapporre al «viaggio», al journey, e induce una riflessione ulteriore su ciò che questa esperienza significa, in concreto, per l’individuo, ovvero sugli effetti, sulle tracce che questo «viaggio» lascia sul viaggiatore virtuale. Il problema è, da questo punto di vista, complesso, perché il concetto di «realtà virtuale» non è solo relegato alla sfera tecnologica o a quella scientifica o a quella cinematografica, ma è sempre più una sorta di «concetto ombrello» che, partendo da una realtà tecnologica definita, arriva a inglobare l’intero mondo della World Wide Web, la grande rete che trasporta gli individui in uno spazio nuovo, globale, sovrapposto a quello tradizionale: una sorta di bitsphere che si sovrappone e ingloba la tradizionale biosphere. Questi due termini forse delineano la differente prospettiva di coloro che hanno discusso le implicazioni sociopolitiche legate alla realtà virtuale. Da una parte, i sostenitori accaniti, che vedono nell’avvento dell’elettronica digitale una sorta di «nuova utopia» democratica, dove tutti imparano, tutti conoscono, tutti partecipano e tut-
103
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
VITA FORTUNATI
ti lavorano. Essi credono ciecamente che questa sia una forma nuova di conoscenza, che elide le barriere, politiche e di classe, che apre prospettive nuove di lavoro, di definizione di nuove reti sociali. I nuovi «guru» vedono, come sottolinea Heim, il nuovo secolo come un’enorme alveare, «a global bee-hive», dove la civiltà si libera dal controllo degli individui e lo delega al mezzo: Private territory and material possessions no longer divide people. Digital mediation does away with the battle of the books, and proprietary ideas give way to free exchange and carter. Cooperative intelligence vanquishes private minds. Extropian idealists (who define themselves as the enemy of entropy) encourage members to put their decised bodies on ice until scientists can one day either revive the repaired body or upload the barin-encased mind into silicon chips 9.
Già in questa citazione di Heim appaiono le sconcertanti implicazioni che la realtà virtuale induce. E non è quindi un caso che si levino le voci dei nuovi «apocalittici», che mettono in luce, invece, i pericoli, i lati distopici del virtuale: un’antidemocraticità subliminale, una solitudine esistenziale, l’accentuarsi della dicotomia corpo/mente. La virtualità informatica costruita su una logica binaria, sulla convergenza multimediale, accentua nell’operatore, proprio perché deve rispondere sempre a un sì o a un no, l’atteggiamento tipico di colui che interroga l’oracolo 10. L’operatore finisce così non per conoscere, ma per creare realtà fittizie, virtuali che non rinviano più a una presunta realtà indipendente. Il mondo virtuale, quindi, proprio perché è così prodotto, determina nell’operatore una sorta di pericolosa onnipotenza del pensiero, per cui conoscere risulta non tanto controllare e dominare ciò che si vuole conoscere, ma piuttosto
9 «La proprietà del territorio e i possedimenti materiali non dividono più le persone. La mediazione digitale si libera dalla battaglia dei libri e le idee di proprietà privata lasciano il campo al libero scambio e al mercato. L’intelligenza cooperativa sconfigge le mentalità privatistiche. Gli idealisti estropici (che si definiscono come i nemici dell’entropia) incoraggiano i loro adepti a mettere sotto ghiaccio i loro corpi defunti fino a che gli scienziati non riusciranno, un giorno, a riportare in vita il corpo riparato o a caricare il cervello racchiuso nella mente in chips al silicio». Ivi, p. 41. 10 Vorrei ringraziare l’amico Franco Voltaggio per avermi fatto leggere il manoscritto di un saggio sulla realtà virtuale, non ancora pubblicato, nel quale si discute sulla capacità euristica della realtà virtuale.
104
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
IL
VIRTUALE COME ULTIMA FRONTIERA DEL POSSIBILE UTOPICO E FANTASCIENTIFICO
«crearlo». Per il fruitore, la libertà di «navigazione» è solo all’apparenza infinita, essendo in realtà pre-definita dalle maglie, dagli «snodi», dai links previsti. Senza entrare nel merito di questo difficile dibattito, vorrei però sottolineare come oggi, dopo l’inevitabile entusiasmo degli inizi, sembrano essersi concretizzati alcuni avvertimenti suggeriti già negli anni Novanta da molti studiosi della comunicazione: il nuovo «villaggio globale» è controllato da un numero ristretto di multinazionali che studiano e possiedono le nuove tecnologie, elaborate da pochi cervelli in laboratorio e, comunque, fuori dalla rete continua a esistere una sorta di nuovi «morlocchi», privati dell’accesso perché non «alfabetizzati», destinati a produrre ciò che il computer progetta, ma non fabbrica 11. Prima di passare alla riflessione sul cyborg, come ultima frontiera del possibile utopico, è importante soffermarsi sul concetto di spazio (virtuale) e di fisicità o nuova fisicità (dal bio al bit) indotta da questa nuova tecnologia, perché la stessa idea del cyborg sembra connotarsi come una delle risposte più importanti ad alcuni «effetti» di questa nuova situazione tecnologica e culturale. Se i due termini journey e trip sottolineano una profonda differenza tra il viaggio utopico della tradizione e il viaggio nei mondi virtuali, la nuova tecnologia digitale costringe l’operatore a muoversi non più verso il «fuori» e il lontano fisico, come avveniva con le vecchie macchine, ma verso un «dentro» profondo ed altrettanto ignoto quanto lo era lo spazio stellare nei primi romanzi fantascientifici. Nei mondi virtuali viene offerto una sorta di «spazio interiore», la cui architettura ricorda l’interno di un edificio, con finestre che si aprono verso il «dentro»: spazi interni, la cui forma è strutturata concettualmente come un labirinto o come una serie infinita di scatole cinesi, in cui ci si muove, spesso inconsapevolmente, vincolati dalla logica binaria della matrice combinatoria. Una logica che, mentre sollecita a continuare all’infinito l’esplorazione (il labirinto non si ar11 Sul rapporto tra nuove tecnologie, mezzi di comunicazione e forme di potere si vedano, oltre ai già citati studi mcluhaniani, gli studi seminali H.A. INNIS, Empire and Communication, Oxford University Press, London 1950, trad. it. Impero e Comunicazioni, Meltemi, Roma 2002; The Bias of Communication, University of Toronto Press, Toronto 1951, trad. it. Le tendenze della comunicazione, SugarCo, Milano 1982.
105
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
VITA FORTUNATI
resta mai, non si trova mai «un muro», c’è sempre uno svincolo, un altro percorso, la possibilità di ritornare indietro), rischia però di indurre effetti ipnotici e allucinatori, una sorta di nevrotica dipendenza che inibisce la capacità di scelta e di discrimine. È uno spazio interiore, un grande mare da navigare secondo una segnaletica accattivante, colorata, dall’estetica raffinata che induce il navigatore solitario a prendere rotte predefinite, inebriandolo nell’illusione di una vertigine conoscitiva infinita. È una tipologia di spazio che l’individuo percepisce «nel» e «con il» mezzo. La grande rete sembra aver indotto una sorta di «implosione» sensoriale, che ha come effetto immediato quello di riconfigurare il mondo non solo come «eterno presente», ma anche come artefatto complesso in cui gli stessi confini tra mondo organico e inorganico sembrano sempre più elidersi. Come preannunciava Marshall McLuhan nei primi anni Sessanta: After three thousands years of explosion, by means of fragmentary and mechanical technologies, the Western world is imploding. During the mechanical age we had extended our body in space. Today, after more than a century of electric technology, we have extended our central nervous system in a global embrace, abolishing both space and time as far as our planet is concerned 12.
Anche uno scrittore di fantascienza come James Graham Ballard ha riflettuto a lungo sull’impatto dei nuovi media sulla sensibilità dell’individuo. Già nel 1974, nella sua illuminante introduzione a Crash, egli sottolineava come il connubio «scienza e tecnologia» stava provocando cambiamenti radicali, dei quali occorreva avere consapevolezza: è proprio la visione apocalittica di un presente onnivoro, che tutto ingloba, a spingere l’individuo a esplorare uno spazio interno, quello che Ballard chiamava Inner Space, «quel territorio psicologico nel quale si incontrano, fondendosi, il mondo interiore
12 «Dopo tremila anni di esplosione, attraverso tecnologie frammentarie e meccaniche, il mondo occidentale sta ora implodendo. Durante l’era meccanica abbiamo esteso il nostro corpo nello spazio. Oggi, dopo oltre un secolo di tecnologia elettrica, abbiamo esteso il nostro sistema nervoso centrale in un abbraccio globale, abolendo, per quel che concerne il nostro pianeta, lo spazio e il tempo». M. MCLUHAN, Understanding Media, cit., p. 19.
106
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
IL
VIRTUALE COME ULTIMA FRONTIERA DEL POSSIBILE UTOPICO E FANTASCIENTIFICO
dello spirito e il mondo esteriore della realtà» 13. Queste riflessioni di Ballard prefigurano le caratteristiche dello spazio virtuale, costruito verso l’interno, un inner space tecnologico che presenta caratteristiche complesse, che possono sfociare in forme tribali dove l’individuo si annulla nella dimensione mediatica 14. Siamo quindi giunti all’ultima grande sfida proposta dal cyborg, nuova perturbante frontiera, perché ora quello che si tenta di mutare è l’hardware. Cambiano gli attori del gioco: non è più l’uomo, ma un essere mutante, ibrido, un connubio di elementi tecnologici e di elementi biologici. Cambia quindi l’idea stessa di «individuo» e, inevitabilmente, tutte le categorie tradizionali che servono a definirlo: genere, etnia, identità. I cyborg rappresentano un ponte tra i due mondi, un tramite, una soglia che permette il contatto tra l’umano e il «post-umano». Esseri la cui identità non si identifica più con il solo «corpo biologico», ma è una identità «terminale», perché i «terminali» sono impiantati direttamente nelle cellule cerebrali delle persone. L’essere terminale è sicuramente un cyborg, perché la sua vita non può fare a meno degli strumenti tecnologici; è terminale perché fa parte di una rete potenzialmente infinita, quella che contiene l’universo dei dati e che dà loro una rappresentazione fisica e visiva, che permette la connessione a un sistema globale di mezzi e di comunicazione 15. Ed è terminale anche perché costituisce l’ultima frontiera che critici come Katharine Hayles o Donna Haraway, hanno definito «post-umana» 16. Non mi soffermerò sulla vastissima produzione di scrittori e di scrittrici che hanno speculato nelle loro finzioni narrative sulle potenzialità euristiche del cyborg, né sulle differenze di genere nell’affrontare questo tema 17. Vi è però un aspetto che vorrei sottolineare, J.G. BALLARD, Introduzione, in Crash, Rizzoli, Milano 1996, p. XVI. Cfr. a questo proposito E. L AMBERTI, Marshall McLuhan. Tra letteratura, arte e media, Bruno Mondadori, Milano 2000. 15 Cfr. S. BUKATMAN, Terminal Identity. The Virtual Subject in Postmodern Science Fiction, Duke University Press, Durham and London 1993. 16 Cfr. K. HAYLES, How we became posthuman: virtual bodies in cybernetics, literature, and informatics, University of Chicago Press, Chicago 1999; D. HARAWAY, How Like a Leaf: Donna J. Haroway, an Interview with Thyrza Nichols Goodeve, Routledge, New York-London 2000. 17 Cfr. V. FORTUNATI, The Revision of the Utopian Paradigm in Ursula Le Guin’s Work, in W. GÖBEL, S. KOHL, H. ZAPF (Hrsg.), Modernisierung und Literatur, Tübingen, 13
14
107
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
VITA FORTUNATI
perché si ricollega al mio assunto, se il cyborg rappresenti veramente l’ultima frontiera del «possibile utopico». Negli anni Ottanta, il manifesto cyberpunk di Bruce Sterling, firmato con lo pseudonimo Vincent Omniaveritas 18, ha avuto una carica innovativa ed eversiva: già il termine cyberpunk costituisce un ossimoro, perché unisce la parola cyber, che connota l’alta tecnologia innestata nel corpo umano, come già teorizzato dagli sviluppi moderni della cibernetica, alla parola punk, che allude alla cultura underground, di rivolta, propria degli emarginati metropolitani. Negli articoli presenti nel Manifesto, come pure nei romanzi di Gibson, per citare forse il più rappresentativo degli scrittori di questo genere, appare evidente non solo lo sforzo di coniugare il biologico con le nuove frontiere tecnologiche, ma anche l’intenzione di operare una critica nei confronti della società postindustriale e postcapitalista. La stessa potente carica euristica si può rinvenire anche nel Manifesto Cyborg di Donna Haraway del 1991 19, che ha costituito un punto di partenza importante per il pensiero delle donne, spingendole a riconsiderare, come dice Rosi Braidotti, il loro rapporto con il corpo, la tecnologia e la scienza e, soprattutto, a utilizzare «le nuove tecnologie a favore delle donne» 20. I personaggi di Gibson sono veri e propri cyborg, uomini che portano sul corpo i segni fisici della tecnologia: un braccio meccanico multiuso, armi retrattili nascoste sotto le unghie, fori alla base del cranio che permettono di collegarsi con i computer o di inserire nel loro cervello dati di vario tipo. Questa mutazione o metamorfosi della carne in metallo o in chips non è però sempre indolore: il corpo fisico resta ancora come «materia organica» sulla quale operare trapianti, innesti, operazioni chirurgiche che lasciano tracce sul corpo Gunter Narr Verlag 2000, pp. 223-31; E. FEDERICI, Women and Cyborgs: Transformation and Development of a Cultural Icon, in V. FORTUNATI, A. L AMARRA, E. FEDERICI (a cura di), The Controversial Women’s Body: Images and Representations in Literature and Art, Bononia University Press, Bologna (in corso di pubblicazione). 18 Cfr. V. OMINAVERITAS (pseudonimo di Bruce Sterling), La nuova fantascienza in Alphaville, temi e luoghi dell’immaginario di genere, n. 1, Phoenix Enterprise, Bologna 1992. 19 D.J. HARAWAY, Manifesto Cyborg, Routledge, New York 1991, trad. it. L. BORGHI (a cura di), Manifesto Cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo, Feltrinelli, Milano 1995. 20 R. BRAIDOTTI, La molteplicità. Un’etica per la nostra epoca, oppure meglio cyborg che dea, in D.J. HARAWAY, Manifesto Cyborg, cit., p. 12.
108
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
IL
VIRTUALE COME ULTIMA FRONTIERA DEL POSSIBILE UTOPICO E FANTASCIENTIFICO
corazzato che diventa, come ha messo in luce Scott Bukatman, un «oggetto bricolage» con vari accessori. Questo corpo che tenta disperatamente di fondersi e confondersi con la macchina diventa anche lo sfondo sul quale proiettare disagi sociale o possibili cambiamenti. L’universo di Gibson, lungi dall’essere un universo utopico, si presenta con connotazioni distopiche. La grande rete informatica, la nuova «città», si configura infatti, come nuovo spazio decentrato, basato sul concetto del network senza confini, un grande reticolato nelle cui maglie vivono i nuovi esseri, inconsapevolmente manipolati dai pochi che detengono l’accesso alle «matrici». Questo mondo è così dominato dalle grandi multinazionali, che operano come nuovi guardiani di un’unica società panottica; l’unica arma di rivolta è nelle mani degli hackers che, con azioni episodiche, possono però solo scalfire il sistema del potere, ma non certo sovvertirlo. L’unica forma di libertà nei romanzi di Gibson è quella di una guerriglia urbana che può avere luogo soltanto nei vicoli del gigantesco rizoma dei media: un labirinto che spesso è paragonato alla mappa di una città. All’uomo cyberpunk resta solo la possibilità di isolarsi nel proprio mondo e vivere nel porto franco rappresentato dalle cyberzones; mentre coloro che detengono il monopolio controllano il loro tesoro fatto di informazione e contemporaneamente si godono i parchi dei divertimenti virtuali. Da questo punto di vista, la narrativa di Gibson si può accostare al filone della fantascienza sociale: nei suoi romanzi vengono criticati alcuni aspetti che caratterizzano la società dell’informazione. Mi riferisco soprattutto ai «corrieri» umani, persone che vengono usate dalle multinazionali per immagazzinare informazioni che però non conoscono e che devono solo trasportare. I personaggi di Gibson appaiono come drogati di informazione, che si stipa nelle loro cellule terminali: correnti di informazioni che circolano senza tregua tra cervelli e computer; essi diventano, quindi, gli elementi biologici della grande rete. A loro, infatti, non è concesso di accedere al cyberspace, perché non conoscono la chiave, il codice, la password. Il potere è «sapere» o, meglio «decifrare», dare un senso alle informazioni, possedere le matrici; un sapere che è gestito in modo altamente gerarchico dal soggetto collettivo delle multinazionali ed è negato agli hackers. Ed è per questo che gli hackers cercano dispe-
109
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
VITA FORTUNATI
ratamente il codice d’accesso per fare crollare tutte le difese delle multinazionali. Per concludere, mi sembra che l’operazione di Gibson sia stata interessante come tentativo di coniugare l’alta tecnologia informatica con la cultura underground, ispirando un immaginario visivo che ha attraversato la cinematografia, i fumetti, i videoclip, le nuove forme di arte contemporanea. Una produzione che è stata però ben presto inglobata da una vera e propria industria culturale. Gibson, come tanti altri scrittori che hanno usato il genere cyborg, non rappresenta l’ultimo orizzonte dell’utopia: se è vero infatti che in Gibson vi è ancora il fascino di un ideale collettivo realizzato dai gruppi di emarginati, le tribù underground, coloro che sono stati cacciati dal mondo dell’alta tecnologia, è però anche vero che questi reietti si ribellano senza avere un preciso ideale o una precisa ideologia da realizzare o da proporre. La mia posizione è in sintonia con quella di Vivian Sobchack e Donna Haraway circa l’impossibilità di considerare queste figurazioni apocalittiche una nuova forma di utopia 21: la rivolta di Case, il protagonista di Neuromancer, o quella di Rick Deckard in Blade Runner, per citare solo i due modelli per eccellenza, si limitano, infatti, a una pratica di resistenza quotidiana, non sostenuta da una utopia realmente percorribile, pubblica e collettiva. L’ambiguità dell’operazione di Gibson consiste proprio nel fascino che egli prova nei confronti di questo nuovo universo, che an-
21 «Promoting future utopian “Networks” in which everyone at every level of society is connected and plugged in to everyone else, the New Age Mutant Ninja Hackers, in the midst of this communitarian dream, have no real idea of how to achieve it. Instead, they privilege the individual – modelling themselves after some combination of Neuromance’s world weary Case and/or Blade runner’s Rick Deckard […] Although it dreams of a communication utopia, its major impulses are to secure maximum individualism and privatisation». (Il promuovere futuri “Networks” utopici, dove tutti sono collegati a tutti, in modo trasversale rispetto alle divisioni di classe, Nuovi Mutanti Epocali Ninja Hackers immersi in questo sogno comunitario, non implica nessuna idea reale di come raggiungerli. Invece essi privilegiano l’individuo – modellandosi sulle combinazioni del mondo logoro di Case in Neuromancer o di Rick Deckard in Blade Runner […] Sebbene il sogno sia quello di una utopia della comunicazione, l’impulso che prevale è quello di assicurare il massimo dell’individualismo e della privatizzazione»). V. SOBCHACK, New Age Mutant Ninja Hackers: Reading Mondo 2000, in M. DERY (a cura di), Flame War. The Discourse of Cyberculture, Duke University Press, London p. 24. Cfr. D.J. HAROWAY, Private Visions: Gender, Race and Nature in the World of Modern Science, Routledge, London 1989; ID., Manifesto Cyborg, cit.
110
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
IL
VIRTUALE COME ULTIMA FRONTIERA DEL POSSIBILE UTOPICO E FANTASCIENTIFICO
nulla la capacità critica nel flusso accelerato e velocissimo dei bits, affascinando il «navigatore» e facendogli assumere un atteggiamento quasi mistico nei confronti di chi detiene la matrice. È il ritorno del Grande Fratello, invisibile, onnipotente, e invincibile. L’unico orizzonte possibile, misero surrogato dell’utopia, ha lo stesso colore dell’incipit di Neuromancer, «the color of the television tuned to a dead channel» 22.
22 «il colore del televisore sintonizzato su un canale morto». W. GIBSON, Neuromancer, Harper Collins, London 1995, p. 9.
111
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
LE SANG DE LA NOUVELLE CHAIR. LE GORE DANS LA SCIENCE FICTION di PHILIP ROUYER
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
«Pourquoi ne pas faire un concours de beauté pour le plus beau rein, l’estomac le plus joliment formé, le foie le plus exquis? Pourquoi pas?» David Cronenberg
Je ne referai pas ici l’historique des liens étroits qui unissent depuis toujours la science fiction et l’horreur. Pour m’en tenir au cinéma, je rappellerai simplement que le Frankenstein de James Whale (1931) devait donner naissance à une impressionnante galerie de savants fous qui, en essayant de repousser les frontières de la mort, ont mené des expérimentations propres à susciter l’effroi. Et que les années cinquante, marquées en Amérique par la peur du péril rouge et de la bombe atomique, Guerre Froide oblige, ont inspiré de superbes séries B relatant des histoires d’invasions extraterrestres qui, de The Thing From Another World (Christian Nyby et Howard Hawks, 1951) à Invasion of the Body Snatchers (Don Siegel, 1956), relevaient au moins autant de la science fiction que de l’épouvante. Pour d’évidentes raisons de censure, la représentation de ces horreurs restait très discrète; elle fonctionnait principalement sur les éclairages, la suggestion, l’ellipse et le hors-champ. Une tradition qui allait voler en éclats à la suite de la naissance du cinéma gore dans les années soixante. Le terme anglais gore n’a pas été inventé pour le cinéma. Le Barnhart Dictionary of Etymology, qui propose comme définition «sang répandu, sang coagulé» situe l’apparition du mot, dans son
115
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
PHILIP ROUYER
orthographe actuelle, aux alentours de 1150. Le réalisateur américain Herschell Gordon Lewis et son producteur David F. Friedman ont été les premiers à l’appliquer au cinéma en affirmant qu’avec Blood Feast (1963), ils avaient signé «the first “blood & gore” pictures». Depuis, le mot s’est progressivement imposé 1 pour désigner une catégorie spécifique de films d’horreur dont la ligne dramatique est régulièrement prolongée ou interrompue par des scènes où le sang et la tripe s’écoulent en gros plans des corps meurtris et mutilés. Blood Feast et les premiers films gore étaient plutôt des films de serial killer, mais bientôt ce type de représentation a explosé les limites du cinéma d’horreur stricto sensu pour contaminer d’autres genres: western, film de guerre, fantastique et bien sûr science fiction. De nouvelles images pour la science fiction Dans le domaine de la science fiction comme dans d’autres genres, lorsque le gore n’est qu’un moyen de détailler une mise à mort qui était naguère suggérée, son intérêt demeure limité. Même si on peut s’amuser de voir comment, dans Starship Troopers (1997), Paul Verhoeven oppose les effets sanglants des corps martyrisés des soldats terriens aux effets numériques de leurs adversaires arachnéides et comment il trouve dans ces simulacres de boucherie l’écho sardonique des massacres bien réels que nous infligent les journaux télévisés, le gore n’apporte ici qu’une variante à une imagerie bien connue. D’autres réalisateurs de science fiction, au contraire, ont bien compris comment le gore pouvaient leur ouvrir de nouveaux horizons. Ils se sont emparés de ce type de représentation pour réinventer les lois de l’anatomie et intégrer dans leurs fictions des images qui relevaient jusqu’alors du fantasme pur. Un des exemples les plus marquants est la séquence du premier volet de la saga Alien (Ridley Scott, 1979) dans laquelle John 1 Même si plusieurs exégètes lui préfèrent l’appellation splatter, substantif du verbe anglais «to splatter», littéralement gicler bruyamment, asperger, éclabousser. Cfr. J. MCCARTY Splatter movies: Breaking the Last Taboo of the Screen, St. Martin’s Press, New York 1984.
116
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
LE
SANG DE LA NOUVELLE CHAIR.
LE
GORE DANS LA SCIENCE FICTION
Hurt découvre brutalement qu’il est enceinte de la créature. Il porte littéralement dans son ventre le bébé monstre qui va le transpercer de l’intérieur pour voir le jour. La trouvaille de Ridley Scott est d’avoir transposé ici l’imagerie habituelle de l’accouchement. Au cours du petit déjeuner qui réunit toute l’équipe du vaisseau, le personnage de John Hurt est soudain victime de spasmes violents (équivalent des contractions) qui amènent ses camarades à l’allonger sur la table, comme une parturiente. Une première explosion de la poitrine offre une variation hard de l’expulsion de la poche des eaux. Puis des secousses internes de plus en plus violentes gonflent le torse du malheureux jusqu’à la déchirure de la peau qui permet à la créature de sortir la tête et de pousser son premier cri, dans un bain d’hémoglobine qui éclabousse l’assistance médusée. Pour parfaire le tableau, dans le gros plan qui fait suite à cette barbare «délivrance», on peut même trouver une certaine ressemblance entre la longue queue enroulée autour de l’alien et un cordon ombilical. Toute aussi marquante, la scène de défibrillation de The Thing, le remake du film de Howard Hawks et Christian Nyby par John Carpenter en 1982, offre l’illustration littérale d’un autre grand fantasme masculin, celui du ventre denté. Dans l’imaginaire collectif, le ventre ou plus exactement le vagin denté renvoie à la peur de la castration. Ce dont cette séquence est une métaphore à peine voilée. Il faut d’abord remarquer comment Carpenter obtient un effet de surprise en traitant la tentative de réanimation comme une action secondaire. Toute l’attention est tournée vers McReady (Kurt Russell) qui menace ses compagnons avec de la dynamite. Même l’attirail médical déballé ici semble nourrir cette action première puisque la caméra montre en gros plan une main qui vole un bistouri pour maîtriser le forcené. Il faut attendre la seconde tentative avec le défibrillateur pour qu’un changement d’axe cadre la poitrine nue du mourant en gros plan. La peau se déchire alors pour laisser apparaître une mâchoire géante qui se referme sur les mains du praticien. En gros plan, on voit la pression des poignets pour se dégager et finalement les deux bras qui se relèvent en brandissant les moignons sanguinolents. Dans la foulée, l’action se poursuit avec les vermicelles verts qui jaillissent du ventre écartelé pour s’élever en une colonne de chair surmontée par une hideuse caricature de
117
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
PHILIP ROUYER
tête 2. Alors que le lance-flamme brûle cette horreur, le cou de l’homme étendu s’allonge démesurément pour découvrir sous la peau un réseau de ligaments et bubons verdâtres qui s’étirent pour faire glisser sur le sol son crane qui, détaché du reste du corps, devient le torse d’un insecte géant. L’effet est spectaculaire et répugnant, mais finalement moins horrible que les deux moments où la peau s’écarte pour découvrir le spectacle des organes mutants. L’enveloppe corporelle perd alors son statut de cache pour devenir un cadre, une fenêtre ouverte sur ce que le bon goût relègue dans le hors-champ. Il convient de noter que dans ces deux séquences, Ridley Scott comme John Carpenter ont réussi la synthèse des deux grandes voies de l’horreur: le danger vient de l’extérieur (une créature extraterrestre), le danger vient de l’intérieur (les victimes ont été contaminées et abritent en leur sein un mal qui les détruit). Par ailleurs, ces deux séquences surfent sur une imagerie médicale (jusque dans la blancheur des décors et costumes de la séquence d’Alien qui évoque l’univers de l’hôpital), Carpenter n’ayant pas hésité à déclarer: «Je considère la Chose comme un virus. C’est une métaphore du cancer et du sida» 3. Reste que les deux cinéastes misent avant tout sur l’effet de surprise et qu’ils ne dépassent pas le stade de l’icône. Ces plans de corps déchiquetés de l’intérieur ne sont qu’une étape nécessaire dans le processus de développement du monstre. En cela, ils se différencient de l’œuvre du Canadien David Cronenberg qui, au moins dans la première partie de sa carrière (jusqu’à The Fly, 1986), a choisi le corps humain et ses métamorphoses comme sujet principal de ses films. La «nouvelle chair» de David Cronenberg À la sortie de The Fly (son libre remake du film réalisé par Kurt Neumann en 1958), David Cronenberg répétait que la science fiction était avant tout pour lui un moyen de s’abriter derrière un genre 2 Au-delà des effets spéciaux, on notera le parallèle établi entre la Chose et les déjections et excréments expulsés du corps. 3 J. CARPENTER, in L. L AGIER, J.B. THORET, Mythes et masques: les fantômes de John Carpenter, Dreamland, Paris 1998, p. 41.
118
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
LE
SANG DE LA NOUVELLE CHAIR.
LE
GORE DANS LA SCIENCE FICTION
pour raconter une histoire qui l’intéressait. Et d’ajouter que sans le recours à la science fiction, il n’aurait jamais pu disposer d’un budget confortable pour tourner cette intrigue désespérante: un homme et une femme se rencontrent; ils sont jeunes, beaux, intelligents et ils s’aiment. Mais bientôt l’homme est atteint d’un mal incurable qui va le vieillir prématurément et le tuer. Sa compagne accepte de l’aider à abréger ses souffrances. En même temps, ce qui distingue The Fly d’un drame qui raconterait la même histoire de manière réaliste, c’est l’attachement du réalisateur à la maladie ellemême. L’attention qu’il porte à ses personnages rend leur histoire émouvante, mais la quasi unicité de lieu, l’austérité du décor et l’absence d’allusions au passé du protagoniste confirment que ce qui passionne au premier chef Cronenberg c’est comment un homme par ailleurs savant (Seth Brundle, joué par Jeff Goldblum) devient un homme-mouche (BrundleFly). D’où la place particulière occupée par Cronenberg dans le cinéma de science fiction. Il en détourne l’arsenal visuel pour le mettre au service de son imagination; il en reprend les intrigues en se débarrassant de ses codes habituels. Dans ses films, les savants sont au moins autant des philosophes voire des artistes que des scientifiques. Ils n’opèrent pas dans des laboratoires fantaisistes ou dans des cryptes gothiques, mais dans de banals espaces urbains. D’ailleurs, à l’exception de The Fly où le savant devient son propre cobaye, ses personnages de scientifiques n’occupent qu’une place secondaire dans l’intrigue. Après avoir servi de catalyseur à l’intrigue, ils disparaissent, généralement victimes de leur création, sans que leur mort ne provoque d’émotions particulières. Leur point de vue (et donc leur tragédie) n’intervient guère dans la problématique du réalisateur focalisé sur son thème de prédilection: les métamorphoses du corps et, corollairement, l’interaction de la chair et de l’esprit. «Les grandes religions disent que le corps et l’esprit peuvent se séparer, que l’esprit ou l’âme survit à la mort. Je ne crois pas à cela. Selon moi, l’esprit et le corps sont si étroitement liés qu’un changement chez l’un provoque une réaction chez l’autre» 4, 4
p. 43.
Entretien avec Alain Charlot et Marc Toullec,in «Mad Movies» n. 58, mars 1989,
119
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
PHILIP ROUYER
explique-t-il avant d’ajouter qu’il ne saurait y avoir de vie de l’esprit séparé du cerveau. En détruisant physiquement le cerveau, on détruit en même temps la pensée. L’histoire de Seth Brundle, le savant de The Fly qui enregistre impuissant la déchéance de son corps d’homme (avec cette belle idée mélancolique de conserver dans son armoire à pharmacie les vestiges de son passé humain: ongles, dents, oreille…) avant de découvrir qu’il commence non seulement à agir mais aussi à penser comme un insecte («Les insectes ne font pas de politique», s’exclame-t-il), est la parfaite illustration de cette idée. Mais on pourrait citer d’autres fables de Cronenberg: les pouvoirs télépathiques et meurtriers des Scanners (1980), les hallucinations suscitées par la tumeur au cerveau née de l’exposition au signal vidéo d’une émission composée de tortures et de meurtres non simulés (Videodrome, 1982) et bien sûr l’argument de The Brood (1979). Dans ce film, il est question d’un talentueux médecin qui a mis au point une technique pour faire extérioriser physiquement à ses patients leurs traumatismes et leurs colères. Cette méthode psychosomatique est particulièrement efficace sur Nola (Samantha Eggar) qui matérialise ses mauvaises pensées sous la forme de petits enfants monstrueux 5 dont elle accouche par le nombril et qui répondent à ses désirs inconscients de meurtres. En cela, The Brood peut se voir comme une adaptation moderne et gore, du grand classique de la science fiction, Forbidden Planet (1956). Les «enfants de la rage» de l’héroïne rappellent en effet les monstres engendrés par l’agressivité refoulée des Krells dans le film de Fred McLeod Wilcox. Ce qu’a souligné Cronenberg en baptisant «Krell School» l’école où se situent plusieurs séquences de The Brood. Il s’agit encore d’une relecture particulièrement répulsive de la réalité de l’accouchement. La poche des eaux est remplacée par une poche de sang que la mère déchire avec ses dents avant d’en extraire son bébé qu’elle nettoie avec sa langue. La membrane ver5 Chacun de ces êtres porte en lui une sorte de poche qui se substitue à ses fonctions alimentaires et respiratoires. Quand le contenu de la poche est épuisée, la créature meurt.
120
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
LE
SANG DE LA NOUVELLE CHAIR.
LE
GORE DANS LA SCIENCE FICTION
dâtre et bubonique du cordon qui relie la mère à l’enfant ajoute à l’horreur du sang qui barbouille la bouche de Nola. Cette séquence située dans la dernière bobine doit beaucoup à sa mise en scène. On découvre, avec les yeux du mari de la malade, l’horrible origine des créatures monstrueuses qui semaient la mort depuis le début du drame. Le recours au gore est ici nécessaire car la propre réaction de dégoût du spectateur est un bon moyen de comprendre comment le mari ne peut cacher ses sentiments malgré la gravité de la situation. La séquence aurait eu beaucoup moins d’impact si cet accouchement était resté hors champ. En revanche dans les plans qui suivent, Cronenberg n’insiste pas sur les sanglantes mutilations infligées au médecin par les créatures dans la pièce voisine. C’est ce que le réalisateur explique quand il affirme: Il y a beaucoup de films d’horreur explicite qui ne m’intéressent pas du tout parce que je n’ai pas envie d’aller voir un abattoir … C’est une chose que de voir un personnage qui lève son couteau au-dessus de la poitrine d’un autre et d’entendre ensuite un swouch hors champ; vous savez ce qui va arriver, vous le comprenez … Moi, mon but véritable est de montrer l’immontrable, de dire l’indicible … Je crée des éléments qui ne peuvent être suggérés car difficilement imaginables pour le spectateur 6.
De la même manière, Cronenberg a été amené à montrer les parasites sexuellement transmissibles qui transforment les héros de Shivers (1975) en zombies assoiffés de sexe et le dard phallique qui a poussé sous l’aisselle de Marilyn Chambers, communiquant la rage à tous ceux qu’elle étreint dans Rabid (1976) 7. Dans l’extrait de The Brood que nous venons de voir, la posture de Samantha Eggar installée sur une estrade accentue la dimension théâtrale de la séquence. À la manière d’un rideau qui se lève sur une scène, les pans de sa chemise qu’elle relève donne à voir le spectacle d’un corps qui s’est affranchi des lois élémentaires de la biologie. À l’échelle d’un organisme se dispute ainsi la partie engagée entre les 6 Entretien avec William Beard, Piers Handling et Pierre Véronneau, in «L’horreur intérieure: les films de David Cronenberg», Cerf, coll. «7e art», Paris 1990, p. 24. 7 Symptomatiquement, les deux premiers longs métrages de Cronenberg, Stereo (1969) et Crimes of the Future (1970), qui développaient une thématique comparable sans passer par une représentation explicite, relèvent du cinéma expérimental.
121
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
PHILIP ROUYER
parasites et la communauté des humains dans Shivers. Du point de vue des hommes, la contamination du parasite à l’ensemble des occupants de l’immeuble est une défaite; du point de vue des parasites, c’est une victoire. L’étrangeté des films de Cronenberg naît de cette idée originale d’envisager le point de vue de l’organe contre l’organisme qu’il colonise et réorganise à sa guise. C’est le fameux concept de «Nouvelle chair» développé dans Videodrome où le héros, après être devenu littéralement un homme magnétoscope (une fente vaginale apparue sur son abdomen permet d’y introduire des cassettes pour le programmer comme un robot), doit passer par la destruction de son corps pour accéder à un autre stade de son évolution. Pour le propriétaire du corps qui sert de champ de bataille à ce curieux affrontement existentiel, la folie n’est jamais loin. Soit il adopte la cause de sa maladie (Nola dans The Brood) et il bascule dans une autre réalité proche de la folie, soit il la combat et il se retrouve «avec une révolution de ses organes sur les bras» pour paraphraser un autre patient de The Brood. La situation est d’autant plus compliquée que le mal peut paraître séduisant aux yeux de celui qu’il contamine. Les victimes de Shivers sont heureuses d’avoir enfin perdu tout complexe quant à leur libido; avant de constater la dégénérescence de son corps d’homme, le savant de The Fly se réjouit de l’extraordinaire force physique qu’il a acquise dans la téléportation. Se prenant pour un demi-dieu, il invite sa partenaire à «dépasser sa peur grisâtre de la chair» et à «une plongée profonde dans le bain plasmatique». Videodrome se clôt sur le suicide du protagoniste, mais on sait que Cronenberg a longtemps envisagé d’ajouter une scène montrant les corps du héros et de ses deux partenaires féminines mêlés dans une incroyable orgie qui utiliserait la fente abdominale de l’homme comme un nouvel organe sexuel 8. À chaque fois, les hypothèses tératologiques envisagées sont scientifiquement très improbables, mais elles puisent leur efficacité dans nos phobies. Phobies de perdre le contrôle de son propre
8 Ce dont se rapproche la fameuse scène de Crash (1996) dans laquelle James Spader honore la longue plaie verticale que Rosanna Arquette arbore fièrement sur sa jambe.
122
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
LE
SANG DE LA NOUVELLE CHAIR.
LE
GORE DANS LA SCIENCE FICTION
corps, phobies de dérèglements internes qui exposent à la vue ce qui aurait dû rester caché à l’intérieur du corps (ce qui revient à l’essence même du gore). Sans chercher à porter de jugement de valeur, on peut affirmer que la peur cultivée dans les films de Cronenberg est une peur plus adulte que dans les films de monstres. Car la certitude de porter en soi les germes de sa propre destruction sans pouvoir y échapper est autrement plus angoissante que la crainte suscitée par la présence d’une créature, de l’Autre tapie dans les ténèbres. «A nos yeux, notre propre corps est un mystère et, d’une certaine façon, il le restera toujours», déplore Cronenberg 9.
9 In David Cronenberg, entretiens avec Serge Grünberg, «Les Cahiers du cinéma», Paris 2000.
123
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
IL SANGUE DELLA NUOVA CARNE. L’ASPETTO GORE * NELLA FANTASCIENZA di PHILIP ROUYER
* Benché in Italia la dizione splatter sia più diffusa per indicare l’orrido nel cinema, si è preferito mantenere il termine gore anche nella traduzione per una maggiore fedeltà al testo originale. (N.d.T.)
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
«Perché non fare un concorso di bellezza per il rene più bello, lo stomaco dalla forma più graziosa, il fegato più delizioso? Perché no?» David Cronenberg
Non si vuole in questa sede riproporre la cronistoria degli stretti legami che da sempre uniscono la fantascienza e l’orrore. Attenendoci al cinema, ricorderemo semplicemente che il Frankenstein di James Whale (1931) doveva dare inizio a una immensa galleria di scienziati pazzi che, nel tentativo di allontanare le frontiere della morte, hanno condotto esperimenti capaci di suscitare terrore; e che gli anni Cinquanta, segnati in America dalla paura del pericolo rosso e della bomba atomica, Guerra Fredda oblige, hanno ispirato superbi film di serie B su storie di invasioni extraterrestri che, da The Thing From Another World (La «cosa» da un altro mondo, Christian Nyby e Howard Hawks, 1951) a Invasion of the Body Snatchers (L’invasione degli ultracorpi, Don Siegel, 1956) si rifacevano tanto alla fantascienza quanto all’orrore. A causa di ovvie ragioni di censura, la rappresentazione di tali orrori rimaneva molto discreta avvalendosi principalmente dei punti di vista, della suggestione, dell’ellissi e del fuori campo. Una tradizione, questa, che si sarebbe spezzata negli anni Sessanta in seguito alla nascita del cinema gore. Il termine inglese gore non è stato coniato per il cinema. Il Barnhart Dictionary of Etymology, che propone come definizione «sangue sparso, sangue coagulato», colloca l’apparizione della parola, nella sua ortografia attuale, intorno al 1150. Il regista americano Herschell Gordon Lewis e il suo produttore David F. Friedman sono stati i primi ad applicarlo al cinema affermando che, con Blood Feast (1963), avevano firmato «the first “blood and gore” pictures». In seguito, il termine si è progressivamente
127
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
PHILIP ROUYER
imposto 1 per designare una categoria specifica di film dell’orrore la cui progressione drammatica viene regolarmente prolungata o interrotta da scene in cui il sangue e le budella fuoriescono in primo piano da corpi feriti e mutilati. Blood Feast e i primi film gore erano più che altro film di serial killer, ma presto questo tipo di rappresentazione ha travalicato i limiti del cinema dell’orrore stricto sensu per contaminare altri generi: western, film di guerra, fantastico e sicuramente fantascienza.
Nuove immagini per la fantascienza Dal momento che il gore non è che un mezzo per esaminare nei dettagli, come è stato appena suggerito, una uccisione, sia nel campo della fantascienza sia in quello di altri generi, il suo interesse resta limitato. Sebbene ci si possa divertire a vedere come, in Starship Troopers (Starship Troopers Fanteria dello spazio, 1997), Paul Verhoeven opponga gli effetti sanguinosi dei corpi martirizzati dei soldati terrestri agli effetti numerici dei loro avversari aracneidi e come il regista trovi in tali simulacri di mattatoio l’eco sardonica dei massacri reali che ci infliggono i telegiornali, qui il gore non aggiunge che una variante a un’iconografia ben nota. Altri registi di fantascienza, al contrario, hanno ben capito quanto il gore potesse aprire loro nuovi orizzonti. Si sono impadroniti di questo tipo di rappresentazione per reinventare le leggi dell’anatomia e integrare, nelle loro finzioni, immagini che fino a quel momento avevano attinto alla fantasia pura. Uno degli esempi più memorabili è la sequenza della prima parte della saga di Alien (Ridley Scott, 1979) nella quale John Hurt scopre brutalmente di essere in attesa della creatura. L’uomo porta letteralmente nel ventre il bambino mostro che lo trafiggerà dall’interno per venire alla luce. La trovata di Ridley Scott consiste nell’aver qui trasposto l’abituale complesso di immagini legate al parto. Durante la colazione che riunisce l’intero l’equipaggio dell’astronave, il personaggio di John Hurt è colpito improvvisamente da spasmi violenti (equivalenti delle contrazioni) che spingono i suoi compagni a distenderlo sul tavolo, come una partoriente. 1 Anche se molti esegeti preferiscono la denominazione splatter, sostantivo del verbo inglese «to splatter», letteralmente schizzare rumorosamente, spruzzare, inzaccherare. Cfr. J. MCCARTY, Splatter movies: Breaking the Last Taboo of the Screen, St. Martin’s Press, New York 1984.
128
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
IL
SANGUE DELLA NUOVA CARNE.
L’ASPETTO
GORE NELLA FANTASCIENZA
Una prima esplosione del petto offre una variante hard della rottura delle acque. Successivamente, scosse interne sempre più violente gonfiano il torace dello sventurato fino alla lacerazione della pelle che permette alla creatura di far uscire la testa e di lanciare il suo primo grido, in un bagno di emoglobina che imbratta gli astanti impietriti. Per completare il quadro, nel primo piano che segue questa barbara «nascita», si può persino cogliere una certa somiglianza fra la lunga coda avvolta attorno all’alieno e un cordone ombelicale. Altrettanto memorabile, la scena di defibrillazione di The Thing (La Cosa), remake del film di Howard Hawks e Christian Nyby realizzato da John Carpenter nel 1982, offre la rappresentazione letterale di un’altra grande fantasia maschile, quella del ventre dentato. Nell’immaginario collettivo, il ventre, o più precisamente la vagina dentata, rinvia alla paura della castrazione della quale questa sequenza costituisce una metafora appena velata. Occorre anzitutto notare come Carpenter ottenga un effetto di sorpresa sviluppando il tentativo di rianimazione come un’azione secondaria. L’attenzione è interamente concentrata su McReady (Kurt Russel) che minaccia i suoi compagni con la dinamite. Persino l’armamentario medico esibito sembra sostenere questa azione principale giacché la macchina da presa mostra in primo piano una mano che ruba un bisturi per bloccare il forsennato. Bisogna attendere il secondo tentativo con il defibrillatore perché un cambiamento di angolazione inquadri in primo piano il petto nudo del moribondo. Allora la pelle si lacera per lasciare apparire una mascella gigante che si richiude sulle mani del medico. In primo piano si vede la tensione dei polsi per liberarsi e finalmente le due braccia che si tirano su agitando con forza i moncherini insanguinati. Sulla scia del gesto, l’azione continua con i piccoli vermi verdi che schizzano dal ventre dilaniato per elevarsi in una colonna di carne sormontata da un’orrenda caricatura di testa 2. Mentre il lanciafiamme brucia questo orrore, il collo dell’uomo disteso si allunga smisuratamente per scoprire, sotto la pelle, un reticolo di legamenti e bubboni verdastri che si stirano facendo scivolare a terra il suo cranio. Staccato dal resto del corpo, esso diviene il torso di un insetto gigante. L’effetto è spettacolare e ripugnante, ma in definitiva meno orribile dei due momenti in cui la pelle si lacera svelando lo spettacolo degli organi mutanti. L’involucro corporeo perde allora il 2 Al di là degli effetti speciali, si noterà il parallelo stabilito fra la Cosa e le deiezioni e gli escrementi espulsi dal corpo.
129
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
PHILIP ROUYER
suo statuto di nascondiglio per diventare una cornice, una finestra aperta su ciò che il buon gusto relega nei fuori campo. È opportuno notare che in queste due sequenze, Ridley Scott come John Carpenter sono riusciti a sintetizzare le due grandi vie dell’orrore: il pericolo viene dall’esterno (una creatura extraterrestre), il pericolo viene dall’interno (le vittime sono state contaminate e portano dentro di loro un male che le distrugge). Peraltro, queste due sequenze si muovono lungo tutto un corredo di immagini mediche (fino al biancore della scenografia e dei costumi nella sequenza di Alien che evoca l’universo dell’ospedale), al punto che Carpenter non esitò a dichiarare: «Considero la Cosa come un virus. È una metafora del cancro e dell’aids» 3. Resta il fatto che i due cineasti mirano soprattutto all’effetto della sorpresa e non superano lo stadio dell’icona. Queste inquadrature di corpi ridotti a brandelli dall’interno non sono che una tappa necessaria al processo di sviluppo del mostro. In questo, essi si discostano dall’opera del canadese David Cronenberg che, almeno nella prima parte della sua carriera (fino a The Fly, La mosca, 1986), ha scelto i corpi umani e le sue metamorfosi come soggetto principale dei suoi film.
La «nuova carne» di David Cronenberg All’uscita di The Fly (libero rifacimento del film realizzato da Kurt Neumann nel 1958), David Cronenberg ripeteva che per lui la fantascienza era innanzitutto un mezzo per nascondersi dietro un genere con lo scopo di raccontare una storia che lo interessasse. Bisogna aggiungere che, senza il ricorso alla fantascienza, non avrebbe mai potuto disporre di un budget appropriato per girare questo intrigo sconfortante: un uomo e una donna si incontrano, sono giovani, belli, intelligenti e si amano. Ma presto l’uomo è colpito da un male incurabile che lo fa invecchiare prematuramente e morire. La sua compagna accetta di aiutarlo ad abbreviare le sue sofferenze. Ma ciò che distingue The Fly, da un dramma che racconti la medesima storia in maniera realista, è l’attaccamento del regista alla malattia stessa. L’attenzione che Cronenberg dedica ai personaggi rende la loro storia commovente, ma la quasi unicità del luogo, l’austerità 3 J. CARPENTER, in L. L AGIER, J.B. THORET, Mythes et masques: les fantômes de John Carpenter, Dreamland, Paris 1998, p. 41.
130
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
IL
SANGUE DELLA NUOVA CARNE.
L’ASPETTO
GORE NELLA FANTASCIENZA
della scenografia e l’assenza di allusioni al passato del protagonista confermano che ciò che in primo luogo appassiona il regista è come un uomo, che è comunque uno scienziato (Seth Brundle, interpretato da Jeff Goldblum), diventi un uomo-mosca (Brundle Fly). Di qui il posto particolare occupato da Cronenberg nel cinema di fantascienza. Il cineasta ne capovolge l’arsenale visivo per metterlo al servizio della sua immaginazione; ne riprende gli intrecci sbarazzandosi dei suoi codici abituali. Nei suoi film i sapienti sono a dir poco tanto filosofi, addirittura artisti, quanto scienziati. Non operano in laboratori bizzarri o nelle cripte gotiche, ma all’interno di banali spazi urbani. D’altronde, a eccezione di The Fly in cui lo scienziato diventa la cavia di se stesso, tutti i personaggi che Cronenberg trae dal mondo scientifico non occupano che un posto secondario nell’intreccio. Dopo aver agito come catalizzatori della trama, scompaiono, generalmente vittime della loro creazione, senza che la loro morte provochi particolari emozioni. Il loro punto di vista (e dunque la loro tragedia) non interviene molto nella problematica del regista che resta legato al suo tema preferito: le metamorfosi del corpo e, conseguentemente, l’interazione della carne e dello spirito. «Le grandi religioni affermano che il corpo e lo spirito possono separarsi, che lo spirito o l’anima sopravvivono alla morte. Io non lo credo. Secondo me, lo spirito e il corpo sono legati in maniera talmente stretta che un cambiamento dell’uno provoca una reazione nell’altro» 4, spiega il regista prima di aggiungere che non potrebbe esserci vita per lo spirito separato dal cervello. Distruggendo fisicamente il cervello, al tempo stesso si distrugge il pensiero. La storia di Seth Brundle, lo scienziato di The Fly che registra impotente la decadenza del suo corpo di uomo (con la bella idea malinconica di conservare nell’armadietto dei medicinali le vestigia del suo passato umano: unghie, denti, orecchie…) prima di scoprire che sta iniziando non solo ad agire ma anche a pensare come un insetto («Gli insetti non fanno politica», esclama), è l’esemplificazione perfetta di questa idea. Ma si potrebbero citare altre fantasie di Cronenberg: i poteri telepatici e omicidi degli Scanners (1980), le allucinazioni provocate dal tumore al cervello nato dall’esposizione al segnale video di una trasmissione fatta di torture e assassini non simulati (Videodrome, 1982) e sicuramente l’argomento di The Brood (Brood, la covata malefica, 1979). Il film tratta di un medico di talento che ha messo a punto una tecnica per far estroiettare 4
Conversazione con Alain Charlot e Marc Toullec, in «Mad Movies» n. 58, mars 1989,
p. 43.
131
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
PHILIP ROUYER
fisicamente ai suoi pazienti i loro traumi e le loro ire. Questo metodo psicosomatico è particolarmente efficace su Nola (Samantha Eggar) che materializza i suoi cattivi pensieri sotto forma di bambini mostruosi 5 che la donna partorisce dall’ombelico, e che rispondono ai suoi desideri inconsci di assassinio. In tal senso, The Brood può essere considerato un adattamento moderno e gore del grande classico di fantascienza Forbidden Planet (Il pianeta proibito, 1956). In effetti, i «bambini della rabbia» dell’eroina ricordano i mostri generati dall’aggressività repressa dei Krells nel film di Fred McLeod Wilcox. Idea che viene esplicitamente sottolineata da Cronenberg nel battezzare «Krell School» la scuola dove si collocano numerose sequenze di The Brood. In alcune di queste sequenze è possibile rintracciare una lettura particolarmente ripugnante della realtà del parto. La borsa delle acque è rimpiazzata da una borsa di sangue che la madre strappa con i denti prima di estrarne un bambino che pulisce con la lingua. La membrana verdastra e butterata del cordone che lega la madre al bambino accresce l’orrore del sangue che insudicia la bocca di Nola. Questa sequenza situata nell’ultima parte della pellicola deve molto alla regia. Si scopre, attraverso gli occhi del marito della malata, l’orribile origine delle creature mostruose che dall’inizio del dramma seminavano la morte. Qui il ricorso al gore è necessario poiché la stessa reazione di disgusto dello spettatore è un buon mezzo per comprendere come il marito non possa nascondere le proprie sensazioni malgrado la gravità della situazione. La sequenza avrebbe avuto molto meno impatto se questo parto fosse rimasto fuori campo. In compenso, nelle inquadrature che seguono, Cronenberg non insiste sulle sanguinose mutilazioni inflitte al medico dalla creatura nella stanza vicina. Ciò è spiegato dal regista quando afferma: Ci sono molti film dell’orrore espliciti che non mi interessano affatto perché non ho voglia di vedere un mattatoio […] Una cosa è vedere un personaggio che alza il coltello verso il petto di un altro e poi sentire uno swouch fuori campo; sapete cosa sta per accadere, lo capite […] Il mio vero scopo è quello di far vedere ciò che non si può far vedere, dire l’indicibile […] Ho creato elementi che non possono essere suggeriti perché difficilmente immaginabili dallo spettatore 6.
5 Ognuno di questi esseri porta in sé una sorta di tasca che si sostituisce alle sue funzioni alimentari e respiratorie. Quando il contenuto della tasca è esaurito, la creatura muore. 6 Conversazione con William Beard, Piers Handling et Pierre Véronneau, in «L’horreur interiéure: les films de David Cronenberg», Cerf, coll. «7e art», Paris 1990, p. 24.
132
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
IL
SANGUE DELLA NUOVA CARNE.
L’ASPETTO
GORE NELLA FANTASCIENZA
Analogamente, Cronenberg è giunto a mostrare i parassiti trasmissibili per via sessuale che trasformano gli eroi di Shivers (Il demone sotto la pelle, 1975) in zombi assetati di sesso e il pungiglione fallico che è cresciuto sotto l’ascella di Marilyn Chambers, che comunica la rabbia a tutti quelli che stringe in Rabid (Rabid Sete di sangue, 1976) 7. Nella sequenza di The Brood cui abbiamo accennato, la posizione di Samantha Eggar sopra una pedana accentua la dimensione teatrale della sequenza. Come un sipario che si alza sul palcoscenico, i lembi della camicia che la donna tira su fanno vedere lo spettacolo di un corpo che si è affrancato dalle leggi elementari della biologia. In rapporto a un organismo si disputa così in Shivers la partita tra i parassiti e la comunità degli umani. Dal punto di vista degli uomini, la contaminazione da parte del parassita di tutti gli abitanti dell’edificio è una sconfitta; dal punto di vista dei parassiti è una vittoria. La singolarità dei film di Cronenberg nasce da questa idea originale di considerare il punto di vista dell’organo, in opposizione all’organismo che esso colonizza e riorganizza a suo piacimento. È il famoso concetto di «Nuova carne» sviluppato in Videodrome in cui l’eroe, dopo essere diventato letteralmente un uomo videoregistratore (una fessura vaginale apparsa sul suo addome permette di introdurvi delle cassette per programmarlo come un robot), deve passare attraverso la distruzione del suo corpo onde accedere a un altro stadio della propria evoluzione. Per il proprietario del corpo, che funge da campo di battaglia per questo curioso scontro esistenziale, la follia non è mai lontana: sia che l’uomo adotti la causa della sua malattia (Nola in The Brood) e precipiti in un’altra realtà vicina alla follia, sia che la combatta e si ritrovi «con una rivoluzione dei suoi organi a carico» per parafrasare un altro paziente di The Brood. La situazione è tanto più complicata dal momento che il male può apparire seducente agli occhi di colui che ne viene contaminato. Le vittime di Shivers sono felici di avere finalmente perso ogni complesso legato alla loro libido. Lo scienziato di The Fly, prima di constatare la degenerazione del suo corpo di uomo, si compiace della straordinaria forza fisica che ha acquisito nel teletrasporto. Considerandosi un semidio, il protagonista invita la sua compagna a «superare la paura grigiastra della carne», a effettuare «un’immersione profonda nel bagno plasmatico». Video7 Significativamente i primi due lungometraggi di Cronenberg, Stereo (1969) e Crimes of the Future (1970), che sviluppavano una tematica simile senza passare attraverso una rappresentazione esplicita, rientrano nell’ambito del cinema sperimentale.
133
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
PHILIP ROUYER
drome si chiude con il suicidio del protagonista, ma si sa che Cronenberg ha considerato a lungo l’ipotesi di aggiungere una scena che mostrasse i corpi degli eroi e delle loro due compagne mescolati in un’incredibile orgia in cui la fessura addominale dell’uomo sarebbe stata utilizzata come un nuovo organo sessuale 8. Ogni volta, le ipotesi teratologiche appaiono tutte scientificamente molto improbabili, ma attingono efficacia dalle nostre fobie. Fobia di perdere il controllo del proprio corpo, fobia di irregolarità interne che espongono alla vista ciò che avrebbe dovuto restare nascosto all’interno del corpo (ciò si riconduce all’essenza stessa del gore). Senza cercare di esprimere giudizi di valore, si può affermare che la paura coltivata nei film di Cronenberg è una paura più adulta di quella alimentata nei film di mostri. Giacché la certezza di portare in sé i germi della propria distruzione, senza potervi sfuggire, è ancora più angosciante della paura suscitata dalla presenza di una creatura, di un Altro nascosto nelle tenebre. «Ai nostri occhi, il nostro stesso corpo è un mistero e, in qualche modo, lo resterà sempre», lamenta Cronenberg 9. (traduzione di Loredana Ferro)
8 A questo si avvicina la famosa scena di Crash (1996) nella quale James Spader onora la lunga ferita verticale che Rosanna Arcquette ostenta fieramente sulla gamba. 9 In David Cronenberg, conversazione con Serge Grünberg, «Les Cahiers du cinéma», Paris 2000.
134
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
CI SONO I BAGNI NEL CYBERSPAZIO? PARADOSSI ED EPIFANIE DEL VIRTUALE di GIANNI CANOVA
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
Cercherò di parlare non tanto di film, quanto di cinema. E, forse, neanche tanto di cinema, quanto di relazioni visive fra soggetti e oggetti scopici nello scenario cronologico, epistemologico e culturale che si va delineando. Mi riallaccio direttamente alla conclusione dell’intervento che mi ha preceduto, in cui si evoca – attraverso il cinema di David Cronenberg – una delle due grandi paure tematizzate dal cinema di fantascienza degli ultimi vent’anni: la paura di un io che si scopre impotente di fronte al farsi altro da sé, o di fronte al trauma del vedersi diventare altro da quello che è. A me piacerebbe partire, come in una sorta di dissolvenza incrociata, dal «sentimento» opposto a quello precedente: la paura o l’orrore di non poter essere che identico a sé, di non poter sperimentare l’altro in sé. È un tema declinato in vari modi in numerosi film, da Blade Runner (1982) di Ridley Scott a A.I. Intelligenza Artificiale (2001) di Steven Spielberg. La scena che io trovo più traumatica in A.I., ad esempio, è quella in cui il piccolo David scopre all’improvviso di non essere unico, di essere un prodotto di serie, identico a mille altri: ed è proprio questa scoperta della condanna alla riproducibilità seriale, o all’impossibilità della differenza, a generare nel piccolo «mecca» spielberghiano il trauma che lo indurrà a tentare il suicidio. Vorrei partire da qui, perché è proprio su questo tema che mi piacerebbe articolare un breve ragionamento sullo spazio virtuale, a partire però dall’inevitabile presenza del corpo, o di corpi, dentro questo spazio. Mentre preparavo la relazione per questo convegno, mi è capitato casualmente di rileggere una pagina di un grande romanzo novecentesco, La nausea di Jean Paul Sartre. C’è un passo molto bello in questo libro, ed è quello in cui l’io narrante, Antoine
137
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
GIANNI CANOVA
Roquentin, descrive la sua visita ai quadri della galleria di Bouville, dove sono raffigurati i notabili della città, gli antenati nobili di quelli che lo stesso Roquentin chiama in genere i salauds, gli sporcaccioni di questa piccola cittadina della provincia francese. Ciò che è rappresentato nei quadri e sulle tele di questa galleria d’arte non sono tanto dei soggetti, ma una sorta di «unica Idea» che, per apparire, deve incarnarsi in più persone – o forse, intendendo il termine «persona» in senso etimologico, in più «maschere». Tutti quei ritratti hanno una finalità precisa: tramandano ognuno la memoria di un nome e l’immagine di una persona, ed evocano tutti insieme il nucleo fondativo, identitario di una collettività. Il problema (ed è per questo che mi è venuta in mente questa pagina partendo dalla sequenza di A.I. che citavo prima) è che quei ritratti si assomigliano un po’ tutti e raggiungono il loro obiettivo – ripeto: trasmettere il senso di un’identità al contempo individuale e collettiva – a un prezzo molto alto, che è la cancellazione in ognuno di quei ritratti di ogni traccia di esistenza e l’abrasione o la rimozione dei tratti nudi del volto. Sartre scrive così: Li avevano dipinti con grande esattezza; eppure, sotto il pennello, i loro volti avevano perso la misteriosa debolezza dei visi umani. Tutte le facce, anche le più molli, erano nette, come maioliche: invano ricercavo in esse un legame con gli alberi e le bestie, le evocazioni della terra o dell’acqua. Pensavo che, da vivi, essi non dovevano averlo mai sentito il bisogno di questa dissimulazione. Ma, al momento di passare alla posterità, si erano affidati a un pittore di fama affinché, con discrezione, operasse sul loro volto quei dragaggi, quelle traforazioni, quelle irrigazioni con i quali essi avevano trasformato il mare e la campagna tutt’intorno a Bouville. […] Ciò che queste cupe tele offrivano ai miei sguardi era l’uomo rifatto dall’uomo 1.
Detto altrimenti: per diventare eterni, per acquisire un’identità in memoriam, i notabili di Bouville descritti da Sartre hanno dovuto in qualche modo cancellarsi in quanto soggetti e affidarsi a una trasformazione che dissimulasse la loro individualità e li trasformasse in maschere mortuarie. Rileggendo questa pagina mi venivano in mente alcune raffinate osservazioni di Ernest Gombrich a proposito 1
J.P. SARTRE, La nausea, Einaudi, Torino 1990, pp. 123-124.
138
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
CI
SONO I BAGNI NEL CYBERSPAZIO?
PARADOSSI
ED EPIFANIE DEL VIRTUALE
di quell’effetto percettivo che un po’ tutti abbiamo molte volte sperimentato, per cui spesso si sente dire che agli occhi di un occidentale tutti i cinesi e tutti i giapponesi in qualche modo si assomigliano, o agli occhi di un africano tutti noi bianchi occidentali risultiamo molto simili e difficilmente distinguibili, o quell’altra osservazione per cui visitando una galleria di ritratti settecenteschi se ne ricava talora l’impressione che tutti quei volti col parruccone e col collo inamidato finiscano a loro volta, in qualche modo, per assomigliarsi. In tutti questi casi mi sembra di poter dire che i tratti di somiglianza, di omogeneità, di recursività prevalgono su quelli di differenziazione e di individualizzazione. Di fatto, percepire la somiglianza tra me e te è come far sparire in dissolvenza incrociata ciò che fa di me qualcosa d’altro da te e, in ultima sostanza, ciò che fa di me me, e di te te. Ho fatto questa lunga premessa per invitarvi ora a una sorta di capriola comparativa, proponendovi di infilarci in un cortocircuito spazio-temporale. Proviamo a spostarci dal terreno su cui mi sono mosso finora ed entriamo nell’universo iconico di un film come Final Fantasy The Spirits Within (Final Fantasy, 2001, Hironobu Sakaguchi, Motonori Sakakibara), il primo interamente «interpretato» da simulacri digitali che prendono il posto degli attori in carne e ossa. Pensate ai personaggi del film: anche in questo caso siamo di fronte – per riprendere le parole di Sartre – a un esempio di «uomo rifatto dall’uomo», sia pure con un pennello digitale, invece che con un pennello di setole. Come è ovvio, tanto nella galleria di Bouville quanto in Final Fantasy siamo di fronte a degli artefatti visivi che lavorano a partire dall’icona del volto e del corpo umano: ma nel primo caso (nella galleria di Sartre) sono delle icone mimetiche, nel secondo (in Final Fantasy) sono delle icone sintetiche. I ritratti nella galleria sartriana tentano di riprodurre delle singole individualità per suggerire un’idea di collettività, mentre i volti dei personaggi digitali di Final Fantasy tentano di evocare un’idea di umanità saltando il passaggio intermedio che è dato dalla riproduzione mimetica delle singole individualità. Paradossalmente, la descrizione sartriana delle tele di Bouville funziona alla perfezione anche se applicata alle ombre sintetiche di Final Fantasy. Rileggiamo il passo già citato della Nausea pensando ai personaggi del film: «Li avevano dipinti con grande esattezza; […]. Tutte le facce, anche le più molli, erano net-
139
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
GIANNI CANOVA
te, come maioliche». Credo che sia una descrizione perfetta, anche se involontaria, non solo dei protagonisti di Final Fantasy, ma un po’ di tutti i personaggi, i divi e le eroine virtuali che con sempre maggior densità stanno popolando l’universo dei media e la scena dello spettacolo. Il che configura una situazione per certi versi paradossale: tanto il ritratto pittorico-analogico quanto l’icona sinteticodigitale rischiano di produrre lo stesso effetto di morte del soggetto, di omologazione, di appiattimento. Il problema che mi pongo allora è questo: perché si assomigliano in maniera così forte sia i ritratti dei notabili di Bouville sia i vari e diversi personaggi di Final Fantasy? È lo sguardo dello spettatore-ossevatore-fruitore che li osserva a perdere percettivamente la cognizione della differenza o ci sono dei tratti, delle marche, dei segni, degli indizi oggettivi che portano l’analogia a prevalere sulla differenza? Sospendo ogni giudizio per quanto riguarda la pittura, rispetto alla quale non ho la competenza e l’autorevolezza necessarie per formulare un’ipotesi plausibile. Provo invece ad azzardare una riflessione nel campo del film digitale. I personaggi digitali del film da cui sono partito presentano, infatti, alcuni oggettivi elementi di omogeneità indifferenziata: stesso impasto materico, stesso grado di riflettanza luministica, stessa pastosità cromatica, stessa assenza di quei dati corporei non programmabili che a volte lasciano traccia di sé in un ritratto pittorico o filmico e che invece non appaiono – o non appaiono ancora, o forse non appariranno mai – nel mondo digitale. Di conseguenza, l’impressione che se ne ricava è che negli universi integralmente digitali come quello di Final Fantasy (altra cosa sono gli universi ibridi e contaminati in cui l’immagine digitale si mescola e si sporca con immagini filmiche analogiche, come in A.I.) l’effetto di omogeneità è fortissimo e cancella ogni altra forma di differenza. È come visitare un’esposizione di statue, dove alla fine ciò che ti porti a casa è la percezione della «marmoreità» piuttosto che i tratti singolari e individuali di ogni statua, di ogni singolo artefatto scultoreo che hai avuto modo di percepire e di ammirare. Ora, a partire dalla rilevazione di questa oggettiva omogeneità che cancella le differenze individuali sul piano della raffigurazione e della rappresentazione del corpo e del volto, vorrei provare a spostarmi sul piano della rappresentazione dello spazio virtuale per
140
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
CI
SONO I BAGNI NEL CYBERSPAZIO?
PARADOSSI
ED EPIFANIE DEL VIRTUALE
chiedermi se si verifichi anche qui un problema analogo. Lo spazio virtuale è sempre a suo modo e contemporaneamente tanto uno spazio «reale», nel senso di agibile, di penetrabile e di esplorabile, quanto uno spazio rappresentabile e rappresentato. Detto in altri termini, è sempre allo stesso tempo uno spazio in cui si possono agire rappresentazioni (videogiochi, film, simulazioni di progetti architettonici e urbanistici), ma anche uno spazio che può in qualche modo essere assunto quale oggetto di rappresentazione da parte di un altro linguaggio, come ad esempio quello del cinema. La mia impressione è che gli spazi virtuali «rappresentati» abbiano per lo più un problema analogo a quello dei volti di Final Fantasy: si assomigliano in maniera molto forte, perdono la loro identità, diventano a loro volta delle maschere mortuarie sintetiche, spaziali invece che fisiognomiche. Se concentriamo poi la nostra attenzione sugli spazi virtuali e digitali, sui set virtuali assunti appunto come set di possibili performance di altro tipo, anche qui è evidente come manchino di qualche cosa per essere percepibili nella loro identità; i volti di Final Fantasy mancano di sudore, ad esempio, o di tutti quegli elementi di organicità che potrebbero renderli ulteriormente o definitivamente credibili, così come gli spazi virtuali mancano a loro volta di sporcizia. Si potrebbe dire di essi ciò che Laurie Anderson diceva di città come Vancouver o Singapore: «Dovete metterci dentro un po’ di sporcizia se volete credere che facciano parte del mondo reale». Io credo che questo sia tanto più vero quanto più il tema dello scarto e del rifiuto è in qualche modo uno degli elementi-chiave per capire la virtualità. Lo spiega molto bene Bruce Sterling, che in un importante libro firmato con William Gibson 2, pubblica un intervento significativo e illuminante su questo tema, intitolato per l’appunto La città virtuale. Sterling scrive così: La realtà virtuale offre opportunità uniche per il design, perché priva di limitazioni materiali. Non c’è materia in essa, per definizione. Sono soltanto pixel in movimento, perciò qualunque cosa può sembrare una qualsiasi altra; serve soltanto qualcuno intenzionato a investire il proprio tempo e i propri sforzi per farla apparire in un determinato modo. Nulla arruggi2
2001.
Cfr. B. STERLING, W.GIBSON, Parco giochi con pena di morte, Mondadori, Milano
141
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
GIANNI CANOVA
nisce, nulla si rompe, nulla crolla; viene solo cancellato dal disco. Non ci sono leggi fisiche nella realtà virtuale, non c’è entropia, né attrito. Gli ambienti virtuali, pertanto, possono assorbire infinite quantità di manodopera e di ingegno progettuale. […] Il risultato è questo mondo planare color caramella di sterilità inorganica […]. Non c’è sporcizia né asperità 3.
Insomma: ci sono bagni nel cyberspazio? si chiede Sterling. E, potremmo aggiungere, ci sono discariche, immondezzai, rifiuti? O la rete è semplicemente un universo in cui qualcosa si cancella e scompare senza lasciare traccia di sé? E che ne è in ogni caso delle rovine della rete, dei siti morti, di quelli abbandonati? Esistono cimiteri digitali? C’è una fognatura che raccolga gli escrementi del virtuale? Ma Sterling va anche più in là, e pone con grande chiarezza la questione-chiave con cui avremo a che fare nel prossimo futuro: stando a tutte le stime elaborate da vari istituti di ricerca, ricorda Sterling, è assolutamente probabile che nel giro di cinquant’anni su questo pianeta ci siano più di dieci miliardi di persone. Questo è il problema di fondo. E qui entra in campo la Rete. Come? Semplice, scrive Sterling: offrendo qualcosa da fare a tutta questa gente. Dobbiamo dargli in qualche modo qualcosa da fare. Qualcosa che le interessi, per passare il tempo. Qualcosa di innocuo. E che può esservi di più innocuo che milioni di persone sedute, perfettamente immobili mentre muovono le punta delle dita su e giù sulla tastiera, fissando uno schermo? 4
La Rete diventa insomma – nella visione di un autore senz’altro non apocalittico come Bruce Sterling – una sorta di ammortizzatore sociale capace di tenere occupato quello che un tempo era il proletariato, rendendolo videodipendente, con le radici conficcate nel divano di casa, e faticosamente impegnato a far apparire un menù sul televisore invece che «distratto» da altre attività socialmente pericolose. Dieci miliardi di persone, tutti connesse, e tutti «interfacciate» con un unico grande schermo che rinvia a chiunque le medesime immagini. È questo il futuro? 3 4
B. STERLING, La città virtuale, in Op. cit., pp. 63-64. Ivi, p. 63.
142
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
CI
SONO I BAGNI NEL CYBERSPAZIO?
PARADOSSI
ED EPIFANIE DEL VIRTUALE
Ma c’è un altro problema. Ed è quello che nasce dalla necessità di capire che rapporto tendenziale vanno a istituire questi dieci miliardi di persone con lo spazio omologato che si offre come oggetto scopico al loro sguardo collettivo. A questo proposito la mia tesi, ricavata da un’osservazione approfondita delle dinamiche e delle tendenze del cinema e della visual culture contemporanea, è molto precisa: mi sembra cioè – come ho cercato di mostrare nel mio saggio L’alieno e il pipistrello 5 – che nelle pratiche immersive del virtuale sia cambiata e stia cambiando soprattutto una «modalità di relazione». Quello che è cambiato, in fondo, non è tanto lo sguardo o il punto di vista dello spettatore, né è cambiato l’oggetto-mondo osservato e messo in scena (se non per quelle marche di omogeneità e di indifferenziazione che richiamavo prima). Quello che è cambiato davvero è il rapporto che si dà tra il soggetto e l’oggetto scopico: è mutata la relazione, la modalità di connessione. Ed è mutata perché è venuto meno – credo definitivamente – quel modello relazionale che è stato mirabilmente sintetizzato da Hans Blumenberg attraverso la metafora del «naufragio con spettatore» 6. Blumenberg, come è noto, prendeva le mosse dal passo iniziale del secondo libro del De rerum natura di Lucrezio per costruire un modello di relazione spettatoriale fondato sulla distanza: da una parte c’è la terraferma con uno spettatore, dall’altra c’è un naufragio – non un «naufrago»: lo spettatore è un soggetto, mentre l’oggetto della visione non è un individuo, un soggetto, ma un dato evenemenziale, un nodo fattuale. Per secoli la cultura occidentale si è basata su questo paradigma: qui c’è la terraferma, qui c’è un soggetto che osserva, e a distanza c’è un oggetto osservato. La mia impressione è che stiamo vivendo, o forse abbiamo già vissuto, il collasso e l’eclissi di questa distanza, e che la terraferma e il mare siano ormai inevitabilmente sovrapposti, compromessi, per cui non ci sono più naufragi, non ci sono più spettatori, ma alternativamente, o forse simultaneamente, siamo portati a vivere perennemente e contemporaneamente nello stesso istante l’una e l’altra condizione. Cfr. G. CANOVA, L’alieno e il pipistrello, Bompiani, Milano 2001. Cfr. H. BLUMENBERG, Naufragio con spettatore. Paradigma di una metafora dell’esistenza, Il Mulino, Bologna 1985. 5 6
143
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
GIANNI CANOVA
Ce lo dice il cinema, prima ancora che la pratica empirica del web. Il cinema, da dieci anni a questa parte, non fa che raccontare questa storia: la racconta con tantissimi film che sono stati evocati nelle relazioni precedenti, film che fantascientificamente collegano gli opposti, e che ci dicono dell’impossibilità di tracciare confini netti o separazioni rigide fra ciò che un tempo era distinto e tutelato dalla distanza. Voglio citare un film che mi sembra imprescindibile in questa prospettiva, Il pianeta delle scimmie (2001) di Tim Burton. Si pensi anche solo al finale, quando il protagonista crede di essere fuggito dall’altrove in cui era precipitato e crede di tornare a casa, a Washington, nel luogo dell’identità, e arrivato lì – osservando in controcampo la statua di Abramo Lincoln – vede, con un bellissimo movimento di macchina, che nel volto scolpito di Lincoln si è incistato – come in una sorta di mostruosa sovrimpressione – il volto dello scimmione, dell’Altro da cui credeva di essere fuggito. L’Altro è lì, coincide con l’Identico, l’identico si è fatto altro, e le due dimensioni non sono più distinguibili. Questo ci dice questo film, come ce lo dicono eXistenZ di Cronenberg e A.I. di Spielberg: siamo definitivamente dentro l’eclissi della distanza, dentro la sua perdita. Questo è lo scenario con cui dobbiamo fare i conti. Al cinema e fuori di esso. Perché solo se riusciamo a elaborare la capacità di far continuare ad agire lo sguardo dentro l’eclissi della distanza possiamo sperare di evitare il rischio che ci sia qualcuno (come, nel film di Tim Burton, il generale che guida le scimmie) che pretende di fare pulizia etnica e di reintrodurre una distanza tra le parole e le cose, fra l’altro e l’identico, fra il qui e il là, fra il prodotto e il suo scarto. Questo è il pericolo: che qualcuno ancora sogni di tornare a quello schema di pensiero binario e manicheo. La sfida è far agire lo sguardo e andare a ritrovare l’identità dentro la differenza, ma accettando la loro compresenza, il loro mescolamento inevitabile e già del tutto compiuto.
144
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
SF & SFX. IL RUOLO DEGLI EFFETTI SPECIALI di MARCELLO WALTER BRUNO
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
a Sofia Amendola e Davide Greco che hanno raggiunto il pianeta Terra nel fatidico anno 2001
La fantascienza scenografica La fantascienza è un genere che oscilla fra l’utopia e la profezia. Il suo sfondo concettuale è infatti la distanza: quella spaziale, quella temporale o entrambe. Da questo punto di vista, è quasi inevitabile che la visualizzazione cinematografica del distante sia indebitata con gli effetti speciali: dovendo immaginare luoghi altri ed entità altre, un semplice profilmico di stampo documentaristico richiederebbe location tali da risultare impervie per una produzione di serie B. Ma la dialettica fra mondi possibili ed innovazione tecnologica è complessa: da una parte, lo scatenamento della fantasia – anche solo in direzione della previsione scientificamente attendibile – costringe la tecnica ai salti evolutivi richiesti dal progetto registico; dall’altra, la disponibilità pratica di determinate innovazioni determina alcune soluzioni artistiche e addirittura alcuni temi drammaturgici. Proviamo a seguire l’intreccio dialettico tra SF e SFX 1 attraverso alcuni punti nodali della storia del cinema utopico e profetico. Per la fantascienza cinematografica delle origini, il futuro non è ancora cominciato – oppure, se volete, il futuro è il cinema stesso. Si pensi ai capolavori di Georges Méliès Il viaggio nella luna e Il viaggio attraverso l’impossibile: è chiaro che qui tutta la macchineria
1 Sillabando in inglese la sigla SFX si pronuncia «es-ef-ex», contrazione dell’inglese «special effects». (N.d.C.)
147
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
MARCELLO WALTER BRUNO
teatrale delle botole e delle finte prospettive si somma alle novità del mezzo cinematografico – le sparizioni a vista per interruzione della ripresa, le doppie esposizioni, le animazioni di elementi dipinti – per ottenere il risultato neobarocco di una meraviglia fiabesca. Non si tratta di una poetica tutta e solo meliesiana: nel film di Robert W. Paul The ? Motorist (1906) un’automobile impazzita e magica arriva fino in cielo, finendo con l’utilizzare gli anelli di Saturno come un minuscolo circuito di corsa. Né bisogna dimenticare il film dell’inglese Walter R. Booth Airship Destroyer (1919), dove il modellino della città di Londra viene bombardato in una sorta di primo attacco alieno. In tutti questi casi, il valore del trucco è sempre teatrale in senso sociologico: ciò che si sottopone al pubblico è la possibilità di vedere il mai visto, in un senso opposto ma complementare al déjà-vu costituito dall’esotismo documentaristico inaugurato dagli operatori Lumière. Siamo dunque in quel lato del fantastico che Roger Caillois definisce «fiaba» 2: un mondo non realistico, in cui per principio il perturbante è espunto, ridotto alle dimensioni di un’alienità tutta di fantasia. Anche Fritz Lang, come ci informa Paolo Bertetto 3, ha dichiarato che Metropolis è un racconto di fate; ma questo evidentemente riguarda la favoletta sociopolitica a lieto fine, non la costruzione dell’immagine. Il referente visivo non è infatti un pianeta o il nostro lontano satellite, bensì New York come simbolo del capitalismo. Insomma, Metropolis è un film di fantascienza solo perché è un film sulla modernità e dunque sull’innovazione tecnologica. E il suo versante autoriflessivo è proprio la modernità della concezione visiva, il metodo di lavoro collettivo e il gusto della sperimentazione tecnica. L’effetto più innovativo è il cosiddetto «procedimento Schüfftan», che consiste nell’utilizzo di modellini in fase di ripresa per comporre – con l’ausilio di particolari specchi – inquadrature in cui gli attori si muovono all’interno di scenografie non in scala reale. Insomma, i grandi ambienti industriali sono già ambienti virtuali; il lavoro cinematografico produce il plusvalore della spettacolarità come puro effetto ottico, trompe l’œil che coniuga staticità e movimento. Un altro effetto innovativo, che supera la classica sovraimpressione con qualcosa che già somiglia al «ma-
2 3
Cfr. R. CAILLOIS, Dalla fiaba alla fantascienza, Theoria, Roma 1985. Cfr. P. BERTETTO, Fritz Lang. Metropolis, Lindau, Torino 1990.
148
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
SF & SFX. IL
RUOLO DEGLI EFFETTI SPECIALI
scherino mobile» (travelling matte), è la scarica elettrica che trasforma il robot Hel nella finta Maria. Ma qui, l’impossibilità di una trasformazione a vista inficia l’illusione diegetica: la finta Maria è, evidentemente e necessariamente, la stessa attrice che interpreta la vera Maria (Brigitte Helm). Il tema del doppio non riesce a diventare effetto visivo, e il robot fantascientifico sembra all’improvviso un semplice riaggiornamento della più classica delle figure espressioniste: il golem. La questione scenografica è centrale nella fantascienza degli anni Trenta e Quaranta, sia quando deve visualizzare mondi futuri (non per caso il regista di La vita futura Nel 2000 guerra o pace, è William Cameron Menzies, lo scenografo di Via col vento) sia quando deve inventarsi le possibilità visivamente eclatanti della scienza contemporanea. In quest’ultimo caso, il rapporto fra microscopico e macroscopico diventa l’elemento centrale delle trovate di sceneggiatura: tanto lo scienziato di La bambola del diavolo (film scenografato dal grande Cedric Gibbons, quello di Il Mago di Oz e di Il pianeta proibito) quanto quello di Il dottor Cyclops (film diretto dal regista di King Kong) sono dediti a improbabili esperimenti sul rimpicciolimento degli esseri viventi, il che permette di ottenere situazioni drammaturgicamente forti al prezzo della ricostruzione ingrandita di ambienti familiari. Il trucco, insomma, è perlopiù profilmico; ma qui la teatralità è già lontana, perché su un palcoscenico sarebbe evidente questo gioco delle sproporzioni che invece funziona nello spazio assoluto dello schermo bidimensionale. L’autonomia dell’immagine rivela il valore puramente segnico del profilmico: lo spazio della quotidianità è già pronto a rivelare il suo carattere alieno e perturbante, una volta che lo sguardo spettatoriale è stato sconnesso dalla prospettiva teatrale e reinserito nel «montaggio ubiquitario» 4 del modo di rappresentazione istituzionale. L’effetto è talmente cinematografico che il protagonista Cyclops, metafora del regista manipolatore, può permettersi questa battuta rivelatrice rivolta a una vittima dell’esperimento: «Non è lei che è diventato piccolo, ma il resto che è diventato grande». Il dottor Cyclops è il primo film di fantascienza a ottenere una nomination all’Oscar per i migliori effetti
4 Cfr. N. BURCH, Il lucernario dell’infinito. Nascita del linguaggio cinematografico, Pratiche, Parma 1994.
149
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
MARCELLO WALTER BRUNO
speciali, che all’epoca (1940) non distingue tra effetti visivi, sonori, meccanici; ma Gordon Jennings e il mago della retroproiezione Farciot Edouart dovranno attendere un paio d’anni, mentre l’Oscar 1940 va a Il ladro di Bagdad, un blue screen da mille e una notte. La fantascienza prostetica Per la fantascienza cinematograficamente moderna, il futuro è già cominciato. È cominciato in un arco di tempo che va dal 6 agosto 1945 a un’imprecisata data del 1947: ovvero dalla prima bomba atomica, sganciata su una popolazione civile, al primo avvistamento ufficiale di un UFO. A partire da questo periodo, l’industria degli effetti speciali deve confrontarsi con un panorama scientifico-tecnologico profondamente mutato: il realismo ontologico implica la necessità di riuscire a rappresentare anche una reazione nucleare (cosa non facile, tanto che Stanley Kubrick per il finale di Il dottor Stranamore ricorre a riprese documentarie) o le mutazioni indotte sul corpo umano dalla radioattività. Quando la fantascienza si mette a fantasticare sull’era atomica e sugli extraterrestri, gli effetti speciali sono chiamati a ridisegnare un immaginario collettivo sospeso fra il fantastico puro e l’ipotesi scientifica. Il corpo non umano o post-umano è al centro di un’inedita necessità d’immaginare l’inimmaginabile, sotto forma di fisicità dell’entità aliena o di metamorfosi dell’anatomia terrestre: in un caso e nell’altro – ed escludendo le soluzioni tipo Ultimatum alla Terra, in cui l’extraterrestre è semplicemente un terrestre in tuta spaziale – ciò che serve è l’arte del trucco teatrale spinto fino all’estremo limite del surrealismo biologico. Dal make-up si passa allora alla prostetica, intesa come «estetica della protesi»: non più semplice lavoro sulla fisionomia del volto da coniugarsi con qualche eccentricità dell’abbigliamento, ma utilizzo del lattice (nuovo materiale plastico messo a disposizione del cinema dall’industria chimica) in funzione di vere e proprie tute-corpo di cui il corpo attoriale diventa il supporto marionettistico. Appartengono a questo design della nuova carne il mutante metalunare di Cittadino dello spazio, il mutante postatomico del cormaniano Il mostro del pianeta perduto, l’uomo-cactus del-
150
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
SF & SFX. IL
RUOLO DEGLI EFFETTI SPECIALI
l’inglese L’astronave atomica del dottor Quatermass; e poi, a fine anni Sessanta, il look degli abitanti di Il pianeta delle scimmie, che costringe l’Academy a inventare un Oscar speciale per premiare il make-up di John Chambers. Per il resto – evitando la facile soluzione dell’alieno vegetale (La «cosa» da un altro mondo, L’invasione degli ultracorpi, Il giorno dei trifidi) o dell’alieno «psicologico» (Il villaggio dei dannati) – ciò che abbiamo è un’ennesima variazione sul tema del gigantismo, effetto del disastro ecoambientale sul mondo animale: le formiche retroproiettate di Assalto alla Terra, il ragno retroproiettato di Tarantola, i granchi postatomici di L’assalto dei granchi giganti; ma anche Godzilla, il drago giapponese che – al contrario del suo lontano riferimento americano King Kong – non è risolto con i pupazzi in stop motion ma con un costume prostetico disegnato da Eiji Tsuburaya. Ovviamente, la fantascienza scenografica non cessa di essere prodotta, solo che i suoi sogni si spostano dalle utopie architettoniche alla Fritz Lang o Cameron Menzies – legate a una visione politica del mondo in cui il gioco fra le classi non è distruttivo fino in fondo – a profezie d’invasione territoriale e dunque di catastrofe urbanistica: i modellini di città sono fatti per essere distrutti. Abbiamo così Los Angeles rasa al suolo dai raggi marziani in La guerra dei mondi (premio Oscar 1953 per i migliori effetti speciali a Gordon Jennings, peraltro unico candidato), Tokyo calpestata da Godzilla nell’omonimo film di Inoshiro Honda (scenografia di Satoshi Chuko e Takeo Kita), Washington sorvolata dagli UFO di Ray Harryhausen in La Terra contro i dischi volanti (scenografia di Paul Palmentola). Nella fantascienza europea, compressa fra la politica ontorealistica degli autori e la povertà dei budget, lo sfondo scenografico si sposta dai modellini in studio all’urbanistica modernista delle metropoli reali: l’Alphaville di Jean-Luc Godard è in realtà il quartiere parigino della Défense filmato a metà anni Sessanta; il viaggio nel tempo di La jetée di Chris Marker si svolge fra il Trocadero e l’aeroporto di Orly; L’ultimo uomo della Terra, versione cinematografica italiana del romanzo di Richard Matheson, I vampiri, si muove nei grandi spazi del quartiere romano dell’EUR.
151
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
MARCELLO WALTER BRUNO
La fantascienza ottico-meccanica Il mito modernista della novità in arte e quello del realismo ontologico, più specificamente legato al cinema attraverso le riflessioni normativizzanti di André Bazin 5, confluiscono in qualcosa che Georges Méliès non avrebbe capito: la fantascienza realistica. Gli anni Cinquanta si aprono con il premio Oscar per i migliori effetti speciali assegnato al dipartimento effetti della Eagle Lion (la casa di produzione di George Pal) per Uomini sulla Luna, film che ottiene anche una nomination per la categoria «miglior scenografia e arredamento per film a colori». Data la trama esigua (nonostante lo zampino di Robert Heinlein) e la recitazione non entusiasmante, l’importanza del film non può che essere ricondotta ai suoi intenti pedagogici e politici: in un decennio in cui la guerra fredda USA-URSS viene metaforizzata col solito cliché dell’invasione aliena (La «cosa» da un altro mondo, L’invasione degli ultracorpi, Fluido mortale) e in cui il genere fantascientifico viene considerato ancora di serie B e tendenzialmente «televisivo» (con l’eccezione dello shakespeariano Il pianeta proibito, che rientra nella tradizione utopico-scenografica alla Cedric Gibbons), il film di Irving Pichel dice chiaramente che la conquista della Luna è tecnologicamente possibile (spiegazione affidata a un cartone animato di Picchiarello) e militarmente utile. La profezia si trasforma in anticipazione, l’immaginazione utopica accetta la sfida dell’obsolescenza: un film sullo sbarco degli uomini sulla Luna è destinato a diventare antiquato appena arriveranno le immagini in diretta televisiva; e il film, in effetti, non è concepito come una previsione degli eventi, bensì come una post-visione retrospettiva, in cui una civiltà del futuro tenta di riandare agli inizi delle esplorazioni stellari come gli studiosi omerici tentano di ricostruire i miti dell’antica Grecia. Le sfide sono sostanzialmente tre: la rappresentazione del suolo lunare e del paesaggio che si può godere (ad esempio l’aspetto del nostro pianeta dal punto di vista del nostro satellite); la rappresentazione del razzo e del modulo, visti sia dall’esterno che all’interno; infine, la rappresentazione degli effetti, sul corpo umano, causati dall’assenza di gravità. Ecco allora che il team SFX è sotto la giurisdizione di tre professionisti con competenze di5
Cfr. A. BAZIN, Che cosa è il cinema?, Garzanti, Milano 1973.
152
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
SF & SFX. IL
RUOLO DEGLI EFFETTI SPECIALI
verse: Chesley Bonestell, bozzettista, provvede ai fondali; John Abbott, esperto di modellini e animazione, fa procedere l’astronave (ma anche un’omerica «cetra spaziale») a passo uno; e Lee Zavitz, l’uomo che ha incendiato Atlanta in Via col vento, sovraintende agli effetti meccanici. La tappa successiva della fantascienza pedagogico-documentaristica è Viaggio allucinante, brutto titolo italiano per un’avventura i cui protagonisti sono sì degli astronauti, ma lo spazio interstellare è sostituito dall’universo illimitato ma finito dell’interno del corpo umano. Nello stesso 1966 in cui Michelangelo Antonioni ha una nomination per Blow-Up, film sull’ingrandimento dell’immagine come ricerca e perdita del senso, Viaggio allucinante – film autoriflessivo sulla miniaturizzazione – vince ben due Oscar: quello per la categoria «miglior scenografia e arredamento per film a colori» (peraltro sconfiggendo il felliniano Giulietta degli spiriti) e quello per la categoria «migliori effetti visivi» (ormai distinta dai «migliori effetti sonori», per la quale comunque il film è candidato). La statuetta premia Art Cruickshank, un poliedrico veterano della Disney che si è specializzato nella cosiddetta miniature photography, punto d’intersezione fra il meccanico e l’ottico, tra il profilmico e il filmico. Si consideri che, a questa data, gli Oscar per gli SFX assegnati a film di fantascienza sono solo cinque: Uomini sulla Luna (1950); Quando i mondi si scontrano (1951), con la New York inondata da Gordon Jennings; La guerra dei mondi (1953); L’uomo che visse nel futuro (1960); Viaggio allucinante (1966). Il punto d’arrivo del realismo ontologico è 2001 Odissea nello spazio, in cui Kubrick firma personalmente la progettazione degli effetti speciali – quasi a confermare che è lì la vera autorialità nel cinema fantascientifico – pur avvalendosi di uno stuolo di professionisti che vanno dai veterani Tom Howard e Wally Veevers (la cui esperienza risale a La vita futura e, più in generale, alla scuola inglese di Percy Day, l’inventore del matte painting e del glass shot) al giovanissimo Douglas Trumbull. Il film è in parte una summa del sapere tecnico dell’epoca, nel senso che sfrutta la possibilità di scelta fra varie alternative (ad esempio la rinuncia al blue screen a favore della proiezione frontale su schermo scotchlite, come nell’incipit africano), e rifacendo in versione «documentaristica» trucchi prima usati
153
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
MARCELLO WALTER BRUNO
in funzione surrealista: è il caso della rotazione del set, che Stanley Donen aveva utilizzato per far ballare Fred Astaire sul soffitto di Royal Wedding (Sua Altezza si sposa, 1951) e che Kubrick adotta come soluzione a uno dei problemi già affrontati da Uomini sulla Luna, ovvero l’assenza di gravità all’interno delle astronavi; la rotazione è ottenuta con una gigantesca «centrifuga» costruita dall’industria meccanica Vickers Engineering Group, costata sei mesi di lavoro e 300.000 dollari degli anni Sessanta. In parte, però, 2001 è un effettivo tentativo di sperimentazione originale, il cui risultato più visibile è senz’altro il «corridoio stellare» ottenuto da Trumbull con un’apparecchiatura denominata «slit-scan»: una macchina da presa riprende a passo uno, attraverso una fessura e a distanza variabile, fonti di luce proiettate su uno schermo; l’effetto, che rimanda al «trascinamento» della cosiddetta streak photography, riunisce in un’unica esperienza visiva i cromatismi della pittura pop e l’astrazione figurativa dei trip allucinogeni. Si apre la strada a un cinema fantascientifico del puro visibilismo, di cui Trumbull diventa il nume tutelare. La fantascienza visiva Nel 1971, infatti, non ancora trentenne, Douglas Trumbull partecipa alla realizzazione del film di Robert Wise Andromeda e poi scrive, produce e dirige Silent running, che la distribuzione italiana «kubrickizza» col titolo 2002 la seconda odissea; suoi collaboratori sono John Dykstra e Richard Yuricich. Nel 1977, Dykstra vince l’Oscar per aver inventato la cinepresa a movimento controllato con cui George Lucas ha girato Guerre stellari, mentre Trumbull e Yuricich ottengono una nomination per Incontri ravvicinati del terzo tipo: il terzetto di amici, insomma, determina lo stile visivo delle due poetiche del cinema SF postmoderno, quello ebraico-misticheggiante di Steven Spielberg e quello antropologico campbelliano di George Lucas. Incontri ravvicinati è un film su Dio, sull’epifania del divino di cui gli UFO sono la metafora junghiana: non per caso il protagonista è un elettricista che ha la sua prima visione – annunciata nell’incipit del film, dove un vecchio messicano racconta a François Truffaut che il sole gli è apparso di notte e s’è messo a cantare per lui – in una notte resa più buia da un blackout elettrico. Mentre il nostro è fermo nel
154
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
SF & SFX. IL
RUOLO DEGLI EFFETTI SPECIALI
suo camioncino a controllare una mappa alla luce di una torcia elettrica, due fari si fermano dietro, incorniciati dal vetro posteriore; l’uomo fa cenno per farsi superare, e gli spettatori vedono i due fari alzarsi verso l’alto e sparire nel fuori-campo superiore del lunotto. A questo punto, grande fascio di luce dall’alto: una versione tecnologicamente avanzata dell’illuminazione caravaggesca di Saul lungo la strada di Damasco. L’elemento epifanico della luce si sovrappone per tutto il film alla confusione fra cielo e terra, mezzi di trasporto umani e mezzi di trasporto alieni: le piccole astronavi di luce – riprese in una smoke room per accentuare la morbidezza diffusa del cromatismo luminoso – sembrano seguire la linea autostradale, salvo portare fuori strada le auto della polizia a sirene (e luci) spiegate; invece, quando le luci arrivano dall’alto, si scopre che sono elicotteri venuti a reprimere le adunate sediziose dei fedeli ufologi. L’incontro ravvicinato non può che avvenire di notte in cima a una montagna: l’astronave-madre è un gigantesco occhio di Dio le cui due metà sono state paragonate al panorama notturno di Los Angeles (la parte inferiore, piatta ma percorsa da fasci modulari che finiscono col produrre musica) e New York (skyline a diagramma di blocchi, tutto pinnacoli da raffineria con luci di posizione o, per i critici più cattivi, torta di compleanno stracarica di candeline); ed è in un certo senso un oggetto mistico, in parte fisico (il modello di Greg Jein in cui la luce è veicolata dalle fibre ottiche) e in parte «trascendente» (costruito in postproduzione con le tecniche di light scanning di Trumbull). Guerre stellari, con i suoi 365 effetti speciali (quasi quattromila elementi fotografici separati da riunificare in truka) contro i 35 di 2001, rappresenta il trionfo di una visionarietà analitica, capace di scindere ogni immagine nelle sue componenti tecnicamente producibili: movimenti di macchina (controllati dalla Dykstraflex, il sistema che guadagna l’Oscar a John Dykstra), modelli (animati in stop motion), ambienti (matte paintings utilizzati sia mediante la tecnica shot design sia in retroproiezione), esplosioni (filmate in Vistavision a 100 fotogrammi al secondo). L’estetica della luce, che in un film «pacifista» come Incontri ravvicinati si concentra sulle nubi elettriche e le astronavi luminose (entrambi veicoli della divinità che arriva dall’alto dei cieli), nella saga «reaganiana» di Lucas si concentra in quel simbolo aggiornato del duello cavalleresco che è la spada laser:
155
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
MARCELLO WALTER BRUNO
un oggetto ovviamente inesistente, ottenuto con bastoni ricoperti di scotchlite (il materiale ultrariflettente utilizzato da Kubrick per costruire il grande schermo per la proiezione frontale dei paesaggi africani di 2001) modificati con la vecchia tecnica del rotoscoping (sostanzialmente un ritocco pittorico fotogramma per fotogramma) per ottenere l’alone tipo neon (se ne ricorderà Luc Besson per il suo esordio Subway, dove il protagonista brandisce un tubo fluorescente come se fosse appunto un’arma da guerriero Jedi). La tappa successiva di Trumbull è Star Trek (1979), quando il vecchio amico Robert Wise lo chiama per sostituire il team di Robert Abel, esperto di computer animation in 3-D ma con esperienze legate più agli spot pubblicitari da 30 secondi che non ai lungometraggi; Trumbull, che ormai deve realizzare in nove mesi il lavoro che era stato previsto in ventuno, chiama in soccorso Dykstra e Yuricich, ricostituendo così il gruppo di Silent running. La sostituzione di Abel con Trumbull suona paradossalmente come un ritorno indietro dalle sperimentazioni informatiche (presenti comunque in scene come la fuga dal pianeta Genesis, creato dalla Pixar con immagini di sintesi) alle tecniche ottico-meccaniche; ma ciò che è in gioco è pur sempre il realismo ontologico, e il puro visibilismo trumbulliano non antepone la tecnologia monocratica al racconto, bensì elabora poetiche dello sguardo la cui realizzazione può essere trasversale a tutte le tecnologie. Si legga la dichiarazione riportata da Ettore Pasculli a proposito della nuvola che avvolge Vger: A poco a poco mi venne l’idea che questa nuvola dovesse avere una forma particolare per provocare un interesse drammatico. Non poteva essere semplicemente un pezzo di cotone; doveva avere una forma che permettesse diversi angoli di ripresa. Quello che volevo, più in particolare, era qualcosa che suggerisse dei nuclei di energia, collegati e intrecciati in una serie complessa di forme quasi trasparenti disposte attorno a un punto centrale. Ho realizzato l’effetto con un’asta verticale, sulla quale avevo fissato un gruppo di fili di ferro ricurvi dipinti di bianco. Abbiamo fatto girare questa asta, e l’abbiamo illuminata con un flash stroboscopico che scattava ogni quarto di secondo; ogni tempo di posa contava all’incirca cento o duecento flash, creando un flou controllato che dava il suo volume alla nuvola 6. 6
E. PASCULLI, Il cinema dell’ingegno, Mazzotta, Milano 1990, p. 100.
156
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
SF & SFX. IL
RUOLO DEGLI EFFETTI SPECIALI
È l’aleatorietà artigianale del procedimento produttivo che crea l’effetto di singolarità dell’oggetto visivo, laddove l’immagine computerizzata è ancora legata al determinismo progetto/esecuzione, per cui nulla può davvero apparire se non è già stato pre-visto. L’epifania del divino, in attesa delle tecniche frattali, si affida ai processi stocastici della persistenza retinica. Blade Runner, che nel 1982 guadagna a Douglas Trumbull e Richard Yuricich una nomination all’Oscar per i migliori effetti speciali visivi, chiarisce fin dall’incipit in cosa consista il misticismo trumbulliano: la minuziosa miniatura di Los Angeles, lunga più di venti metri per poter essere sorvolata dall’occhio della speciale camera Snorkel, è puntellata di lucine in fibra ottica, si accende in postproduzione dei fuochi delle raffinerie – è, insomma, la ricaduta in Terra dell’astronavemadre di Incontri ravvicinati. Ma questa estetica del neon s’incontra con l’uso della nebbia, che rende l’atmosfera contemporanamente misty e mystical, numinosa e nebulosa: l’eccesso di luce diffusa non rende più facile la visione, anzi la rende più difficoltosa (così, in Incontri ravvicinati, gli alieni sono ri-velati, ovvero messi in luce e con ciò stesso coperti di nuovo alla vista dello spettatore). E anche la pioggia, ripresa a parte e aggiunta in truka, diventa non solo un disturbo grafico ma un ennesimo gioco sull’esistenza del profilmico: in un film interamente basato sulla poetica dickiana dell’indecidibilità dei simulacri, l’attenzione posta sull’opposizione umano/replicante (irrilevante sul piano del profilmico, poiché gli androidi sono interpretati da attori con tanto di nome nei credits) fa distrarre rispetto alla vera questione dell’immagine mixa, sintesi unitaria di fonti diversissime (compresi i panorami finali, che provengono addirittura da un altro film, essendo le riprese aeree scartate da Kubrick per l’incipit di Shining). Nessuna sorpresa, dunque, che il film inizi con il dettaglio di un occhio e che il test per gli androidi si basi sul controllo dell’iride: la SF tematizza la visione quando gli SFX sono giunti al punto da rendere indecidibile l’unitarietà dell’inquadratura e la tipologia delle fonti delle eventuali ipo-icone. Il cinema, parlando del «più umano dell’umano», entra in ciò che Jean Baudrillard 7 chiama iperrealismo: più reale del reale. Come la pioggia in postproduzione. 7 Cfr. J. BAUDRILLARD, Lo scambio simbolico e la morte, Feltrinelli, Milano 1979; ID., Il delitto perfetto. La televisione ha ucciso la realtà?, Cortina, Milano 1996.
157
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
MARCELLO WALTER BRUNO
La fantascienza animatronica Nella cronologia di Baudrillard, l’ordine dei simulacri passa dalla fase classica della contraffazione (il falso contrapposto al naturale riconoscibile) alla fase industriale della produzione seriale (che coinvolge l’opera d’arte costringendola alla riproducibilità tecnica) per giungere fino alla fase attuale della simulazione fondata sulla legge strutturale del valore, fra codice e modello. Gli esseri artificiali che corrispondono ai primi due ordini sono l’automa e il robot: il primo è anàlogon e interlocutore dell’uomo, sua contraffazione teatrale e singolare (meccanica artigianale); il secondo è equivalente operativo (non iconico) dell’uomo, ponendosi come possibile sostituto (in serie) all’interno dei processi produttivi. La SF letteraria prefigura da tempo, in particolare con i romanzi di Philip Dick, il terzo ordine dei simulacri: quello dell’androide che, riproducendo le fattezze del corpo umano grazie a una microcommistione di componenti elettronico-meccaniche e componenti biotecnologiche (fino a configurare un cyborg, un organismo cibernetico, vivente biomeccanico o macchina biomorfa), pone l’indecidibilità cartesiana fra intelligenza umana e intelligenza artificiale, fra animazione corporea e corpo senza anima. Il cinema ha ovviamente affrontato la questione fin dai tempi de L’uomo meccanico (dove il robot viene piegato a scopi criminali) e Metropolis (dove l’automa rimanda al mito di Frankenstein e del Golem) per giungere – attraverso Il mondo dei robot di Michael Crichton (che nei primi anni Settanta parodizza, col nome di Westworld «mondo occidentale», quell’avveniristico parco a tema di Disneyland per cui un decennio prima era stato coniato il termine «audio-animatronics», elettronica applicata alla costruzione di automi semoventi e parlanti), Blade Runner (dove gli androidi di Dick vengono ribattezzati «replicanti»), Terminator, Robocop, Tetsuo – fino ad A.I. Intelligenza Artificiale. Ma il cinema è esso stesso il luogo dell’ibridizzazione dei simulacri: in esso s’incontrano e solidarizzano la contraffazione teatrica dei corpi e degli ambienti, la produzione seriale e mercantile delle immagini e delle storie, la simulazione del movimento e dello sguardo. La macchina da presa speciale (Louma Crane, Snorkel, Dykstraflex, Skycam) è già un robot, sostituto compute-
158
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
SF & SFX. IL
RUOLO DEGLI EFFETTI SPECIALI
rizzato di ogni antiquato Serafino Gubbio 8 operatore. E gli automi si disseminano ben oltre i ristretti confini della SF, creando il tipico paradosso del realismo ontofotografico: quando il personaggio è un automa o un robot o un cyborg, il più delle volte l’interprete è un essere umano (come la ballerina «meccanica» del felliniano Casanova); mentre la robotica e l’animatronica si nascondono altrove, ad esempio in animali e persone «ordinarie» sottoposte a performance «straordinarie». Fra i grandi artisti del simulacro di terzo ordine – quello che supera l’antica concezione della stop motion alla Willis O’Brien o alla Ray Harryhausen (mai ingaggiati dal settore SF) ma anche quella che Richard Rickitt 9 chiama suitmation e che noi abbiamo chiamato prostetica (l’animazione di un costume da parte di un attore) – è il ferrarese Carlo Rambaldi 10, attivo nel cinema italiano ed europeo fin dai primi anni Sessanta (suo il costume indossato da Jane Fonda in Barbarella, così come le ali estensibili, battenti e chiudibili dell’angelo) ma il cui talento incontra i giusti budget solo dopo il suo trasferimento da Cinecittà ad Hollywood. Il primo Oscar è per il remake di King Kong (1976): Rambaldi, che giudica inadeguato il lavoro effettuato nell’originale del 1933 per riprodurre ciò che alla fin fine è un gorilla (cioè un animale realmente esistente), decide di «imitare la natura al 100 per cento» e va a studiarsi un gorilla dello zoo di San Diego, che diventa il modello di un King Kong in scala uomo (costume completo di quattro teste meccaniche comandate da una distanza di 15 metri) e di un King Kong meccanico in scala gigante (dodici metri e mezzo di altezza); completano il profilmico braccia meccaniche in scala uomo e braccia e gambe meccaniche in scala gigante. Nei titoli di coda la produzione accredita, oltre a Rambaldi, Glen Robinson (capo officina della Metro Goldwyn Mayer) e Rick Baker (mago del make-up ma qui «animatore» del costume prostetico); a lavorare dietro King Kong, però, ci sono circa duecento persone. Probabilmente, rive-
Allusione a un romanzo di Luigi Pirandello. (N.d.C.) Cfr. R. RICKITT, Special effects: the history and technique, Virgin, London 2000. 10 Cfr. L. PELLIZZARI (a cura di), Carlo Rambaldi e gli effetti speciali, Aiep, San Marino 1987. 8 9
159
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
MARCELLO WALTER BRUNO
dendo oggi (dopo l’11 settembre) la carcassa del mitico animale che riempie la piazza del World Trade Center, la fantascienza sembra lasciare il posto alla metafora politica; resta il fatto che la metafora non è qui giocata su una ricostruzione di fantasia, ma sul tentativo di resa tecnologica di elementi reali (i movimenti corporei e facciali di un gorilla). Degli Oscar a Incontri ravvicinati del terzo tipo nulla viene a Rambaldi, che costruisce per il finale un extraterrestre meccanizzato capace di sorridere, muovere gli occhi (addirittura dilatando la pupilla), stendere il braccio e muovere la mano per fare i segnali corrispondenti alle note di Zoltan Kodaly. L’artista ferrarese si rifà con Alien, dove dà tridimensionalità e movimento alla creatura disegnata da Hans Ruedi Giger: famosa la bocca da cui esce una lingua quadrangolare con una seconda bocca a denti dilatabili in avanti; ma la collaborazione comprende anche l’uomo-robot, con la testa che continua a vivere pur essendo staccata dal corpo. In seguito arriva il momento magico di E.T., creatura originale in cui confluiscono i tratti del giovane protagonista del film, del gatto himalaiano di Rambaldi e anche di una figura presente in un suo quadro del 1952; anche se per alcune inquadrature vengono utilizzati dei nani e un bambino focomelico, il personaggio di E.T. è «interpretato» da tre pupazzi: uno completamente elettronico con 85 punti di movimento (praticamente come il corpo umano) governato da un’ingombrante centralina informatica, uno completamente meccanico con 40 movimenti, uno misto con 60. Quanto al successo mondiale di un personaggio così «brutto», Rambaldi non ha dubbi: «E.T. è stato accettato non per la forma, bensì per la personalità, il che fa una bella differenza», la differenza che c’è fra l’indice e l’icona, fra la percezione dell’interprete e il transfert col personaggio, fra la bravura tecnica del burattinaio e la retorica poetica del narratore. La fantascienza digitale Se l’animatronica allude a un livello dell’informatica che sconfina dai simulacri del secondo ordine (il robot come equivalente fenomenico-funzionale dell’umano) ai simulacri del terzo ordine (il re-
160
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
SF & SFX. IL
RUOLO DEGLI EFFETTI SPECIALI
plicante come organismo autocosciente bioscientificamente progettato), lo fa invertendo il rapporto fra metafisica drammaturgica e tecniche di rappresentazione profilmica: è sempre un attore che interpreta il cyborg di qualunque generazione (Yul Brinner che in Westworld si autocita come il pistolero dei Magnifici sette, il Terminator a scheletro meccanico di Arnold Schwarzenegger, il Robocop in armatura prostetica, i replicanti e le replicanti di Blade Runner), mentre la tecnologia animatronica serve piuttosto a dar corpo a entità biologiche ma fantastiche e comunque non umane (King Kong gorilla fuori misura, E.T. alieno che impara l’inglese, Alien e «la cosa» entità metamorfiche per definizione). Il digitale allude anch’esso a un salto di livello, che riguarda però ciò che Nicholas Negroponte 11 descrive come il passaggio dagli atomi ai bit: appena si passa dal mondo direttamente esperito alla sua rappresentazione, non c’è più modo di distinguere l’immagine riprovisiva (che pretende di documentare il profilmico se non la realtà) dall’icona informatica (il cui carattere di similarità è completamente interno alla logica semiotica dell’assenza del referente). È per questo che il passaggio tecnologico dall’animatronica al digitale involge un cambiamento tematico dalla simulacralità del corpo (se mi commuovo per l’inesistente E.T., chi mi dice che la donna che amo non sia una replicante?) all’indecidibilità dell’intero universo del visibile (con un’estensione della celebre domanda di Ludwig Wittgenstein: «La mia telefonata a New York mi certifica che l’America esiste?» 12). Primo film a incorporare una minisequenza in computer graphics è considerato Tron (1982), un contemporaneo di Blade Runner ed E.T. che sconnette la fantascienza dalle sue classiche coordinate temporali (il film di Ridley Scott è ambientato in una California post-globalizzazione e post-effetto serra) e spaziali (anche il film di Steven Spielberg è ambientato sulla Terra, ma il Cielo rimane il referente antropo-religioso) per accettare la neonata poetica cyberpunk della virtualità: se la sacra sillaba Tron è il nucleo della parola «elettronica», il cronotopo della storia non poteva che essere il cyberspazio di un videogioco, metafora delle regole narrative e
11 12
Cfr. N. NEGROPONTE, Essere digitali, Sperling & Kupfer, Milano 1995. Cfr. L. WITTGENSTEIN, Della certezza, Einaudi, Torino 1978.
161
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
MARCELLO WALTER BRUNO
della paradossalità di qualunque mondo finzionale; cosa di cui si ricorderà Gabriele Salvatores in Nirvana, laddove sintetizza la poetica di Tron e quella di Blade Runner in un metafilm la cui cornice mistica è quella delle religioni orientali (o di Kurt Cobain?). Nonostante l’utilizzo d’immagini di sintesi in Star Trek II (1982) e Giochi stellari (1984), l’insuccesso di Tron sembra relegare la sperimentazione informatica ai cortometraggi d’animazione, anche se il decennio Ottanta si chiude con una magistrale performance della lucasiana Industrial Light and Magic per il film di James Cameron The Abyss: lo «pseudopodo d’acqua» – forma con cui si presenta l’entità aliena, prodotta da quella tecnologia a sua volta un po’ aliena che è la computer graphics di nuova generazione (legata allo sviluppo della geometria frattale) – non solo si muove con naturalezza nello spazio profilmico dell’inquadratura tradizionale, ma finisce con l’imitare il volto della protagonista femminile, chiarendo definitivamente il carattere speculare delle nuove infoicone. Superato infatti l’apprendistato di una produzione ex novo, assimilabile al vecchio cartone animato seppur con un’enorme capacità di elaborazione dei dati (cioè con un’automatizzazione del lavoro che porta il segno grafico dal fumettismo o pittoricismo tradizionale verso il fotorealismo o pittoricismo iperrealista), la CGI raggiunge le vere rive del digitale: quelle in cui la «convergenza tecnologica» (ritraducibilità di qualunque segnale in «dato informatico» numericamente trattabile mediante la potenza di calcolo dei nuovi computer) permette la manipolazione delle immagini di qualunque origine (dunque anche ottico-fotografica) e soprattutto la loro ibridizzazione. L’estetica cyberpunk è servita. Cameron e Spielberg sono gli araldi di massa della fantascienza digitale anni Novanta, secondo una progettualità neo-autoriale che vede nel regista non tanto il responsabile della drammaturgia quanto il demiurgo dell’innovazione tecnologica; anche se Cameron, spingendo fino in fondo il parallelo con Kubrick e con Lucas, finisce con lo scrivere le proprie sceneggiature ma anche col costituire la propria casa di postproduzione grafica (programmaticamente denominata Digital Domain). Terminator 2, ennesimo Oscar per gli effetti visivi a Dennis Muren, è un rifacimento di Terminator giocato sulla doppiezza tecnologica: Schwarzenegger, ormai simbolo di un di-
162
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
SF & SFX. IL
RUOLO DEGLI EFFETTI SPECIALI
vismo destinato a essere soppiantato dal nuovo star system dell’effetto speciale, è un cyborg diventato così «buono» da votarsi al suicidio; il nemico è un personaggio la cui capacità metamorfica è tutta giocata sulle possibilità di «trasformazioni a vista» che il computer regala all’ideologia baziniana del realismo ontologico, per cui adesso vale la nuova regola che ogni montaggio proibito è un effetto digitale riuscito. Jurassic Park comincia nello stesso parco a tema dove Michael Crichton aveva abbandonato i suoi robot di Westworld, solo che qui la cibernetica ha lasciato il campo alla genetica; se il cartone animato di Picchiarello spiegava i misteri dell’astronautica al pubblico di Uomini sulla Luna, qui il regista David Attenborough spiega la clonazione con l’ausilio della computer graphics, dopo aver dissolto il dubbio di un astante: «I personaggi che state vedendo non sono animatronics». Il mondo perduto rincara la dose del confronto intertestuale recuperando il primo titolo di Willis O’Brien (quello scritto da Conan Doyle) e dunque lasciando chiaramente intendere che Jurassic Park si colloca in una linea evolutiva rispetto alla quale la sua funzione innovativa è paragonabile a quella del King Kong di O’Brien; la polemica di Rambaldi contro lo stop motion si rivela improvvisamente inutile, perché l’animatronica si ritrova a ricoprire lo stesso ruolo archeologico nell’epoca della CGI ad altissima definizione, capace di riprodurre la stessa illuminazione del set. E l’ex specialista in stop motion Dennis Muren, diventanto il traghettatore definitivo del cinema dal fotogramma al pixel con Star Wars episodio uno, chiude gli anni Novanta (e dunque il secolo e il millennio) aggiungendo la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood. Ma il film che chiude davvero il millennio è Matrix, metafora definitiva del «delitto perfetto» che il virtuale ha perpetrato rispetto alla realtà: un hacker del 1999 scopre che il mondo che lo (ci) circonda è una simulazione prodotta dai supercomputer del 2099. Ancora una volta, ciò che l’estetica cyberpunk ricicla è il concetto dickiano di «mondi che cadono a pezzi»: se il cinema di fantascienza è in grado di dispiegare effetti speciali che rendono verosimile (fotorealistico) l’impossibile, perché mai il possibile (il reale) non potrebbe essere il prodotto di una tecnologia visiva (iconopoietica) ancora più avanzata? Nel mondo invertito di Matrix, il presente è un prodotto del futuro perché le tecnologie cinematografiche sono più
163
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
MARCELLO WALTER BRUNO
fantascientifiche del mondo che esse «rappresentano»: diventa finalmente evidente che non sono gli SFX al servizio della SF, ma che sono i contenuti narrativi a essere causati dalle possibilità del mezzo. Nell’epoca della softwarizzazione del referente, la realtà è un effetto speciale come tutti gli altri.
164
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
EPIFANIA DEL DIO VIRTUALE E SUA STRAORDINARIA SCOMPARSA di MASSIMILIANO SPANU
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
Cercherò di ripercorrere brevemente quella particolare trasformazione immaginifica e popolare, di contenuti e tecnologica che, attorno al 1980, avrebbe determinato il rinnovamento delle cosmologie narrative, dei pantheon e delle mitologie di classico riferimento in corrispondenza soprattutto dell’avvento di nuove tecnologie digitali che, con grande forza, investono anche il cinema. L’assunto di partenza mi proviene dall’affermazione di uno degli amici e maestri, Gianni Canova, a cui mi riferisco sempre con singolare attenzione e interesse vista la sua straordinaria capacità e lucidità interpretativa dei fenomeni e degli sguardi cinematografici del contemporaneo. Che in questo mio caso, per quella che è davvero una pura coincidenza (e naturalmente molto di più), riscopro e rileggo, mosso ancora una volta al suo pensiero e ai suoi scritti dal titolo di una relazione che, senza accordo o incontro alcuno tra noi, risulta assai simile: «epifanie dello spazio virtuale» per lui, «epifania del Dio virtuale» per me. Insomma, con un po’ d’immaginazione potremmo provare a scambiarci i titoli e fare la relazione l’uno per l’altro. Questo, naturalmente, sarebbe motivo di sicurezza per me, per lui non so quanto… L’assunto di partenza, dicevo, riguarderebbe quello che Canova chiama «paradosso scopico della virtualità» (gli invidio molto questa nettezza, questa precisione, questa sinteticità), e a proposito leggo un passo definitorio dal suo ultimo libro dove scrive: Quanto più le nuove tecnologie sviluppano ed estendono al massimo le facoltà percettive e connettive del corpo, rendendolo potentissimo in quanto soggetto scopico, tanto più il corpo stesso scopre di sentirsi inadeguato (o ininteressante) in quanto oggetto scopico, e cessa di fare di sé (e della costruzione della propria immagine) uno degli obiettivi prioritari della propria performatività visiva. Nel momento in cui può arrivare ovunque
167
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
MASSIMILIANO SPANU
e può vedere tutto, il soggetto scopico sembra perdere interesse per se stesso in quanto oggetto e assiste indifferente all’indebolimento del desiderio di afferrare la propria immagine 1.
Nelle corde di questo cinema di corpi in crisi, di corpi che spariscono, vibrerebbe forte anche quella del mettere in scena la propria «inevitabile residualità assieme alla sua tendenziale sparizione», cosa che per motivi che vedremo mi pare folgorante soprattutto se, come mi appresto a fare, le stesse riflessioni valessero per il concetto di «immagine digitale», o virtuale, invece che di «corpo». Sposterei l’attenzione, cioè, non sul corpo ma sul «suo sostituto», sul suo succedaneo digitale, sul simulacro che ne ha preso il posto innumerevoli volte. A queste considerazioni, per parlare di cinema della contemporaneità, andrebbe aggiunta l’attenzione al radicale cambiamento nella fruizione spettatoriale concretizzatosi nella nascita e crescita di una generazione figlia della televisione che vive i grandi e tutto sommato striscianti scarti culturali e tecnologici degli anni Settanta-Ottanta, in corrispondenza, poi, del potente sviluppo della cosiddetta Artificial Intelligence (spesso, e non a caso, confusa con la «realtà virtuale» che ne è prodotto straordinario e possibile), e che per quasi due decenni rappresenterà il luogo prediletto della narrazione fantascientifica specialmente, e fantastica in genere, del letterario (cyber) e dell’audiovisivo (il postmodern, ad esempio). Tanto, poi, da autorizzare nei filosofi, nei semiologi, nei sociologi e negli economisti che del periodo si sono occupati (da Baudrillard a Meyrowitz, da Postman a Harvey) espressioni e ricerche convergenti nell’affermare lo scarto di sguardo e visione, e motivare pienamente gli scritti che facciano addirittura riferimento a una «scienza della fantascienza» 2. «Qui parla Dio. State sconvolgendo l’ordine naturale delle cose, e verrete severamente puniti per l’Eternità!». «Quante volte te lo devo dire, Frank? Tu non sei Dio… Sono io!». «Scusa capo, dimenticavo!». Hollow Man (L’uomo senza ombra), di Paul Verhoeven 1 Cfr. G. CANOVA, L’alieno e il pipistrello. La crisi della forma nel cinema contemporaneo, Bompiani, Milano 2000. 2 Si veda, ad esempio, A. CARONIA, Le scienze della fantascienza, in «Biblioteca e territorio» n. 6, Prov. Milano 1982, oppure R. GIOVANNOLI, La scienza della fantascienza, Bompiani, Milano 1991.
168
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
EPIFANIA
DEL
DIO
VIRTUALE E SUA STRAORDINARIA SCOMPARSA
Visto che di un Dio (e di un demone) devo parlare, mi adeguo da subito, forzando un po’ – ma non troppo – il significato voluto dall’autore del termine che adopererò, e getto le basi per la mia personale «psico-storiografia» (o psico-storia, psychohistory per Isaac Asimov) 3. Psico-storiografia che trova l’anno zero proprio nell’epocale incidenza e coincidenza di e tra moderne tecnologie informatico-digitali e le derivanti, nuove capacità ottico-aptiche, linguistiche, e genericamente neuro-fisiologiche del cosiddetto «homo technologicus» 4. Se, come scrive Giuseppe O. Longo, evoluzione bio-culturale c’è stata; se appunto di «homo technologicus» dobbiamo parlare, e cioè di un nuovo «simbionte di essere umano e di protesi sensoinformazionale», allora facilmente deduciamo anche quella di un corpo e di una psiche diversi: non certo modificati nella loro essenza basilare, quella delle principali «valenze emotive ed espressive», ma senz’altro «in tensione di tipo coevolutivo tra fattori di profondo mutamento e resistenza e nell’inconsapevolezza di questa tensione» 5. A questa evoluzione sarebbe corrisposta anche un’evoluzione nel modo di pensare, vedere, sognare le cose (affermazione peraltro banale, ma per nulla scontata, e tutta da dimostrare). La relazione mirerebbe quindi a stabilire le fasi di esibizione dell’icona computergrafica, con il suo iniziale palesarsi come Dio eccessivo e potente, figurativamente concretato in forme mostruose, aliene o immani, in scena o fuori scena, presenti o alluse, per passare poi all’affermazione piena del Dio coincidente, tuttavia, con la sua stessa sparizione, cosa doppiamente sospetta e significativa proprio per la trasformazione dello stesso in un tutto. In Hollow Man (L’uomo senza ombra, 2000) di Paul Verhoeven (film odiosissimo, eppure di ottimi effetti speciali) l’eroina Linda McKay/Elizabeth Shue sussurra alla fine «Non Dio, non più ormai», quando Sebastian, l’uomo invisibile, lo scopritore della «transizione di fase bio-quantica» che fa sparire le cose, gli animali e se stesso, e che in virtù della propria genialità scherza sul proprio «es3 Cfr. I. ASIMOV, Cronache della Galassia, Il crollo della Galassia Centrale, L’altra faccia della spirale, Mondadori, Milano 1963-1964, e L’orlo della Fondazione, Mondadori, Milano 1984. 4 Cfr. G. O LONGO, Homo Technologicus. Tecnologia ed evoluzione, in «Nuova civiltà delle macchine», XIV, n. 1-2, 1996. 5 ID., Il nuovo Golem. Come il computer cambia la nostra cultura, Editori Laterza, Bari 1998, p. 102.
169
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
MASSIMILIANO SPANU
ser Dio», muore nell’ultima esplosione e fiammata. Quasi «si fosse fatto» fuoco dopo esser stato digitalmente visibile solamente se sotto l’acqua, o nel vapore, nel fumo o nel sangue per gran parte del film. Visibile già, quindi, ma «in assenza», o contrasto. Per dire queste cose parto da lontano, dal fumetto che tra le diverse forme di narrazione mi pare quella più innovativa e narrativa durante gli anni Ottanta, che maggiore ricaduta ha avuto sul cinema mainstream di quegli anni 6, campo scontatamente «tecnologico» per eccellenza e ovviamente prediletto della mia breve indagine. La caduta degli dei In dodici numeri, prodotti tra il 1986 e il 1987, Alan Moore e Dave Gibbons (nella versione italiana delle Edizioni Play Press, con Stefano Caldari al lettering e John Higgins ai colori) confezionano uno dei più grandi capolavori del fumetto di ogni tempo: Watchmen. Il fumetto illustra una nerissima realtà americana e parallela dove Bernstein e Woodward sono trovati morti in un garage. Conseguentemente Nixon è riconfermato per ben tre volte alla presidenza degli Stati Uniti, e il supereroe fascista detto «il Comico», uomo tanto generoso quanto autore di efferatezze varie in Vietnam, è defenestrato da un grattacielo e si sfracella malamente sul selciato; il suo ex-compare, un tedesco che si fa chiamare Rorschach (psicolabile, sessofobico e solitario che si nasconde dietro la maschera con le 6 Ricorro, senza cercare troppo in giro, a una cronologia assai intelligente e attenta, firmata da Lorenzo Codelli per Storia del cinema mondiale. Gli Stati Uniti II, Giulio Einaudi Editore, Torino 2000; dal 1982 al 2000 alcuni film chiaramente debitori per modi, tempi, all’estetica cartoonizzata o fumettara di cui si è detto, mi paiono: Raiders of the Lost Ark di S. Spielberg; Blade Runner di R. Scott; The Twilight Zone. The Movie; The Evil Dead di S. Raimi; Ghostbusters di I. Reitman; A Nightmare on Elm Street di W. Craven; Back to the Future di R. Zemeckis; Pee-Wee’s Big Adventure di T. Burton; Luxo Jr di J. Lasseter; Innerspace di J. Dante; Who Framed Roger Rabbit di R. Zemeckis; Batman di T. Burton; Dick Tracy di W. Beatty; Edward Scissorhands di T. Burton; Barton Fink di J. Coen; Reservoir Dogs di Q. Tarantino; Bram Stoker’s Dracula di F.F. Coppola; The Crow di A. Proyas; Tim Burton’s Nightmare Before Christmas di T. Burton; Pulp Fiction di Q. Tarantino; Toy Story di J. Lasseter; Strange Days di Kathryn Bigelow; MIB di B. Sonnenfeld; A Bug’s Life di J. Lasseter; The Matrix di L. e A. Wachowski; Fantasia 2000 di J. Algar P. e G. Brizzi; Final Fantasy di H. Sakaguchi; e X-Men di B. Singer.
170
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
EPIFANIA
DEL
DIO
VIRTUALE E SUA STRAORDINARIA SCOMPARSA
omonime macchie) è un folle giustiziere e giustizialista a qualsiasi costo, che cerca di capire cosa stia accadendo ai vecchi supereroi e che finisce disintegrato per la buona sorte del mondo intero. Il dottor Manhattan, il disintegratore, l’uomo azzurro di tachioni e neutrini che in un primo momento scompare su Marte disinteressato ormai alle miserie terrestri, è pur pronto a tornare quand’è il momento. Lui che da superuomo si è fatto divinità, capace com’è di essere pura energia creatrice (o distruttrice) e demiurgo, addirittura entità disposta sincronicamente in ogni dove e in ogni tempo, come Dio torna sulla Terra per prendere fondamentali decisioni da uomo (anche, e pessimamente, da politico). In Watchmen il nuovo che viene è ovviamente un altro «super», Adrian Veidt, il multimiliardario e tecnocrate delle Veidt Industries, l’eroe capitalista della ratio riordinatrice di fine millennio, fine e sapiente scienziato, artista e comunicatore (sempre all’insegna di un bizzarro neo-neoclassico tradizionalista e arcadico che lo vuole simile a un Apollo: tanto luminoso ed integralista quanto disumano). Veidt si informa e studia la complessa realtà dei nostri giorni attraverso centinaia di schermi televisivi. Si definisce un Rameses reincarnato, l’Ozymandias, il re dei re cantato da Mary Shelley. Insomma, un nuovo semi-dio che per salvare il mondo non esiterebbe a distruggerlo. Sui muri dei vicoli e dei palazzi di questa America iperscrutata televisivamente, avente più facce e maschere, in un universo densissimo di significati e segni, di dei nuovi e mitologie del passato, in un mondo diegetico che si manifesta anche per mezzo di lettere, di bollettini di società ornitologiche o di verbali di arresto, di cartoline d’amore e di pagine di un qualsiasi giornale destrorso e in ciclostile (in una frantumazione vertiginosa di punti di vista che al suo apparire in Italia meritò l’introduzione di Alberto Abruzzese), improvvisamente questa stessa America molteplice rivela, tra tanta e tale oggettualità e gettatezza e magari solo di scorcio, gli anonimi graffiti che s’interrogano sul quesito fondamentale di ogni società democratica, quello innescato dal libro sesto delle Satire di Giovenale: «Quis custodiet ipsos custodes?», «Who watches the watchmen?» (da cui il titolo dell’opera). Qualcuno dei custodi di un tempo, infatti, è nel pieno del suo sporco lavoro, e sta progettando e realizzando il ripristino di un ar-
171
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
MASSIMILIANO SPANU
tificioso e delicatissimo ordine mondiale basato sull’immagine catodica, sulla sua rinnovata percezione, sul sangue e la paura. Un ordine elettronico, dunque, che si avvale di mostri inconsci; il Nuovo attraverso i Grandi Antichi. Il nuovo equilibrio non prevede un posto per i custodi e i valori di un tempo, per i supereroi classici (tutti più o meno sconfitti, invecchiati, afflitti da qualche stato melanconico o nostalgico, sentimentaloide e patetico, perverso o patologico della psiche, alcuni conservatori se non fascistoidi, altri scriteriatamente progressisti – questi ultimi, alla fine, non meno irregimentati, ideologici, grotteschi dei primi). Accade qualcosa di simile nella postmodernità steampunk in genere: si pensi, ad esempio, a The League of Extraordinary Gentlemen di Alan Moore, che mette in scena tutti i grandi eroi della letteratura angloamericana, dal capitano Nemo al nonno di Bond, Campion; da Allan Quatermain a Jeckyll/Hyde, da Mina Murray a Dupin, dove il Regno Unito può cadere in mano a potentati criminali di stampo massonico, magari con Moriarty accanto alle antiche triadi cinesi: in questa stessa pseudo-modernità letteraria e apocrifa che sembra riempire di sé tutta la visionaria, iconoclasta British invasion fumettara degli anni Ottanta-Novanta, la critica sociale e il revisionismo politico sembrano di comune fattura, conseguenza prima di una evidente inadeguatezza culturale, aggredita artisticamente in virtù di una convinta adesione ad ideali più volte vagheggiati di anarchia politica e creativa (quelli di Grant Morrison, o di Neil Gaiman, mi paiono di provenienza libertaria e antideologica, psichedelica, esoterica addirittura perché umanista, nel rifiuto di ogni istituzione religiosa, politica o militare opprimente). Si tratterebbe di un’inadeguatezza emblematizzata, colta nei suoi aspetti grotteschi più evidentemente e tipicamente deteriori, tra tutti proprio quelli risibili, e per l’appunto «comici» («il Comico», appunto, è da buttare giù da una finestra…) incarnati nei superuomini vecchio stampo. Se poi le stesse considerazioni si possono fare a proposito d’innumerevoli testate e firme non meno famose 7 degli stessi anni (The 7 Dal The Preacher, storia di un prete angelicato e diabolico assieme che controlla il verbo di Dio, realizzato da Garth Ennis e Steve Dillon; al Sandman, il modellatore dell’inconscio e dei sogni di provenienza celtica e tuttavia sconfitto nell’unico
172
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
EPIFANIA
DEL
DIO
VIRTUALE E SUA STRAORDINARIA SCOMPARSA
Preacher, Sandman, The Dark Knight Returns) ciò che si evince chiaramente è la svolta non solo artistica ma storica, economica e linguistica (storica ed economica «proprio» perché linguistica). Vi si celerebbe, prima di tutto, un’evidente svolta culturale, che propone valori, ritmi, segni e immaginari che si attestano produttivamente attorno a marchi specifici e indipendenti, alla fine della prima metà degli anni Ottanta, e che trova estremi paladini del comicdom (quelli stessi che poi hanno impregnato di sé Hollywood nel 2000) in protagonisti liminali, eccessivi, folli, anarcoreazionari, militaristi o totalmente schizofrenici: come, ad esempio, Foolkiller e The Punisher – ma potrei dire, uno per tutti gli altri, anche il John Constantine di Hellblazer, che al cinema sembra sarà interpretato da Nicolas Cage: che è mago, alcolista, puttaniere, fumatore incallito, scommettitore, brav’uomo e demonio assieme. Diversità Negli anni di questo sotterraneo ribollire di capacità e fantasie fumettistiche, tra le reganomics, la Thatcher, le star wars – il programma di svariati miliardi di dollari per la guerra nello spazio, non il film – gli immaginari sembrano dissanguarsi prima di riesplodere. Negli anni Novanta si ricorre sempre più frequentemente al demonico, al vampirizzato (Intervista col vampiro di Neil Jordan, Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola), all’esangue e al rappezzato (dai vari Frankenstein Unbound di Roger Corman, o Frankenstein di Mary Shelley di Kenneth Branagh, sino a Frankenweenie o Nightmare Before Christmas di Tim Burton). Come dice Canova, i corpi si fanno «agonici». All’inizio degli anni Ottanta i Bauhaus, per voce del loro leader Peter Murphy – che allora sembrava il Sandman di oggi perché Gaiman s’ispirò al suo volto – cantano le profondità e le ricchezze delamore della sua vita, a firma di Neil Gaiman; o anche al The Dark Knight Returns, dove il Batman di Frank Miller e Klaus Janson è ancora animato dal vecchio Bruce Wayne, miliardario al di là del bene e del male, del giudizio dei conservatori più aspri e degli psicologi/psichiatri televisivi, dei politicanti delle università e dei sit-in o dei commentatori in doppio petto e cravatta regimental.
173
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
MASSIMILIANO SPANU
l’anima, la passione, il sangue e la morte degli amanti, inaugurando potentemente le atmosfere gothic, o come si diceva allora glittering dark, postindustriali e vagamente neoromantiche di vampirismo urbano, di tribalismo aristocratico e anarchico assieme, di sensualità underground che torna in tanta musica e cinema fantastico degli anni immediatamente a venire (dai Batman di Tim Burton a The Hunger di Tony Scott, film che addirittura vede la band inglese in cameo suonare nel locale «Heaven»; da The Crow di Alex Proyas sino all’ultimissimo From Hell dei fratelli Hughes…). In questi anni, in verità assai revisionisti e «post», proprio il già citato Foolkiller, uno dei più entusiasmanti antieroi di palingenesi morale e ideologica in cui sia stato possibile incappare, fa capolino in ambito Marvel: è l’«insanicida», l’uccisore dei folli, degli sbandati, dei balordi, dei poveracci, denunciando la patologia di un paese «in ostaggio della malattia che lo infesta – non la gente di sinistra o il crimine […] ma un paralizzante autoinganno» 8. Foolkiller uccide i pazzi, espressione com’è, egli stesso, di una follia assai diffusa, ed anzi, trascendente (si pensi anche a Shade, psichedelico eroe di Milligan, Bachalo e Pennington, costantemente alle prese con la «follia americana» intesa come forza oscura e caotica capace delle peggiori e malevole concretizzazioni). In questa sotterranea rivolta fumettara e immaginifica degli Eighties anglosassoni e americani, a momenti sconfinanti nella più radicale delle dichiarazioni di sconfitta (Robin e Superman muoiono; Batman, ormai entrato nella senilità e in odore di pedofilia, può finire anche al manicomio con i suoi stessi folli avversari, come capita in Arkham Asylum; Iron Man finisce su una sedia a rotelle; qualcun altro addirittura muore di aids, o si droga…), si nasconde una vera rivoluzione copernicana, e il più profondo degli sconvolgimenti ideologici e formali nell’avvertire il mondo. Il pantheon supereroistico moderno e di riferimento, quello degli anni Sessanta, va in soffitta e il racconto si rivolge a temi del passato ancestrale, all’esotico, all’uomo e alle sue infinite profondità interiori e spirituali. La contaminazione, l’ibridazione, il recupero seriale, il cross-over, il rap e l’hip hop, e poi la parodizzazione, il remake, il meta e il bozzetto gore diventano modalità, forme, culture di una crisi e di una efferve8
«Il Punitore», anno III, giugno/luglio 1991, n. 24, p. 60.
174
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
EPIFANIA
DEL
DIO
VIRTUALE E SUA STRAORDINARIA SCOMPARSA
scente, nuova vivacità del raccontare (e del protestare la propria differenza, e stanchezza, il proprio vuoto, il disagio) che influenza ogni medium. Se in letteratura e in musica si guarda evidentemente al microcosmo etnico e postcoloniale, a momenti televisivo, a momenti cinematografico e spirituale allo stesso tempo – ad esempio quello di Tutuola (non a caso My Life in the Bush of Ghost, oltre che bellissimo romanzo di successo, diverrà anche una delle opere più significative e anticipatrici di David Byrne e Brian Eno) o a quelli di Ondaatje, di Ghosh, di Chandra, di Rushdie – il fumetto e il cinema da parte loro rivoluzionano i propri sistemi «cosmogonici», regalandocene alcuni di nuovi e di efficacissimi, come quello degli «Endless», degli Immortali (sono Desiderio, Destino, Disperazione, Delirio, Sogno, Morte e Distruzione) in Sandman Master of Dreams. La serie di Gaiman si rifà alle entità eterne della fiaba, della letteratura tradizionale e del racconto mitologico e religioso di ogni provenienza indifferentemente, rileggendo e filtrando ogni cosa attraverso la lente postmoderna del lisergico e del postorganico, del cyber o del New Age. Scrivere di e nei sogni, dunque. Affermava a questo proposito Jay David Bolter: «L’intelligenza artificiale è l’arte di programmare il computer a “scrivere sulla mente”» 9. E di fatto, la centralità, la divinità della visione, l’aesteadycam, i punti di vista impossibili, l’angelizzazione e la divinizzazione dello sguardo del nuovo cinema (fatto, non a caso, di Corvi, di Terminator, di Ghosts, di «morti-vivi» e «vivi-in morte» in una complessiva crisi del paradigma dello sguardo classico, ove cioè, in una generica compresenza, è andata persa ogni distanza dall’oggetto) ci guidano a ciò che Elémire Zolla chiama «Quarta dimensione» (in qualche modo il self) che nella realtà virtuale si fa addirittura visibile, interagibile, e che altrimenti Derrick de Kerckhove intuisce come cocooning, letteralmente «una metafora tecnologica dell’implosione del mondo tecnico su se stesso e sul corpo fisico». Sempre Bolter: in qualità di nuova tecnologia di scrittura, il computer diventa un’ulteriore metafora della mente. Con l’aiuto del computer, colui che scrive co9 J.D. BOLTER, L’intelligenza artificiale, in Lo spazio dello scrivere. Computer, ipertesti e storia della scrittura, Edizioni Vita e Pensiero, Univ. Cattolica, Milano 1993, cap. IX, p. 217.
175
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
MASSIMILIANO SPANU
struisce il testo come rete dinamica di simboli verbali e visivi. Questi simboli elettronici posti nella macchina paiono costituire una estensione della rete di concetti presenti nella mente stessa. Più efficacemente del codice e del libro a stampa, il computer riflette la mente intesa come trama di elementi visivi e verbali disposti entro uno spazio concettuale 10.
Guardando dentro di sé, estroflettendo fuori il dentro e materializzandolo in mondo, tra le metafore di scrittura «nella» mente di Socrate e Platone, arrivano nel 1994 The Invisibles, eroi psichedelici pre-Matrix, capaci di mettere assieme Arcadia e De Sade, Baron Samedi e Mahabharata, Giuliano, Maddalo e Jack Frost: potentemente saccheggiati dai Wachowski (motivo per il quale Grant Morrison intenterà prima una causa multimiliardaria, e poi abbandonerà il marchio DC), con Shade, Swamp Thing, e Hellblazer rappresenteranno il luogo letterario della grande rinascita di un innerspace esteriorizzato, essendo fumetti di tradizioni e mitologie, d’ipnagogie, esoterismi e magie, di poesia e pop art. Mi pare si possa azzardare, dunque, che qui nasce il cross-over mitologico, demonico di cui letteratura postmoderna, musica e cinema faranno patrimonio nell’ultimo decennio del millennio; che il «si sente» dionisiaco-virtuale e apollineo-televisivo, postumano, postorganico (e nietzschiano), quello tipico da fumetto anni Novanta (quasi si facesse immagine da nobilissimo storyboard che era), si metta qui in immagine-tempo e movimento. In un cinema che potremmo dire «di Turing», parafrasando la famosa definizione di Bolter. Il grande dentro, dunque «La televisione è Dio!». Alex, tredici anni
In questo sotterraneo, mitologico, magmatico e comune «grande dentro» di stelle e strisce (disegnate, o di pellicola, o di bande sonore, di nastri magnetici), che sarebbe da supporto a un testo e al10 Ivi, in Scrivere la mente, Edizioni Vita e Pensiero, Univ. Cattolica, Milano 1993, cap. XI, p. 263.
176
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
EPIFANIA
DEL
DIO
VIRTUALE E SUA STRAORDINARIA SCOMPARSA
l’immaginario postmoderno di questi anni, in un «dentro» che almeno audiovisualmente – l’abbiamo visto, non nel fumetto – qualcuno dice esser «privo di profondità» (e a guardare l’ultimo capolavoro rizomico e di cognitive overload che è Mulholland Drive di David Lynch verrebbe da rispondere che l’affermazione è smentita nei fatti), trova sviluppo il nuovo modo di raccontare, di mostrare, di esibire smaccatamente il digitale, ad ogni costo, anche in assenza di una storia (basta ricordare i film di primo hackeraggio giovanilistico, di fallimentare contrapposizione al sistema «adulto»: da WarGames (1983) di John Badham, a Brainscan (1994) di John Flynn, o Hackers (1995) di Iain Softley, quelli sì davvero «bidimensionali»…). Il demone digitale, il divoratore di storie, nasce dalla disillusione nuova e feroce e dal disagio culturale che ha messo in grave difficoltà anche i grandi maestri a cavallo tra generazioni e cinema diversi, sospesi tra la new Hollywood (Francis Coppola, Martin Scorsese, Jonathan Demme, Robert Altman) e la new new Hollywood (Steven Spielberg, George Lucas), o tra quest’ultima e le nuovissime generazioni di autori figli della televisione e del fumetto, del cartoon e del videoclip (come Tim Burton, Paul Verhoeven, new new new secondo Vito Zagarrio). Eppure quella ludica e disincantata voglia di sprofondare in sé, di rifugiarsi all’interno, in coincidenza di un nuovo neo-tribalismo, di un neo-hippismo immaginifico, della rivisitazione delle culture altre in virtù non di un nuovo interesse antropologico, ma di accettabili e inedite radici (roots bloody roots, secondo lo slogan urlato qualche anno fa dalla band brasiliana dei Sepultura), pare descrivere solo la fase più interessante della parabola narrativa cinematografica, quella che abbandonata la fase della ricerca e dell’estetica baracconesca dell’effetto per se stesso, mirante all’ipnosi degli occhi e dei sensi, all’accecamento quasi, ha raggiunto prima gli spazi «dischiusi aperti» dell’inconscio, delle menti bizzarre (di scrittori, psichiatri, assassini, anchormen, bambini traumatizzati, programmatori e videogiocatori, o computersDei, da Videodrome a Barton Fink; da The Naked Lunch a The Cell; da The Sixth Sense a The Matrix, da The Fisher King a eXistenZ), per tornare infine a concentrarsi sulla propria natura di dispositivo, sullo specifico versante linguistico e codicale, aggredito con particolare determinazione autoriale, attestandosi magari su quello prediletto, quello spettatoriale e fatico dell’uomo che guarda in sala.
177
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
MASSIMILIANO SPANU
In tal senso, fatte salve le solite, nobili eccezioni che confermano la regola – il Kubrick di Shining, ad esempio, aveva già nel 1980 disposto con somma abilità il proprio cerebro cinematografico nei saloni e lungo i corridoi dell’Overlook Hotel (e in tal senso, ad esempio, Barton Fink di Joel Coen, del 1991, è direttamente debitore di quel film) – bisogna rilevare che proprio intorno agli anni Ottanta, in corrispondenza di questa ricalibratura «deistica», immersiva e interiore (concetto abusato che proviene da Jullier) parte l’avventura dell’«infoicona». Come il Dioniso invadente di parousìa in Le Baccanti di Euripide, che prima di farsi Dio è personaggio in scena e portatore di maschera, che reca con sé felicità e distruzione, il Dio virtuale induce a una trance, o alla manìa. Non riconosciuto dall’inizio in quanto spirito (è questa la causa della tragedia di Penteo con Dioniso), il dio-demone virtuale si cela inizialmente tra le tute bordate fluo di Tron, o nel giroscopio gigante e la grafica soggettiva (tipo Doom, o Duke Nukem prima maniera) della realtà in cui è trasferito Jobe in The Lawnmower Man di Brett Leonard; lontano assai da quel che sarà presto, il digitale divoratore di corpi e di realtà nel cinema contemporaneo, e nel film di Steven Lisberger appariva già come «Master Control Program» e pure aveva un suo volto umanoide. Appariva fragorosamente, in effigie (siamo ben lontani dalla scelta simbolica, di codice e borgesiana della cascata di caratteri di The Matrix) e scompariva altrettanto velocemente, in una velocissima obsolescenza tecnologica; tant’è che a rivederlo, oggi, fa sorridere per la tenerezza, quel volto schematico e spigoloso. In quel film e in quei lineamenti «sintetici» era già scritto un incipit importante, il destino del Dioniso digitale che dalla Silicon Valley scendeva a Hollywood, la cui volontà di far sbranare la realtà fotografica dalle sue Menadi, con la tensione all’apparire diegetico, in un’epifania che consenta agli spettatori la propria rivelazione, scontava comunque e già allora la propria manifestazione e colpa principale, quella di trascendere e di essere assorbito allo stesso tempo, di essere deus ex machina, segno, significante, referente, esistente e personaggio, eppure «ininteressante» (come dice Canova di quei corpi), in virtù proprio di una dimensione assai più ampia, potente che lo avvolge, quella complessivamente «narrativa» che lo comprende con i suoi sogni (quan-
178
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
EPIFANIA
DEL
DIO
VIRTUALE E SUA STRAORDINARIA SCOMPARSA
do non trascesa del tutto, in azzardi senza avvenire). Sandman, il signore dei sogni, degli incubi, della memoria e delle illusioni, padre e ispiratore di Calliope, di Orfeo, di Ottaviano Augusto, di Shakespeare, non a caso è tra tutti gli dei, tra tutte le divinità di diversa tradizione, il più potente: quello a cui l’angelo più bello, il demonio che se ne va, ha ben lasciato le chiavi dell’inferno (accade nella serie intitolata Season of Mists, n. 21-23, 1990-91). Il passo successivo fu, quindi, quello dell’avviarsi dell’«infoicona» verso un superiore spessore fotorealistico, nella sua più profonda aderenza alla realtà rappresentata, capace di una migliore fascinazione sullo spettatore e in virtù di una straordinaria potenza di calcolo ottenuta attraverso la riduzione a pochi micron (0,15) per microchip. Non cambiano le cose, se non che il dio-demone di cui sopra tende attraverso il «micro» a farsi mondo, molteplicità, legione ingannevole. A un monoteismo iconoclasta si sostituisce un politeismo di immagini, disordinato, ridondante, privato di memoria, di «oblio» (perché «il demonio arreca grandi danni alle anime che fanno molto uso della memoria», ricorda Giuseppe O. Longo). Tale politeismo afferma la parvenza, il simulacro invece del Dio stesso. In un film già nostalgico, di computergrafica divertita e per certi versi superflua 11, Mars Attacks!, Burton poteva ricordare i vecchi, amati mostriciattoli delle figurine Topps, e farne cinema. A un primo utilizzo dell’«infoicona», atto alla caratterizzazione dell’immagine nei termini dell’illusorietà, l’immagine infografica – come dice Philippe Quéau – definiva quindi la simulazione del reale attraverso l’astratta operazione matematica sottintendendo, attraverso l’algoritmo e la programmazione informatica, la rappresentazione di una «assenza»; successivamente sarà possibile ipotizzare visivamente il contatto, l’utilizzo del trucco spettrale e fantasmatico con il quale finalmente «interagire» (magari nell’inconsistenza digitale del liquido), come succede nel 1989 nel bellissimo The Abyss di James Cameron. A questa fase corrisponde tecnologicamente, è evidente, una fase evoluta di interazione sensoriale uomo-macchina (tematicamente fu pioneristi11 È cosa nota che Burton vagheggiasse l’ipotesi dello stesso Mars Attacks! presentato nei cinema anche nella sua versione senza la postproduzione di effetti speciali digitali.
179
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
MASSIMILIANO SPANU
co, già nel 1983, Brainstorm di Douglas Trumbull) tale da consentire la decifrazione del reale attraverso processi simulativi, o mappe cognitive, dove il virtuale si faccia lato astratto della nostra comprensione del mondo. L’estremizzazione del tema, ovviamente, fu proprio nell’intendere «cinematograficamente» il virtuale come lato realistico della nostra comprensione del mondo… Ci si muoveva, quindi, verso l’inglobamento complessivo di esistenti, verso la costituzione di un metamedium (nota definizione di Gene Youngblood) 12 capace di fagocitare e di appropriarsi degli altri, verso un potenziamento del dio-demone che cercava il tramite della carne per emergere dal nulla (in «macro» ciò che Proteus aveva sperimentato nel microuniverso, all’interno invece che all’esterno di una casa, dove il suo hardware è accolto fisicamente quand’è alla ricerca di una figliolanza, in Demon Seed di Donald Cammell). La tecnologia e l’interfaccia si sono fatte user friendly, miniaturizzate, si sono rese portatili o definitivamente casalinghe. L’ambiente d’interazione è sempre più tecnologicamente avanzato e a misura d’uomo; nell’innerspace si può sprofondare attraverso il viaggio di film 3D come Seafari, Endless Summer, Space Shuttle America o Jurassic Tour, tutta roba immersiva che ci fa «corpi-scafandro» (Canova) e che oggi fruiamo al Luna Park, o in speciali FX-theaters. Il virtuale, il cyberspace, è pervasivo, interagente con noi attraverso veicoli 3D, ma anche protesi «aptiche» tipo penne ottiche, lettori, touchscreen, joystick, joypad… gamepod (eXistenZ). Perde significato la differenza dentro/fuori (Johnny Mnemonic, 1995, di Robert Longo; Nirvana, 1997, di Gabriele Salvatores), di se stesso e di se stessi in quanto proiettati (per mezzo di tecnologie dette third person, o projected, dove l’utente vede la propria immagine proiettata su schermo ma interagente con un mondo virtuale), e si inizia a parlare di «Computer Augmented Reality» (CAR), di reale più del reale stesso, anche nel racconto. La visione si colloca nella mente attraverso gli occhi: prima è parzialmente immersiva, attraverso i cosiddetti caschi see trough, dotati di head mounted display, dove la grafica di sintesi vada a so12 G. YOUNGBLOOD, Cinema elettronico e simulacro digitale. Un’epistemologia dello spazio virtuale, in R. ALBERTINI, S. LISCHI (a cura di), Metamorfosi della visione. Saggi di pensiero elettronico, ETS, Pisa 1988, p. 33.
180
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
EPIFANIA
DEL
DIO
VIRTUALE E SUA STRAORDINARIA SCOMPARSA
vrapporsi alla realtà circostante in campo visivo (soprattutto in campo militare e aereonautico); poi totalmente, come capita a chi visiti e viva l’esperienza dello squid in Strange Days, o a chi sperimenti quanto approntato – come si fosse immersi in un Dio liquido – dal computer sul ponte ologrammi di Star Trek. «The dream is always running ahead To live for a moment in unison with it, That is the Miracle». Anaïs Nin, e slogan della Flyng Cam
La terza tappa rappresenta la scomparsa straordinaria del Dio, che si fa anima mundi in una complessiva fantastizzazione del racconto di ogni genere e provenienza. Da una parte eXistenZ di David Cronenberg e The Matrix dei Wachowski Bros.; dall’altra Toy Story, Bug’s Life, Shreck, o Monsters & Co. che, per modalità comuni, sono film che segnano la trasformazione del Dio in Natura e la sua scomparsa attraverso la sua sustanziazione nel tutto: da una parte l’inganno e la maschera del Dioniso sono avvertiti in extremis da un Penteo contemporaneo, Neo, che conosce o intuisce la fallacità completa dell’esperienza di vita che lo riguarda (alla verità, eventualmente, lo conduce Morpheus). Dall’altra, si mette in moto una chiara tensione all’omologazione di segni umani, animali, e digitali, quasi fosse fortissima la possibilità di sedurre nell’estroflessione dell’Id nel mondo. Della psico-tecnologia in questione i bimbi e gli adolescenti sono primo, favorito bersaglio. Infatti, negli anni Novanta, le majors americane cercano di creare o di stabilire sinergie operative con le industrie cosiddette «quaternarie» di servizi e prodotti informatici ed elettronico-digitali: Matsushita/MCA, Paramount/Viacom, 20th Century Fox/Fox Inc., che si dedichino alla realizzazione di prodotti da avviare sul mercato del videogame o dell’edutainment tratto da film. Il risultato finale, il punto di ulteriore svolta, può essere Final Fantasy, di Hironobu Sakaguchi, ma la direzione è piuttosto segnata dall’ultimo visionario Vidocq di Pitof. Se in Final Fantasy il chiaroscuro visivo non esiste, perché il film si è fatto interamente ombra sintetica, in un simulacro perfettamente videoludico, Vidocq, interamente girato e montato in digitale, si colloca tra il teatro ottico, quello d’ombre, o il diorama e il fumetto artistico, uno spot di
181
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
MASSIMILIANO SPANU
Gaultier, le litografie e gli inchiostri d’epoca. Nel film di Pitof (che viene dalla pubblicità) l’Alchimista è il demone avversario dell’eroe del titolo, il Vidocq interpretato dal massiccio Gerard Depardieu, e pure lo racconta «essendone il biografo». L’alchimista «è divenuto» le sue stesse vittime, il loro e il nostro mondo angosciante che nel suo volto si specchia, perché indossa la maschera che è superficie riflettente, che del loro sangue si nutre, e delle anime che sono nei lineamenti stravolti delle vittime. Il mondo rimane, sino alla frantumazione finale, in quel vetro soffiato, insufflato con l’anima delle figlie del popolo comprate a due soldi. Così come i vicoli del rione del Tempio, i postriboli, i teatri osceni, le fumerie d’oppio, che passano per le mille lenti, per i vetri, per gli occhiali, le tende, i velarini e gli stracci o i panni bianchi a far da schermi e quinte, ogni cosa è racchiusa nel guardarsi (digitalmente). Rutilante, assordante per immagini e illiberale (nel suo essere perfettamente filtrato ai toni seppia, ai marroni e neri plumbei che fanno Rivoluzione francese e Resident Evil, tanto da costringere alla visione, da obbligarci alle cartoline d’inferno della Parigi preindustriale), Vidocq affronta il Dio apparentemente invincibile, presenta l’invisibilità dietro lo specchio, decide di condurre l’indagine in assenza, perché muore nelle prime scene. Accadeva qualcosa di simile al protagonista del bruttissimo Hollow Man di Verhoeven, quando si poneva dinanzi alla superficie riflettente. La realtà non è più, e il cerchio si chiude: l’uomo si è fatto digitale, e il digitale (definitivamente, nella sua ormai completa analogia a vita, pelle, peli, capelli, umori, carne) molteplice textura perfetta (e proprio per questo motivo, ancora una volta, segno, testo, oggetto dello scrivere del biografo, del giornalista imbrattacarte, del poliziotto – tutta gente che scrive molto, in Vidocq). L’imperfetto, lo sporco, il consunto e il vecchio, invece, sono rassicuranti, vita pur nel suo ludibrio di umori, di sangue, di pelle, nella sporcizia o nel tanfo (i pubblicitari, ancora alla ricerca di anàlogon perturbanti, ma tutto sommato rassicuranti, lo sanno bene). Il piccolo sommovimento surreale di Il favoloso mondo di Amélie è poesia videoclippata delle piccole cose d’amore, dei buoni sentimenti riappacificanti e di ottimo gusto, ma anche lì non c’è ritorno. Ripensando la battuta del vecchio, ma sempre bello e non datato The Professionals, «la rivoluzione è», ancora e per fortuna, «una baldracca»: per poco
182
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
EPIFANIA
DEL
DIO
VIRTUALE E SUA STRAORDINARIA SCOMPARSA
ancora, perché sempre più patrimonio di una carne cinematografica sostituita (ah! la Cardinale, che donna…) che è ultimo gladiatore nella videoarena della realtà digitale, almeno sino dai tempi di Videodrome. La carne, e i corpi di Canova, sono davvero l’ultima discriminante a questo capolinea paradisiaco o infernale che è nel digitale. Perché, purtroppo, questa è realtà che tende irresistibilmente e infinitamente a sdoppiarsi e sostituirsi – nel suo freddo orrore di peli e smagliature, e nell’arida voluttà di siliconi, protesi, corpi glabri, posture da manichino –; che tende al proprio fantasma, al desiderio astratto, alla propria utopia dionisiaca che passi anche per una de-concretizzazione spietata, mortalmente apollinea. Così è quasi ovvio che al centro del Male, in The Lord of the Rings di Peter Jackson, ci sia un grande «occhio-vagina» fiammeggiante di nero che insidia Frodo. «Choose Yourself Your Dream A Reality Tu sueño, una realidad». Paloma Navares
Ripenso, infine, anche all’occhio di Kinoglaz, a quelli di Ballet mécanique, a quelli famosissimi perché violati, tagliati, feriti (Bronenosec Potemkin, Un chien andalou, L’âge d’or), ai mille occhi del cinema, e sento con un brivido e senza riuscire a resistervi, tutto questo neoavanguardismo dell’immagine de-ideologizzata, questa rivisitazione neoclassica, neobarocca o neorococò, insomma «neo» o «post», che sa di industrial-chic, di roba reazionaria, di formaldeide, con le sue pubblicità per riviste patinate di moda, dove dal fotoritocco si è passati alla «sintetizzazione» della figura umana («artificialità» mi proviene da artisti come la Paloma Navares degli Implantes, e dalla campagna della Diesel articolata attorno a messaggi tipo «Stay Young – Discover how you can stay looking young and beatiful forever») sino alla costruzione della modella di sintesi, orribilmente posticcia e bellissima, finta del tutto (per Triumph International) e reale in ogni pixel (Micha Klein); sento questo filtraggio e la perdita del referente, quasi fosse ormai totale il controllo elettronico, alla Veidt, e divino l’occhio assoluto sulla realtà e sull’immagine, degno appunto della divinità (alta o bassa) che di-
183
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
MASSIMILIANO SPANU
sinteressata ha consegnato le chiavi del Paradiso e dell’Inferno e se ne è andata, magari su Marte… Noi, con le nostre immagini, siamo insetti serrati nell’ambra, resina preziosa, divina addirittura che in greco si scrive elektron. E – mirabile gioco di specchi nella maschera del Dio alchimista – ci piace la nostra collezione di lepidotteri.
184
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
«WHERE AM I?» GLI INCERTI EPILOGHI DELLO SGUARDO E DELL’IDENTITÀ NELLA SF HOLLYWOODIANA CONTEMPORANEA di MICHELE FADDA
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
L’interrogativo esistenziale del titolo – sia subito detto – ha molto di umano, ma è pronunciato da qualcuno che, almeno in apparenza, non ha nulla di umano. Il grido di dolore fu lanciato mezzo secolo fa da un umanissimo personaggio di un cartone animato, ma la sua domanda è ancora attuale, se è vero che di questi tempi a porsi interrogativi sullo statuto del proprio «essere nel mondo» sono anche immateriali esseri giocattolo, come dimostra il popolarissimo Toy Story di John Lasseter. E allora, visto che parliamo di giocattoli, di umano e d’identità, credo sia giusto far partire il mio discorso da A.I. Questo non solo per l’attesa che la pellicola aveva provocato ancor prima della sua materializzazione, ma anche perché il film si configura come un percorso più o meno riuscito di apprendimento, ricerca e conferma di un’identità, quale ultima forma aggiornata della tipica prassi statunitense del finding yourself, applicata alla fantascienza attraverso il contributo, non si sa bene quanto di gruppo, di colui che con 2001 Odissea nello spazio aveva inaugurato la definitiva speculazione sulla dimensione dell’essere nel cinema SF, insieme al regista che con George Lucas aveva dato il via, almeno a partire da Incontri ravvicinati del terzo tipo, a quelle dinamiche dello sguardo e del visibile che hanno intaccato in maniera indelebile la fruizione e la percezione del fantascientifico nel cinema hollywoodiano degli ultimi trent’anni. È chiaro, infatti, che la questione qui posta non è solo quella di una Artificial intelligence, ma anche, forse soprattutto, di una Artificial identity, se non addirittura di una American identity. Partendo quindi dall’assunto di base del film – la storia di un essere «non vero», che cerca una favola e si inoltra in un viaggio per renderla viva e «vera», conscio che la caratteristica più «umana» è l’abilità di inseguire i sogni (o, come meglio sottolinea il «mecca» gigolò a pro-
187
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
MICHELE FADDA
posito degli orga, nel «credere in ciò che non si può vedere e misurare») – vorrei soprattutto soffermarmi sul lungo finale, questo interminabile epilogo di un film che forse trova interamente la sua sostanza più autentica solo nella veste di un «epilogo», teso tra una mutazione già avvenuta in un «prima» non più rinvenibile e un «termine» che non sembra mai realizzarsi, e quindi concentrato inevitabilmente soprattutto in un «qui e ora» in lento avvicinamento verso la propria fine. Una dilatata conclusione che, come noto, è divisa in diversi tronconi. Il primo momento è quello che vede il protagonista, il bambino artificiale David, giunto nel laboratorio del suo aggiornato Geppetto, incontrare per la prima volta il suo doppio – che decapiterà in un impeto d’ira selvaggia – o ancor meglio i suoi doppi, la scena in cui il bimbo-giocattolo comprende di non essere «unico» e vede se stesso come «prodotto», oggetto di consumo (sequenza anche questa anticipata nel primo Toy Story, quando l’astronauta giocattolo digitale Buzz Lightyear si scopre riprodotto in migliaia di copie sugli scaffali di un supermercato). Questo primo troncone coincide con la sequenza in cui Steven Spielberg, mettendo David davanti all’involucro vuoto di un altro David, ci concede la soggettiva di questa sorta di Pinocchio della tardività mentre guarda il mondo sommerso dagli oceani da dietro le orbite vuote del suo doppio, per poi piazzare un controcampo che si tuffa nell’altro lato di queste stesse cavità, al fine di restituirci tutta la tristezza di questo sguardo meccanico che ci guarda. È un’immagine insieme di assenza e di pienezza, dove attraverso lo sguardo di chi con tutto il cuore vuole appartenere a qualcuno, la sua mamma – e ricordiamo per inciso che in precedenza il marchio che decretava l’imprinting del giocattolo bambino era dato dall’affettività che, come in un lampo, si faceva largo negli occhi di David – attraverso cioè questa visione desiderante, scopriamo che è questo stesso dispositivo dello sguardo a non appartenerci più, a non esserci mai appartenuto, perché è qualcun altro, o meglio qualcos’altro, a guardare in nostra vece. Il secondo momento è quello che potremmo definire della visione nell’«abisso». Che è poi la discesa nel paradosso di un essere in cerca di una favola per renderla vera, che però è egli stesso un tessuto inestricabile di favole – più Peter Pan che Pinocchio, a ben ve-
188
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
«WHERE
AM
I?» GLI
INCERTI EPILOGHI DELLO SGUARDO E DELL’IDENTITÀ…
dere –, il quale vive e si inabissa in un mondo in tutto e per tutto «fabula», illusione, la cui sostanza da «c’era una volta» – il parco divertimenti, metafora di tanti film spielberghiani – è ormai sommersa dalle acque e incrostata dagli anemoni di mare. È qui che, con gli occhi di David, i quali si sovrappongono questa volta a quelli della Fata Turchina, il bimbo giocattolo rivolge la sua preghiera («Fata Turchina, ti prego, fammi diventare un bambino vero!»), davanti a un simulacro di Fata Turchina in realtà più «fantasma turchino nel ghiaccio, sempre sorridente e sempre in attesa» di questo invito straziante in ragion del quale – ci ricorda il narratore – «David non si mosse più, ma i suoi occhi rimasero sempre aperti, a “fissare in eterno” davanti a lui, attraverso l’oscurità di ogni notte, finché passarono duemila anni…». L’ultima parte che ci interessa riguarda invece quello che dovrebbe essere il «vero» finale (David che ritrova la sua mamma, per un solo giorno, grazie alla proiezione concessagli dagli alieni), per alcuni critici qualcosa di quasi inutile, e in ogni caso macchiata da un intento consolatorio che nulla avrebbe a che fare con il genio di Kubrick, perché, ovviamente, in tutto e per tutto espressione della sensibilità infantile di Spielberg. Nell’accusare il film di essere consolatorio, si perde però di vista la dimensione più autentica del progetto di A.I. Perché una cosa è certa: in questa pellicola, con tutti i suoi difetti, non c’è proprio nulla di consolatorio, e l’incedere pesante verso il finale sempre posticipato sembra essere il corrispettivo di uno sguardo che fa resistenza al destino di credere o appartenere a ciò che sta osservando. Il lieto fine in questione è un concentrato di ambiguità, nel quale l’homecoming è la scoperta di «una mia casa che non è però la stessa casa» (dagli arredi freddi e asettici quanto le stanze del finale kubrickiano di 2001), e soprattutto di una mamma che non è assolutamente la mamma crudele e nevrotica che avevamo conosciuto all’inizio del racconto. Infatti, esiste solo un miraggio, realtà virtuale ma anche un po’ cinema, posto in essere dagli alieni, marchiato inevitabilmente dal peso della falsità e della provvisorietà. Miraggio, tra l’altro, neppure condivisibile socialmente sotto forma di un’allucinazione consensuale, ma a beneficio unico di una visione privata così oppressa dalla solitudine (unico conforto, la
189
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
MICHELE FADDA
compagnia dell’orsacchiotto Teddy) che fa di A.I. uno dei film più dolenti apparsi sugli schermi negli ultimi anni. Il cinema – quello classico, innanzitutto, ma anche quello mainstream dei nostri anni – era stato per decenni il luogo della materializzazione dei nostri desideri, spazio di conferma di un’identità, di condivisone sociale di un’ideologia, o più semplicemente di un’identificazione con un vero e proprio «mondo», un orizzonte più interessante, «vero» e meno problematico dello spazio reale e materiale in cui gli spettatori si trovavano a vivere. Poi, certo, è venuto il tempo del cinema moderno, il momento della demistificazione, della scoperta dell’impossibilità d’instaurare un rapporto «naturale» con l’immaginario, disincanto che se da un lato aveva un tempo portato a guardare con sospetto paranoico la superficie del visibile, dall’altro lato non aveva inficiato una forma d’amore verso quella stessa immagine che si stagliava sullo schermo, nelle vesti ben note della cosiddetta cinefilia. Ma ora, con film quali A.I., non solo non si riesce più a contare sino in fondo sull’apparenza, sulla proiezione dei nostri desideri, ma anche il sentimento di amore e di affetto che gli si accorda appare come gesto forzato, pesante. Con un’aggravante, e cioè che questo desiderio apparentemente incarnato, questo mondo visibile provvisorio sul quale non possiamo a lungo contare, è comunque l’unico mondo che ci è rimasto, dal quale non è possibile fuggire, perché non c’è altra sostanza al di fuori di questa sostanza di favola di cui lo stesso protagonista è fatto. Siamo di fronte a quella sorta di «estranea familiarità» di cui ha parlato Vivian Sobchack 1 (lo straniamento della «mia casa che tuttavia non è la mia stessa casa»), che sembra invertire la logica dell’unheimlich freudiano, nel senso che l’incertezza non è più rivolta (come vorrebbe la tradizione del fantastico) verso un fantasma, ma diretta nei confronti di una sostanza che si afferma come «realtà», lasciando perciò intuire non tanto una patologia del soggetto percipiente (che scambia la finzione per verità) quanto la patologia di un oggetto percepito che il vedente fa fatica ad accettare come reale. 1 V. SOBCHACK, Introduction, in Vivian Sobchack (a cura di), Meta Morphing. Visual Transformation and the Culture o f Quick Change, University of Minnesota Press, Minneapolis-London 2000, p. XI.
190
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
«WHERE
AM
I?» GLI
INCERTI EPILOGHI DELLO SGUARDO E DELL’IDENTITÀ…
Questo sospendere il «fine» di una visione non può però che rimettere in discussione tutta la sostanza del finding yourself, la stessa teleleogia (direi meglio, escatologia) del racconto – della Storia di questa specie d’individuo. Se è vero che il modello «classico» ad Hollywood, come scrive giustamente Rick Altman in polemica con la direzionalità narrativa descritta da David Bordwell – quella di una consequenzialità che sviluppa l’impulso esercitato nell’incipit, nella causa di partenza –, sarebbe quello per il quale i film hollywoodiani, paradossalmente, non partono dall’inizio ma dalla fine, nel senso che il punto scatenante sta nella ricomposizione del mondo che si attua solo nella conclusione, in una conferma dei desideri spettatoriali che porta ogni pellicola a «ragionare all’indietro» 2, non resta allora che constatare quanto un finale come quello proposto da A.I. non può farsi catalizzatore di una coerenza, in qualunque forma la si voglia intendere. Certo, chiunque potrebbe obbiettare che di finali (soprattutto lieti) non credibili è disseminata tutta la storia del cinema, anche quella hollywoodiana. Eppure, il problema è qui dato dall’approdo in una dimensione – digitale almeno nello spirito – veramente senza «fondamento». La questione della fine (di un fine) viene messa in questione. Per il piccolo David, che in quanto artificiale non è mai nato e non ha quindi mai festeggiato un compleanno, non c’è davvero né un’origine né un termine su cui fondare la veridicità della sua persona. L’enigma posto dal «chi sono» non può essere suffragato dalla certezza del «dove sono», e deve quindi essere cercato, verificato, reso «sostanziale», in qualche altro modo, in un altro luogo. Ma dove? Spielberg (Kubrick?) ci spinge a dirigerci verso il «luogo in cui nascono i sogni». Questo potrebbe essere l’orizzonte, funereo, di un sonno infinito, ma potrebbe anche essere un modo per retrodatare la conclusione di A.I. verso quello che ho sopra chiamato il secondo finale di A.I., il destino di un’intelligenza artificiale – tuffata in un abisso, in una condizione di transito infinita – che ha rinunciato da tempo a una dimensione puramente mentale, cognitiva e razionale, in favore invece di un «sentire» mai soddisfatto, statuto terminale 2 R. ALTMAN, Dickens, Griffith and Film Theory Today, in J. GAINES (a cura di), Classical Hollywood Narrative, Duke University Press, Durham and London 1992, p. 32.
191
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
MICHELE FADDA
(ma non ancora «finito») di uno sguardo meccanico che non cessa di vedere e di desiderare, con occhi spalancati nell’eterno del ghiaccio ai quali viene restituito un controcampo problematico. Lì dove, ancora una volta, non si tratta più della «verità» di una rappresentazione, del regime spettacolare dell’apparenza, ma della verità della risposta alle sollecitazioni di un certo orizzonte di mondo. Chiedo scusa per questa lunga premessa su un film che sembra non concludersi, premessa destinata a restare essa stessa, per certi versi, irrisolta. L’epilogo messo in moto da A.I. sembra tuttavia portare allo scoperto molti degli interrogativi posti dal problema dell’identità nella SF contemporanea (e non solo). Questo, a ben vedere, in linea con le modalità di una tradizione, quella del cinema fantascientifico nel suo insieme, che è stata tante volte capace di indicarci il destino più autentico della rappresentazione identitaria, sporgendosi come nessun altro genere cinematografico sui limiti inerenti al self e allo sguardo che lo sostiene; o meglio, in linea con una tradizione che ha per tanti versi evidenziato il carattere paradossale comune sia alla sostanza del cinema che a quella dell’America, una natura «non risolta» che lo statuto terminale a cui è giunto il genere, in alcuni esempi recenti, sembra davvero portare alle estreme conseguenze. Parlare dell’ambivalenza costitutiva del rapporto tra il soggetto e la tecnologia dello sguardo, delle aporie nell’intreccio per cui «il mondo diviene immagine e l’uomo subjectum» 3, vuol dire naturalmente riferirsi all’ovvio. Significa per esempio riferirsi all’ambiguità che il potere del soggetto mostra di fronte all’invenzione del cinematografo: da un lato, l’evidenza del cinema come fantasmagoria che più di ogni altra si è adoperata per compensare l’affievolirsi del potere cognitivo del soggetto attraverso una nuova forma di potere panottico, nell’affermazione di quell’«era dell’immagine analogica» che prepara l’emergere di una nuova soggettività sempre più fondata sull’atto della visione, sul piacere di un mondo, scrive Pierre Sorlin, «a portata di sguardo», un’immagine che sembrava indipendente, oggettiva, e che s’impose «non tanto perché avvicinava l’essere umano al reale, quanto perché il pubblico enfatizzava il suo potere 3 M. HEIDEGGER, L’epoca dell’immagine nel mondo, in Sentieri interrotti, La nuova Italia, Firenze 1997, p. 97.
192
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
«WHERE
AM
I?» GLI
INCERTI EPILOGHI DELLO SGUARDO E DELL’IDENTITÀ…
rivelatore, e si aspettava da lei che rafforzasse l’autorità dell’uomo sul mondo» 4; dall’altro lato, il prendere coscienza di un’affermazione della potenza umana effimera e contraddittoria, se è vero che il potere della fotografia e poi del cinematografo si realizza non in un trionfo ma in uno scacco del soggetto, all’interno di una realtà in cui per la prima volta la presenza dell’uomo non è più necessaria, perché regolata da un automatismo – l’occhio che non ci appartiene e vede per noi – che rimuove l’agire umano dal fenomeno della riproduzione 5. Questo intreccio fondativo risulta però altrettanto ambiguo se spostiamo la nostra attenzione sul territorio dell’America, in teoria il luogo per eccellenza di proiezione di un sogno, di un immaginario, e storicamente orizzonte fondante la modernità stessa dell’individuo. Una contraddizione s’insinua già nell’atto stesso della scoperta dell’America – quel viaggio per certi aspetti un po’ fantascientifico, proiettato verso il futuro, ed attuato per confermare un sogno che, come sappiamo, non apparteneva solo a Colombo ma anche a gran parte dell’immaginario europeo medievale 6. Come è stato scritto, l’esperienza della conquista e della scoperta dell’America si configura come una «registrazione potente delle pretese e delle limitazioni della pratica della rappresentazione europea» 7, se è vero che l’atto stesso di reificazione di un sogno non può, già nella fondazione del nuovo mondo, prescindere dall’esperienza della «meraviglia», dallo shock visivo che si stagliava davanti agli occhi dei conquistatori, quel wonder – elemento da sempre costituivo dell’identità americana – allo stesso tempo istanza di un sentire «sublime» e shock che precede e mette in discussione le stesse categorie della metafisica occidentale. In altri termini, in America il possesso di un mondo ridotto a immagine non può essere scisso dalla reazione dello spettatore. Di qui quella tensione nella visione che è elemento fondante dell’identità americana, presente in tante pagine del romanzo americano ottocenP. SORLIN, I figli di Nadar, Einaudi, Torino 2001, p. 232. Cfr. S. CAVELL, The World Viewed, The Viking Press, New York 1971. 6 T. TODOROV, nel suo fondamentale La conquista dell’America, Einaudi, Torino 1984, ha parlato giustamente di una «strategia finalistica dell’interpretazione» che presiederebbe alla scoperta stessa del nuovo continente. 7 S. GREENBLATT, Meraviglia e possesso, Il mulino, Bologna 1994, p. 51. 4 5
193
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
MICHELE FADDA
tesco. Si veda, a solo titolo di esempio, la scena madre iniziale all’interno de La lettera scarlatta di Nataniel Hawthorne (le miriadi di occhi che osservano la A scarlatta – A come Adulterio ma anche A come America – impressa sulle vesti di Hester esposta alla gogna e al ludibrio pubblico). Oppure, sempre nella narrativa americana, quella tormentata vocazione alla spettatorialità di cui ha parlato Guido Fink, nei termini, come è stato scritto, di una vera e propria «discrepanza tra il guardante e il guardato» 8: nel Wakefield che per venti anni guarda non visto da una finestra la sua famiglia, in Hawthorne; nei testimoni-narratori dei racconti di Henry James; nel terrore dell’«essere guardato» dell’«uomo della folla» di Edgar Allan Poe. O ancora, infine, quella oscillazione costituiva di cui ha scritto anni fa Tony Tanner, la diffidenza da parte dei romanzieri statunitensi ad affidarsi a un’immagine, a una forma, autoconclusa, sclerotizzata, unita al concomitante terrore di un mondo senza forma, interamente senza confini 9. Da questo punto di vista, sarebbe abbastanza logico considerare Hollywood come il luogo in cui questo genere di contraddizioni può trovare la propria risoluzione. Questo, naturalmente, non solo grazie a quell’intrinseca reversibilità del mezzo cinematografico, in grado – seppure attraverso il ricorso a un occhio meccanico – di creare un sistema capace di rendere conto al tempo stesso di un oggetto della visione e di un soggetto percipiente 10, ma grazie soprattutto a quella sorta di contratto implicito stabilito con lo spettatore, reificato ovviamente nella dimensione della «trasparenza» e della coerenza narrativa del cinema classico, in un regime dell’immaginario e in un progetto ideologico che, comunque, si configura come riflesso accomodante non del mondo in sé, ma del «modo» in cui la massa degli spettatori si rivolge a questo stesso mondo 11. Se non fosse che, come ben sappiamo, questo equilibrio, nella sua perfezione e nella sua organicità, trova la sua realizzazione in un ristretto periodo di tempo e di pellicole, lasciando invece posto a una ricomposi8 Cfr. G. FINK, I testimoni dell’immaginario, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1978. 9 T. TANNER, City of Words, Harper and Row, New York 1971. 10 Cfr., a questo proposito, V. SOBCHACK, The Address of the Eye, Princeton University Press, Princeton 1992. 11 Cfr. R.B. RAY, A Certain Tendency of the Hollywood Cinema, 1930-1980, Princeton University Press, Princeton 1985.
194
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
«WHERE
AM
I?» GLI
INCERTI EPILOGHI DELLO SGUARDO E DELL’IDENTITÀ…
zione dei conflitti e delle contraddizioni sempre più difficile, a una tensione visiva e narrativa che renderà negli anni sempre meno produttiva la conferma ideologica e d’identità sottesa a tutto il sistema hollywoodiano. Su una cosa si può comunque essere d’accordo: nell’indicare cioè la fantascienza cinematografica come spazio privilegiato per investigare questa tensione essenzialmente visiva a cui può accompagnarsi un disequilibrio nella coerenza, sia essa applicata sul piano narrativo che su quello del consolidamento di un principio di realtà o d’identità. Non si tratta soltanto di ricordare come la SF, nella sua versione più autentica, si afferma soprattutto a partire dagli anni Cinquanta, in un periodo di forte insicurezza della nazione americana, di sospetto, come sappiamo, reificato non solo nello sguardo rivolto verso l’esterno, ma indirizzato anche nel cuore dell’identità stessa americana. Si tratta anche, se non soprattutto, di affrontare la specificità stessa della SF: la sua apertura verso nuovi mondi, verso nuovi modi di vedere e di essere che, in effetti, possono contrastare l’impeto verso la chiusura della narrativa classica. Non a caso, c’è chi ha visto nella SF cinematografica il genere che più di ogni altro si riavvicina a quella «esperienza visiva della modernità» che aveva caratterizzato la cinematografia delle origini, quel cinema delle «attrazioni» su cui ha ampiamente discusso Tom Gunning, arte che ha più radici nello spettacolo, nell’esibizione della novità tecnologica, che non nel divenire di una storia 12. Consisterebbe anche in questo la logica stessa dell’«effetto speciale»: nel de-enfatizzare il patto narrativo dando maggior peso, rispetto agli altri generi hollywoodiani, al senso di meraviglia e stupore di fronte alla superficie delle immagini. Il che non significa azzerare la forza narrativa, ma prendere coscienza di come la costruzione di un senso debba comunque, nella fantascienza, maggiormente fare i conti con le modalità di reazione a una superficie visiva, in genere aliena. Per questo, rispetto alle immagini fornite dalla SF, non mettiamo in moto, come nel cinema Fantasy, la nostra volontaria so12 B. L ANDON, Diegetic or Digital? The Convergence of Science-Fiction Literature and Science-Fiction Film in Hypermedia, in A. KUHN (a cura di), Alien Zone II, Verso, London-New York 1999, pp. 31-36.
195
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
MICHELE FADDA
spensione dell’incredulità, ma ci affidiamo in maniera «credibile», rinvenendo un senso nella relazione che queste stesse immagini sempre stabiliscono, all’interno di ogni film, con il nostro universo familiare 13. Da ciò deriva quella tensione tra impulsi opposti, tra il familiare e l’alieno, che accompagna tutta la storia della SF cinematografica, e che, sulla scorta degli studi della Sobchack, si può provare, a grandi linee, a periodizzare in tal senso. Prima, nella fantascienza cinematografica classica, si afferma, in senso lato, il sentimento dell’alienazione, la freddezza di una «distanza», ovvero il distacco di uno sguardo pseudoscientifico che è il correlativo oggettivo di uno stupore inteso come «timore», sospetto della novità imposta dal nuovo orizzonte tecnologico o alieno. Questo perché l’effetto speciale irrompe come inserimento di un elemento alieno nel territorio del familiare, capace di mettere in crisi l’epistemologia terrestre. Ciononostante, il movimento che viene descritto non è, per così dire, quello che va dalla terra alle stelle, ma semmai quello che riporta lo strano a casa (o scaccia lo strano da casa), nel tentativo di ricucire quel principio di realtà e d’identità che era stato messo in discussione. Poi, invece, dopo il viaggio intrapreso in 2001, nella seconda grande stagione della SF cinematografica, si attua una vera frattura epocale. È come se la distanza venisse annullata, al punto che lo spazio che credevamo alieno si mostra come domestico, pur nella sua freddezza agghiacciante, mentre il futuro si avvicina inesorabilmente verso il presente. Da questo momento in poi, l’effetto speciale è sempre più atteso, nel senso che non è tanto questo a insinuarsi come perturbante nel tessuto narrativo, ma è la narrazione a preparare l’effetto speciale, o altrimenti: se nell’effetto speciale s’insinua l’alienità, il fine della storia è nella dimensione – di attrazione – di questo stesso effetto speciale. Così l’attrazione diventa fatale. Si va incontro alla dimensione spettacolare ed aliena nel momento stesso in cui questa ci viene incontro, come in Incontri ravvicinati del terzo tipo. Lo sguardo infantile di Richard Dreyfuss, che si getta nel grembo materno dell’alieno, segna l’inizio del nostro inesorabile scivolamento nella dimensione del tecnologico, che è accettazione di uno 13
V. SOBCHACK, Screening Space, Ungar Publishing Company, Ungar 1987, p. 88.
196
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
«WHERE
AM
I?» GLI
INCERTI EPILOGHI DELLO SGUARDO E DELL’IDENTITÀ…
stato culturale e tecnologico che ci appartiene, una rinnovata «familiarità con il meraviglioso», nella forma di una partecipazione visiva emozionale e soprattutto «affettiva» 14 nei confronti di un’immagine spettacolare che vale solo per se stessa, quasi sempre intrisa dal marchio di fabbrica della lucasiana Industrial Light and Magic. La postmoderna erosione dei confini ha tuttavia un prezzo. Nella cancellazione della distanza che ci separa dall’alieno e dallo spettacolare, non si tratta soltanto di constatare il prevalere della superficie sulla profondità, o di rilevare l’inevitabile consumarsi dell’ultima discontinuità, quella tra uomo e macchina, preannunciata dalla letteratura di Philip Dick ed elevata a paradigma nella breve stagione del cyberpunk. Si tratta anche di prendere atto delle conseguenze che si attuano sul piano spettatoriale e dello statuto dell’immagine e della realtà. Ci troviamo infatti di fronte a una paradossale esaltazione del dominio della raepresentatio a cui si accompagna un’inversione della sua normale logica di potere. Se, come scriveva Martin Heidegger, l’intreccio fondamentale dell’uomo moderno è consistito, almeno a partire dall’umanesimo, nel contrapporre davanti al subjectum la presenza di un mondo concepito come immagine, che fosse il luogo in cui l’uomo potesse orientarsi ed affermare il proprio potere e la propria presenza, ecco che a partire dai tardi anni Settanta certo cinema di fantascienza ci dimostra come sia proprio la messa in immagine del mondo, portata alle sue estreme conseguenze, a preparare l’eclissi del soggetto, imprigionato in un visibile che in realtà non gli appartiene. Non è più il soggetto, nel suo sforzo ermeneutico, che s’impegna a rendere fenomenica l’immagine, ma è l’immagine stessa a rendersi fenomenica, a farsi definitivamente «realtà». È esattamente in questo senso che l’immagine progressivamente si fa «corpo», carne, deriva iperreale di un falso più vero del vero, più reale del reale. Lungo tutto il corso della SF degli anni Ottanta, si assiste allora a un fenomeno di vera e propria «feticizzazione» della rappresentazione, un «dare peso» all’apparenza e al visibile attraverso un’immagine che non è figura altro che di se stessa, e si pone progressivamente come l’unico habitat possibile. 14
Ivi, p. 225.
197
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
MICHELE FADDA
Un vero e proprio primato del materialismo dell’immaginario che la fantascienza hollywoodiana ha per lo più alimentato, nel piacere di una spettacolarizzazione spesso fine a se stessa, o altre volte timidamente combattuto – nella narrativa di un ultimo scampolo di realtà che prova a contrapporsi al progredire della dimensione cyborg –, almeno fino a quando, all’inizio degli anni Novanta, nella parte finale della saga di Terminator non compare il T 1000, il terminator metamorfico dalle mille facce, definitivo invalidamento del principio aristotelico della non contraddizione, materialità di una sostanza immateriale invincibile, perché non conosce la mortalità… Dov’è finita allora la SF? Sulla base di quanto detto, la risposta più ovvia ci obbliga a riconoscere che il genere è entrato definitivamente in un territorio marchiato dal senso della fine. È cosa nota. La fantascienza ci ha fatto tuffare in un metamondo, in un’immagine divenuta realtà al punto di non avere più bisogno della retorica che un tempo la sosteneva, perché capace di vivere di vita propria. La fine del soggetto, della Storia, del narrativo, è tuttuno con la volontà e il piacere di mostrare un territorio che non è più il luogo della creazione umana, dello spazio dell’agire di un soggetto. Tutto vero. Se non fosse, però, che negli anni Novanta una tale episteme non ha affatto comportato la fine del genere (come spesso accade ogni qual volta si entra nel territorio della fine, fine del romanzo, del cinema, etc.). Il persistere del «dopo la fine» dimostra semmai la trasformazione di un termine in una condizione quasi strutturale di «epilogo»: nella coincidenza di una fine già registrata e non più evitabile e di una condizione di living end, un continuare a finire, a ritardare questa conclusione. Proviamo a spiegarci. Parlare di epilogo strutturale non significa affermare che la SF contemporanea non partecipi di quel delirio visivo caratteristico del genere negli anni Ottanta. Anzi, se è possibile questo è ancora più ribadito come condizione necessaria sulla quale speculano gran parte dei più recenti film fantascientifici. Eppure, l’apparenza di questo visibile sembra darsi a vedere in un modo diverso. Certo, possono permanere esempi di apoteosi dell’effetto speciale, e il dominio almeno produttivo dell’immaginario di Lucas persiste ancora. Tuttavia, i suoi film ci appaiono per certi versi anacronistici e ai margini. La tendenza che sembra essersi radicalizzata,
198
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
«WHERE
AM
I?» GLI
INCERTI EPILOGHI DELLO SGUARDO E DELL’IDENTITÀ…
nei migliori film di questi anni, è invece quella di mostrare l’apoteosi del visivo nella forma di un trompe l’œil generalizzato. Nel concedersi al dominio dello spettacolare, non sembra più così importante mostrare il carattere straordinario del visibile. Come è stato notato 15, l’effetto speciale sta in un certo senso venendo meno, non appare più così necessario (o appare ridicolo, come nei tentativi di figurativizzare lo spazio discontinuo e frattale del ciberspazio nella trasposizione dell’omonimo racconto di William Gibson Johnny Mnemonic). O meglio ancora: l’effetto speciale sta diventando invisibile. L’immagine che si è fatta corpo, il meraviglioso che è diventato domestico, ordinario, ha finito per introdurre all’interno del cinema hollywoodiano un nuovo tipo di trasparenza, per niente rassicurante. Dove non si tratta più di un’invisibilità intesa come nascondimento degli artifici attraverso i quali si dà un mondo, ma della presa d’atto dell’avvenuta trasformazione in cui l’immaginato è diventato il «percepito». La recente produzione di David Cronenberg, il primo che ci aveva avvertito degli effetti di questa mutazione in un film seminale come Videodrome, lo dimostra ampiamente. In eXistenZ, il videogame innestato sulla corteccia cerebrale ci immerge in una sorta di nastro di Moebius, un incubo degno del racconto borgesiano Le rovine circolari, in cui la figura tipica cronemberghiana dell’assenza del fuori campo viene esaltata alle estreme conseguenze, nel piacere di un pericoloso gioco in cui ogni dialettica pare abolita. In maniera analoga, una realtà virtuale si mostra agli occhi inconsapevoli della vittima nell’universo di The Truman Show, spazio nel quale l’individuo è solo funzione di un’immagine sin troppo domestica. Mentre ben più consapevole è l’esibizione della nuova abitabilità del virtuale in Strange Days: nell’ebbrezza del paralitico che corre sulla spiaggia con il corpo di un altro, si consuma l’effetto definitivo dello squid, la droga meccanica che reifica l’esperienza vissuta e sembra offrirci la vita senza la mediazione del linguaggio. Ciononostante, è proprio questo esibire il reificarsi dell’immaginario che ci ricorda, nei film citati, della necessità di ricercare una differenza in un tale territorio dell’indifferenziato. Nell’esasperazio15 R. MENARINI, Altri mondi. Temi e rappresentazioni del virtuale nel cinema di fantascienza contemporaneo, in M. SPANU (a cura di), Science plus Fiction, Lindau, Torino 2001, pp. 151-156.
199
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
MICHELE FADDA
ne del furore di un’apparenza che si fa sinestetica, è palese una critica del visibile, o almeno una diffidenza ad adagiarsi nella seduzione esercitata dall’immagine che è difficile rinvenire nella Hollywood degli anni Ottanta. Non a caso, l’incipit di Strange Days rappresenta una delle sequenze più emblematiche del cinema americano contemporaneo. La logica dello squid, nella forsennata corsa della steadycam, ci mostra la soggettiva e l’apoteosi della visione come salto mortale nel vuoto. Con un saggio di maestria tecnica che ha pochi pari, Kathryn Bigelow dimostra una volta per tutte in che misura la figura retorica deputata a esprimere le mire del soggetto – portata alle sue estreme conseguenze realistiche – non può affatto sostenere il soggetto, se è vero che il passo successivo al piacere dello squid è quello che porta al black jack, la vertigine di vedere noi stessi che moriamo negli occhi dell’altro che ci stupra e uccide. Ennesima presa d’atto della fine del soggetto, dello statuto di un vedere che in realtà è un essere visto, ma anche attacco esplicito al supporto che dovrebbe sostenere la posizione del self. Si pensi ancora a quanto in un film come Gattaca di Andrew Niccol, il visibile non possa più confermare l’identità né attraverso un processo d’identificazione né di riconoscimento: se già in Blade Runner le fotografie dei replicanti non potevano farsi prova di una memoria, di un passato, ora le fotografie letteralmente non esistono più, e a validare l’identità non è più l’apparenza ma un codice genetico manipolato nel tentativo, messo in atto anche dal protagonista, di spogliare il soggetto da tutti gli attributi che un tempo ne garantivano un’individualità16. Quello che infatti risulta evidente è che, in questi film, l’affettività e disponibilità verso l’immagine viene meno, sino ad assumere, nel recente sequel (o remake?) carpenteriano Fuga da Los Angeles, una vena in tutto e per tutto iconoclasta, nel momento in cui un vecchio Iena Plissken, lui stesso ridotto a ologramma in un mondo che non è altro che un miraggio, decide con un fiammifero di spegnere definitivamente il mondo del visibile. Il destino si gioca nel seno della verità posta in essere dal tecnologico. La cosa non sorprende, perché è normale che la fanta16 G. STEWART, Body Snatching: Science Fiction’s Photographic Trace, in A. KUHN (a cura di), Alien Zone II, cit., p. 242.
200
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
«WHERE
AM
I?» GLI
INCERTI EPILOGHI DELLO SGUARDO E DELL’IDENTITÀ…
scienza si mostri come l’avamposto hollywoodiano delegato a sfruttare e investigare le trasformazioni decise dalla tecnica, in questo caso associate alle modalità di creazione della realtà, imposte dalla svolta digitale. Solo che, per dirla con Jacques Derrida 17, la questione della tecnica s’intreccia sempre con quella della fede, con il credito accordato alle immagini in ogni loro fase di produzione. In questo senso, l’unione forzata del seeing al believing può mostrarsi nelle vesti di una trappola mortale. In 12 Monkeys, di Terry Gilliam, per fare un altro esempio, il credito concesso a un passato strutturato sotto forma di immaginario cinematografico – un ri-vedere se stessi nell’identità di un’immagine (in un’immagine identica) – si configura, nel finale, come clamorosa smentita della verità dell’immagine, e di conseguenza del cinema. Al pari di altri film contemporanei anche non fantascientifici (si pensi al cinema dei fratelli Coen), l’accettazione a priori del materialismo dell’immaginario può in effetti essere letale, ma questo non significa affatto che uno scetticismo generalizzato possa porsi come soluzione. Al contrario, nella dimensione del metamondo sembra imporsi una logica della credenza paradossale. Nel cinema classico, il patto tra regista e spettatore si fondava nel credere il falso di una visione, coscienti che «vedere non era credere» 18; ora invece il credere fa resistenza a una visione che è diventata l’unica realtà possibile. Perché non si tratta tanto di svelare il falso, di operare in senso antirealistico, quanto forse di mettere in questione la nozione di verità associata al visibile, e quindi, per così dire, di spostarne l’accento. Quando, alla fine della sua quest, il David di A.I. arriva di fronte al sogno lucido reificato dagli alieni, il suo aspirare alla verità di un inizio e di una fine viene al tempo stesso negato sia dalla sostanza del suo desiderio materializzato che dalla realtà strutturale del suo stesso essere, il quale appunto non può né nascere né morire. Negare un inizio e una fine è sinonimo della negazione dei riferimenti (e quindi dei referenti) di questa nuova dimensione dalla quale non si può prescindere. Nel momento stesso in cui il trompe l’œil viene 17 Si veda Le cinéma et ses fantômes, intervista al filosofo apparsa in «Cahiers du cinéma», n. 556, 2001, pp. 75-85 e recentemente tradotta su «Aut Aut» n. 309, maggiogiugno 2002, pp. 52-68. 18 A. BESUSSI, Amorose distanze. Divagazioni spettatoriali, in «Aut Aut», cit., p. 81.
201
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
MICHELE FADDA
ribadito ed esibito, l’habitat familiare che ne consegue viene svelato privo di fondamenti, come la città in Dark City di Alex Proyas, notturno universo urbano letteralmente senza «fondamenta». Contrariamente alla fantascienza degli anni Ottanta, non siamo più invitati a compiacerci del «pieno» di un’immagine, ma semmai ad avvertire un vuoto strutturale a questa stessa pienezza. Il modello – seppure non nella dimensione del trompe l’œil – è in fondo quello già consapevole, agli albori degli anni Novanta, in The Abyss di James Cameron, non a caso esplicito tuffo in un universo d’acquea consistenza, figurazione non più indicale, al di là della quale si estende per l’appunto l’abisso. La conseguenza di una tale immersione nell’immaginario, ci diceva Cameron, può però anche essere questa: il senso di una visione – la visione di tutta la fantascienza, sia essa paranoica che desiderante – non dimora nel visibile, ma semmai nella volontà, l’atto stesso del vedere. Il peso non sta più nell’immagine – che infatti è senza peso – ma si sposta sulla domanda del «come» essere, del come vedere. Da cui il paradosso: non più l’affetto verso l’effetto speciale, ma, ci insegna il David spielberghiano-kubrickiano, l’effetto speciale che «prova affetto», e che tuttavia così facendo pone il principio di realtà e d’identità non come un dato di fatto stabilito una volta per tutte, ma come interrogativo sempre in fieri. Non è un particolare da poco, perché sottolinea quanto l’accento, in questi casi, non venga più a cadere sul piano assoluto della «rappresentazione», ma torni a spostarsi sulle modalità di «produzione» di un ente. Ciò che vale a livello della «storia», vale infatti anche a livello del «discorso». Si tratta in fondo di contestare il vecchio pregiudizio già presente nel Lessing di Lacoonte, che vorrebbe l’istanza mimetica svincolata da quella diegetica. Perché il gesto del «mostrare» lo spazio fino alla reificazione del visibile, l’imporsi di un carattere ekfrastico nella rappresentazione – quel volere essere altro da sé che nella fantascienza attuale sembra diventare davvero altro da sé – non necessariamente inibisce il fluire del racconto. Al contrario, non solo la mimesis e la diegesis sono tradizionalmente legate a doppio filo, ma la SF contemporanea – che pure pone in essere l’ipotesi di una materialità del mimetico – continua paradossalmente a confermare la tendenza novecentesca (a dire il vero già presente in nuce nel romanzo ottocentesco) verso un raccontare per im-
202
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
«WHERE
AM
I?» GLI
INCERTI EPILOGHI DELLO SGUARDO E DELL’IDENTITÀ…
magini, nel quale il narrativo nasce da un misurarsi con lo spazio, o dove si tratta di trovare, nel prevalere dello spazio, uno spazio diverso di racconto. La vecchia affermazione di Italo Calvino, secondo la quale la fabulazione precede sempre la mitopoiesi 19, mi sembra avere ancora un senso in questi racconti della fine in cui il mito sembrerebbe essersi definitivamente consolidato come realtà. Anche per questo motivo, una volta di più, il tono apocalittico comune a molti di questi film – dalla fine millennio di Strange Days, alla Los Angeles del dopo disastro di John Carpenter, sino allo stesso A.I. – dà luogo a una finzione segnata dalla fine che però non è ancora «finita». Non c’è bisogno di rispolverare l’Adorno dei Minima Moralia per riscoprire l’idea di una tensione verso il «tramonto» a cui mirerebbe ogni vera opera d’arte 20. Ci basti ricordare che se è vero che la fantascienza si vuole misurare con gli effetti di una mutazione intervenuta a livello tecnologico, è anche vero che da sempre in ogni fase storica di mutamento della tecnica la novità non nega il passato ma lo trasforma dialetticamente, costringendo ogni tecnologia a iscrivere nel proprio linguaggio gli effetti prodotti da un’altra, nuova tecnologia. Detto altrimenti, è solo nel cinema e col cinema che, almeno per il momento, si dà a vedere e si può «pensare» la progressiva affermazione della logica imposta dal digitale. Come giustamente ha scritto Franco La Polla 21, il problema della realtà virtuale e delle nuove tecnologie consiste nel non avere ancora elaborato un proprio linguaggio, e nell’essere quindi costretti ad adottare dei codici appartenenti a una tecnologia precedente. Ma questo significa anche che il linguaggio cinematografico rimane il luogo privilegiato in grado di indagare criticamente le conseguenze storiche di una mutazione, attraverso quell’operare già messo in luce da Walter Benjamin, secondo il quale, in ogni fase storica di passaggio epistemico, una forma d’arte aspira a effetti che potrebbero essere ottenuti solo con un’altra forma d’arte 22. 19
p. 178.
I. CALVINO, Cibernetica e fantasmi, in Una pietra sopra, Einaudi, Torino 1980,
T. W. ADORNO, Minima Moralia, Einaudi, Torino 1954, pp. 71-72. F. L A POLLA, Corpi/non corpi. Le nuove tecnologie e il cinema (saggio apparso solo su internet). 22 W. BENJAMIN, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino 1991, pp. 19-56. 20 21
203
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
MICHELE FADDA
Insomma, anche nella fantascienza contemporanea, la tensione dell’ente verso un’altra forma continua a essere centrale, almeno quanto l’evidenza dell’essersi consolidati in un’altra forma. In un certo senso, l’importanza dello straniamento sklovskijano – di un’arte come visione e non come riconoscimento, modo di percepire il «divenire» e non il «già compiuto» dell’oggetto – si conferma in una situazione però paradossale, in virtù della quale il «procedimento» si compie interamente nell’ambito stesso della percezione automizzata 23. Di qui, il carattere specifico della questione della realtà e dell’identità, nella visione messa in atto da questi film. Ammesso ormai che il mero fatto di un’esistenza fisica non è più capace di garantire la persistenza del soggetto, ecco che la migliore SF degli ultimi anni, osserva Scott Bukatman, si impegna in un fenomeno di endosmosi opposto alla trasformazione del sé così come l’abbiamo spesso intesa, anche a partire dalla decostruzione del self tipica dell’arte modernista 24. Se, ancora in Proust, si trattava di recuperare un principio di realtà partendo da un’identità frammentaria, ora si tratta invece di osservare in maniera esplicita una forza che trasforma e altera la sostanza del reale e dell’identità 25, di qualunque materia esso sia fatto. Esattamente per questo motivo la dimensione del morphing, così pervasiva nella Hollywood contemporanea, diventa fondamentale. Perché è nella possibilità tecnica del visibile di essere sempre, in ogni istante, altro da sé, che si afferma quell’assenza di differenza che appiattisce ed omologa gran parte della produzione dell’attuale cinema americano. Ma, d’altro canto, ci ricorda ancora la Sobchack, è la natura stessa del morphing che è capace, in ogni suo istante, di mettere in discussione la stabilità e la posizione dominante delle figurazioni della metafisica occidentale o della American identity 26. Di nuovo, non è più un problema d’inizio o di fine: in questi casi tutto ciò che attiene al senso di realtà o d’identità è funzione di un bildungroman senza bildung, un procedimento assolutamente nuovo, 23 V. SKLOVSKIJ, L’arte come procedimento, in T. TODOROV (a cura di), I formalisti russi, Einaudi, Torino 1968, p. 88 e ID., Una teoria della prosa, Bari 1966, p. 12. 24 S. BUKATMAN, Taking Shape. Morphing and the Performance of the Self, in V. SOBCHACK (a cura di), Meta Morhing, cit., p. 229. 25 Ivi, pp. 228-229. 26 V. SOBCHACK, Introduction, in V. SOBCHACK (a cura di), Meta Morphing., cit., p. XII.
204
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
«WHERE
AM
I?» GLI
INCERTI EPILOGHI DELLO SGUARDO E DELL’IDENTITÀ…
sempre capace di negare l’irreversibilità che fondava le rappresentazioni di carattere analogico 27. All’interno della dimensione filmica s’insinua il virus di una figurazione che, nel medesimo istante in cui si afferma, è capace di negare se stessa. La realtà o l’identità che si impone e mostra come prodotto è, infatti, al tempo stesso anche «processo», «sentire» di una sostanza prefabbricata che non può mai essere definitivamente identica a se stessa, esemplare nello statuto di Odo, il personaggio di Star Trek Deep Space Nine, che sempre la Sobchack individua come un’avatar di una mutazione palindroma, continuamente reversibile, pura forma del cambiamento spurgata da ogni casualità o ragione specifica 28. La fantascienza cinematografica, in fondo, non è troppo cambiata. Come sempre, nonostante le apparenze e le intenzioni, il genere non si sporge tanto verso il futuro, non si interessa di un altro da noi, ma ci parla piuttosto di noi stessi, di quello che siamo stati o che stiamo diventando. Questo radicarsi nel presente ha però tanto più senso ora, in una condizione storica nella quale l’eclissi della distanza non permette più al soggetto di disporre a suo piacimento dell’oggetto, ma è quest’ultimo semmai a rimettere in discussione la questione della soggettività. Il nuovo realismo imposto dalla tecnica, nel momento in cui ribadisce l’impossibilità della fuga e del distacco, non comporta tuttavia necessariamente una accettazione a priori del miraggio che pone in essere. Al contrario, la SF contemporanea pare condividere l’atteggiamento, per certi versi patologico, comune anche ad altri film hollywoodiani (si pensi, per esempio, alla dinamica dello sguardo e della «trasparenza» imposta da un film dichiaratamente rivolto al grande pubblico, come il recente A Beautiful Mind di Ron Howard), dove la coscienza del trovarci imprigionati in una visione è tutt’uno con una demistificazione delle nostre stesse illusioni, per quanto «vere» esse possano apparire. In altri termini, da queste pellicole si avverte l’urgenza storica, per usare le parole usate da Pier Aldo Rovatti in un altro contesto, di allontanarci dal «troppo di trasparenza» nel quale siamo immersi, fino a «spalan-
27 ID., At the Still Point of the Turning World, in V. SOBCHACK (a cura di), Meta Morphing, cit., p. 136. 28 Ibidem.
205
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
MICHELE FADDA
care gli occhi davanti alla contraddizione in cui ci troviamo a essere e che di fatto siamo», sospendendo il dominio delle leggi ottiche in un procedimento in cui il guardare non è solo un «fine» ma un «modo» di distoglierci da «un occhio in più e di troppo», capace di giocare contro se stesso il nuovo statuto d’identità e realtà 29. Certo, può sembrare difficile e utopistico riveicolare la direzionalità dello sguardo nell’era definitiva della «macchina che vede», o rimettere in questione il principio di realtà e d’identità dentro una sostanza che, nel suo mostrarsi denudata da qualsiasi referente, ha la consistenza e magari anche l’apparenza di un cartone animato. Ma a questo punto è bene ricordare che, almeno un tempo, esistevano in America due grandi tradizioni del cartoon: l’abbaglio imposto dalla illusion of life di Disney, da una parte, e dall’altra le gesta dei cartoni animati Warner e MGM di un Tex Avery o un Chuck Jones, attraverso le quali il mondo per eccellenza della animazione disneyana veniva al tempo stesso svelato come falso e come qualcosa da cui non si poteva sfuggire, perché consustanziale agli esseri stessi che lo frequentavano. Per questo, proprio con un omaggio a Jones – quel Jones che aveva dato il famoso Duck Dodgers, il cartoon fantascientifico che riappare in Incontri ravvicinati del terzo tipo – ho voluto iniziare e vorrei chiudere, ritornando al capolavoro jonesiano Duck Amuck, se non altro per il suo valore di parabola, attualizzata, ancora una volta, sotto forma di epilogo. È il film in cui Daffy Duck – il papero più umano della storia dei cartoni animati – vede la sua ansia di impersonare sempre qualche cosa d’altro da se stesso umiliata dagli sbeffeggiamenti impietosi di un animatore (in realtà Bugs Bunny), che cambia al papero di continuo sfondi, costumi e connotati, in un’inarrestabile metamorfosi keatoniana in cui tutto ciò che appare – i contorni, i colori, la voce dello stesso Daffy – si mostra nella falsità di un disegno, inteso appunto sia come figura di un pennello che come macchinazione. Solo che se l’evidenza di un corpo e di un mondo può essere fatta a pezzi e cancellata, ecco che lo spettro dei desideri, dei sentimenti, delle stesse meschinità del personaggio, non possono estinguersi, dal momento che niente è importante per Jones eccetto l’idea che Daffy possiede delle emozioni – 29
P.A. ROVATTI, Abitare la distanza, Feltrinelli, Milano 1994, pp. 19-25.
206
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
«WHERE
AM
I?» GLI
INCERTI EPILOGHI DELLO SGUARDO E DELL’IDENTITÀ…
tutto quello insomma che contribuisce a rendere il personaggio, unico, vero, intatto, qualunque violenza e «malattia» gli possa essere inflitta, in qualunque forma. Così quando la gomma cancella definitivamente la vittima della macchinazione e il pubblico si trova di fronte allo schermo vuoto, nel momento stesso in cui Daffy implora «Where am I?» sullo sfondo nero, anche nella sua assenza il pubblico è certo della sua presenza. Nell’era della dissoluzione del soggetto e dell’immagine che lo dovrebbe sorreggere, la salvezza, come già in A.I., non sta, infatti, nell’apparenza dell’essere, e neanche nel poter essere, ma solo, unicamente nel voler essere, nell’emozione di uno sguardo desiderante che ci rivolge la sua domanda. Contro l’illusione di vita disneyana, si prova a reagire credendo solo nella specificità della vita stessa, tutto quello che non appare dietro la forma di un giocattolo preconfezionato. La domanda di Daffy, il papero sognatore, come quelle di David, è forse, inequivocabilmente, ancora la nostra, soggetti terminali ai quali, almeno per il momento, non è stato ancora concesso l’epilogo definitivo.
207
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
LOVE MACHINES. SPIELBERG/KUBRICK, ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND OTHER OXYMOROUS OF SF CINEMA di VIVIAN SOBCHACK
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
In Bruno Schulz’s extraordinary little book, The street of crocodiles, the author’s father (who believes that tailors’ dummies should be treated as people) warns his children: Matter never makes jokes; it is always full of the tragically serious. Who dares to think that you can play with matter, that you can shape it for a joke, that the joke will not be built in, will not eat into it like fate, like destiny? Can you imagine the pain, the dull imprisoned suffering, hewn into the matter of that dummy which does not know why it must be what it is, why it must remain in that forcibly imposed form which is no more than a parody? Do you understand the power of form, of expression, of pretense, the arbitrary tyranny imposed on a helpless block, and ruling it like its own, tyrannical, despotic soul? 1.
In what follows, I want to explore both the «joke» and the «tragic seriousness» of two culturally significant «dummies» jointly tailored by two major American filmmakers in the recent science fiction film, A.I. Artificial intelligence (2001). The filmmakers are, of course, Stanley Kubrick who worked on pre-production of the film for many years before he died in 1999 and Steven Spielberg who ultimately wrote the final screenplay and directed it. The culturally significant «dummies» are, in this instance, two very smart male robots: both «artificial intelligences» whose «forcibly imposed form» is human, and both programmed as what I shall here call – as a joke and in tragic seriousness – «love machines». However, like the two filmmakers’ respective cinematic oeuvres and attitudes, these love 1 B. SCHULZ, The street of crocodiles, trans. Celina Wieniewska, Penguin, London 1977 (Walker and Company 1977), p. 64.
211
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
VIVIAN SOBCHACK
machines couldn’t be more contradictory in both their form and function. And yet, like the filmmakers, their seeming binary opposition comes into complementary conjunction and confusion in A.I. – and has something important (and sad) to tell us about the contemporary technological (and male) American imagination and its irreconcilable and irresolute visions of what seems an impossible and inhuman future; that is, that imagination’s overarching present nostalgia for a humanity that has been both hollowed-out and abandoned, and a future that can only be conceived as always already past. J.P. Telotte, in his Replications: A robotic history of the science fiction film, argues that «the image of human artifice, figured in the great array of robots, androids, and artificial beings found throughout the history of the science fiction film, is the single most important one in the genre» 2. Using the terms I’ve borrowed above, Telotte views the robot, in particular, as «a trope or mechanism for revealing a human nature that has been largely drained of identity, an abandoned body» 3, a literal image of the «anatomized, hollowedout, modern self […] that underscores [the] degree to which we all seem to have become mechanized, programmed beings, bodies detached from spirit» 4. However, if we are to be imaginative as well as literal, we might also realize that the trope of the abandoned robotic body is not necessarily synonymous with the hollowed-out or empty robotic body – and, indeed, each may generate specific narratives of our imaginary relations with technology that are contradictory, if also complementary, in their convergence. Such is the case with the narratives generated by the two central robotic protagonists in A.I., a highly anticipated science fiction film that was, for most viewers (both critics and public), a major disappointment – criticized not only, and at once, for being both too cold and too sentimental but criticized also for its inability to integrate what one critic has called «Kubrickian irony and Spielbergian ick» 5, and for being 2 J.P. TELOTTE, Replications: A robotic history of the science fiction film, University of Illinois Press, Urbana and Chicago 1995, p. 5. 3 Ivi., p. 150 sgg. 4 Ivi, p. 165 sgg. 5 T. BURR, Electric Youth, in «Entertainment weekly», March 8, 2002, p. 51.
212
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
LOVE
MACHINES.
SPIELBERG/KUBRICK,
ARTIFICIAL INTELLIGENCE…
narratively irresolute and seemingly unable to end. And yet all this is precisely what makes A.I. so interesting for the film points to two quite different and contradictory cultural visions of our displaced technological existence – both of which converge with ambivalent force to hollow out, abandon, berate, and mourn an always already failed and lost human race. These contradictory visions (which are, in fact, complimentary in their end) are embodied and literalized in the film’s two robotic protagonists – the one an «empty body» that is anatomized as literally and always hard: Gigolo Joe, a dream lover of a tireless adult sex machine who enjoys his work until he is framed and hunted for the murder of one of his clients; the other, an «abandoned body»: David, a mechanical love child who is literally deserted and left in the forest by his human «Mommy», and who seeks thereafter (with Pinocchio as his model) to become the «real boy» he thinks she will love. Joe and David – two quite different «love machines» – converge in the woods to begin a journey that will eventually lead not only to what the narrative calls «the end of the world» but also to the end of humanity itself. Gigolo Joe: «The empty body» Although David is the film’s primary protagonist, let me begin first with Gigolo Joe, the «dummy» who is tailored as an amusing (if also ultimately unnerving) «parody» or «joke» on technophilic masculinity, and who, thus, is the more stereotypical and simple robotic figure. Joe is a «love mecha» who services lonely «orga» (or human) women, provides his own mood music (including a 1930s version of I only have eyes for you), and tells his first-time customers: «Once you’ve had a lover robot, you’ll never want a real man again». Joe is a sex machine and knows it; agile, sharp, and self-reflexive, he is a cynic disguised as a romantic and, throughout the film, has no desire to be «really human». Indeed, aware of the special nature and function of «mecha» sexual power, he spells it out to a group of thrill-seeking teenage boys from whom he’s trying to hitch a car ride to Rouge City (a bordello-like Disneyland constructed solely for
213
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
VIVIAN SOBCHACK
adult fun): «There are girls your age [in Rouge City] who are just like me. We are the guiltless pleasures of lonely human being. You’re not going to get us pregnant or have us to supper with mommy and daddy. We work under you, we work on you, and we work for you. Man made us better at what we do than was ever humanly possible». Born not of woman but of «man» and a company called Cybertronics of New Jersey, Gigolo Joe, as one critic has put it, is «revved-up […] with glittering hysteria and a sheen by turns clammy and sexy […]. Joe knows with inhuman sureness that he is programmed for a cold, vertiginous, Mommy-less world of violent Kubrickian sensation» 6. Joe is, indeed, a Kubrickian figure – a robotic extension of amoral and juiced-up Alex in A Clockwork Orange (1971), perfectly fit for the society that made him, deserves him, and fears him. Thus, it is illuminating that, as initially conceived by Kubrick, Gigolo Joe was «much more aggressive [and] sinister» 7 than he is in the completed film, which softens his edginess and suggests, according to Spielberg, that «he’s not a hardcore gigolo [but] a romantic» 8 – in other words, to use a phrase that is particularly strange in relation to an exchange economy sex-worker, that Joe is really a hooker with «a heart of gold». Kubrick, of course, has long been interested in contemporary industrial and postindustrial society’s perverse displacements of Eros onto technology and technique – what cultural critic Mark Dery calls our «mechano-eroticism» 9. We can see this displacement (barely disguised) as a recurrent theme throughout Kubrick’s work – not only in Dr. Strangelove, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964), 2001 A Space Odyssey (1968) and A Clockwork Orange but also as surely in the orgiastic and mechanical repetitions of his last film, Eyes Wide Shut (1999). This «mechano-eroticism», however, finds its most literal – and culturally stereotypical – figuration in A.I.’s Gigolo Joe. As Dery observes, «In recent years, the subrational ap6 L. SCHWARTZBAUM, Sci-fi channel, review of «A.I.: Artificial intelligence», in «Entertainment weekly», Summer Double Issue 2001, p. 110. 7 S. DALY, Humanoid nature, in «Entertainment weekly», July 13, 2000, p. 26. 8 Ivi, p. 28 sgg. 9 M. DERY, Sex machine, machine sex: mechano-eroticism and robo-copulation, in «Mondo 2000», 5 (n.d.), p. 43.
214
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
LOVE
MACHINES.
SPIELBERG/KUBRICK,
ARTIFICIAL INTELLIGENCE…
petites of the collective unconscious have given rise to a vast proliferation of mechano-erotic imagery […]. Man-machine miscegenation – robo-copulation, by any other name – may seem a seductive alternative to the vile body, locus of a postmodern power struggle involving aids, abortion rights, fetal tissue, genetic engineering, and nanotechnology» 10. And, I would also add, contemporary gender relations. Thus, in the imagination of male technophilia, as Dery put its: «The only thing better than making love like a machine […] is making love with a machine» 11. Or so, at first, it would seem. Certainly, although Spielberg de-emphasizes and romanticizes sex as much as he can, Gigolo Joe literalizes and fulfills the human male wish for a «hard body» always able to «get it up», to satisfy every female sexual need and desire (including, here, the desire for romance) without wearing out. In the male technophilic imagination, this is to make love like a machine, to have robotic power but, to have it «transparently» – that is, as one’s own male self but enhanced.. And, there is also a brief focus in A.I. on the companion male fantasy of making love with a machine – with a youthful, beautiful, pliant, and hollowed-out female body that doesn’t need romance or protestations of love, that won’t get headaches or pregnant or want to get married and that will, as Joe tells those teenage boys, literally «work under you, […] work on you, and […] work for you». Indeed, at the film’s beginning, Professor Hobby of Cybertronics demonstrates the simplicity and lack of emotional messiness that inheres in a female «mecha» who looks like a human woman but loves like a machine. Emphasizing her consciousness as preeminently material and literal, Professor Hobby asks her «What is love?», and she responds, before being stopped in her litany of «sensuality simulations»: «Love is first widening my eyes a little bit and quickening my breathing a little and warming my skin». This is, indeed, the robotic figure that Telotte sees as an image of the contemporary «anatomized, hollowed-out, modern self – an image that underscores [the] degree to which we all seem to have become mechanized, programmed beings, bodies detached from spirit» 12. Thus, as Geoffrey O’Brien observes: «Love, for 10 11 12
Ibidem. Ibidem. J.P. TELOTTE, Op. cit., p. 165.
215
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
VIVIAN SOBCHACK
A.I.’s purposes, is an involuntary emotional imprinting as cold as any other form of software programming» 13. Unlike Spielberg who, in his narratives, again and again pursues the resolution of damaged family romances «through» technology and its magical special «affects», Kubrick is much more interested in our displacement of human agency, care, and desire «onto» technology and its consequential special «effects». In Kubrick’s ironic cinematic visions, the robotic, the technological, and repetitively technical threaten to supercede the originality and spontaneity of the very human beings who brought them into existence. Indeed, the ironic Kubrick has always been a mordant jokester bent on pointing out human hubris and folly. Unlike Spielberg who believes in fairy tales and wish fulfillment (and tries desperately – and unsuccessfully – to achieve it in A.I., which is as much fairy tale as it is science fiction), the more Swiftian and Grimm Kubrick knows that wish fulfillment in fairy tales often grants desire exactly (and literally) what it asks for – and this often with dire consequences that are not only ironic but also poetically just. That is, unlike Spielberg, Kubrick knows about the return of the repressed, knows that wish fulfillment often comes back to bite you in the ass. That is, Kubrick knows that «matter never makes jokes», that it is «tragically serious», and that if it is played with and shaped for a joke, «the joke will […] be built in, will […] eat into it like fate, like destiny». Such is the case with the realization of the male technophilic fantasy of «love mechas» or sex machines in A.I. The repressed returns, the joke is built into the very parodic matter that is the humanly-formed Gigolo Joe, and wish fulfillment has its ironic consequences for both robot and man. The «arbitrary tyranny imposed on [this] helpless block», the tragic seriousness of the joke that is Joe’s fate, is that, for all his sexual prowess, he will forever stand as a hollowed-out parody of the men who dreamed him, a robotic figure that Telotte describes as a kind of exteriorized, «public body» fashioned in the «image of a generally empty human nature – and what is equally noteworthy, a generally masculine empty nature – that reflects the 13 G. O’BRIEN, Very special effects, in «The New York review of books», August 9, 2001, p. 13.
216
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
LOVE
MACHINES.
SPIELBERG/KUBRICK,
ARTIFICIAL INTELLIGENCE…
sort of controls that […] determine our lives» 14. Thus, hollowed-out, at the moment of his capture and impending destruction, all Joe can say to David is «I am…I was». But, along with the hollowed-out parody, there is also the tragic seriousness of the joke played by matter on the human men who constructed Joe in their idealized and wish-fulfilling image. The joke is that, as Joe says of «love mechas», «man made us better at what we do than was ever humanly possible». And thus, wish fulfillment comes back to literally give technophilic man exactly what he asked for and exactly what he deserves. Hence the Kubrickian irony that informs the reassuring words Gigolo Joe speaks to a first-time female client: «Once you’ve had a lover robot, you’ll never want a real man again». This is, indeed, not where technodreams begin but where they end – and it prognosticates, in A.I., not only the death of male hubris but also of humanity.
David: «The abandoned body» A.I.’s central figure (and the one in which we are tempted to invest our feelings) is David, a soft, prepubescent boy-child «mecha», also programmed to love but, in this instance, singularly, adoringly, insistently, unconditionally, and forever – his object of desire the human woman that his one-time-only, irreversibly indelible, imprinting identifies as «Mommy». It is this singular, adoring, insistent, unconditional, enduring – and «infantilized» – robotic love (realized yet again according to male technophilic fantasy) that – as Schulz puts it – is the «form», «expression», and «pretense» of «the arbitrary tyranny imposed on […] that helpless block» that is David and «that rules it like its own tyrannical, despotic soul». Professor Hobby describes David as the «perfect child caught in a freeze frame, always loving, never ill, never changing» – neither in his purpose nor his desire. And this is the tragically serious joke built into David and that eats into him «like fate, like destiny» – shaping A.I.’s overall narrative trajectory and its multiple and impossible endings. 14
J.P. TELOTTE, Op. cit., p. 151.
217
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
VIVIAN SOBCHACK
If Gigolo Joe is essentially a Kubrickian figure (softened, if not completely domesticated, by Spielberg), then David is essentially a Spielbergian figure (if made insistent, despairing, and a little creepy, by Kubrick). David’s form, expression, and pretense is, as Geoffrey O’Brien notes, is not only «the embodiment of the golden child who has haunted the American imagination in these latter decades: the inner child, the abandoned child, the illuminated child», but also that «Spielberg certainly grasps the implications of that fetish, since he has done more than his share to reinforce the myth of childhood as a privileged sphere of imaginative freedom, moral courage, [and] uncorrupted emotion» 15. This particular fetish of the American imagination, however, seems particularly male – emerging, perhaps, as both a self-critical response to the first-wave feminist critique of a hard-bodied and power-mad patriarchy and a phenomenologicallylived response to a newly-perceived and fearful sense of patriarchy’s present impotence and powerlessness. David is literally a «born again» – yet motherless – boy-child, at once both pure and new and cleansed of patriarchal imprinting and helpless, soft, and thus (in relation to patriarchy) inevitably abandoned and lost. (Several times during the film, in moments of robotic terror, David cries out «Keep me safe, keep me safe».) Thus, it is no small, if subdued, fact that, in relation to David, A.I. not only displaces David’s infantilized and feminized desire and terror at abandonment onto «Mommy», but also that it continually elides (while still significantly figuring) David’s two nominal «fathers», Henry and Professor Hobby – both of whom, in different ways, have abandoned or lost their human sons. For David, «Daddy» – and other human males – are simply not in this picture. Thus, in the film’s final and truly ambiguous ending, when – thousands of years after his journey began and human beings no longer exist – David is found literally frozen in his desire by future artificial intelligences and told that is the only «enduring memory of the human race», this fact is indeed chilling. For in David’s enduring memory, the world remembered is completely man-less. Reunited for a single perfect day with an illusory resurrection of his now-loving «Mommy» (details taken from his robot-child’s memory), David lives 15
G. O’BRIEN, Op. cit., p. 13.
218
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
LOVE
MACHINES.
SPIELBERG/KUBRICK,
ARTIFICIAL INTELLIGENCE…
a faux fairy-tale mise en scène in which the narrator – in voice-over – tells us that there was no Henry, there was no Martin (David’s rival human «brother»), «there was only David». Thus, it is only in fantasy – here a robot-fantasy ironically programmed (and filmed) by adult human males – that David can momentarily (and falsely) realize his programmed identity, but this is a realization that neither David nor the film can sustain, a realization that can only be forever suspended. In her wonderful book On longing, an exploration of what she calls the «social disease of nostalgia» 16, literary critic Susan Stewart writes what might well serve as a gloss on the impossible dilemma that faces both Spielberg, the adult human male filmmaker, and David, the male robot-child character at the end of A.I.: In the play of identity and difference out of which the subject «appears» at any given point, the relation between childhood and the present, a relation which is and is not a repetition, constitutes an imaginary an either end: for the child, the mother as object of desire; for the adult, the image of the past, the dual relation before it was lost […]. And out of this adult desire springs the demand for an object – not an object of use value, but a pure object, an object which will not be taken up in the changing sphere of lived reality but rather will remain complete at a distance. In this way, it resembles childhood, which will not change 17.
Thus when the crazed father in The street of crocodiles asks: «Can you imagine the pain, the dull imprisoned suffering, hewn into the matter of that dummy which does not know why it must be what it is», it is clear that he understands a great deal more about the consequences of nostalgic replication than does either of David’s more rational «fathers». And thus David – as does the film – can never become more (or less) than «a machine for unfulfilled longing» 18. Indeed, he spends the entire film attempting to refuse his robotic existence and fate and disavowing his status as, indeed, a replication that possesses no originality. Not only is he a robotic simulacrum of Professor Hobby’s dead son, but he is also a prototype who, toward 16 S. STEWART, On longing: narratives of the miniature, the gigantic, the souvenir, the collection, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1984, p. 17. 17 Ivi, pp. 125 sgg. 18 G. O’BRIEN, Op. cit., p. 13.
219
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
VIVIAN SOBCHACK
A.I.’s, end, is revealed as merely the first among equals in rows and rows of waiting-to-be animated Davids. Yet David keeps insisting – first to Joe and then to the animate robotic twin he finds sitting in Professor Hobby’s office and tries to destroy – «I’m the only one… I’m special. I’m unique. I’m David». Indeed, when Stewart writes that «nostalgia is the repetition that mourns the inauthenticity of all repetition and denies the repetition’s capacity to form identity» 19, she might well be speaking of David’s – and A.I.’s – ultimate dilemma as «a machine for unfulfilled longing». The film can never be narratively satisfied and thus «ends» three times and yet not at all: first with David’s attempted suicide «after realizing he is merely the prototype for an endless line of mass-produced replicas» 20; then with his frozen suspension for two thousand years under the ocean, his gaze locked with an amusement park Blue Fairy; and finally with his embrace of undecidable sleep and/or death, with the possible dream of narrative’s beginning – and/or its possible end. And so there is little narrative satisfaction in David’s finally achieving, as the narrator puts it, «the everlasting moment he had been waiting for» – the moment when «Mommy», now recreated in the shape of his own desire, tells him as she drifts off to a sleepy death, «I love you, David. I do love you. I have always loved you». As critic David Denby writes, what we have in the end is «a ponderous death-of-the-world fantasy, which leaves us with nothing but an Oedipal robot – hardly a redemption. […] That Kubrick gave up on the human race will not come as a surprise, but Spielberg is a different story» 21. Thus, the strange contradiction and complementarity when David’s «Mommy» falls asleep to die and David, lying down beside her, dies to fall asleep – the narrator reversing the trajectory of human time and existence with the film’s final words: «So David went to sleep too and, for the first time, he went to that place where dreams are born». But that place, we should remember, rounded with a sleep, is where, perchance, all dreams also end. As Stewart points out: «The direction of force in the desiring narrative is always a future-past, a de19 20 21 22
S. STEWART, Op. cit., p. 23. G. O’BRIEN, Op. cit., p. 13. D. DENBY, Face/off, in «The New Yorker», July 2, 2001, p. 87. S. STEWART, Op. cit., p. x.
220
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
LOVE
MACHINES.
SPIELBERG/KUBRICK,
ARTIFICIAL INTELLIGENCE…
ferment of experience in the direction of origin and thus eschaton, the point where narrative begins/ends» 22. Whether we interpret it as sleep or death, the future-past, at the end of A.I., David, who despairingly refuses to accept what he really is and whose desperate desire to be otherwise can never be satisfied, is allowed «the only small miracle permitted him: […] blissful unconsciousness» 23. The tragically serious joke built into David and that eats into his «mecha» existence and informs his (and the film’s) fate is not only that, unlike Gigolo Joe, he refuses his parodic existential status as a love machine. It is also that again – as with Joe – there are unforeseen, uncalculated, and cruel consequences to being a love machine. That is, loving «like» a machine (that is, with horrifying, insistent, and unchanging mechanical adoration), David’s identity is completely dependent upon being loved in return by the object of his programmed desire – yet, because he «is» a machine, this is an impossibility. As Joe tells David of his human «Mommy»: «She loves what you do for her as my customers love what it is I do for them. But she does not love you, David. She cannot love you. You are neither flesh nor blood. You are not a dog or a cat or a canary. You were designed and built specific like the rest us». Yet while David has been programmed with the capacity to love, he is not programmed «to understand why his adoptive human mother fails to love him back» 24. Thus, both Spielbergian pathos and Kubrickian irony converge in the tragic joke that informs David and makes of the robot – and A.I. itself – not only a nostalgic «machine for longing» but also an ironically impossible object.
Requiem for the «authentic body» Deconstructing the machinery of longing, Stewart tells us (as if she were writing directly about David, as well as about A.I.’s final and impossible mise en scène):
23 24
G. O’BRIEN, Op. cit., p. 13. Ibidem.
221
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
VIVIAN SOBCHACK
The prevailing motif of nostalgia is that erasure of the gap between nature and culture, and hence a return to the utopia of biology and symbol united within the walled city of the maternal. The nostaligic’s utopia is prelapsarian, a genesis where lived and mediated experience are one, where authenticity and transcendence are both present and everywhere 25.
Yet this utopian vision is ultimately melancholic; that is, as Stewart suggests, it «turns toward a future-past, a past which has only ideological reality» 26. And while David would rather sleep forever than to acknowledge that this past has only ideological reality, Kubrick, Spielberg, and the film do not so blissfully escape the melancholy that comes with knowledge. A.I., its entire narrative located in a future-past by an off-screen narrator, is thus filled with tears – with weeping that is, at once, both intimate and oceanic. Indeed, at the film’s beginning, we are told that global warming has caused the oceans to inundate the earth’s coastal cities – including New York (Manhattan referred to, later in the film, as «the end of the world where the lions weep». Melancholia pervades A.I. and tears are everywhere and yet displaced – and often frozen. It is thus particularly ironic that, at the beginning of the film, when Monica (later to become David’s «Mommy») pays a visit to her son Martin, cryogenically frozen until a cure is found for his illness, she is told by the doctor: «Mourning is not appropriate. Martin is still pending». Yet mourning work in the present for the future-past, for a lost humanity (inscribed as male), seems to be the film’s over-arching narrative project and achievement. (One of the film’s most lingering images is David floating as if drowned, motionless and alone at the bottom of a backyard swimming pool.) Mid-way through A.I., inspired by Pinocchio, David goes in search of the Blue Fairy who will supposedly make him a real boy. Gigolo Joe suggests they go to Rouge City so they can quiz Dr. Know (a holographic data-base reminiscent of the Wizard of Oz but fashioned to look like a cartoon Einstein who is supposed to know everything). Glossing Blue Fairy and its possibilities (which include both a plant and the Blue Fairy Escort Service), Dr. Know tells them 25 26
S. STEWART, Op. cit., p. 23. Ibidem.
222
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
LOVE
MACHINES.
SPIELBERG/KUBRICK,
ARTIFICIAL INTELLIGENCE…
that «In the world of orga, blue is the color of melancholy». Blue is also the color of water and of weeping, a sepulchral color, the color of cold and ice. It is the film’s visual dominant – even in David’s bedroom, even in Rouge City, and especially underwater in the ocean where David finally finds the amusement park Blue Fairy and prays to her without effect forever: «until the oceans froze» and he, like the Fairy, becomes a «blue ghost in ice». Stewart writes: «Nostalgia is a sadness without an object, a sadness which creates a longing that of necessity is inauthentic because it does not take part in lived experience. Rather, it remains behind and before that experience […]» 27. Thus it is narratively poetic when, combining two contradictory categories of Dr. Know’s database (the one «Flat Fact», the other «Fairy Tale»), David and Joe are let in on the «real» secret of the Blue Fairy’s location. Yet it is telling that this revelation is first introduced with a poem whose address is both powerfully moving and deeply inauthentic because it is meant for the present (and human) spectators of A.I. and not for the artificial intelligences that read its mournful words. Inscribed also over the entrance to Professor Hobby’s office located at the end of the world, it reads: Come away O human child To the waters and the wild With a fairy hand in hand For the world’s more full of weeping Than you can understand.
There is, in the end, a mordant irony informing A.I.’s nostalgic and prelapsarian yearning. The joke built into the film – and it is tragically serious – is that «it remains “behind” and “before”» contemporary experience, behind and before its own present technophilic male fantasies of the «hollowed-out» and the «abandoned» body. Thus, the «behind» and «before» that is A.I.’s future-past says something significant about what is perceived as a future-impossible present. Stewart writes: 27
Ibidem.
223
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
VIVIAN SOBCHACK
As experience is increasingly mediated and abstracted, the lived relation of the body to the phenomenological world is replaced by a nostalgic myth of contact and presence. «Authentic» experience becomes both elusive and allusive as it is placed beyond the horizon of present lived experience, the beyond in which the antique, the pastoral, the exotic, and other fictive domains are articulated. In this process of distancing, the memory of the body is replaced by the memory of the object 28.
Thus, A.I.’s nostalgia and melancholia. As O’Brien aptly describes it, the film is«an ideogram of grief, disguised as a Hallmark card» 29. Suspended between a Kubrickian critique of technological man and his Spielbergian redemption, viewed by those of us in the present, A.I. merges and confuses its contradictions to become a work of both science fiction and fairy tale that is achingly ironic.
28 29
S. STEWART, Op. cit., p. 133. G. O’BRIEN, Op. cit., p. 13.
224
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
MACCHINE DELL’AMORE. SPIELBERG/KUBRICK, INTELLIGENZA ARTIFICIALE E ALTRI OSSIMORI DEL CINEMA di VIVIAN SOBCHACK
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
Nello straordinario libretto di Bruno Schulz, La via dei coccodrilli, il padre dell’autore (che crede che i manichini debbano essere trattati come persone) mette in guardia i suoi figli: La materia non scherza mai; è sempre piena di tragica serietà. Chi oserebbe pensare di poter giocare con la materia, di poterla forgiare per gioco, senza che il gioco diventi parte di essa e la distrugga come il fato, il destino? Riuscite a immaginare il dolore, la sofferenza sorda racchiusa, incisa nella materia di quel manichino che non sa perché esso debba essere ciò che è, perché debba restare in quella forma imposta con la forza che non è nulla di più di una parodia? Capite il potere della forma, dell’espressione, dell’apparenza, la tirannia arbitraria imposta sopra un blocco indifeso che ne viene dominato come essa fosse la sua stessa anima dispotica e tiranna? 1.
Quanto segue intende esplorare sia il «gioco» sia la «tragica serietà» di due manichini culturalmente significativi creati insieme da due grandi registi americani nel recente film di fantascienza A.I. Artificial intelligence (A.I. Intelligenza artificiale, 2001). I registi sono, ovviamente, Stanley Kubrick che ha lavorato per molti anni alla pre-produzione del film, fino alla sua morte avvenuta nel 1999 e Steven Spielberg che ha scritto la sceneggiatura definitiva e ha diretto il film. I manichini culturalmente significativi sono, in questo caso, due robot maschi molto svegli: entrambi «intelligenze artificiali», la cui «forma imposta con la forza» è umana, ed entrambi programmati come ciò che in questa sede chiameremo – per gioco e con tragica serietà – «macchine dell’amore». A ogni modo, come le rispettive opere e attitudini cinematografiche dei due registi, queste macchine dell’amore non potevano essere più contrastanti sia nella forma sia 1 B. SCHULZ, The street of crocodiles, trans. Celina Wieniewska, Penguin, London 1977 (Walker and Company 1977), p. 64.
227
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
VIVIAN SOBCHACK
nella funzione. Tuttavia, come i registi, in A.I. la loro apparente opposizione binaria si concilia completandosi ed entra in contraddizione comunicandoci qualcosa di importante (e di triste) sull’immaginazione tecnologica (e maschile) dell’America contemporanea e sulle sue visioni inconciliabili e irresolute di un futuro impossibile e inumano. In altre parole, tale opposizione esprime la più importante «nostalgia» dell’immaginazione del nostro tempo per una umanità che è stata svuotata e abbandonata e per un futuro che può essere sempre e unicamente concepito come già passato. J.P. Telotte nel suo Replications: a robotic history of the science fiction film, sostiene che «l’immagine dell’artificio umano, rappresentato dalla lunga serie di robot, androidi ed esseri artificiali incontrati nella storia del cinema di fantascienza, è l’immagine più importante di questo genere di film» 2. Utilizzando i termini che abbiamo preso in prestito sopra, Telotte vede il robot, in particolare, come «una metafora o un meccanismo per rivelare una natura umana che è stata in gran parte svuotata dell’identità, un corpo abbandonato» 3, un’immagine precisa dell’«io moderno, anatomizzato, svuotato […] che evidenzia sino a che grado tutti siamo diventati esseri meccanizzati, programmati, corpi staccati dallo spirito» 4. Comunque, se dobbiamo essere fantasiosi oltre che letterali, potremmo anche comprendere che la metafora del corpo robotico abbandonato non è necessariamente sinonimo di corpo robotico svuotato o vuoto. Anzi, ognuno può generare specifiche narrazioni delle nostre relazioni immaginarie con la tecnologia, narrazioni contraddittorie, se pure complementari, nelle loro convergenze. È questo il caso delle storie originate dai due protagonisti robotici di A.I., un film di fantascienza molto atteso che è stato, per la maggior parte degli spettatori (sia tra i critici sia tra il pubblico), una grande delusione – criticato non solo per essere, al tempo stesso, troppo freddo e sentimentale, ma anche per essere inadeguato a integrare quello che un critico ha definito «ironia kubrickiana e sdolcinatezza spielberghiana» 5, infine per essere incerto dal punto di vista narrativo e per non riuscire, apparentemente, a concludersi. Eppure, questo è esattamente ciò che rende A.I. così interessante poiché il film
2 J.P. TELOTTE, Replications: A robotic history of the science fiction film, University of Illinois Press, Urbana and Chicago 1995, p. 5. 3 Ivi, p. 150 sgg. 4 Ivi, p. 165 sgg. 5 T. BURR, Electric Youth, in «Entertainment weekly», March 8, 2002, p. 51.
228
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
MACCHINE
DELL’AMORE.
SPIELBERG/KUBRICK,
INTELLIGENZA ARTIFICIALE…
evidenzia due visioni culturali della nostra esistenza tecnologica simulata affatto diverse e contraddittorie, che convergono entrambe con forza ambivalente al fine di svuotare, abbandonare, oltraggiare e dolersi per un genere umano sempre già caduto e perduto. Tali visioni contraddittorie (che sono, di fatto, complementari nei loro intenti) sono incarnate e rappresentate letteralmente dai due protagonisti robotici del film – l’uno un «corpo vuoto» anatomizzato come sempre vigoroso: Gigolo Joe, un amante straordinario raffigurato da un’instancabile macchina del sesso adulta che ama il suo lavoro finché non viene incastrata e ricercata per l’assassinio di una delle sue clienti; l’altro, un «corpo abbandonato»: David, un bambino dell’amore meccanico che viene letteralmente abbandonato nella foresta dalla «Mamma» umana e che da quel momento cerca (avendo come modello Pinocchio) di diventare il «bambino vero» che, secondo lui, la donna amerà. Joe e David – due «macchine dell’amore» affatto diverse – si incontrano nel bosco per cominciare un viaggio che alla fine condurrà non solo a ciò che la narrazione chiama «la fine del mondo», ma anche alla fine dell’umanità stessa.
Gigolo Joe: «Il corpo vuoto» Benché David sia il protagonista principale del film, ci sia consentito di cominciare da Gigolo Joe, il «simulatore» creato come una divertente «parodia» o un «gioco» (seppure, in definitiva, spaventoso) della mascolinità tecnofila, e che, di conseguenza, è la figura robotica più stereotipata e semplice. Joe è un «mecca dell’amore» che soddisfa unicamente donne «orga» (o umane), fornisce la sua musica d’atmosfera personale (inclusa una versione degli anni Trenta di I only have eyes for you) e dice alle sue nuove clienti: «Una volta avuto un amante robot non vorrai mai più un vero uomo». Joe è una macchina del sesso e ne è consapevole; sveglio, acuto e autoreferenziale, un cinico travestito da romantico che, nel corso di tutto il film, non desidera mai di essere «veramente umano». Anzi, consapevole della natura e delle speciali funzioni del potere sessuale dei «mecca», le spiega chiaramente a un gruppo di ragazzini alla ricerca di esperienze eccitanti dai quali sta cercando di farsi dare un passaggio in macchina fino a Rouge City (una Disneyland simile a un bordello, costruita esclusivamente per il divertimento degli adulti): «Ci sono ragazze della vostra età [a Rouge City] che sono come me. Noi siamo gli schietti piaceri dell’essere umano solitario. Non ci ingraviderete mai e
229
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
VIVIAN SOBCHACK
non ci avrete mai a cena con mamma e papà. Lavoriamo sotto di voi, lavoriamo su di voi e lavoriamo per voi. L’uomo ci ha creati bravi in ciò che facciano più di quanto fosse umanamente possibile». Nato non da una donna, ma da un «uomo» e da una società del New Jersey chiamata Cybertronics, Gigolo Joe, come ha suggerito un critico, viene «mandato su di giri […] con brillante isteria e uno splendore di volta in volta sudaticcio e sexy […]. Joe sa con sicurezza inumana di essere programmato per un mondo freddo, vertiginoso e senza madri, di violento sentire kubrickiano» 6. Per meglio dire, Joe è una figura kubrickiana – un’estensione robotica dell’amorale ed elettrizzato Alex di A Clockwork Orange (Arancia meccanica, 1971), perfettamente adatto alla società che lo ha creato, lo merita e lo teme. Di conseguenza, è illuminante che, come inizialmente concepito da Kubrick, Gigolo Joe fosse «molto più aggressivo [e] sinistro» 7 di quanto non si riveli nel film, che mitiga la sua inquietudine e suggerisce, secondo l’intenzione di Spielberg, che «lui non è un gigolo da pornografia [ma] un romantico» 8. In altre parole, per usare una frase particolarmente singolare in relazione a un lavoratore del sesso mercenario, Joe sarebbe un mascalzone dal «cuore d’oro». Kubrick, naturalmente, si è a lungo interessato alle perverse proiezioni dell’Eros da parte della società contemporanea industriale e postindustriale sulla tecnologia e la tecnica, ciò che il filosofo Mark Dery definisce il nostro «meccano-erotismo» 9. È possibile considerare tale proiezione (appena velata) come un tema ricorrente dell’intera opera kubrickiana – non solo in Dr. Strangelove, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (Il dottor Stranamore, ovvero come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba atomica, 1964), in 2001 A Space Odyssey (2001 Odissea nello spazio, 1968), ma anche e senza alcun dubbio nelle ripetizioni orgiastiche e meccaniche del suo ultimo film Eyes Wide Shut (1999). Questo «meccano-erotismo», comunque, trova la sua più fedele – e culturalmente stereotipata – raffigurazione nel Gigolo Joe di A.I. Come ha osservato Dery, «Negli ultimi anni, gli appetiti irrazionali dell’inconscio collettivo hanno dato origine a una vasta proliferazione di im-
6 L. SCHWARTZBAUM, Sci-fi channel, rivista di «A.I.: Artificial intelligence», in «Entertainment weekly», Summer Double Issue 2001, p. 110. 7 S. DALY, Humanoid nature, in «Entertainment weekly», July 13, 2000, p. 26. 8 Ivi, p. 28 sgg. 9 M. DERY, Sex machine, machine sex: meccano-eroticism and robo-copulation, in «Mondo 2000», 5 (n.d.), p. 43.
230
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
MACCHINE
DELL’AMORE.
SPIELBERG/KUBRICK,
INTELLIGENZA ARTIFICIALE…
magini meccano-erotiche […]. L’uomo-macchina frutto dell’incrocio di diverse «razze» – robo-copulazione, la si chiami come si vuole – può sembrare un’alternativa seducente al vile corpo, luogo di una lotta di potere postmoderna che coinvolge l’aids, i diritti all’aborto, il tessuto fetale, l’ingegneria genetica e la nanotecnologia» 10. A ciò aggiungeremmo la contemporanea relazione tra i sessi. Di conseguenza, nell’immaginazione tecnofila maschile, come suggerisce Dery: «La sola cosa migliore del fare l’amore come una macchina […] è fare l’amore con una macchina» 11. O almeno così sembrerebbe in un primo momento. Sicuramente, benché Spielberg per quanto possibile ridimensioni e romanticizzi il sesso, Gigolo Joe rappresenta letteralmente e appaga il desiderio maschile di un «corpo vigoroso» costantemente in grado di «darci dentro», di soddisfare qualunque bisogno e desiderio femminili (incluso, qui, il desiderio di romanticismo) senza stancarsi. Nell’immaginazione tecnofila maschile, questo vuol dire fare l’amore «come» una macchina, possedere una potenza robotica, ma possederla «in modo evidente» – ossia, come identità maschile, però esasperata. A.I. pone brevemente l’accento anche sulla fantasia che accompagna il maschio di fare l’amore con una macchina – con un corpo femminile, giovane, bello, arrendevole e svuotato che non ha bisogno di poesia o dichiarazioni d’amore, che non avrà mai mal di testa e non resterà incinta o vorrà sposarsi e che, come racconta Joe a quegli adolescenti «lavora sotto di te, […] lavora su di te a […] lavora per te», nel vero senso della parola. In effetti, all’inizio del film, il Professor Hobby della Cybertronics dimostra la semplicità e la mancanza di confusione emotiva proprie di un «mecca» femmina che ha l’aspetto di una donna umana, ma ama come una macchina. Enfatizzando la sua coscienza prevalentemente materiale e schematica, il Professor Hobby le chiede «Cos’è l’amore?», e lei risponde, prima che la sua litania di «simulazioni di sensualità» sia interrotta: «L’amore è spalancare leggermente gli occhi, accelerare un po’ la respirazione e riscaldare la pelle». Questa è sicuramente la figura robotica che Telotte vede come un’immagine del contemporaneo «io moderno anatomizzato, svuotato – un’immagine che evidenzia sino a che grado tutti siamo diventati esseri meccanizzati, programmati, corpi separati dallo spirito» 12. Pertanto, come osserva Geoffrey O’Brien «L’amore, secondo gli intenti di A.I., è un imprinting emozionale 10 11 12
Ibidem. Idibem. J.P. TELOTTE, Op. cit., p. 165.
231
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
VIVIAN SOBCHACK
involontario, freddo come qualunque altra forma di programmazione di software» 13. A differenza di Spielberg, che nelle sue narrazioni persegue continuamente la risoluzione di idilli familiari compromessi «attraverso» la tecnologia e i suoi magici «affetti» speciali, Kubrick è molto più interessato alla nostra proiezione di potere, attenzione e desideri umani «sulla» tecnologia e ai suoi conseguenti «effetti» speciali. Nelle ironiche visioni cinematografiche di Kubrick, il robotico, il tecnologico e la ripetizione meccanica minacciano di soppiantare l’originalità e la spontaneità degli stessi esseri umani che li hanno generati. In verità, il Kubrick ironico è sempre stato un istrione mordace determinato a mostrare la follia e l’ambizione dell’umanità. A differenza di Spielberg che crede nei racconti di fate e nella realizzazione del desidero (e cerca disperatamente, e senza successo, di raggiungerla in A.I., che è tanto racconto di fate quanto fantascienza), Kubrick, più swiftiano e simile a Grimm, sa che nei racconti di fate la realizzazione del desiderio spesso concede al desiderio esattamente (e letteralmente) ciò che esso chiede, e spesso con terribili conseguenze che non sono solo ironiche, ma anche calzanti dal punto di vista poetico. Vale a dire che, a differenza di Spielberg, Kubrick conosce il riemergere del rimosso, sa che la realizzazione del desiderio spesso ci si ritorce contro. In altre parole, Kubrick sa che la «materia non scherza mai», che è «tragicamente seria» e che se si gioca con essa e la si plasma per gioco, «il gioco […] diventerà parte di essa, […] la distruggerà come il fato, il destino». È questo il caso della realizzazione, in A.I., della fantasia tecnofila maschile dei «mecca dell’amore» o macchine del sesso. Il rimosso riemerge, il gioco diventa parte dalla materia parodica che è il Gigolo Joe dalla forma umana e la realizzazione del desiderio ha le sue ironiche conseguenze sia per il robot sia per l’uomo. La «tirannia arbitraria imposta su [questo] blocco indifeso», la tragica serietà di quello scherzo che è il destino di Joe è che, malgrado la sua abilità sessuale, egli resterà per sempre una parodia svuotata degli uomini che lo sognarono, una figura robotica che Telotte descrive come una sorta di «corpo pubblico» esteriorizzato, foggiato a «immagine di una natura umana totalmente vuota – e ciò che è egualmente degno di nota, una natura vuota principalmente maschile – che rivela il genere di autorità che […] determina la nostra vita» 14. E così, svuo13
G. O’BRIEN, Very special effects, in «The New York review of books», August 9, 2001,
14
J.P. TELOTTE, Op. cit., p. 151.
p. 13.
232
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
MACCHINE
DELL’AMORE.
SPIELBERG/KUBRICK,
INTELLIGENZA ARTIFICIALE…
tato, al momento della sua cattura e dell’imminente distruzione, tutto quello che Joe riesce a dire a David è «Io sono… Io sono stato». Ma insieme alla parodia svuotata, c’è anche la tragica serietà dello scherzo giocato dalla materia agli uomini che costruirono Joe in base all’immagine idealizzata di se stessi, dando così vita ai loro desideri. Lo scherzo consiste nel fatto che, per usare le parole di Joe sui «mecca dell’amore», «l’uomo ci ha creati bravi in ciò che facciamo più di quanto fosse umanamente possibile». La realizzazione del desiderio torna così indietro per dare letteralmente all’uomo tecnofilo esattamente ciò che ha chiesto ed esattamente ciò che merita. Di qui l’ironia kubrickiana che pervade le parole rassicuranti pronunciate da Gigolo Joe a una cliente che va da lui per la prima volta: «Una volta che hai avuto un amante robot, non vorrai mai più un vero uomo». A dire il vero, questo non indica dove iniziano i tecno-sogni, ma dove finiscono e preannunzia, in A.I., non solo la morte dell’ambizione maschile, ma anche dell’umanità.
David: «Il corpo abbandonato» La figura centrale di A.I. (e l’unica sulla quale siamo tentati di investire i nostri sentimenti) è David, un tenero «mecca» bambino preadolescente, anche lui programmato per amare ma, in questo caso, in modo singolare, intensamente, insistentemente, incondizionatamente e per sempre – oggetto del suo desiderio: la donna umana che il suo unico imprinting, indelebile in maniera irreversibile, identifica come «Mamma». È questo singolare, adorante, insistente, incondizionato, perpetuo, e «infantilizzato», robotico amore (realizzato, ancora una volta, secondo la fantasia tecnofila maschile) che – come suggerisce Schulz – costituisce la «forma», l’«espressione» e l’«apparenza» della «tirannia arbitraria imposta su […] quel blocco indifeso» che è David e «che lo governa come fosse la sua stessa tirannica, dispotica anima». Il Professor Hobby descrive David come il «bambino perfetto racchiuso in un fermo immagine, sempre affettuoso, mai ammalato, immutabile» sia nella volontà sia nel desiderio. E questo è il gioco tragicamente serio che è parte di David e che lo distrugge «come il fato, il destino», disegnando il percorso narrativo globale di A.I. e le sue molteplici e impossibili conclusioni. Se Gigolo Joe è una figura essenzialmente kubrickiana (addolcita, se non completamente addomesticata, da Spielberg), David è una figura essenzialmente spielberghiana (se pure resa insistente, disperata e un tanti-
233
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
VIVIAN SOBCHACK
no orripilante da Kubrick). La forma, l’espressione e l’apparenza di David, come nota Geoffrey O’Brien, non sono solo «l’incarnazione del bambino d’oro che ha ossessionato l’immaginazione americana in questi ultimi decenni: il bambino interiore, abbandonato, illuminato», ma anche il segno che «Spielberg certamente comprende le implicazioni di quel feticcio, poiché ha rafforzato oltremodo il mito dell’infanzia come sfera privilegiata della libertà immaginativa, del coraggio morale […] e dell’emozione incorrotta» 15. Questo peculiare feticcio dell’immaginazione americana, comunque, risulta specificatamente maschile – emergendo forse sia come risposta autocritica da parte del pensiero femminista della prima generazione a un patriarcato dal corpo vigoroso e bramoso di potere, sia come risposta vissuta in modo fenomenologico a un senso spaventoso, di recente percepito, dell’attuale impotenza e mancanza di autorità del patriarcato. David è un bambino «rinato» nel vero senso della parola, tuttavia senza madre, tanto puro e nuovo quanto purificato dall’imprinting patriarcale, indifeso, tenero e pertanto (in relazione al patriarcato) inevitabilmente abbandonato e perduto. (Nel corso del film diverse volte, nei momenti di terrore robotico, David urla: «Tienimi al sicuro, tienimi al sicuro».) Dunque non è un fatto trascurabile o privo di significato che, in riferimento a David, A.I. non solo proietti il desiderio infantilizzato ed effeminato e la paura dell’abbandono sulla «Mamma», ma che elida di continuo (benché li rappresenti pur sempre significativamente) i due «padri» nominali di David, Henry e il Professor Hobby – che hanno entrambi, ma in maniere diverse, abbandonato o perduto i loro figli umani. Per David, il «Papà» – come ogni altro maschio umano – rimane semplicemente ai margini. Successivamente, nel definitivo e decisamente ambiguo finale del film quando – dopo migliaia di anni dall’inizio del suo viaggio, allorché l’umanità non esiste più – David viene ritrovato da intelligenze artificiali del futuro letteralmente congelato nel suo desiderio e gli viene detto che lui è la sola «memoria immutabile della razza umana», la cosa risulta decisamente agghiacciante. Poiché nella memoria immutabile di David, il mondo ricordato è completamente privo di uomini. Riunito per un unico giorno perfetto a una illusoria resurrezione della «Mamma» che lo ama in quel momento (particolari presi dalla sua memoria di robot-bambino), David vive la mise en scène di un racconto di fate faux in cui il narratore – con voce fuori campo – ci racconta che non esisteva nessun Henry, non 15
G. O’BRIEN, Op. cit., p. 13.
234
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
MACCHINE
DELL’AMORE.
SPIELBERG/KUBRICK,
INTELLIGENZA ARTIFICIALE…
esisteva nessun Martin (il «fratello» umano rivale di David), «esisteva soltanto David». Dunque, è solo nella fantasia – qui una fantasia-robot ironicamente programmata (e filmata) da maschi umani adulti – che David può momentaneamente (e falsamente) realizzare la sua identità programmata, ma questa è una comprensione che né il film, né David possono sostenere, una consapevolezza che può restare solo sospesa per sempre. Nel suo meraviglioso libro On Longing, un’esplorazione di ciò che lei chiama la «malattia sociale della nostalgia» 16, il critico letterario Susan Steward scrive qualcosa che può benissimo fungere da chiosa all’impossibile dilemma di fronte al quale si trovano sia Spielberg, il regista adulto, maschio e umano, sia David, il personaggio robot-bambino, alla fine di A.I.: Nel gioco di identità e differenze dal quale il soggetto «emerge» in una data situazione, il rapporto tra infanzia e presente, un rapporto che è e tuttavia non è una ripetizione, rappresenta un duplice fine immaginario: per il bambino, la madre come oggetto del desiderio; per l’adulto, l’immagine del passato, il rapporto duale prima che fosse perduto […]. E da questo desiderio adulto scaturisce la richiesta di un oggetto – non un oggetto utile, ma un oggetto puro, un oggetto che non sia coinvolto nella sfera mutevole della realtà vissuta, perfetto, inarrivabile. In tal modo, esso assomiglia all’infanzia che rimane immutabile 17.
Così, quando il padre folle di La via dei coccodrilli chiede: «Riuscite a immaginare il dolore, la sofferenza sorda imprigionata, incisa nella materia di quel manichino che non sa perché esso debba essere ciò che è», è evidente che l’uomo comprende molto di più circa le conseguenze della riproduzione nostalgica di quanto non facciano entrambi i «padri» più razionali di David. E così David – come il film – non può mai diventare più (o meno) di «una macchina dei desideri non realizzati» 18. Di conseguenza, durante l’intero film cerca di rifiutare la sua esistenza e il suo destino robotico e ripudiare la sua condizione di replica, appunto, che non possiede originalità. Lui non è solo il simulacro robotico del figlio morto del Professor Hobby, ma è anche un prototipo che, verso la fine di A.I., viene mostrato semplicemente come la prima di numerose copie di 16 S. STEWART, On longing: narratives of the miniature, the gigantic, the souvenir, the collection, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1984, p. 17. 17 Ivi, p. 125 sgg. 18 G. O’BRIEN, Op. cit., p. 13.
235
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
VIVIAN SOBCHACK
David che aspettano, disposte lungo interminabili file, di essere animate. David tuttavia continua a insistere, prima con Joe e poi con il suo gemello robotico animato che trova seduto nello studio del Professor Hobby e che tenta di distruggere: «Sono l’unico… Sono speciale. Sono unico. Sono David». Certamente quando Steward scrive che «la nostalgia è la replica che lamenta l’inautenticità di qualunque replica e nega la capacità della replica di costituire un’identità» 19, potrebbe benissimo parlare del dilemma ultimo di David, e di A.I., come «macchina dei desideri non realizzati». Il film non può mai essere pago dal punto di vista narrativo per cui «finisce» tre volte e tuttavia non finisce affatto: prima con il tentato suicidio di David «dopo aver compreso di essere semplicemente il prototipo di una produzione industriale di repliche» 20; poi con la sua sospensione congelata per duemila anni sotto l’oceano, lo sguardo fisso sulla Fata Turchina di un parco dei divertimenti; infine, con il suo abbraccio di sonno e/o di morte, con il sogno possibile dell’inizio della narrazione – e/o la sua possibile fine. C’è dunque scarsa compiutezza narrativa nel raggiungimento finale da parte di David, come espone il narratore, del «momento eterno che lui aveva atteso», il momento in cui la «Mamma» – ricreata nell’immagine del suo desiderio – gli dice mentre si dissolve in un sonno di morte, «Ti voglio bene, David. Ti voglio bene. Ti ho sempre voluto bene». Come scrive il critico David Denby, ciò che viene rappresentato alla fine è «una tediosa visione della morte del mondo, che ci lascia senza null’altro che un edipico robot – che difficilmente può rappresentare una redenzione. […] Che Kubrick avesse rinunciato a capire il genere umano non è una novità, ma il caso di Spielberg è diverso» 21. Ne consegue la strana contraddizione e complementarietà quando la «Mamma» di David si addormenta per morire e David, disteso accanto a lei, muore per addormentarsi – mentre il narratore ribalta il corso del tempo e dell’esistenza umana con le parole conclusive del film: «Così anche David andò a dormire e, per la prima volta, andò nel luogo dove nascono i sogni». Ma quel luogo, bisogna ricordarlo, circondato da un sonno è, forse, anche il luogo dove tutti i sogni finiscono. Come chiarisce Steward: «La direzione obbligata nella narrazione del desiderio è sempre un futuro-passato, una dilazione dell’esperienza in direzione dell’origine e dunque l’eschaton, il punto dove la 19 20 21
S. STEWART, Op. cit., p. 23. G. O’BRIEN, Op. cit., p. 13. D. DENBY, Face/off, in «The New Yorker», July 2, 2001, p. 87.
236
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
MACCHINE
DELL’AMORE.
SPIELBERG/KUBRICK,
INTELLIGENZA ARTIFICIALE…
narrazione inizia/finisce» 22. Che il futuro-passato venga interpretato come sonno o come morte, alla fine di A.I., a David, che rifiuta disperatamente di accettare ciò che lui è realmente e il cui ostinato bisogno di essere diverso non può mai essere soddisfatto, è concesso «l’unico piccolo miracolo possibile: […] la beata incoscienza» 23. Il gioco tragicamente serio che è parte di David e che distrugge la sua esistenza di «mecca» e pervade il suo destino (e quello del film) non è solo che, a differenza di Gigolo Joe, rifiuta la sua parodica condizione esistenziale di macchina dell’amore. È anche che, ancora una volta – come nel caso di Joe – nell’essere una macchina dell’amore vi sono conseguenze impreviste, non calcolate e crudeli. Dal fatto di amare «come» una macchina (ovvero, con meccanica adorazione, terrificante, insistente e immutabile) ne deriva che l’identità di David dipende interamente dall’essere riamato dall’oggetto del suo desiderio programmato. Tuttavia, poiché lui «è» una macchina, questo è impossibile. Joe parla a David della sua «Mamma» umana in questi termini: «Lei ama quello che tu fai per lei, come le mie clienti amano tutto quello che io faccio per loro. Ma non ama te, David. Non può amarti. Non sei fatto di carne e ossa. Non sei un cane, un gatto, un canarino. Tu sei stato ideato e specificatamente costruito come tutti noi». Ciò nonostante, benché David sia stato programmato con la capacità di amare, non è stato programmato per «capire perché la madre adottiva umana non riesca a ricambiare il suo amore» 24. In questo modo, sia il pathos spielberghiano sia l’ironia kubrickiana convergono nel tragico gioco che permea David e fa del robot, e di A.I. stesso, non solo una nostalgica «macchina del desiderio», ma anche un oggetto ironicamente impossibile.
Requiem per il «corpo autentico» Decostruendo il meccanismo del desiderio, Steward riferisce (come se stesse scrivendo direttamente su David, come pure sulla mise en scène definitiva e impossibile di A.I.):
22 23 24
S. STEWART, Op. cit., p. x. G. O’BRIEN, Op. cit., p. 13. Ibidem.
237
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
VIVIAN SOBCHACK Il motivo dominante della nostalgia è quella cancellazione del divario tra natura e cultura, di qui un ritorno all’utopia di biologia e simbolo uniti all’interno della città cinta di mura che è il grembo materno. L’utopia del nostalgico è prelapsariana 25, una genesi dove esperienza vissuta e meditata sono una cosa sola, dove autenticità e trascendenza sono entrambe presenti e onnipresenti 26.
Tuttavia, questa visione utopica è essenzialmente malinconica; ovvero, come suggerisce Steward, «si volge verso un futuro-passato, un passato che ha una realtà solo ideologica» 27. E mentre David preferirebbe dormire per sempre piuttosto che prendere coscienza del fatto che il suo passato ha una realtà solo ideologica, Kubrick, Spielberg e il film non fuggono così felicemente la malinconia che accompagna la conoscenza. In A.I., l’intera struttura narrativa, in un futuro-passato descritto da un narratore fuori campo, è estremamente colma di lacrime, di pianto intimo e oceanico a un tempo. Anzi, all’inizio del film ci viene detto che l’effetto serra ha provocato l’inondazione delle città costiere da parte dell’oceano, inclusa New York (ci si riferisce a Manhattan, più avanti nel film, come alla «fine del mondo dove i leoni piangono». La malinconia pervade A.I., le lacrime sono dovunque e tuttavia rimosse, spesso congelate. Risulta dunque particolarmente ironico che all’inizio del film, quando Monica (che in seguito diventerà la «Mamma» di David) fa visita al figlio Martin, criogenicamente congelato fino a quando non sarà trovata una cura per la sua malattia, il dottore le dica: «Il lutto è inappropriato. Martin è semplicemente sospeso». Tuttavia, il lutto del presente per il futuro-passato, per una umanità perduta (iscritta come maschile) sembra essere il progetto narrativo e l’esito più importante del film. (Una delle immagini più ricorrenti è quella di David che galleggia come se fosse annegato, immobile e solo, in fondo alla piscina del giardino di una casa). Nella parte centrale di A.I., ispirata a Pinocchio, David va in cerca della Fata Turchina che presumibilmente lo farà diventare un bambino vero. Gigolo Joe suggerisce di andare a Rouge City in modo da poter interrogare il Dottor Know (una banca dati olografica che ha la fama di sape25 Anglicismo di calco derivato dall’aggettivo inglese «prelapsarian» che indica lo stato di innocenza dell’uomo prima della caduta. Il vocabolo, di etimologia latina (pre + lapsus), si diffuse alla fine del XIX secolo. Si è scelto di prendere in prestito la dizione inglese dal momento che, a nostro avviso, ogni sua possibile traduzione non avrebbe reso il significato dell’aggettivo originale in maniera altrettanto immediata ed efficace. (N.d.T.) 26 S. STEWART, Op. cit., p. 23. 27 Ibidem.
238
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
MACCHINE
DELL’AMORE.
SPIELBERG/KUBRICK,
INTELLIGENZA ARTIFICIALE…
re tutto e che ricorda il Mago di Oz, ma fatta in maniera tale da sembrare un cartone animato di Einstein). Interpretando Fata Turchina e le sue possibilità (che includono sia una pianta sia un Servizio Escort Fata Turchina), il Dottor Know dice loro che «Nel mondo degli orga, il turchino è il colore della malinconia». Il turchino è anche il colore dell’acqua e del pianto, un colore sepolcrale, il colore del freddo e del ghiaccio. È il motivo visivo dominante del film, persino nella camera di David, persino a Rouge City e specialmente sott’acqua, nell’oceano dove David trova finalmente la Fata Turchina del parco dei divertimenti e la implora invano, continuamente: «fino a quando l’oceano diventò ghiaccio» e lui, come la fata, «un fantasma turchino nel ghiaccio». Scrive Steward: «La nostalgia è una tristezza senza oggetto, una tristezza che crea un desiderio necessariamente inautentico perché non partecipa dell’esperienza vissuta. Piuttosto resta dietro e prima di quell’esperienza […]» 28. Dal punto di vista narrativo è dunque poetico il momento in cui, combinando insieme due categorie contraddittorie della banca dati del Dottor Know (l’una il «Crudo fatto», l’altra la «Fata Turchina»), David e Joe vengono messi al corrente del «vero» segreto riguardo al luogo in cui si trova la Fata Turchina. Tuttavia è significativo che tale rivelazione sia dapprima introdotta da una poesia il cui messaggio è insieme potentemente commovente e profondamente inautentico perché è rivolto agli spettatori del presente (nonché umani) di A.I. a non alle intelligenze artificiali che leggono le sue parole dolenti. Iscritta anche sulla porta dello studio del Professor Hobby situata alla fine del mondo, la poesia recita: Come away O human child To the waters and the wild With a fairy hand in hand For the world’s more full of weeping Than you can understand 29.
L’anelito nostalgico e prelapsariano di A.I. è, in definitiva, pervaso da un’ironia caustica. Il gioco, tragicamente serio, che fa parte del film è che «esso resta “dietro” e “prima”» dell’esperienza contemporanea, dietro e 28
Ibidem. Vieni via O piccolo umano/Verso le acque e il selvaggio spiano/Alla fata la mano darai/Perché il mondo è più pieno di pianto/Di quanto capire potrai. 29
239
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
VIVIAN SOBCHACK
prima delle sue odierne fantasie tecnofile maschili del corpo «svuotato» e «abbandonato». Così, il «dietro» e il «prima», ovvero il futuro-passato di A.I., esprimono qualcosa di significativo su quanto viene percepito come un futuro-impossibile presente. Steward scrive: Dal momento che l’esperienza è sempre più mediata e astratta, la relazione vissuta dal corpo con il mondo fenomenologico è sostituita da un mito nostalgico di contatto e presenza. L’esperienza «autentica» diventa elusiva e allusiva a un tempo giacché è situata al di là dell’orizzonte dell’esperienza vissuta nel presente, l’altrove dove si succedono l’antico, il pastorale, l’esotico e altri ambiti dell’immaginario. In questo processo di distacco, la memoria del corpo è sostituita dalla memoria dell’oggetto 30.
Ne conseguono la nostalgia e la malinconia di A.I. Come descrive appropriatamente O’Brien, il film è «un ideogramma del dolore travestito da cartellino di un marchio di garanzia» 31. Sospeso tra la critica kubrickiana dell’uomo tecnologico e la sua redenzione spielberghiana, visto da noi nel presente, A.I. fonde e confonde le sue contraddizioni per diventare un’opera di fantascienza e, al tempo stesso, un racconto di fate dolorosamente ironico. (Traduzione di Loredana Ferro)
30 31
S. STEWART, Op. cit., p. 133. G. O’BRIEN, Op. cit., p. 13.
240
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
I libri dell’Associazione Sigismondo Malatesta
Studi di Letteratura comparata e Teatro Collana diretta da: Paolo Amalfitano, Silvia Carandini, Francesco Fiorentino 1. Il romanzo tra i due secoli (1880-1918) a cura di Paolo Amalfitano (1993) Saggi di: M. Bongiovanni Bertini, R. Ceserani, F. Erspamer, G. Farese, F. Marenco, M. Modenesi, S. Perosa, P. Pugliatti 2. Realismo ed effetti di realtà nel romanzo dell’Ottocento a cura di Francesco Fiorentino (1993) Saggi di: A.M. Carpi, A. Castoldi, M.Columni Camerino, F. Fiorentino, G. Iotti, F. Marucci, G. Merlino, F. Moretti, F. Orlando, S. Sabbadini 3. Il valore del falso. Errori inganni equivoci sulle scene europee in epoca barocca a cura di Silvia Carandini (1994) Saggi di: F. Angelini, A. D’Agostino, D. Dalla Valle, S. Ferrone, N. Fusini, A. Lombardo, F. Marenco, F. Orlando, M.G. Profeti, A. Serpieri, F. Vazzoler 4. La tradizione dell’umorismo nero di Stefano Brugnolo (1994)
242
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
5. Scene, itinerari, dimore. Lo spazio nella narrativa del ‘700 a cura di Loretta Innocenti (1995) Saggi di: P. Amalfitano, A. Castoldi, A. Chiarloni, P. Colaiacomo, G. Fink, G. Mazzacurati, F. Moretti, A. Pizzorusso, A. Principato, S. Romagnoli 6. Proust e la letteratura anglosassone di Carlo Lauro (1995) 7. Sui primi poeti del Novecento. La generazione degli anni Ottanta a cura di Giuseppe Merlino (1995) Saggi di: M. Bacigalupo, A. Berardinelli, C.G. De Michelis, P. V. Mengaldo, I. Porena, M. Richter, S. Sabbadini, G. Sacerdoti 8. Meraviglie e orrori dell’aldilà. Intrecci mitologici e favole cristiane nel teatro barocco a cura di Silvia Carandini (1995) Saggi di: E. Cancelliere, S. Carandini, P. Fabbri, G. Fasano, D. Gambelli, V. Gentili, P. Petrobelli, G. Sacerdoti, F. Taviani 9. Raccontare e descrivere. Lo spazio nel romanzo dell’800 a cura di Francesco Fiorentino (1997) Saggi di: R. Ceserani, F. Marenco, F. Moretti, F. Orlando, C. Pagetti, A. Serpieri, P. Tortonese, L. Villa, E. Villari, L. Zagari 10. Chiarezza e verosimiglianza. La fine del dramma barocco a cura di Silvia Carandini (1997) Saggi di: R. Ciancarelli, D. De Seta, M. Fagiolo dell’Arco, F. Fiorentino, R. Giomini, L. Innocenti, A. Lombardo, V. Papetti, J. Rousset, G. Violato, N. Von Prellwitz
243
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
11. Le configurazioni dello spazio nel romanzo del ‘900 a cura di Paolo Amalfitano (1998) Saggi di: P. Amalfitano, V. Amoruso, M. Bertini, V. Coletti, A. Gargano, A. Lavagetto, F. Malcovati, G. Mochi, S. Sabbadini, S. Teroni 12. Il personaggio romanzesco. Teoria e storia di una categoria letteraria a cura di Francesco Fiorentino e Luciano Carcereri (1998) Saggi di: R. Ascarelli, M. Botto, F. Brioschi, M. Domenichelli, F. Fiorentino, G. Grilli, Ph. Hamon, R. Luperini, G. Paduano, A. Varvaro 13.14.15. Teatri barocchi. Tragedie, pastorali, commedie nella drammaturgia europea fra ‘500 e ‘600 a cura di Silvia Carandini (2000) Saggi di: P. Amalfitano, F. Angelini, G. Aquilecchia, S. Arata, E. Bonfatti, R. Camerlingo, C. Corti, D. Dalla Valle, G. Forestier, M. Fusillo, A. Gareffi, H. Gatti, G. Grilli, M. Lombardi, S. Mamone, F. Marenco, Ch. Mazouer, B. Papasogli, M. Plaisance, P.C. Rivoltella, S. Rufini, G. Sacerdoti, A. Serpieri, E. Tamburini, R. Tessari, S. Zatti. 16. Il giudizio di valore e il canone letterario a cura di Loretta Innocenti (2000) Saggi di: L. Bolzoni, A. Castoldi, L. Dällenbach, P. Fabbri, E. Franco, F. Marenco, F. Moretti, F. Orlando
244
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
17. La letterarietà dei discorsi scientifici. Aspetti figurali e narrativi della prosa di Hegel, Tocqueville, Darwin, Marx, Freud di Stefano Brugnolo (2001) 18. La poesia dell’età romantica. Lirismo e narratività a cura di Andreina Lavagetto (2002) Saggi di: M. R. Alfani, G. Cacciavillani, P. Colaiacomo, S. Corrado, P. Gibellini, A. Guyaux, G. Iotti, F. Rognoni, L. Rossi 19. Il ritratto dell’artista nel romanzo tra ‘700 e ‘900 a cura di Enrica Villari e Paolo Pepe (2002) Saggi di: G. Baioni, P. Boitani, A. Boschetti, S. Calabrese, M. D’Amico, M. Palumbo, S. Perosa, G. P. Piretto, G. Rubino, P. Tortonese 20. La trama nel romanzo del ‘900 a cura di Luca Pietromarchi (di prossima pubblicazione) Saggi di: A. Boscaro, A. Cagidemetrio, A. Compagnon, C. Corti, D. Del Giudice, C. Gorlier, F. Orlando, L. Pietromarchi, E. Pittarello, G. Roscioni 21. Il tragico nel romanzo moderno a cura di Piero Toffano Saggi di: P. Amalfitano, A. Asor Rosa, A. M. Carpi, B. Clément, I. Duncan, F. Fiorentino, F. Marenco, G. Paduano, V. Strada, C. Segre, P. Toffano 22. Le emozioni nel romanzo. Dal comico al patetico a cura di Paolo Amalfitano (di prossima pubblicazione) Saggi di: P. Amalfitano, C. Benedetti, A. Chairloni, M. Domenichelli, M. T. Giaveri, H. Godard, A. Guyaux, A. Portelli, A. Redondo, P. Tortonese, E. Villari, S. Zatti
245
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
23.24. La scena ritrovata. Mitologie teatrali del Novecento a cura di Delia Gambelli e Fausto Malcovati (di prossima pubblicazione) Saggi di: F. Angelini, S. Arata, U. Artioli, C. Corti, C. G. De Michelis, M. Fazio, M. Fusillo, L. Innocenti, A. Landolfi, F. Malcovati, F. Marotti, D. Millet Gérard, G. Paduano, P. Puppa, D. Rizzi, S. Saïd, F. Taviani, A. Tinterri
Studi sul cinema 1. Il racconto tra letteratura e cinema a cura di Lucilla Albano (1997) Saggi e interventi di: L. Albano, G. Amelio, G. Bertolucci, I. Bignardi, G. Fink, C. Garboli, M. Grande, R. La Capria, M. Martone, G. Merlino, P. Ortoleva, M. Rafele, L. Ravera, F. Scarpelli, G. Tinazzi 2. Modelli non letterari nel cinema a cura di Lucilla Albano (1999) Saggi e interventi di: A. Abruzzese, A. Aprà, S. Bernardi, B. Bertolucci, E. Dagrada, G. De Vincenti, G. Frezza, M.M. Gazzano, P. Montani, M. Rafele, P. Terni 3.4. Il cinema che ha fatto sognare il mondo. La commedia brillante e il musical a cura di Franco La Polla e Franco Monteleone (2002) Saggi di: J.-L. Bourget, R. Campari, V. Caprara, E. Comuzio, R. Durgnat, J. Finler, L. Gandini, G. Gosetti, E. Guzzo Vaccarino, F. La Polla, F. Malcovati, A. Masson, I Moscati, G. Muscio, P. Ortoleva, A. Sapori, V. Zagarrio
246
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.
5. Science Fiction a cura di Franco Monteleone e Cecilia Martino Saggi di: G. Canova, G. Cremonini, M. Fadda, V. Fortunati, F. La Polla, C. Pagetti, P. Rouyer, R. Runcini, V. Sobchack, M. Spanu, M. Walter Bruno
247
www.torrossa.com - For non-commercial use by authorised users only. License restrictions apply.