Leopardi
269 85 14MB
Italian Pages 220 Year 1990
Recommend Papers
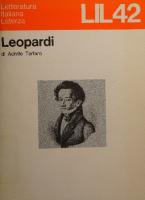
- Author / Uploaded
- Achille Tartaro
File loading please wait...
Citation preview
letteratura Italiana lalerza
Leopardi di Achille Tartaro
!
Nt 6) I REMITERO: PER l'EPDITtA SPIRI E AMBIENTALI PS
i
* i BENI
UFFICIO DEGLI SCAM BI Ia IERNAZIONALI
2
bian
3;
ML
URALI
WIT HDRAWN From Toronto Public Library &
=
e
3 N
Prima edizione Prima ristampa
aprile 1978 giugno 1978
Seconda ristampa . Terza ristampa Quarta ristampa
È
9
È s
1981 1983 1985
#7)
uc
MEscROPARDÌ di
Achille Tartaro SUL SIM]
d
A
Ù
IL PRIMO
OTTOCENTO
L'ETÀ NAPOLEONICA
E IL RISORGIMENTO
$$ 42-49
numerazione dei paragrafi è data Per facilitare i rinvii ad altri volumi della stessa collana, la volume. singolo ogni per non e secolo ciascun di o all’intern progressivamente
GIACOMO LEOPARDI
Inte
È
Gt
fai patta
pod
Midi tare
5
î
die + s* “Sy sa
GIACOMO
$ 42.
LEOPARDI
Filologia ed erudizione ; il modello del « letterato cristiano »
Di, Le circostanze mi avevan dato allo studio delle lingue, e della filologia antica » (Zibaldone, 1741). Nulla che ci faccia intendere come l’attività filologicoerudita, intensa soprattutto fra il 1813 e il 1816, in seguito rallentata ma mai 1798,
29 giugno: nasce a Recanati dal conte Monaldo (1776-1847) e dalla marchesa Adelaide Antici (1778-1857). 1803: i beni familiari, su richiesta di Monaldo, vengono affidati a un amministratore; la direzione della casa passa nelle mani di Adelaide. A Monaldo resta il compito di seguire l’edue sa figlî, di Giacomo e degli altri natigli successivamente: Carlo (1799-1878), Paolina
1805: Monaldo fonda nel proprio palazzo un’Accademia poetica col proposito di rinnovare quella più antica dei € Disuguali ». 1807: l’educazione scolastica dei fratelli Leopardi, affidata a precettori ecclesiastici (al prete di casa don Vincenzo Diotallevi e al gesuita messicano Giuseppe Torres, già maestro del padre), è ora guidata: — fino al 1812 — dall’abate Sebastiano Sanchini. 1809: dopo aver letta Omero scrive il sonetto La morte di Ettore. Hanno inizio i sette anni del suo studio « matto e disperatissimo »; anni d’intensa applicazione nel chiuso della biblioteca paterna è delle più fornite biblioteche recanatesi (quelle del Seminario e quelle dei Roberti e degli Antici). Qualche influenza su di lui è probabilmente esercitata dall’alsaziano don Giuseppe Antonio Vogel (1756-1817).
1811: sta per concludersi un periodo di primissime esercitazioni letterarie, versi e prose anche latine raccolti dagli editori sotto la denominazione di « puerili ». Risale a quest'anno L’« Arte poetica » di Orazio travestita, ed esposta in ottava rima; compone inoltre la tragedia in tre atti La virtù indiana. 1812: compone gli Epigrammi e la tragedia Pompeo in Egitto. Continua a stendere le sue Dissertazioni filosofiche: nell’11 aveva scritto Sopra l’anima delle bestie; scrive ora il Dialogo filosofico sopra un. moderno libro intitolato « Analisi delle idee ad uso della gioventù ». 1813: nasce l’ultimo det fratelli Leopardi: Pierfrancesco (morirà nel 1851). Dopo Paolina erano nati ancora: Luigi (morto pochi giorni dopo la nascita nel 1803) e un secondo Luigi (180428). Prima dell’àgosto, senza maestro, intraprende lo studio del greco. Scrive la Storia dell’astronomia.. Ha inizio un periodo di fervida e imponente attività filologica. 1814: si dedica al suo primo lavoro di filologia classica, dedicato al De viris doctrina
claris di
Esichio Milesio; compone quindi il Porphyrii de vita Plotini et ordine librorum ejus Commentarius. Seguono i Commentarii de vita et scriptis rhetorum quorundam qui secundo post Christum saeculo vel primo declinante vixerunt e la traduzione dal greco degli Scherzi epigrammatici; dà inizio agli incompiuti Fragmenta Patrum secundi saeculi, et veterum auctorum de illis testimonia collettaet illustrata. ì È : 1815: compone: In Fulium Africanum Facobi Leopardi Recanatensis comitis Lucubrationes e il Saggio sopra gli errori popolari degli antichi. - maggio-giugno: scrive l’orazione Agl’italiani, in occasione della liberazione del Piceno. - estate: traduce gli Idilli di Mosco e la Batracomiomachia (su questa Guerra de’ topi e delle rane tornerà ancora, fornendone nuove traduzioni, nel 1821-2.e poi nel 1826). : ; 1816, gennaio-aprile: scrive il Discorso sopra la vita e le opere di M. Cornelio Frontone e traduce le opere di Frontone scoperte ed edite da Angelo Mai. - primavera:
compone Le rimem-
branze; scrive l’Tnno a Nettuno, fingendolo traduzione da un codice greco scoperto a Roma da un suo amico; compone in greco due anacreontiche adespote. - giugno: pubblica le Notizie istoriche e geografiche sulla città e chiesa arcivescovile di Damiata. - estate-autunno: pubblica nello « Spettatore italiano e straniero » il Saggiodi traduzione dell’« Odissea » (il 1 libro del poema omerico). - luglio: incomincia la tragedia Maria Antonietta, incompiuta;
traduce le Inscrizioni greche triopee e il poemetto La torta; compone il Parere sopra il Salterio ebraico e il discorso Della fama di Orazio presso gli antichi. In risposta a M.me de Staél
scrive la Lettera ai compilatori della « Biblioteca italiana », non pubblicata. - autunno-inverno:
traduce
il 1 libro dell’Eneide;
compone
la cantica Appressamento
della morte.
4
Giacomo
del tutto abbandonata,
corrispondesse
a un
interesse
autentico,
Leopardi
fra i più vivi
di Leopardi. Nella prospettiva empiristica dello scrittore, fermamente persuaso — contro ogni forma d’innatismo — che alle nostre inclinazioni spirituali debba attribuirsi il carattere di facoltà acquisite, non congenite ma «prodotte [...] 1817,
gennaio:
traduce
i frammenti
delle Antichità
romane
di Dionigi
d’Alicarnasso,
scoperti
da Angelo Mai. - marzo: ha inizio la corrispondenza e l’amicizia con Pietro Giordani. giugno: compare nello « Spettatore » la sua traduzione della Titanomachia esiodea. - luglioagosto: comincia a redigere lo Zibaldone. - novembre: scrive i Sonetti in persona di ser Pecora fiorentino beccaio (contro Guglielmo Manzi, il bibliotecario della Barberiniana di Roma) e il sonetto Letta la vita di Vittorio Alfieri scritta da esso. - dicembre: conosce la pesarese Gertrude Cassi Lazzari, cugina ventiseienne di Monaldo ospite dei Leopardi dal giorno 11 al 14; se ne innamora: a questa esperienza si collegano il Diario del primo amore, l'Elegia I (poi intitolata I/ primo amore) e la successiva E/egia II. 1818, gennaio-marzo: scrive l’Elegia II; compone il Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica. - settembre: conosce personalmente Giordani, ospite di casa Leopardi (dal giorno 16 al 21) durante un suo viaggio per Roma; ottiene dal padre il permesso per una breve gita a Macerata in compagnia dell’amico; scrive la canzone A/l’Italia e poi — fra il settembre e l’ottobre — quella Sopra il monumento di Dante che si preparava în Firenze. 1819: all’inizio dell’anno compone le canzoni Per una donna inferma di malattia lunga e mortale e Nella morte di una donna fatta trucidare col suo portato dal corruttore per mano ed arte di un chirurgo. - marzo: si manifestano i primi segni della malattia agli occhi che lo affliggerà per tutta la vita. - luglio: tenta di fuggire da Recanati ma il suo tentativo è presto scoperto dal padre. - settembre: compone L’infinito; scrive quindi, durante i mesi autunnali, la Telesilla e probabilmente Alla luna; è di questo periodo anche il Frammento XXXVII dei Canti (intitolato prima // sogno e poi Lo spavento notturno). Risale a quest'anno infine il progetto autobiografico cui s’ispirano i Ricordi d’infanzia e di adolescenza. 1820, gennaio: scrive la canzone Ad Angelo Mai. - estate: Pietro Brighenti gli fa intravedere la possibilità di ottenere la cattedra di eloquenza nell'Università di Bologna. Giacomo, prevedendo l’opposizione del padre ad un suo eventuale distacco da Recanati, lascia cadere il suggerimento dell’amico. - ottobre: scrive forse in questo mese La sera del dì festa. - dicembre: compone probabilmente l’idillio // sogno, la cui stesura si spinge forse agli inizi
dell’anno successivo. progetta e abbozza un certo numero di Inni cristiani. - marzo: sollecita inutilmente l’incarico di « scrittore di lingua latina » presso la Biblioteca vaticana. - estate: compone probabilmente La vita solitaria. - ottobre-novembre: scrive Nelle nozze della sorella Paolina (in occasione del matrimonio, in seguito mancato, della sorella con un Andrea Peroli); scrive A un vincitore nel pallone. - dicembre: scrive Bruto minore. 1822, gennaio: compone la canzone Alla primavera o delle favole antiche. - marzo: fra il 13 e il 19 scrive l’Ultimo canto di Saffo. - luglio: compone l’Inno ai patriarchi. - ottobre: inizia la traduzione in stile arcaicizzante del Martirio de’ santi Padri del monte Sinai (la completa in poco più di un mese). - novembre: parte alla volta di Roma, dove si tratterrà dal 23 di questo mese al 28 aprile dell’anno seguente, ospite degli zii materni nel palazzo Antici-Mattei.
1821:
1823,
febbraio: conosce B. G. Niebuhr (1776-1831), ministro di Prussia
a Roma.
Durante il suo
soggiorno romano stringerà rapporti più o meno stretti con altri letterati: C. Bunsen, il grecista Tiersch, il belga A. Jacopssen, il danese Krarup oltre a F. G. Reinhold, ministro dei Paesi Bassi. - marzo: appoggiato da Niebuhr sollecita presso il cardinale Consalvi
l’impiego di « Cancelliere del Censo »; ma la morte di Pio vii e la sostituzione di Consalvi alla Segreteria di Stato mandano all’aria anche questo suo tentativo. - 3 maggio: arriva a Recanati, di ritorno da Roma. - settembre: scrive Alla sua donna; traduce la Satira di Simonide sopra le donne. - dicembre: spedisce a Brighenti il manoscritto delle sue dieci canzoni; spera di farlo pubblicare a Bologna, ma per due volte consecutive i « Revisori » gli negano il permesso di stampa. 1824, gennaio: riceve l’invito di Vieusseux a collaborare all’« Antologia » con rendiconti sulle ‘ novità scientifiche e letterarie dello stato pontificio »; rifiuta dichiarando l’impossibilità per lui di un tempestivo aggiornamento culturale. - marzo: compone forse in questo periodo l’incompiuto Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’italiani; ha giò intrapreso la stesura delle Operette morali, scritte nella maggior parte in quest'anno (fra il gennaio e il novembre). - agosto: si stampano a Bologna, per i tipi di Nobili, le Canzoni del conte G. Leopardi.
$ 42.
Filologia ed erudizione;
il modello del «letterato cristiano»
5
dalle letture, e dagli studi, e dalle circostanze diverse » (ivi, 1742), la filologia
vale ad attestare, simbolicamente,
il condizionamento
di ‘una realtà familiare al
cui interno persone e luoghi, un padre « molto amante delle lettere » e una biblioteca, concorrono a predeterminare il destino culturale dell’adolescente. 1825,
gennaio: traduce i Ragionamenti morali di Isocrate e quindi l’Orazione areopagitica; progetta una raccolta in traduzione dei Pensieri di Platone. - luglio: parte alla volta di Milano, invitatovi dall’editore Stella con l’incarico di dirigere l’edizione completa delle opere di Cicerone; lungo il viaggio si ferma per qualche giorno a Bologna dove incontra Brighenti e Giordani. = agosto: a Milano fa visita a Vincenzo Monti. - settembre: dopo aver redatto i due Manifesti e la Notizia bibliografica per un'edizione di tutte le opere di Cicerone, riparte per Bologna. Qui vive con un assegno mensile di Stella e con quanto guadagna dando lezioni private a un « ricchissimo signore greco » e al conte Papadopoli, suo amico. Compone probabilmente il Frammento apocrifo di Stratone da Lampsaco. - ottobre: riceve da Roma, tramite Bunsen, l’offerta dell’insegnamento di eloquenza greca e latina presso la Sapienza; suo desiderio, come scrive a Bunsen, sarebbe invece quello di essere assunto al posto allora vacante di segretario dell’Accademia di belle arti. - novembre: Bunsen lo invita a recarsi a Roma; ma Leopardi rifiuta sia per ragioni di salute sia perché ritiene che il compenso di un eventuale incarico romano non gli consentirebbe di vivere in quella città. Intraprende intanto la traduzione del Manuale di Epitteto. - dicembre: conclusa la traduzione epittetea, dà inizio al commento delle Rime di Petrarca (lo porterà a termine nel luglio dell’anno successivo).
1826,
gennaio: rinuncia a un beneficio ecclesiastico di cui potrebbe godere dopo la morte di un
suo zio canonico. Bunsen lo informa che per l’opposizione del governo pontificio non potrà ottenere alcun impiego né a Roma né a Bologna; gli prospetta la possibilità di un incarico di letteratura italiana a Berlino o a Bonn. - marzo: compone l’Epistola al conte Carlo Pepoli: la legge il 28 all'Accademia dei Felsinei. - aprile-maggio: conosce la contessa Teresa Carniani Malvezzi. - maggio: consegna il manoscritto delle Operette morali al rappresentante bolognese dell’editore Stella. - giugno: Stella pubblica le Rime petrarchesche col commento di Leopardi. - luglio: presse la stamperia delle Muse appare l’edizione bolognese dei Versi. A - novembre: lascia Bologna per tornare a Recanati; vi giunge il giorno 12. 1827: agli inizi dell’anno pubblica presso l’editore Stella la Crestomazia italiana della prosa. aprile: riparte per Bologna. - giugno: appaiono le Operette morali (ed. Stella); si stabilisce a Firenze; entra in contatto diretto col circolo di Vieusseux e conosce Capponi, Montani, Niccolini, Tommaseo, Colletta, Poerio, gli Imbriani, Pepe; conosce pure Antonio Ranieri (1806-88). - settembre: presso Vieusseux incontra Alessandro Manzoni; scrive probabilmente Il Copernico e il Dialogo di Plotino e di Porfirio. - novembre: si trasferisce a Pisa. 1828, gennaio: appare, pubblicata da Stella, la Crestomazia italiana poetica. - febbraio: compone lo Scherzo. - aprile: scrive Il risorgimento e A Silvia. - giugno: torna a Firenze; rifiuta la cattedra dantesca all’Università di Bonn propostagli da Bunsen. - ottobre: conosce Vincenzo Gioberti che, nel mese successivo, lo accompagnerà a Recanati restando suo ospite per un giorno. - dicembre: si diffonde fra gli amici fiorentini la notizia della
sua morte. 1829: ancora a Recanati, nei primi mesi di quest'anno, compone forse // passero solitario. - aprile: riceve da Colletta la proposta di trasferirsi a Firenze presso di lui. - agosto-settembre: compone Le ricordanze, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio. . ottobre: dà inizio al Canto notturno di un pastore errante dell’ Asia (lo compirà il 9 aprile dell’anno
successivo).
1830,
s
rad
I
sete
aprile-maggio: accolta l’offerta rivoltagli da Colletta, di trasferirsi a Firenze e di vivervi con il generoso contributo degli amici toscani, lascia per sempre Recanati. - estate: conosce a Firenze, presentatagli da Poerio, Fanny Targioni Tozzetti. - autunno: ritrovato Ranieri, ha inizio il suo « sodalizio » con lui; conosce in questo periodo il filologo svizzero Luigi
De Sinner.
Liga
è
‘
2
1831, marzo: è nominato dal Pubblico consiglio di Recanati deputato rappresentante nell’Assemblea nazionale di Bologna; ma il ritorno degli austriaci a Bologna rende vana la sua nomina. - aprile: appare a Firenze la prima edizione dei Canti (ed. Piatti). - estate: compone forse Il pensiero dominante. - ottobre: in compagnia di Ranieri parte per. Roma, vi si tratterrà fino al marzo dell’anno successivo. - inverno: appaiono anonimi 1 Dialoghetti sulle materie correnti nell’anno 1831 di Montaldo; gli verranno attribuiti e Leopardi fortemente contrariato, sarà costretto ad una smentita nell’ Antologia k di Vieusseux. 1832, maggio: ritornato a Firenze, scrive il Dialogo d’un venditore d’almanacchi e di un passeggere
6
Giacomo
Leopardi
A quali circostanze Leopardi si riferisse è fin troppo noto. Le dichiarerà del resto in una scheda bio-bibliografica redatta nel ’26 (in terza persona) per Carlo Pepoli: Nato dal conte Monaldo Leopardi di Recanati, città della Marca di Ancona, e dalla marchesa Adelaide Antici della stessa città, ai 29 giugno del 1798, in Recanati.
Vissuto sempre nella patria fino all’età di 24 anni. Precettori non ebbe se non per li primi rudimenti che apprese da pedagoghi, mantenuti espressamente in casa da suo padre. Bensì ebbe l’uso di una ricca biblioteca raccolta dal padre, uomo molto amante delle lettere. In questa biblioteca passò la maggior parte della sua vita, finché e quanto gli fu permesso dalla salute, distrutta da’ suoi studi; i quali incominciò indipendentemente dai precettori in età di 10 anni, e continuò poi sempre senza riposo, facendone la sua unica occupazione (Epistolario, 486);
notizie «poco notabili della sua vita» alle quali per gli anni puerili resta da aggiungere ben poco. I giochi infantili, la disposizione alle pratiche devote testimoniataci da Monaldo, i saggi pubblici sulle varie materie di studio costituiscono un patrimonio aneddotico di facile uso a fini biografici, ma affatto inadeguato a illuminarci sulla formazione di una personalità che brucia le proprie esperienze troppo rapidamente perché certa insistenza sulla vita quotidiana nel palazzo Leopardi, gli stessi dati a nostra disposizione sull’indole del giavanissimo Giacomo non ci espongano al rischio di un'immagine deformata, sacrificata a testimonianze che tendono a irrigidirla in un gesto statico e insieme artificiosamente dilatato. Altro il discorso per le allusioni in prima persona. Il recupero negli
anni adulti di particolari anche minimi dell’infanzia dovrà riguardarsi con ben diversa attenzione; ma da una visuale che nel rispetto dei tempi reali della memoria ne segnali il connotato più vero, il senso (o i sensi) della rievocazione, e forse il Dialogo di Tristano e di un amico. - estate: compone forse Amore e morte. - novembre: scrive probabilmente Consalvo. - dicembre: comincia forse a trascegliere dallo Zibal-
done, appena concluso, la serie dei Pensieri pubblicati postumi nel 1845. 1833, primavera-estate: compone forse A se stesso e l’abbozzo dell'inno Ad Arimane. - settembre: insieme con Ranieri parte per Napoli: vi giunge in ottobre, dopo un soggiorno di qualche settimana a Roma. 1834: scrive forse Aspasia. - estate: entra in rapporti con Augusto von Platen; lavora ai Parali-
pomeni della Batracomiomachia. 1835, primavera: scrive forse la Palinodia al marchese Gino Capponi e le canzoni Sopra un basso rilievo antico sepolcrale, dove una giovane morta è rappresentata in attò di partire, accommiatandosi dai suoi e Sopra il ritratto di una bella donna scolpito nel monumento sepolcrale della medesima. - estate: appare presso l’editore napoletano Starita la seconda edizione dei Canti, sequestrata l’anno successivo per ordine del governo borbonico. '- autunno: compone I nuovi credenti. 1836, gennaio: Starita pubblica la terza edizione delle Operette morali (con data 1835), sequestrate per ordine governativo. - aprile: per sfuggire alla minaccia del colera si trasferisce con Ranieri e la sorella di questi, Paolina, a Villa Ferrigni fra Torre del Greco e Torre Annunziata. Qui scrive probabilmente La ginestra e Il tramonto della luna. 1837, 14 giugno: muore assistito da Antonio e Paolina Ranieri; il suo corpo viene tumulato nella chiesa di San Vitale sulla via di Pozzuoli.
$ 42.
Filologia ed erudizione; il modello del «letterato cristiano »
Ò
valida oltre la materialità dei fatti narrati: vicende o stati d’animo infantili su cui s1 proietta una consapevolezza nuova che nel ricordo li trasfigura. Il nostro apporto più consistente riguarderà la fisionomia di una famiglia intrisa di pregiudizi, economicamente dissestata per l'inesperienza di Monaldo,
dominata dalla figura della madre, la dispotica e bigotta Adelaide, sulla quale
grava fin dal 1803 ogni responsabilità domestica; al padre, tipico esemplare di certa nobiltà provinciale del tardo Settecento,è affidata l'educazione dei figli
(di Giacomo e dei fratelli a lui più vicini, Carlo e Paolina) e la cura dei libri
e della propria biblioteca: l'emblema di una passione culturale autentica, baldanzosa per quanto dispersiva, di marca rigorosamente clericale. Il volto della famiglia, esternamente irreprensibile, sembra dissimulare una seria frattura
coniugale: certe ammissioni nell’autobiografia di Monaldo sull’indole e il carattere della moglie, diversi dai suoi « quanto sono distanti fra loro il cielo e la terra » esprimono una tensione che affiora ambiguamente nelle parole di stima per la « donna forte, intenta solo ai doveri e alle cure del suo stato », la donna che « non
ha mai conosciuto altra volontà, piacere o interessi se non quelli della famiglia e di Dio ». Ma all’esterno darietà e di decoro, pur lontani dagli anni in cui ‘pietosa lucidità, i tratti
tutto si ricompone in un rapporto ineccepibile, di solinelle difficoltà e nelle ristrettezze economiche. Siamo
Giacomo rileverà nell'immagine della madre, con imdi una brutale alienazione religiosa (Zibaldone, 353-6)
manifestando così il sentimento di una fanciullezza intristita, delusa di là da ogni apparenza nelle sue attese più elementari. Per il resto basterà aggiungere qualche nome e qualche sparsa informazione. Accanto ai precettori privati, Torres e Sanchini, ricordati anonimamente nelle « notizie » a Pepoli, maestri mediocri fermi ai metodi più tradizionali dell’insegnamento gesuitico, andrà citato l’esule alsaziano Giuseppe Antonio Vogel, un
serio erudito residente a Recanati almeno dal 1806 in qualità prima di professore di storia ecclesiastica presso il Seminario quindi di canonico della cattedrale (morirà a Loreto nel ’17). A Vogel si attribuisce il suggerimento a Giacomo della traduzione oraziana delle Odi e l’idea realizzata più tardi di compilare uno «zibaldone ». All’interno della cerchia familiare dovrà ricordarsi inoltre lo zio materno Carlo Antici, un reazionario intelligente e colto bene introdotto nei circoli politici e moridani della capitale. A Roma dove viveva si adopera a favore del nipote: ne divulgherà il Porfirio e lo metterà in collegamento con: l’abate Francesco Cancellieri, un erudito di fama con il quale il giovane avvia una corrispondenza epistolare abbastanza cospicua. Ma il nome di Antici andrà fatto soprattutto a proposito dei rapporti del poeta con Recanati. Risalgono a lui le prime insistenze presso Monaldo perché consenta al figlio di lasciare Recanati per Roma. Quel suggerimento, ispirato a considerazioni pratiche, in vista per Giacomo di una brillante carriera ecclesiastica, coinciderà presto nel poeta con lo stato di un crescente go che, di là da ogni calcolo utilitaristico sul proprio avvenire, presuppone un’aspirazione intellettuale esclusiva e carica di promesse. Lasciare Recanati vincendo l’irriducibile opposizione paterna, procurarsi
9
Giacomo Leopardi
le condizioni perché la propria vocazione culturale si alimenti in un ambiente che sappia incoraggiarla e valorizzarla è il pensiero fisso dei prossimi anni: sarà uno dei temi ricorrenti nel carteggio con Giordani e si esprimerà nell’ingenuo tentativo di fuga del ’19. Ma allora gli umori dello zio saranno cambiati. L’insofferenza di Giacomo gli sarà apparsa, e non a torto dal suo punto di vista, come il sintomo di una pericolosa deviazione, una « malattia morale funestissima » (Epistolario, ed. Moroncini, 1, p. 203) da scongiurare rafforzando il fisico e dedicandosi
alle «buone » lettere, allo
«studio
delle cose che si riferiscono a
Dio, all'Uomo, al Cittadino » (ivi, p. 205); ritrovando nella famiglia e nell’affetto dei genitori le ragioni di una serenità finalmente consolante, al riparo dalle tentazioni di una società letteraria corrotta e presuntuosa. Non si tarda a scoprire il sospetto del reazionario dinanzi a un atteggiamento che sa di eversione, di rivolta non soltanto adolescenziale e familiare. Un sospetto che si rafforzerà alla lettura delle canzoni civili di cui Antici riconosce prontamente il sottinteso politico, traducendosi allora in un estremo tentativo di persuasione perché il nipote si risolva a indirizzare il proprio talento « non a piangere con altri fantastici e sibaritici poeti il supposto valore e la non perduta gloria letteraria dei secoli anteriori, ma a far guerra ai vizi che imbrattano il secolo presente, ed a concorrere con gli uomini di buona volontà ad intrecciare fra i rami della nostra perfezionata civilizzazione gl’indefettibili appoggi del cristianesimo » (ivi, p. 257). Parole, queste di Antici, destinate come le precedenti a cadere nel vuoto; ma insieme chiarificatrici dell’orizzonte ideologico entro il quale si colloca l’attività giovanile di Leopardi. Di là dalla loro occasione più immediata riassumevano infatti un ideale in cui il giovane fino a pochi anni prima si sarebbe riconosciuto senza riserve; un ideale improntato ai miti politico-sociali della Restaurazione: quelli della pace, della «sicurezza dei giudizi» e dei «buoni ordini di polizia» invocati da Antici come i « maggiori beni che si vogliono dagli uomini riuniti in società » (ibidem). Riferiti a un generale ordine europeo, quei miti si gonfiano enfaticamente fino a configurare l’eterno conflitto fra le forze del male e quelle del bene: « Il genio del male — scrive ancora l’Antici —
lotta con quello del bene, e voi dovete aguzzare i vostri talenti per combattere sotto i vessilli di questo. La vittoria è certa ed assicura palme immortali »(ibidem). Un ideale di milizia reazionaria cui lo scrittore si era conformato, derivandone
gli umori sanfedistici che circolano nelle sue prime esercitazioni su temi filosofico-morali e politici (Dissertazioni filosofiche, 1811-2; sermoni sacri, 1813-4; Agl’italiani, 1815); ma traendone soprattutto le ragioni di un impegno culturale
che, ammantandosi di fiducia nelle definitive conquiste dello spirito umano (la « perfezionata civilizzazione » di Antici), dissimulava in realtà il vizio antico del
dogmatismo e del trionfalismo clericale. Gli appelli di Giacomo « alla retta Filosofia, al parer de’ Sapienti, ed a’ santi Dogmi della Cattolica Religione », certo
compiacimento nel proclamarsi «seguace dell’Evangelo » di cui sarebbe «per divina mercé rivestito », sono le tracce esteriori ma inequivocabili della sua adesione a un’ideologia la cui influenza, per il tramite di Monaldo, abbraccia per
$ 42.
Filologia ed erudizione; il modello del « letterato cristiano»
O)
intero il periodo della formazione, gli anni compresi fra il 1809 e il 1816, quelli dello studio « matto e disperatissimo » di una famosa lettera a Giordani. La prova per questo aspetto più significativa degli anni di cui parliamo è l’orazione Agl’italiani dopo la sconfitta di Murat a Tolentino. L’esecrazione della rivoluzione dell’Ottantanove, l’odio per Napoleone, l’aspra avversione per i francesi costituiscono la trama politica di un discorso al cui iaterno le idealità legittimiste, della sicurezza e della pace laboriosa, le preoccupazioni economico-sociali in merito a tassazioni che si vorrebbero più eque e alla necessità d’incrementare i commerci e l’agricoltura, sotto la protezione « paterna » di sovrani « amati e legittimi », si trasfondono negli accenti di una passionalità calcolata, in equilibrio fra la concitazione antitirannica e l’appello pragmatico. « Italiani! rinunziamo al brillante ed appigliamoci al solido ». È lo stigma, quest’ultimo, di Monaldo: il segno scoperto di un atteggiamento mentale che misura il « vantaggio » e la «felicità » dell’Italia sul metro di un moderatismo miope e cauteloso che, confortandosi della solidarietà dell'Europa restaurata, gabella per buon senso la propria sostanziale meschinità e aridità. Ma in generale Giacomo ripete evidentemente le argomentazioni del padre. Le amplifica nelle forme di un’oratoria sovrabbondante, quasi sempre eccessiva, al cui fondo è la pretesa di rifare i grandi esempi dell’eloquenza classica: Gli antichi soleano dare alla loro patria dei consigli, o felicitarla di qualche successo, dalle tribune o dai rostri col mezzo di arringhe. Essi ci hanno lasciate le loro magnifiche orazioni, che trasportano il lettore nei tempi nei quali furono pronunciate, e lo collocano in mezzo alla udienza romorosa dell’oratore, tra il plauso e l’entusiasmo di un popolo ebbro di sentimenti di gloria. Volli imitarli, indirizzando ai miei compatriotti un’orazione e immaginandomi di parlar loro. Gl’italiani non troveranno in me né un Demostene né un Marco Tullio; ma io spero di trovare negl’italiani degli ateniesi e dei veri successori dei romani (Tutte le opere, con introd. e a c. di W. Binni, con la collaborazione di E. Ghidetti, 1, Firenze
1969, p. 869).
Non sfuggano qui gli elementi che ci rimandano al modello specificamente letterario che Leopardi assimila nell'ambiente familiare, trasmessogli come una verità indubbia insieme con le altre d’ordine propriamente morale. È il modello, diremmo, del « letterato cristiano » di cui ancora Antici scrivendo al nipote nel *18 fisserà il cursus studiorum sulla linea discriminante fra le « buone » e le « belle » lettere. Nella realtà leopardiana — in famiglia, a Recanati — quel modello si contrae in un’ottica particolarmente angusta: la visuale di Antici è di gran lunga
più ampia. Ma occorre intanto notare come quegli elementi, attivi in un sostrato umanistico abbastanza compatto, concorrano a precisare la posizione del giovane (e del modello cui si attiene) nel quadro di un diffuso classicismo sette-ottocentesco.
Di là dal gusto melodrammatico in cui s’inscrive l'immaginazione dell’eccitante exploit tribunizio, proiezione a sua volta di sentimenti ancora fanciulle-
10
Giacomo
Leopardi
schi, ingenuamente esibizionistici, nella dichiarazione leopardiana si distinguono nettamente alcuni dei miti descrittici da Antonio La Penna come costitutivi, nel bene e nel male, della tradizione umanistica radicata nella nostra cultura. Se
la citazione congiunta di Demostene e di Cicerone vale a convalidare la prospettiva moderata del discorso Agl’italiani, e in particolare l’uso a fini legittimisti di una tematica antitirannica che, dietro lo schermo di quei nomi divenuti canonici, camuffava le proprie intenzioni più vere nei modi di un libertarismo vacuamente parolaio; il richiamo all’eredità romana degli italiani, una discendenza naturale che significativamente si vorrebbe qui rafforzata dall’esempio dei greci, e soprattutto la concezione di un'attività letteraria come pratica eminentemente suasoria e celebrativa ci scoprono un orientamento che, adeguandosi a posizioni tipiche dell’intellettuale umanista, ne esalta le deformazioni e i pericoli congeniti. Il tema così della grandezza che sarebbe assicurata all’Italia, pur nelle avversità politiche, da un patrimonio di civiltà direttamente trasmessole dal mondo antico resta un puro espediente oratorio. Privo d’ogni contenuto problematico che lo preservi dalle convenzionalità di un patriottismo astratto (si pensi, per
contrasto, al ben diverso spessore delle posizioni foscoliane), quel tema si ripropone fra i ritrovati di una collaudata ars rhetorica: come il punto d’appoggio di un atteggiamento che attraverso l’ammonizione indiretta, implicita nell’auspicio che gli italiani sappiano raccogliere l’eredità che gli spetta, esprime la funzione tradizionalmente assunta dal ceto intellettuale; una funzione di alto magistero rivendicata come prerogativa propria della cultura, in un rapporto col reale sostanzialmente mistificato, per il quale proprio l’esercizio dell’eloquenza, lo strumento di una letterarietà umanisticamente intesa come partecipazione pro-
fessionale alla vita attiva, accentua il divario fra i problemi reali della storia e le risposte delle élites intellettuali. Che all’interno di quel modello potessero fermentare motivi di segno opposto, veri e propri anticorpi destinati a correggere energicamente il tracciato dell’ideologia letteraria di Leopardi, è fuori discussione. Già a partire dai « puerili », i versi e le prose del periodo 1809-12, s’individuano i tratti di un genuino fervore morale e fantastico in grado di vanificare per sua intima forza, all’interno di un mobilissimo processo intellettuale, ogni presupposto monaldesco. E persino nei momenti più inerti è possibile indicare temi e spunti suscettibili di uno svolgimento in senso progressivo. Così ancora nella dichiarazione proemiale del discorso Agl’italiani, dove non dovrà sfuggirci il sentimento di una classicità grecolatina, non soltanto latina: indizio di un interesse culturale che si apre a un ‘campo, quello degli studi greci, generalmente trascurato fino alla metà dell’Ottocento; con esiti di eccezionale importanza sia dal punto di vista dell’originalità della filologia di Leopardi sia in generale con riguardo alle misure di un classicismo la cui portata è incomparabile — tranne le eccezioni di Foscolo e su un
piano diverso di Giordani — rispetto al livello medio della cultura classicista contemporanea. Né dovrà sfuggirci, in vista delle sue prossime applicazioni, il significato particolare che assume ancora in quel luogo del discorso il tema del-
$ 42.
Filologia
ed erudizione;
il modello
del «letterato
cristiano »
ll
l'imitazione. Sullo sfondo di uno scenario vagamente metastasiano, alla luce di suggestioni per ora soltanto libresche, quel tema esprime la tendenza leopardiana a rifarsi antico nei costumi prima che nelle forme letterarie; in una direzione che, eliminate le scorie dei ricordi scolastici, sfocerà presto in quel n ucleo
di idee che costituiscono il terreno della poesia all’altezza dei primi canti. Ma a quel modello converrà pur sempre riferirsi: sia per misurare l’efficacia delle correzioni introdottevi dal giovane Leopardi, sia per definire i termini di una situazione storico-intellettuale certamente decisiva nella « carriera » leopardiana. Va detto intanto che il modello del « letterato cristiano » così come Giacomo mostra di concepirlo, derivandolo dalle certezze ideologiche dell'ambiente familiare, corrisponde al salto di qualità che si registra nel passaggio dall’educazione scolastica, sotto la guida dei Torres e dei Sanchini, agli studi prodigiosi dell’autodidatta. Pur senza cedere alla tentazione di inopportune sopravvalutazioni non si può negare, beninteso, che già nelle prove dell’apprendistato, in gran parte delle composizioni « puerili » più o meno direttamente legate all’insegnamento di Sanchini, si colgono i segni di una tensione culturale nei suoi limiti sorprendente. Le prose fanciullesche, in latino e in italiano, le traduzioni poetiche, i numerosi versi delle raccolte che fin nei titoli (La campagna, 1809; Componimenti poetici, 1809-10) denunciano il gusto arcadico e tutto settecentesco del compilatore, ci attestano una singolare capacità di risalire da un uso puramente strumentale della letteratura ad operazioni culturalmente più proficue. Nell’esperienza scolastica di Leopardi, conforme agli schemi di una pedagogia d’ascendenza controriformistica, la letteratura si poneva come il dato istituzionale, di partenza, della sua formazione; ma in un senso convenzionalmente retorico, sulla linea di un umanesimo cristallizzato, pedantesco, concepito a sua
volta a sostegno di una pretesa egemonica la cui componente classista, di privilegio e di discriminazione sociale, non tarda a manifestarsi dietro gli atti di fede (sintomatiche nelle memorie di Monaldo le pagine in difesa del latino e
in particolare tutto il cap. xIt) nei valori della tradizione classico-cristiana. In questo senso i versi e le prose « puerili » di Giacomo, di qua da ogni nostra attesa di natura estetica, rientrano nell’ambito di un generico esercizio umanistico, di pura educazione stilistica, affine a quello più vietamente grammaticale compiuto attraverso le composizioni in latino, le parafrasi e le prime versioni poetiche. Un esercizio imitativo, da esibire nei saggi pubblici di casa Leopardi complementarmente alle proprie nozioni di retorica, di aritmetica e di geometria. Nessuna possibilità di collegamento dunque, altro che sul piano di un’attitudine generica, rischiosamente sfuggente, con quell'esperienza del « bello » che Leopardi stesso
ascrive al 1816 a chiusura del periodo della formazione: una scoperta allora risolutiva, dopo gli anni nei quali « tutto il gusto » dello scrittore poteva dirsi preso dagli interessi filologico-eruditi ed egli si sentiva di « disprezzare quindi la poesia » (Zibaldone, 1741). Prima di quella data l’esercizio dei « puerili » varrà piuttosto a documentare i modi di un’entusiastica penetrazione nelle strutture di una
Giacomo Leopardi
12
civiltà letteraria, classica e classico-arcadica, scrutinata in tutta la sua estensione:
nei confini ovviamente segnalati al fanciullo come quelli di un mondo percorribile con fiducia; un mondo che, all’interno degli schemi monaldeschi che regolano — garante il Sanchini — l’educazione scolastica di Giacomo, tende a imporsi per una sua autonoma (non del tutto pretestuosa) validità culturale. La Corti, determinando il quadro fornitoci già da alcuni sondaggi precedenti, ne ha fissate le coordinate ricostruendo il sistema compositivo — dell’« incastro » e del « collage di varie fonti » — intorno al quale si aggregano ecletticamente i suggerimenti più diversi: quelli di un’Arcadia periferica, picena, con quelli degli scrittori « privilegiati in quanto ecclesiastici » (Frugoni, Roberti, Minzoni, Ceva ecc.), dei classici latini (da Cornelio Nepote e Fedro a Orazio, Virgilio, Cicerone ecc.) e di Omero tradotto, degli autori infine italiani (Dante, Caro, Tasso, Metastasio; e poi Zappi, Varano, Fantoni, Bertola, Alessandro Verri, Alfieri, Monti)
e stranieri (soprattutto Young in traduzione). In questo quadro, a parte le prestazioni meno significative, gli elaborati di Leopardi sottendono generalmente una dedizione assoluta, il pieno abbandono ai modelli cui si affidava il suo destino culturale. È la condizione di un mimetismo praticato a carte scoperte, a testimoniare una felicità riproduttiva che attraverso un materiale. assai composito (morale e religioso, storico-leggendario, idillico, favolistico) sa dichiararci le sue predilezioni senza contravvenire agli obblighi di un apprendistato diligente, disponibile a ogni sorta di travestimento formale, d’indiscriminata sperimentazione. Gli stessi temi che con riguardo a futuri sviluppi diremmo più congeniali — quelli della solitudine e della pace agreste, della notte, della tempesta — affiorano spontaneamente, per germinazione spontanea piuttosto che in virtù di una scelta lirica deliberata, in un repertorio tendenzialmente neutrale (ed esaustivo) di generi e forme largamente settecenteschi. Canzonette di vario impianto,
anacreontiche,
sonetti,
versi
martelliani,
terzine,
quartine,
sestine,
endecasillabi sciolti: sono le principali voci del catalogo metrico dei « puerili », attivate in componimenti di misura diversa, dai sonetti d’argomento classico (La morte di Ettore, La tempesta della flotta troiana ecc., 1809) ai poemetti e agli «idilli » in versi sciolti (Sansone,
1809; La spelonca, L'amicizia, I re Magi, Il
diluvio universale ecc., 1810), dalle strutture più esili del madrigale e delle favole moralizzate a quelle più ambiziose, dal disegno ampio e articolato, del Balaamo (1810), delle Notti puniche (1810) e soprattutto del Catone in Affrica (1810). L'esercizio è strenuamente mimetico. La sua innegabile positività nella storia leopardiana dovrà ricercarsi non tanto nelle sparse anticipazioni del Leopardi futuro: nei segni di una « predestinazione alla poesia » che, manifesta già in al-
cune apprezzabili deviazioni rispetto ai modelli poetici, si coglie specialmente — lo nota la Corti — nelle più libere movenze delle prose italiane; quanto nell'atteggiamento del fanciullo precoce, in generale, verso la cultura. L'abbandono confidente alla proprie letture, l’oltranza imitativa, la riscrittura e il gioco conta-
minatorio stabiliscono un rapporto diretto con i modelli, di appropriazione personale. Sulla spinta dei suoi entusiasmi, senza premeditazione, Giacomo si as-
$ 42.
Filologia ed erudizione;
il modello
del « letterato cristiano »
13
sicura così un prezioso ambito d’iniziativa. La guida di Monaldo e di Sanchini non può non cedere là dove ha inizio l’accertamento autonomo, l'esplorazione di un mondo di forme che di qua dalla letteratura, prima di ogni preoccupazione specificamente letteraria, si offre come un’occasione unica, prodigiosamente afferrata, di un impegno intellettuale in definitiva responsabile di se stesso. Il collegamento più consistente sarà insomma da istituirsi con il futuro prossimo dell’autodidatta, con gli anni di un isolamento negli studi fra i cui presupposti sarà l'affrancamento integrale dagli schemi retorico-gesuitici dell’insegnamento monaldesco, in una prospettiva che restituisce appieno alla cultura il valore di un’esperienza non più decorativa e di mera distinzione sociale, potenziandone gli aspetti tecnici, coscientemente professionali: quegli aspetti che nei « puerili » corrispondono all’esercizio insistentemente formale — metrico, stilistico — del tirocinante, sulla via che porta direttamente all’approfondimento del suo impegno in senso filologico e linguistico. È probabile che la tensione culturale e certa puntigliosità tecnica dei « puerili » valessero di per sé a immunizzare Leopardi contro il malanno della versificazione gratuita e dilettantesca: un male epidemico nella nostra cultura setteottocentesca e oltre. Ma ciò non toglie nulla alla funzione correttiva esercitata dal modello del «letterato cristiano » quando questo, sottratto all’ordinaria amministrazione scolastica, si propone nella storia di Leopardi con tutto il peso di un progetto ideologico abbracciato di slancio. Quel malanno e i suoi postumi, le conseguenze perniciose d’ogni frigido accademismo, risultano allora del tutto scongiurati. Così come scongiurato risulta il rischio di un’attività intellettuale che dopo gli anni scolastici prosegua solo per forza d’inerzia, senza interrogarsi sulle proprie motivazioni e sui propri fini. In questo consiste precisamente il salto di qualità attribuibile al momento del passaggio di Leopardi dopo il 1812 agli studi senza maestro, specialistici, dell’erudito e del filologo. Filologia ed erudizione corrispondono in Leopardi a interessi fra loro intimamente connessi. Nel passo anzi dello Zibaldone sopra riferito, in cui si dichiarano determinanti le « circostanze » ambientali e familiari che lo vollero filologo, Leopardi usa un termine per l’altro (« Le circostanze mi avevan dato allo studio delle lingue, e della filologia antica. [. . .] Il mio passaggio però dall’erudizione al bello [. . .]») come fossero sinonimi, o meglio come se un termine confluisse naturalmente nel secondo, rilevando così l'omogeneità e non soltanto la strettissima contiguità in lui di quegli interessi. Vale la pena di notarlo perché, al contrario, potremmo essere tentati di dissociare la produzione più propriamente filologica di Leopardi da quella erudita. Se guardiamo ai risultati la distanza è beninteso incolmabile. Fin nei primi lavori — nei Commentarii del ’14 sulla vita e le opere di Esichio Milesio, di
Porfirio, dei retori; e poi nel 15, nelle Lucubrationes su Giulio Africano — l’apparato erudito, biografico e bibliografico, non più che compilatorio, costituisce l’aspetto caduco in una produzione che ci lascia invece intravedere le grandi qualità di un filologo « quale l’Italia ‘“ antiquaria ”° da lungo tempo non posse-
14
Giacomo
Leopardi
deva » (Timpanaro). Qualità esegetiche, d’interprete e acuto emendatore, confermateci dalle note che accompagnano i volgarizzamenti dal greco e dal latino del periodo 1815-7, quelli in particolare legati ai ritrovamenti di Angelo Mai (il Frontone, i frammenti delle Antichità romane di Dionigi d’Alicarnasso); e destinate a potenziarsi nel senso di una sempre più rigorosa specializzazione filologica negli scritti seguenti: nei contributi sul Filone di Aucher e sulle altre recenti scoperte di Mai, i primi libri del De re publica ciceroniano e la Cronica di Eusebio, pubblicati — fra il ’22 e il 23 — durante il soggiorno romano; e nelle numerose schede e osservazioni critico-testuali nate nel vivo di lavori poi sospesi (come l’esplorazione del fondo greco della Barberiniana) o in margine a imprese appena progettate (la traduzione di tutto Platone). Qualità coltivate assiduamente fino a quando, nel ’28, per lo stato della sua vista Leopardi non fu costretto a desistere dagli studi di filologia, limitandosi allora, fra il ’30 e il ’32, a seguire a distanza il lavoro preparatorio di Luigi de Sinner impegnatosi a pubblicare in Germania i suoi manoscritti oltre a numerosi appunti dello Zibaldone d’argomento filologico. Legati per molti versi ai processi maggiori della storia artistica leopardiana (pensiamo all’esperienza tecnico-linguistica conseguita attraverso le traduzioni e l’approfondimento teorico su problemi di stile), quegli studi si fanno apprezzare di per sé, come altrettante testimonianze di un impegno i cui orientamenti scientifici, di là dai limiti oggettivi che spesso li condizionano, si rapportano legittimamente alle tendenze più avanzate dalla filologia europea. In confronto la produzione strettamente erudita di Leopardi può dirsi persino trascurabile. Ciò vale per gli apparati informativi, bio-bibliografici e storici, che corredano le prime compilazioni de vita et scriptis ma può estendersi alle opere di respiro maggiore, la Storia dell’astronomia (1813) e il Saggio sopra gli errori popolari degli antichi (1815). Nella prima in particolare l’esposizione, consistente nell’accumulo di notizie indirette, in gran parte desunte dai repertori enciclopedici più in uso, si esaurisce nel tracciato di una faticosa esercitazione pedantesca. Certa verve divulgativa, i momenti di un più autentico fervore culturale, apprezzabili soprattutto nella seconda, mentre ci chiariscono la con-
dizione di un promettente fermento intellettuale e artistico, che sorprendiamo teso fra la saggistica di marca razionalistica e settecentesca e gli impulsi di una più morbida sensibilità romanticheggiante, alla Chateaubriand, poco o nulla aggiungono ai meriti scientifici, assoluti, di una filologia che s'impone brillantemente fra i residui del più trito enciclopedismo, all’interno di un mondo car-
taceo, di letture e autori peregrini. Ma da un diverso punto di vista proprio le maggiori opere erudite, più di quelle di puro interesse filologico, chiuse comprensibilmente in un esclusivo ambito tecnico, ci forniscono gli elementi per una valutazione complessiva di
questa fase della storia leopardiana. Una fase d’intensa applicazione negli studi, prodigiosamente laboriosa e fruttuosa, vivificata peraltro da preoccupazioni più generali. Preme sull’autodidatta l'esigenza di orientare la propria attività nel senso di un largo impegno intellettuale: adeguandola in prima istanza a quei
$ 42.
Filologia
ed erudizione;
il modello
del «letterato
cristiano »
15
princìpi d'ordine e di restaurazione anche morale che, esaltati nella predicazione etico-politica del discorso agli italiani, s’identificano in lui con l’obiettivo di un’ispirata missione culturale, di difesa e di divulgazione della verità contro l'errore. Un obiettivo cristiano-razionalistico acquisito pacificamente attraverso i rudimenti filosofici impartitigli da Sanchini, al quale ci rinvia già la polemica antimaterialistica delle Dissertazioni filosofiche (cfr. in particolare il Dialogo filosofico sopra un moderno libro); e che scopriamo attivo nelle opere d’erudizione, dove la battaglia contro l’errore e la superstizione — alla luce dell’« Evangelo » — può spingersi su posizioni illuministiche nel convincimento d’una piena identità fra la scienza e il dogma religioso, fra le verità razionali e quelle di fede:
[CONTRO L'IGNORANZA E GLI ERRORI]
Il mondo è pieno di errori, e prima cura dell’uomo deve essere quella di conoscere il vero. Una gran parte delle verità, che i filosofi hanno dovuto stabilire, sarebbe inutile se l’errore non esistesse; un’altra parte delle medesime è resa tuttora inutile per molti dagli errori che in effetti sussistono. Quante tra esse, che trovano degli ostacoli insuperabili negli errori che ne hanno occupato il luogo! quante, che facilmente potrebbono? apprendersi e sono difficilissime a conoscersi per gli errori che impediscono di ravvisarle! È ben più facile insegnare una verità, che stabilirla sopra le rovine di un errore; è ben più facile l’aggiungere che il sostituire. Egli è pur deplorabile che l’uomo, che ha sì breve vita, debba impiegarne, nel disfarsi degli errori che ha concepiti, una parte maggiore di quella che gli rimane per andare in traccia del vero. Tutti convengono che fa d’uopo rinunziare ai pregiudizi, ma pochi sanno conoscerli ?, pochissimi sanno liberarsene, e quasi nessuno pensa a recidere il male dalla radice. Si deridono con ragione i progetti di riforma universale. Frattanto è evidente che v’ha che riformare? nel mondo, e fra tutti gli abusi quelli che riguardano l’educazione sono, dopo quelli che interessano il culto, i più perniciosi. Noi parliamo dei pregiudizi della infanzia con indifferenza. Si sa che bisogna disfarsene, che non si può esser saggi senza averli dcposti. Essi però si suppongono inevitabili. Ma perché mai deve il fanciullo crescere fra gli errori? Possiamo assicurarci 5 che i pregiudizi della infanzia sarebbono 6 ben pochi, se non si avesse cura di accrescerli. La natura generalmente nasconde delle verità, ma non insegna degli errori; forma dei semplici, ma non
dei pregiudicati ?. La cattiva educazione fa ciò che non fa la natura. Essa riempie d’idee vane le deboli menti puerili: la culla del bambino è circondata da pregiudizi d’ogni sorta, e il fanciullo è allevato con questi perversi compagni. Cresciuto, fa d’uopo che 5
7
li errori
lari degli antichi,
con introd. e a c. di ni 1; in Tutte le opere, LE cap. W. Binni, con la collab. di E. Ghidetti, 1, Firenze 1969, pp. 770-2. 1. potrebbono: potrebbero. 2. conoscerli; riconoscerli come tali,
. v'ha che riformare: vi è di che riformare. . deviazioni. arbitri, ) . abusi: È assicurarci: essere certi. SE Sua . sarebbono: sarebbero. 7. pregiudicati: schiavi del pregiudizio,
Giacomo
16
Leopardi
egli sia sempre in armi per difendersene. Così la forza della verità è indebolita, la penetrazione degl’ingegni è inceppata, i progressi dello spirito umano sono ritardati. [. . .] Il volgo principalmente, vale a dire la massima parte del genere umano, è disposto ad imbeversi degli errori, e difficile a disingannarsi. La piccolezza del suo intendimento è incapace di comprendere la falsità di ciò che gli viene insinuato, e di valutare le prove che la dimostrano 8. Tenace dei suoi antichi costumi, esso lo è altresì delle sue antiche
opinioni. Servo per nascita, esso lo è similmente per elezione. Le altre classi della società partecipano ancor esse agli errori del volgo, ma questi diconsi popolari, perché regnano in singolar modo nel popolo. Quindi la Storia degli errori popolari è equivalentemente quella dei pregiudizi 9. Per distruggere almeno in parte questi nemici della ragione, fa d’uopo farli conoscere; per farli conoscere, fa d’uopo venirne al dettaglio. Una Storia pertanto degli errori popolari, quale da taluno si è in effetto intrapresa !°, può essere di grande utilità. Benché il mondo continui sempre ad essere il medesimo dopo la pubblicazione delle opere utili ed istruttive; e benché gli abusi universali !! non siano soggetti a riforme; quantità !2 di spiriti un poco deboli, ma forniti d’intendimento e capaci di cangiare opinione, possono profittare delle cure di chi travagli a disingannarli. Qui non si volle dare che un saggio degli errorj popolari degli antichi. Una storia completa di essi non si avrà forse mai, ed è anche verisimilmente impossibile l’averla. [. . .] Non essendo questa operetta, siccome dissi, se non un saggio degli errori popolari degli antichi, non si deve attendere da me un completo ragguaglio degli antichi pregiugiudizi. Un disegno sì vasto non potrebbe effettuarsi sì di leggeri 13. Mio intendimento fu di presentare un quadro delle false idee popolari degli antichi, e di descrivere colla possibile esattezza qualcuno dei loro errori volgari intorno all’Ente Supremo, agli esseri subalterni e alle scienze naturali !4. Per eseguire questo disegno, giudicai di dovere attenermi alla scorta dei poeti. È facile distinguere quando questi scrivono a norma delle opinioni dei filosofi, o seguono un sentimento particolare. D’ordinario essi parlano il linguaggio più communemente inteso, che è quello del popolo. Quindi possono riguardarsi come interpreti dei sentimenti del volgo: ed allorquando asserii essere stato un qualche errore commune agli antichi, io mi credei in diritto di allegarli per mallevadori della verità della mia proposizione 15. Una volta si venerava superstiziosamente tutto ciò che venia dagli antichi; ora si disprezza da molti senza distinzione tutto ciò che loro appartiene. Dei due pregiudizi l’uno non è minore dell’altro. Si vedrà in questo Saggio che gli antichi non andarono
8. la dimostrano: ogg. la falsità. 9. Quindi...pregiudizi: così nel capitolo conclusivo del Saggio: + Il pregiudizio [...] è ben differente dall’errore; poiché questo può nascere insieme e spirare, opporsi alle idee generalmente ricevute, esser commune a pochi, ed anche esser proprio di un solo; quello è neces-
sariamente durevole, la sua vità di raro si limita ad una sola generazione, esso è il sentimento del popolo e regna nella massima parte
degli uomini, o almeno di qualche nazione. Ogni pregiudizio è un errore, ma non ogni errore è un pregiudizio » (ed. cit., p. 866). 10. quale ...intrapresa: si riferisce a compila-
tori da lui consultati e ricordati nella Prefa-
zione: fra i quali Lorenzo Joubert e Thomas Browne. 11. universali:
divenuti
comuni,
accettati
dai
più. 12. quantità: un certo numero, 13. di leggeri: facilmente. 14. errori volgari...naturali: indica i temi principali del Saggio: le false credenze dei pagani, le superstizioni relative ai presunti poteri di coloro che, come i maghi e le streghe, si dichiarano interpreti ed esecutori (esseri subalterni) della divinità, gli errori infine legati all’ignoranza scientifica. 15. proposizione: ipotesi dichiarata, affermazione,
$ 42.
Filologia ed erudizione;
il modello
del «letterato cristiano »
17
esenti dagli errori i più grossolani; ma agevolmente si comprenderà che il volgo dei moderni non cede loro quasi in verun conto. Non pochi anzi dei pregiudizi che regnavano un tempo sono anche al presente in tutto il loro vigore. Dopo queste riflessioni, il rispetto, non altrimenti che il disprezzo per l’antichità, viene a moderarsi, le età si avvicinano nella mente del saggio, e si comprende che l’uomo fu sempre composto degli stessi elementi.
Più delle singole osservazioni in questa pagina introduttiva al Saggio, intesa a chiarirne i presupposti di massima e sommariamente la fisionomia, conta soprattutto l'impianto del discorso. Al cui fondo, pur nella prevalente genericità degli argomenti, non si tarda a scoprire la presenza di un serio proposito divulgativo. In virtù del quale il tema del Saggio e il suo assunto cattolico-illuministico si rapportano preventivamente ai criteri tutti dichiarati di una compilazione responsabile, esplicita nell’indicare i limiti materiali della trattazione e le sue fonti, sensibilmente attenta alla precisione terminologica, con riferimento alla difficoltà dell'impresa e alla necessità di determinarne il campo, in vista di un destinatario che, per quanto segnalate approssimativamente, pure si affaccia nell’orizzonte dello scrittore a garantirne la funzione sociale. L'impegno del compilatore, avvalorato dall’antico primato umanistico, della cultura concepita come un alto magistero individuale, può così commisurarsi a più precisi compiti storici. Notevole per quest’ultimo aspetto — oltre che per le significative implicazioni autobiografiche — la presa di posizione nei confronti di una pedagogia innaturale e arretrata: un atteggiamento illuministico, ribadito anche altrove nel Saggio, la cui forza di persuasione corrisponde alla capacità del giovane d’individuare un tema concreto che, sottratto a un progressismo di massima, all’utopia dei « progetti di riforma universale », aderisce a una problematica sostanzialmente riformatrice e innovativa. Se la fede leopardiana nel « regno della ragione » e nei « progressi dello spirito umano » può valere a distanza come un dato segretamente perturbatore, dirompente, in un sistema culturale esposto fin dall’inizio, per le sue stesse premesse razionalistiche, a spontanee trasformazioni in senso laico-settecentesco, si deve aggiungere che gli elementi che sorprendiamo nell’introduzione al Saggio, generici quanto si voglia e tuttavia rivelatori della serietà con cui l’adolescente si assume il compito di volgarizzatore del vero scientifico, ci accertano di un’evoluzione sotterranea destinata ben presto a darci i suoi frutti. Lo scrupolo del divulgatore, nella duplice prospettiva dell’erudizione settecentesca e della più vivace saggistica di tipo illuministico, tra Fontenelle e Voltaire, compresi alcuni dei maggiori esemplari italiani (Algarotti, Bettinelli), è il sintemo di una coscienza culturale già sufficientemente matura per scoprire, prima o poi, i limiti oggettivi della condizione recanatese: il rischio in particolare di esaurirsi in un
ambito poveramente accademico e provinciale. Il modello del « letterato cristiano » e il sentimento che gli si collega di un’impegnativa missione di verità operano in questo senso positivamente. Predisponendo il giovane ad assegnare ai propri
18
Giacomo Leopardi
interessi una più alta giustificazione sociale lo sensibilizzano al problema della propria identità intellettuale inducendolo presto a valutare il pericolo che a Recanati, in una realtà subalterna, tagliata fuori dalla cultura contemporanea, quegli interessi s’insteriliscano in un esercizio privo d’ogni significato. A conclusione di un processo evolutivo che possiamo in gran parte solo ipotizzare, affidato a una maturazione spontanea e perciò non necessariamente avvertita nella sua logica interna, l'amicizia con Giordani nel ’17 avrà il significato di una preziosa occasione liberatoria sulla via di una revisione ideologica radicale. Nel frattempo Giacomo provvede a consolidare la propria cultura letteraria. Le numerose traduzioni e i « travestimenti » dal latino e dal greco, dagli anni puerili in poi, fino alle versioni del 1 libro dell’ Eneide e della Titanomachia esiodea, attraverso alcuni tentativi di poesia originale, ci accertano di uno strenuo tirocinio nel senso di un gusto classicheggiante che si procura, con crescente consapevolezza tecnica e ‘artistica, gli strumenti della propria espressione. Le traduzioni oraziane — i primi due libri delle Odi e l’Arte poetica in otta-
va rima — non vanno oltre un prevedibile esercizio di scuola nelle forme del più trito classicismo arcadico. Ben più interessanti le versioni dal greco del biennio 1814-5. Dove il rapporto col testo si fa più personale lasciando emergere nelle annotazioni in calce agli Scherzi epigrammatici e soprattutto in un Discorso introduttivo agli /dilli di Mosco le tracce di una significativa predilezione per il linguaggio «semplice » e « naturale » degli originali. Significativa, questa predilezione di Leopardi, non tanto in prospettiva futura, con riguardo al momento idillico nella storia dei Canti (pensiamo alle indicazioni in questo senso di De Sanctis); quanto per determinare un gusto letterario che aderisce alla cultura settecentesca riprendendo anche dai traduttori più in voga — da Pagnini in particolare — le misure di una sensibilità linguistica volta a valori di grazia incontaminata, di civiltà espressiva non corrotta dall’artificio: nella direzione (lo dimostra Binni) di un neoclassicismo suscettibile di precise variazioni stilistiche, individuabili fra il Gessner tradotto da Soave e l’Ossian cesarottiano. Nelle versioni della Batracomiomachia e del Moretum, negli anni 1815-6, Leopardi imbocca invece una via diversa. La ricerca della fedeltà massima possibile al testo originale, quell’aspirazione che in precedenza si era espressa nel tentativo di riprodurre il « sapor greco » dei componimenti tradotti, cede ora alla tentazione di una restituzione più spigliata, quasi un rifacimento libero alla maniera parodistico-burlesca di Casti e nella chiave realistica della nostra tradizione didascalica cinque-settecentesca per quanto in specie attiene al Moretum,
la Torta nella traduzione leopardiana: con esiti precisamente valutabili a distanza, attraverso il duplice rifacimento della Batracomiomachia (nel 1821-2 e poi nel ’26), nell’esperienza satirica dei Paralipomeni. All’altezza della « conversione » letteraria, nel quadro di un allargato impegno culturale, anche teorico, come dimostra la contemporanea Lettera ai compilatori della « Biblioteca italiana », l’attività del giovane traduttore subisce una sensibile svolta. A determinarla, lo ha scoperto Bigi, concorre la conoscenza da parte di Leopardi di due articoli
$ 42.
Filologia ed erudizione; il modello del « letterato cristiano »
19
foscoliani (Sulla traduzione dell’« Odissea »; Caro e Alfieri traduttori di Virgilio). A questi risale il ritrovato proposito di una versione fedelmente letterale ma soprattutto il convincimento che l’esercizio del traduttore non possa disgiungersi dalla preliminare approfondita conoscenza di tutta intera la civiltà dell’autore. Conservare il « calore » dei grandi classici, di Omero e Virgilio, ai quali attinge ora Leopardi volgarizzandone rispettivamente il 1 libro dell’Odissea e il 11 dell’Eneide, non è possibile senza avere assimilato intimamente il mondo antico così da rifletterlo nella parola che scrupolosamente lo faccia rivivere. Che è preoccupazione di grande significato se pensiamo all’itinerario ideale in cui s'iscrive: nell’ambito di un’ideologia letteraria che, fatta propria la nozione neoclassica e puristica della naturalità e verginità della lingua, ne deriva presto il principio che attribuisce agli antichi, in opposizione ai moderni, lo stato di un'assoluta felicità immaginativa; secondo una logica che trascende facilmente il campo della letteratura e delle polemiche letterarie, con la Staél (nella Lettera del ’16 indirizzata alla « Biblioteca italiana ») e successivamente con Di Breme (nel Discorso di un italiano), per investire un altro ordine di problemi, largamente morali, relativi alla necessità che i moderni sappiano rifarsi antichi rinnovando nel contatto con la classicità greco-latina la condizione primigenia
di una felicità naturale. Rifarsi antico, assicurando al proposito di una puntuale aderenza al testo il supporto della propria erudizione classica e disciplina filologica, è intanto il metodo del traduttore. Un metodo da rapportare evidentemente alle irrinunciabili inclinazioni ormai dello scrittore, nel senso di una trasposizione che, pur nel rispetto della lettera originale, giusta la lezione di Foscolo, non si sottrae
a certo gusto magniloquente, portato alla coloritura patetica e drammatica, studiatamente arcaicizzante. Ciò vale per la versione dall’Odissea e più ancora Ber quella dall’ Eneide: II. [LA MORTE DI PRIAMO]
Forse ch’il fato di Priàmo ancora vaga d’intender sei. Poscia che presa ruinar Troia vide, e de la reggia svelte le porte, e l’inimico in mezzo a le sue stanze, gli omeri tremanti per lunga etade, invan grava de l’armi già da gran tempo disusate, e cinge
35 Crati
del libro secondo della « Eneide », Tutte le opere cit., 1, p. 441.
689. vaga: desiderosa. Si riferisce a Didone
i
690
cui è indirizzato il racconto di Enea. 691. svelte: divelte, scardinate.
693. grava: appesantisce.
Sogg. Priàmo,
Giacomo
20 695
700
705
710
Leopardi
l’unitil ferro, ed a morir si reca
fra il denso stuolo Acheo. Fu sotto il nudo asse del cielo, a la magione in mezzo, una grand’ara, e soprastante a lei antichissimo lauro che con l’ombra i Penati abbracciava. A questa insieme con sue figlie affollate Ecuba venne, come per atro turbine colombe precipitose; e con le braccia indarno di divi simulacri avviticchiate sedevan tutte. Allor che Priamo scorse di giovenili armi coperto: « E quale, — Ecuba disse — a rivestir quest’armi, consorte infelicissimo, ti spinse crudo pensier? Non quest’aita al tempo vuolsi né schermo talj non s’anco il mio
Ettor qui fosse. Or t’avvicina. O tutti ne salverà quest’ara, o insiem cadremo ».
715
720
725
Disse, e il veglio a sé trasse e ne la sacra sede locollo. Ecco scampato appena da la strage di Pirro, un de’ suoi figli, Polite, in mezzo a gl’inimici, a l’armi fugge pe’ lunghi portici, e piagato trascorre gli atri spaziosi. Ardente con telo ostil Pirro l’incalza, e il preme già con l’asta, e con la man l’afferra. A gli occhi al fin de’ genitori innanzi appena giunto e’ fu, cadde, e la vita con gran sangue versò. Qui non si tenne, benché cinto da morte, e non represse Priàmo i detti e l’ira: «A te gl’Iddii per quest’orror, — gridò — per questa prova
nefanda, se pietà nel ciel s’alloga, che di ciò curi, a te dien premio, e cambio
730
rendan gl’Iddii qual ti si debbe, il fato del figliuol mio poi ch'a veder m'hai stretto,
696-7. sotto ...cielo: traduce l’espressione virdi Ettore, se non fosse ormai morto, risultegiliana «sub aetheris axe » (v. 512). rebbe di scarsa efficacia. 702. atro turbine: corrisponde all’«atra [...] 712. ne: ci. tempestate » dell’originale (v. 516). 715. Pirro: o Neottòlemo, il figlio di Achille e 704. simulacri: le statue sacre (divi) dei Pedi Deidamia. nati. 718. trascorre: attraversa di corsa. 709. crudo pensier: pensiero crudele, funesto; 723. tenne: trattenne. Virgilio: « mens [...] dira» (v. 519). — dl 724. benché ...morte: così nell’originale: tempo: alla gravità del momento. «quamquam in media iam morte tenetur » 710. schermo: difesa. Ben altro aiuto — ammo= (VS533)5 nisce Ecuba — e ben altri difensori occorre727. s'alloga: ha luogo, esiste. rebbero in un momento in cui la stessa presenza 730. stretto: costretto.
$ 42.
Filologia ed erudizione;
il modello
del « letterato cristiano »
e con suo scempio la paterna faccia - hai funestata.
Ma
ben altro, Achille
fu col nemico Re, quegli onde nato falso ti vanti. Ei me supplice accolse, e rispettò mia fé, miei dritti, e al rogo rendé l’Ettoreo corpo e rinviommi a la mia reggia ». Imbelle dardo in questa senz'impeto gittò, che risospinto dal roco bronzo immantinente, appeso invan restò del sommo scudo al mezzo. Cui Pirro: «E questo al genitor Pelide messaggio apporterai: sporgli mie colpe sèrbati a mente e il tralignar di Pirro.
735
740
Or muori ». E sì dicendo, a l’ara istessa
lo trascinò tremante e su pel molto sangue del figlio sdrucciolante, avvolse ne’ capelli la manca, erse con l’altra e nel fianco la spada profondogli insino a l’elsa. Il termine fu questo de’ fati di Priàùmo. Avea tal sorte al regnator de l’Asia, un dì per tante terre e popoli alter, fissa il destino.
745
750
Troia incensa mirar, l’Iliache torri
diroccate in morendo: e’ vasto tronco in su la riva giacesi, dal busto divelto un capo, e senza nome un corpo.
755
L'orientamento stilistico del traduttore di Omero e di Virgilio, ribadito nell’ingegnoso ricalco dell’Inno a Nettuno (la contemporanea contraffazione delle Odae adespotae ci rinvia piuttostò al canone della « semplicità » che aveva informato la versione di Mosco), si esprimerà ancora nelle traduzioni del ’17 e in particolare in quella della Titanomachia esiodea. Ma nel frattempo Leopardi era andato maturando altre esperienze. Nell'area di una produzione schiettamente originale, estranea del tutto al carattere di divertissement letterario che improntava l’esercizio umanistico dell’Inno a Nettuno e delle Odae adespotae, la tragedia appena avviata e lasciata incompiuta (Maria Antonietta) e nel medesimo anno — fra il novembre e il dicembre del 1816 — la composizione del
733-4. onde ...vanti: dal quale ti vanti di essere disceso, tu figlio in realtà degenere.
735. al rogo: gli onori e le pratiche funebri. Virgilio: «sepulcro reddidit » (vv. 542-3). 737. Imbelle: debole, inoffensivo. Anche Virgilio: « telumque imbelle » (v. 544). i 742-3. sporgli...Pirro: ricordati di esporgli
le mie colpe e di avvertirlo che Pirro traligna. 747. erse: sollevò (ogg. la spada). 748. profondogli: affondò, immerse. 752. alter: unisci a regnator, superbo.
753. incensa: in fiamme; come « Troiam incensam » (v. 555).
in Virgilio:
Giacomo
22
Leopardi
l’Appressamento della morte, mentre ci attestano la rilevante omogeneità che collega in questa fase il gusto del traduttore a quello del poeta, valgono anche a segnalare il declino di un’attività che, ripresa successivamente ma in un contesto assai mutato di problemi e di implicazioni culturali, è costretta ora a cedere il passo alle ragioni di una nuova improrogabile esigenza espressiva. In particolare l’Appressamento della morte, la « cantica » ricordata da Leopardi ancora negli anni maturi come un momento significativo della sua storia, è il documento di una letterarietà nutrita dall'esperienza in corso, quella del traduttore di Omero e di Virgilio e presto di Esiodo; e tuttavia indirizzata all’obiettivo di una più diretta testimonianza di sé. Nella struttura allegorica del poemetto, esemplato su modelli relativamente recenti (Varano, Monti), e carico insieme di suggestioni propriamente dantesche, la materia più personale si restringe all’ultimo canto, il v; filtrata peraltro, anche qui, attraverso lo schermo di un linguaggio risaputo, largamente alfieriano:
III. [PRESENTIMENTI
10
15
20
25
DI
MORTE
E DESIDERIO
DI
GLORIA]
Poco andare ha mio corpo ad esser morto. I’ mi rivolgo indietro e guardo e piagno in veder che mio giorno fu sì corto. E ’n mirar questo misero compagno cui mancò tempo sì ch’appien non crebbe, dico: Misero nacqui, e ben mi lagno. Trista è la vita, so, morir si debbe; ma men tristo è ’l morire a cui la vita che ben conosce, u’ spesso pianse, increbbe. I’ piango or primamente in su l’uscita
di questa mortal piaggia, che mia via ove l’altrui comincia ivi è finita. I’ piango adesso, e mai non piansi pria: sperai ben quel che gioventude spera, quel desiai che gioventù desia. Non vidi come speme cada e pera,
III. Appressamento della morte, c. v, vv. 10-54; in Tutte le opere cit., 1, p. 317.
10. Poco. andare ...morto:
ricalca
Petrarca
(cfr. Canz. 76, 14; «questi avea poco andare ad esser morto »); successivamene nel Sogno:
«A desiar colei / che d’ogni affanno il tragge, ha poco andare / l’egro mortal» (vv. 2931). 11. I° mi rivolgo indietro: ancora Petrarca (cfr.
Canz. 15, 1: « Io mi rivolgo indietro a ciascun passo ?).
13. compagno: il suo corpo. 15. ben: a buon diritto. 17-8. ma men tristo... increbbe: morire è meno doloroso per chi, avendo sperimentato e sofferto la vita, ha avuto il modo di provarne disgusto. Per il tema cfr. anche // sogno ai vv. 34-7.
— w°: dove, nella quale.
;
$ 42.
Filologia ed erudizione;
il modello
del «letterato cristiano »
e ’l desio resti e mai non venga pieno, così che lasso cor giunga la sera. Seppi, non vidi, e per saper, nel seno non si stingue la speme e non s’acqueta, e ’l desir non si placa e non vien meno. Ardea come
fiammella
[S°)(3)
30
chiara e lieta,
mia speme in cor pasciuta dal desio quando di mio sentier vidi la meta. Allora un lampo la notte m’aprio, e tutto cader vidi, allor piagnendo ai miei dolci pensieri i’ dissi: addio. Già l’avvenir guardava, e sorridendo
35
dicea: Lucida fama al mondo dura,
fama quaggiù sol cerco e fama attendo. Misero ’ngegno non mi die’ natura. anco fanciullo son: mie forze sento: a volo andrò battendo ala sicura. Son vate: i’ salgo e ’nver lo ciel m’avvento, ardo fremo desio sento la viva fiamma d’Apollo e ’1 sopruman talento. Grande fia che mi dica e che mi scriva
40
45
Italia e ’! mondo, è non vedrò mia fama
tacer col corpo da la morta riva. Sento ch’ad alte imprese il cor mi chiama. A morir non son nato, eterno sono
50
che ’ndarno ’l core eternità non brama. Mentre ’nvan mi lusingo e ’nvan ragiono, tutto dispare, e mi vien morte innante,
e mi lascia mia speme.in abbandono.
Che questo brano, e il canto v nella sua interezza, possa portarsi — come
riterrà lo stesso Leopardi (Zibaldone, 144) — a testimoniare un incontro anticipato, sotto la stretta delle « sventure », con la poesia « sentimentale » e di « affetti » poco aggiunge in realtà al significato complessivo del poemetto. Il cui valore documentario,
di là da ogni considerazione di merito artistico evidentemente
inopportuna, si affida comunque non tanto ai rari accenti di una risentita e imme-
diata verità autobiografica, quanto al tentativo di dar forma letteraria a un mondo 26-7. e ’l desio...la sera: e il desiderio resti inappagato e mai soddisfatto, sicché la morte sorprende un cuore avvilito. — sera: per « morte », immagine di diretta ascendenza dantesca (cfr. Purg. 1, 58: « Questi non vide mai l’ultima sera »; e Sopra il monumento di Dante, v. 102: « Vide la patria tua l’ultima sera »). 45. fiamma d’Apollo: la calda ispirazione della poesia.
46-8. Grande fia...morta riva: accadrà che l’Italia e il mondo intero proclameranno la mia grandezza con parole e con scritti, dall’aldilà non vedrò la mia fama spegnersi ‘insieme con il corpo. — morta riva: è immagine di gusto dantesco (cfr. Bruto minore, v. 73). 51. Che ’ndarno...brama: « La brama d’eternità è di per se ‘stessa indizio e pis di grandezza » (Fubini-Bigi).
24
Giacomo
Leopardi
intero, di pensieri e di persuasioni morali oltre che di sentimenti. Un mondo che lascia spazio all'ideologia del « letterato cristiano » più che ai trasalimenti e all’inquietudine dell’adolescente, riflettendo nella pretenziosa impalcatura del componimento, nelle sue ingenue e fruste invenzioni allegoriche, i princìpi fondamentali del moralismo monaldesco: la fede ultraterrena, il senso del peccato e della vanità delle attrattive umane, l'impegno apologetico contro gli errori dell’ateismo e del materialismo. Da questo punto di vista, con riguardo all’insieme dell’opera e al suo ambizioso disegno unitario, l’Appressamento della morte si colloca naturalmente a conclusione del primo tempo della « carriera » leopardiana. In misura ben più consistente degli altri tentativi coevi di poesia originale (l’idillio Le rimembranze oltre ai pochi versi della Maria Antonietta) la « cantica » ci dà il senso di un approdo in qualche modo risolutivo sulla via, singolarmente frastagliata, di una formazione ideologica e culturale di stampo tardosettecentesco con pesanti ipoteche clericali e reazionarie. Il pieno affrancamento del poeta si dovrà a un processo più maturo di ripensamento e di pensieri, sulla base di una stringente diagnosi della propria condizione d’intellettuale, dopo la conoscenza di Pietro Giordani e nel corso del fatidico 1817; e tuttavia non conviene trascurare già negli anni precedenti il ruolo svolto dalla letteratura all’interno di una « carriera » la cui conversione al «bello », a dispetto d’ogni condizionamento familiare, contro un’accezione retriva e meramente accademica della cultura, passa pur sempre attraverso il contatto diretto, di progressiva assimilazione e assuefazione, con i classici antichi e in particolare con i greci (Zibaldone, 1741). Fermi restanti i princìpi politici e morali di casa Leopardi, è nell’esercizio della letteratura che Giacomo, fin dalle sue prove « puerili », prende le distanze dall’educazione paterna, orientando quegli stessi princìpi nella direzione di un impegno non astratto e dilettantesco: costruito sulle misure di un umanesimo che, generico e moderato nelle operette apologetiche, in specie nell’orazione Agl’italiani, si libera d’ogni falsa retorica nei lavori filologico-eruditi.
Certa enfasi residua, nei secondi,
i
tratti di una religiosità fastidiosamente esclamativa si riscattano nel progetto di una missione di verità che fa propri gli ideali del razionalismo illuministico, rapportandoli a un'ottica cristiana e clericale ma avvalorandoli insieme col supporto di una sensibile consapevolezza tecnica e professionale. Il rigore del grande filologo, il maggiore in Italia al suo tempo, non può non proiettarsi nell’attività del divulgatore. Disponendolo non solo ad approfondire la propria informazione; ma a darle un significato concreto, con riguardo a responsabilità che, imperative alla coscienza del « letterato cristiano », si direbbero fermentare sot-
terraneamente richiamandolo con urgenza al problema di un'identità intellettuale che, pacifica per ora, scoprirà presto l’angustia della realtà recanatese;
e con questa il rischio della mortificazione e della frustrazione. Dall’umanesimo evasivo e reazionario voluto dalle « circostanze » a un umanesimo che, all’interno
delle medesime «circostanze » ambientali, getta le premesse del prossimo affrancamento. È il tracciato profondo del primo itinerario leopardiano.
$ 43.
$ 43.
Il «perfetto scrittore»
; il primo amore e le canzoni civili
ISS)1
Il «perfetto scrittore» ; il primo amore e le canzoni civili
Le lettere al fratello e al padre nelle quali Giacomo espone le ragioni che lo inducono nell’estate del ’19, appena raggiunta la maggiore età, al tentativo di fuga da Recanati ci portano nel vivo di una situazione il cui significato trascende l’episodio in se stesso, o almeno quanto di quell’episodio risente di una decisione presa d’impulso, nelle forme di una protesta intimamente persuasa eppure incline al gesto clamoroso, sofferto e insieme generosamente imprevidente, avventuroso, proprio ancora dell’adolescenza. La situazione è all’apparenza contraddittoria, divisa fra la coscienza di un merito e di un prestigio culturale autorevolmente riconosciuti e la sensazione di un totale fallimento. Lo scarto fra i due piani si verifica nel passaggio da un destinatario all’altro. Nella lettera a Monaldo la costrizione recanatese si commisura al diritto di una piena realizzazione di sé e delle proprie aspirazioni; un diritto rivendicato con passione, che si fa forte dei consensi ottenuti (« Ella non ignora che quanti hanno avuto notizia di me [...] hanno giudicato ch’io dovessi riuscir qualche cosa non affatto ordinaria »; Epistolario, 121) per affermare l’ideale di una vita che, sottraendosi agli accomedamenti di un’esistenza grigia e noiosa, sappia tradurre le proprie sofferenze in una prospettiva di eccezionalità magnanima e di grandezza:
Io so che la felicità dell’uomo consiste nell’esser contento, e però più facilmente potrò esser felice mendicando, che in mezzo a quanti agi corporali possa godere in questo luogo. Odio la vile prudenza che ci agghiaccia e lega e rende incapaci d’ogni grande azione, riducendoci come animali che attendono tranquillamente alla conservazione di questa infelice vita senz'altro pensiero. So che sarò stimato pazzo, come so ancora che tutti gli uomini grandi hanno avuto questo nome. E perché la carriera di quasi ogni uomo di gran genio è cominciata dalla disperazione, perciò non mi sgomenta che la mia cominci così. Voglio piuttosto essere infelice che piccolo, e soffrire piuttosto che annoiarmi (ibidem).
Nella lettera a Carlo, non meno importante di questa più nota al padre, la fiducia nella forza delle proprie aspirazioni e dei propri convincimenti cede a una constatazione inaspettatamente delusa. Gli stessi temi ripresi nella lettera a Monaldo suonano qui diversamente. Così per il tema della noia. Il riferimento al forte abbassamento della vista che nel '19 obbliga Leopardi a tralasciare gli studi conferisce ora a quel tema il carattere di un’esperienza più penosa per
quanto circoscritta. Quella « noia orribile derivata dall’impossibilità dello studio » (ivi, 120) avvalora in effetti, ma nei termini di una verità più stringente, tutta fisicamente sperimentata, lo stato d'animo che nella lettera a Monaldo si collegava, più in generale, alla condizione di una vita alienata nelle « mortifere malinconie » della solitudine e dell’inerzia. Così per il tema della felicità e della
Giacomo
26
Leopardi
grandezza. Le cui ragioni, venuta meno nella lettera al fratello ogni allusione alla stima di cui gode presso gli altri, fuori di Recanati, lo scrittore fissa in un’aspirazione
minima:
« Sta’ bene,
mio
caro,
e a riguardo
mio sta’ lieto, ch'io fo
quello che doveva fare da molto tempo, e che solo mi può condurre ad una vita se non contenta, almeno più riposata. Laonde se m’ami, ti devi rallegrare: e quando io non guadagnassi altro che d’esser pienamente infelice, sarei soddisfatto, perché sai che la mediocrità non è per noi» (ivi, 120). La sicurezza in se stesso, la fede in un ideale di vita che negli accenti alfieriani in cui si esprime riproduce una ferma volontà agonistica, la persuasione che « disperare di se stessi non può altro che nuocere » (ivi, 121), trapassa nel tetro sconforto di una confidenza raggelante: Che sono io ?Un uomo proprio da nulla. Lo vedo e sento vivissimamente, e questo pure m’ha determinato a far quello che son per fare, affine di fuggire la considerazione di me stesso, che mi fa nausea.
Finattantoché mi sono stimato, sono stato più cauto;
ora che mi disprezzo, non trovo altro conforto che di gittarmi alla ventura, e cercar pericoli, come
cosa di niun valore (ivi, 120).
È naturale che Giacomo calibrasse il suo discorso adeguandolo al destinatario: riservando al padre l’immagine di sé più sicura e rassicurante, lasciando al fratello le espressioni più inquiete del proprio animo. Cadremmo in errore tuttavia se pensassimo che le parole indirizzate a Monaldo corrispondano soltanto alla preoccupazione di dimostrare la legittimità della propria scelta affermandone il carattere di una risoluzione. presa al positivo, non per disperazione, alla luce di una coscienza adulta, consapevole delle difficoltà e nondimeno ferma nei suoi obiettivi. La contraddizione del resto è solo apparente. O piuttosto potremmo dire che nel discorso leopardiano, a parte il tono diverso e il diverso rilievo dato nelle due lettere ai temi trattati, le ragioni della fuga si richiamano a esperienze psicologiche ed esistenziali che si susseguono idealmente l’una al-
l’altra; in un rapporto per il quale l’una s’invera nell’altra, la più comprensiva, quella dichiarata al fratello, senza che la prima rinunci perciò a proclamare una sua verità comunque acquisita e per la parte che le compete valida in assoluto. Il riferimento più idoneo per valutare nella sua complessità un atteggiamento che investe la «carriera » poetica di Leopardi, segnando al suo interno la linea
discriminante che separa i canti più antichi (I! primo amore e le canzoni civili, All’Italia e Sopra il monumento di Dante, oltre ai Frammenti XXXVIII e XXXIX
che nel libro maggiore riproducono due luoghi rispettivamente del-
l’Elegia II e dell’Appressamento della morte) dalle canzoni filosofiche e dagli «idilli », resta quello rappresentato dalla storia dello scrittore: dalle vicende che negli anni compresi fra il 1817 e il 1819 ci spiegano il dilatarsi dell’orizzonte leopardiano, il suo protendersi a un nuovo modello ideologico; e insieme con questo, in un processo unitario di maturazione e di sviluppo, l’insorgere di una
$ 43.
sempre
Il « perfetto scrittore » ; il primo
amore
e le canzoni
più acuta curiosità introspettiva.
Vicende
civili
27
che ci rimandano: a persone
e
incontri decisivi, all'amicizia in primo luogo con Pietro Giordani; ma che sarebbe erroneo irrigidire nei termini, sempre improbabili del resto, della necessità e della causalità. L'elaborazione leopardiana segue delle leggi proprie. Di
qui la distanza che si frappone tra i dati materiali di quella storia e il loro esito più profondo nella coscienza dello scrittore. Una distanza da misurare con riguardo all'indagine filosofico-morale che lo Zibaldone, intrapreso nel ’17, ci documenta con intensità crescente a partire dal 1819-20; ma i cui presupposti sono già negli scritti che in questo periodo concorrono a definire la nuova dimensione dell’esperienza leopardiana, quella che Leopardi stesso dirà del « bello » e della « poesia » distinguendola dalla fase precedente, degli studi filologici, e dal momento di una successiva conversione dei propri interessi alla filosofia. L’amicizia con Pietro Giordani, consolidatasi dopo il primo scambio di lettere del febbraio-marzo 1817 nelle forme di una corrispondenza assidua, all’insegna di un reciproco cordialissimo abbandono di affetti e di pensiero, è per Leopardi l'occasione anzitutto di un’essenziale chiarificazione del proprio stato. L’invito a muoversi da Recanati che Giordani, colpito dalla sua straordinaria precocità, gli rivolge interrogativamente (« Non pensa VS. di fare per l’Italia un giro, per conoscere quel moltissimo che vi è di cose belle, e quel poco che ?»; Epistolario, ed. Moroncini, abbiamo d’uomini valenti
I, p. 59), insieme con
l’analogo incoraggiamento espressogli poco prima da Angelo Mai (« Perciò non posso che [. . .] desiderare che si trasferisca [. . .] in un teatro più degno della sua persona »; ivi, p. 57), giunge ad esasperare l’insoddisfazione e il risentimento polemico che in tempi non sospetti, quando ‘ancora Monaldo nori avrebbe potuto — come farà in seguito — attribuire a Giordani un’influenza nociva sul figlio, Giacomo manifestava all’editore Stella alludendo alla « miserabile città e provincia » (Epistolario, 15) in cui era costretto a vivere. Ma rispetto a quello stato d’animo la polemica antirecanatese che corre lungo il carteggio con Giordani, costituendone uno dei principali nuclei tematici, si determina in Leopardi nel quadro di una sempre più precisa attenzione alla propria identità intellettuale. Senza mettere in discussione, esplicitamente almeno, le posizioni ideologiche che informano il modello del « letterato cristiano », il giovane è presto indotto a confrontare le sue più vive persuasioni culturali con la realtà di un ambiente che puntualmente le vanifica. L'amicizia con Giordani gioca in questo senso un ruolo determinante. Più del consiglio di uscire da Recanati, un consiglio prudentemente
ritirato dinanzi all’imprevista, passionale reazione di Giacomo (« Di Recanati non mi parli. M’è tanto cara che mi somministrerebbe le belle idee per un trattato dell’Odio della patria »; ivi, 26), conta soprattutto il contatto in qualche modo
stabilito, insperatamente, con la maggiore cultura contemporanea attraverso uno
dei suoi esponenti più prestigiosi. Il punto di riferimento cui rapportare ora la propria attività non è più la nozione astratta, retorica, della « letteraria repub-
blica » invocata nella Storia dell’astronomia. Bene o male Leopardi si sente inserito in un gruppo intellettuale reale. Per quanto a distanza,i suoi interlocutori sono
Giacomo Levpardi
28
Vincenzo
Monti, Angelo Mai, Pietro Giordani; attraverso
Giordani
si affaccia
alla più vasta realtà della cultura settentrionale e centro-settentrionale italiana. Stringe amicizie nuove e nuove conoscenze, con l’ambiguo e sconcertante Brighenti ma anche in seguito con Giuseppe Grassi, con Giambattista Niccolini, con Cesare Arici, con Giuseppe Montani. La reclusione recanatese si fa tanto più penosa ora che al giovane sembra aprirsi concretamente la prospettiva di un’intensa vita intellettuale. Non possono non allettarlo le occasioni di lavoro culturale che gli si offrono: a parte Stella, un secondo editore milanese (Sonzogno) sollecita la sua collaborazione. Ma soprattutto lo attrae il miraggio di una presenza fisica nei luoghi in cui la cultura letteraria si elabora direttamente, senza mediazioni, senza gli inevitabili ritardi di un aggiornamento difficoltoso, precario per la mancanza di libri, per l’assenza d’ogni stimolo culturale. Soltanto ora che quella prospettiva si è aperta, grazie a Giordani, Leopardi si direbbe incoraggiato a guardarsi intorno, a porsi in relazione con l’ambiente più a portata di mano, quello marchigiano-romagnolo, d’impronta seriamente classicista, rappresentato dal cugino Francesco Cassi, prossimo traduttore di Lucano, da Dionigi Strocchi, da Giulio Perticari. Ma il miraggio resta spostato piuttosto verso Milano. La Milano ch’era stata teatro delle scoperte di Mai e della polemica classico-romantica: fatti decisivi, anche questo secondo, nella biografia culturale di Leopardi, il cui intervento (nel ’16) in polemica con la Staél — non pubblicato dalla « Biblioteca italiana» — costituisce il primo avvio del successivo fondamentale Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica; la Milano in qualche misura idealizzata, e comprensibilmente, nella fantasia del giovane: assunta a rappresentare insieme con il settentrione d’Italia un’eccitante realtà intellettuale in un appassionato confronto con il deserto recanatese: È un bel dire: Plutarco, l’Alfieri amavano
Cheronea ed Asti. Le amavano
e non
vi stavano. A questo modo amerò ancor io la mia patria quando ne sarò lontano; ora dico di odiarla perché vi son dentro, ché finalmente questa povera città non è rea di altro che di non avermi fatto un bene al mondo, dalla mia famiglia in fuori. [. . .] Ma qui tu sei dei primi, in città più grande saresti dei quarti e dei quinti. Questa mi par superbia vilissima e indegnissima d’animo grande. Colla virtù e coll’ingegno si vuol primeggiare, e questi chi negherà che nelle città grandi risplende infinitamente più che nelle piccole ?Voler primeggiare colle fortune, e contentarsi di far senza infiniti piaceri, non dirò del corpo del quale non mi preme, ma dell'animo, per amore di comando e per non istare a manca, questa mi par cosa da tempi barbari e da farmi ruggire e inferocire. Ma qui puoi esser utile più che altrove. La prima cosa, a me non va di dar la vita per questi pochissimi, né di rinunziare a tutto per vivere e morire a pro loro in una tana. Non credo che la natura m’abbia fatto per questo, né che la virtù voglia da me un sacrifizio tanto spaventoso. In secondo luogo, ma che crede Ella mai? Che la Marca e ’1 mezzogiorno dello stato Romano sia come la Romagna e ’1 Settentrione d’Italia? Costì il nome di letteratura si sente spessissimo: costì giornali accademie conversazioni librai in grandissimo numero. I signori leggono un poco. L’ignoranza è nel volgo, il quale se no, non sarebbe più volgo: ma moltissimi s’ingegnano di stu-
$ 43.
Il « perfetto scrittore»
; il primo amore e le canzoni civili
29
diare, moltissimi si credono poeti filosofi che so io. Sono tutt'altro, ma pure vorrebbero esserlo. Quasi tutti si tengono buoni a dar giudizio sopra le cose di letteratura. Le matte sentenze che profferiscono svegliano l'emulazione, fanno disputare parlare ridere sopra gli studi. Un grand’ingegno si fa largo: v'è chi l’ammira e lo stima, v'è chi l’invidia e vorrebbe deprimerlo, v'è una turba che dà loco e conosce di darlo. Costì il promuovere la letteratura è opera utile, il regnare coll’ingegno è scopo di bella ambizione. Qui, amabilissimo Signore mio, tutto è morte, tutto è insensataggine e stupidità. Si meravigliano i forestieri di questo silenzio, di questo sonno universale (Epistolario, 3):
Da un diverso punto di vista, attraverso il miraggio settentrionale e nella piena consapevolezza dei limiti che condizionano oggettivamente la sua attività di uomo di cultura, Leopardi riassume qui — in questa lettera a Giordani dell’aprile del °17 — persuasioni acquisite in buona parte già al tempo del Saggio sopra gli errori popolari degli antichi. Ma la coscienza professionale, d’intellettuale seriamente militante, che nel Saggio si era espressa nell’attenzione rivolta ai modi di una divulgazione sensibile alle proprie finalità sociali e quindi agli aspetti anche tecnici che potevano garantirne l’efficacia, si apre ora a una più risoluta ed esperta considerazione
del contesto ambientale
che, solo, è in grado di dare un senso
concreto, immediatamente costruttivo, all'impegno dell’intellettuale. Il miraggio vale per le esigenze che lo sottendono: esigenze personali, di uno studio non ritardato e subalterno, incoraggiato bensì dalle istituzioni culturali, dai mezzi d’informazione, dal confronto e dalle relazioni con gli altri; ma esigenze che investono
ancora
una volta la dimensione
sociale della cultura, richiamando
lo
scrittore a una funzione pubblica la cui verità non consiste più per Leopardi nel mito umanistico di un astratto primato, fruibile privatamente, quello per intenderci celebrato nella dedica dell’orazione Agl’italiani, quanto nella trama dei rapporti reali, storici, che lo collegano a un pubblico reattivo e a gruppi intellettuali in grado di stimolarne l’iniziativa. Si accelera così un proccsso di revisione che attraverso la polemica antirecanatese, rinnovando antichi malumori e disponendoli sulla linea di una più matura valutazione delle proprie aspettative, non tarda a estendersi all'ideologia del «letterato cristiano ». La crisi relativa alla propria identità di scrittore, al divario esistente fra le aspirazioni dell’uomo di cultura e la realtà effettuale che le deprime, mortificandole nella protesta impotente, nella crudeltà di una costrizione che appare senza scampo, coinvolge presto tutta intera la condizione recanatese, allargandosi naturalmente, in virtù di una naturale reazione psicologica e morale, ai valori familiari — etico-politici e religiosi — che di quella condizione rappresentavano il supporto ideologico fondamentale. Più lento (comprensibilmente) il distacco di Leopardi dal cattolicesimo e da ogni forma di religiosità positiva: un distacco che sarà pieno soltanto nel ”21, concettualmente sofferto, ritardato nel tentativo di un’impossibile conciliazione
teorica. Più rapido e risoluto l’allontanamento dalle posizioni grettamente clericali della famiglia e dai princìpi legittimisti. Per quest’ultimo aspetto la conver-
Giacomo
30
Leopardi
sione leopardiana, affatto indolore, ci richiama di nuovo all’influenza di Giordani e alla parte da questi avuta nell’evoluzione più strettamente politica del suo giovane amico. Un’influenza forse da non sopravvalutare ma neppure da ridurre nei termini di un incoraggiamento di natura esclusivamente tecnico-letteraria. Se è vero infatti che l’azione di Giordani è consistita « nell'avere spinto il giovane a una poesia civile ed eloquente, e non già nell’averlo convertito a ideali liberali e rivoluzionari » (Figurelli); va pur detto che quel suggerimento, impli cito nell’immagine del « perfetto scrittore italiano » tratteggiata da Giordani già all’inizio della sua corrispondenza con Giacomo (Epistolario, ed. Moroncini, 1, p. 124), risultava segnato da una sigla inequivocabile: quella di un classicismo progressivo, di diretta eredità illuministica e alfieriana, le cui prerogative tendono a un credo letterario
complesso,
intrinsecamente
innovativo,
dirompente,
e non
solo
in
sede artistica: Secondo me non è cosa che l’Italia possa sperare finattanto ch’ella non abbia libri adattati al tempo, letti ed intesi dal comune de’ lettori, e che corrano dall’un capo all’altro di lei. [. . .] E mi pare che l’esempio recentissimo delle altre nazioni ci mostri chiaro quanto possano in questo secolo i libri veramente nazionali a destare gli spiriti addormentati di un popolo e produrre grandi avvenimenti. Ma per corona de’ nostri mali, dal Seicento in poi s'è levato un muro fra i letterati ed il popolo, che sempre più s’alza, ed è cosa sconosciuta appresso le altre nazioni. E mentre amiamo tanto i classici, non vogliamo vedere che tutti i classici greci tutti i classici latini tutti gl’italiani antichi hanno scritto pel tempo loro, e secondo i bisogni i desideri i costumi e sopra tutto, il sapere e l’intelligenza de’ loro compatriotti e contemporanei. E com’essi non sarebbero stati classici facendo altrimenti, così né anche noi saremo tali mai, se non gl’imi-
teremo in questo ch’è sostanziale e necessario, molto più che in cento altre minuzie nelle quali poniamo lo studio principale. E fra tanto l’eloquenza italiana, e la poesia veramente calda e gravida di sentimenti e di affetti sono cose ignote, e non si trova letterato italiano ch’abbia fama oltre l’alpi, quando sentiamo di tanti stranieri famosi in tutta l’Europa. Ma V.S. dice ottimamente che allora avremo gran poeti quando avremo gran cittadini, ed io soggiungo che allora parimente avremo eloquenza e libri propriamente italiani e cari a tutta la nazione, allora ci sarà concessa qualche speranza
(ivi, 113):
così a Montani in una lettera del 21 maggio 1819. Leopardi ha già scritte le canzoni civili; la sua poetica, dopo il Discorso di un italiano, al momento in atto dei
primi « idilli », riflette la svolta dei nuovi interessi filosofici. Resta, a conferma di una validità mai rinnegata, sperimentata piuttosto in altri contesti, l’idea di una missione civile — in vista del canto Ad Angelo Mai — la cui espressione letteraria continua ad affidarsi al genere della poesia eloquente. Se risaliamo indietro nel tempo, rifacendo a ritroso l’itinerario di una scelta politicamente compromettente (Leopardi pagherà per anni l’audacia delle canzoni e i sospetti polizieschi che gli procurarono), non tardiamo ad accorgerci che il rapporto così
istituito fra sentimento civile ed eloquenza, nella prospettiva di una cultura che
$ 43.
Il «perfetto scrittore» ; il primo amore e le canzoni civili
31
dai classici deriva la lezione di una presenza socialmente liberatoria, ritraduce
proprio l’immagine che possiamo dire all’origine di quella scelta: immagine del «perfetto scrittore
italiano » che Giordani
voleva «ingegnosissimo », «di
costumi innocentissimi », «innamorato d’ogni genere di bello », « di cuor pietoso, e di animo alto e forte »; e poi ancora: « erudito », « dottissimo di greco e di latino ». Un’immagine che Giacomo riporta a misure meno enfatiche, riducen-
dola di un suo originario connotato di classe (quello della nobiltà di nascita e della ricchezza, che Giordani riteneva indispensabile) oltre che dell’aspetto più pedantesco: « Lo voglio — aveva scritto Giordani ancora del suo scrittore ideale — innamorato del Trecento; lo voglio persuaso che il solo scrivere bello italiano può conseguirsi coll’unire lingua del Trecento a stile greco »; ma conservandone integra la tensione civile e soprattutto convalidandone l’orientamento essenziale: quel suo disporsi verso il futuro come l’oggetto di un’attesa speranzosa (« l’unica ragionevole speranza di salute all'Italia » già per Giordani) la cui affermazione, ripetuta da Leopardi a Montani («allora ci sarà concessa qualche speranza »), comporta la convinzione di una crisi politica e quindi un atteggiamento verso il presente, d’insoddisfazione e di polemica, il cui significato in senso antilegittimista risulta indubbio; né sfuggirà a chi, come Monaldo o Antici, lo ritroverà presto tradotto nella materia delle canzoni civili. Si può discutere sull’efficacia storica di un progetto politico-culturale così fortemente ipotecato dalla letteratura. Così come si può discutere la portata reale, già a questa altezza della storia leopardiana, alla vigilia della sortita civile delle canzoni del ’18, di un sentimento politico evidentemente non isolabile dalle altre ragioni che nel loro insieme, in un intreccio di motivazioni non sempre dichiarate ed evidenti, sulla linea di un cammino assai mosso, mai del tutto prevedi-
bile, costituiscono l’elemento propulsivo nella fase del « bello » e della « poesia ». Nessun dubbio invece sulla forza di emancipazione ideologica che si affida a quel progetto. La cui definizione più avanzata prima del canto Ad Angelo Mai, quella formulata nella lettera a Montani, sensibile a istanze anche romantiche per quanto coerente con le posizioni fermamente classiciste del poeta, appare inconcepibile fuori del nuovo orizzonte che l’amicizia di Giordani apre a Leopardi; l’amicizia, ma anche in particolare lo scambio epistolare: va precisato, crediamo, con riguardo alle occasioni di analisi e di approfondimento concreto, di dominata problematicità e insieme di chiarificazione costante e utilmente circoscritta, che si offrono al giovane attraverso le lettere, nella scrittura, in misura
maggiore forse di quanto non sarebbe accaduto nelle forme di un collegamento più diretto ma meno intenso. Che l’atteggiamento di Leopardi, ormai (e definitivamente) contrario all’ancien régime, presupponga umori secrèti spontaneamente, indipendentemente da Giordani, negli anni o nei mesi di una rivolta che diremmo fisiologica, indistintamente antipaterna, è certamente sostenibile. Lo comprova l’estrema naturalezza di quell’atteggiamento, che si manifesta con i caratteri di un’acquisizione scontata, immune dai traumi di una conversione vera e propria, almeno attuale o troppo vicina, riferibile semmai a crisi superate di
32
Giacomo
Leopardi
crescenza e di formazione della persona. La parte di Giordani resta tuttavia fondamentale. Essa consiste nel far precipitare quegli umori intorno a un'ipotesi tutta ideale ma non perciò meno esaltante. Nella prospettiva di un impegno intellettuale rivitalizzato, il nuovo orizzonte aperto a Leopardi dal piacentino, si creano le condizioni perché il distacco dall’ideologia etico-politica di Monaldo non si esaurisca in un atto privato; disponendosi bensì nel senso di una scelta morale che trova in se stessa — nelle sue determinazioni più valide, d’ordine etico-intellettuale — il modo di risalire da un uso rinnovato della letteratura (aderente al modello del « perfetto scrittore italiano ») a responsabilità più generali, lucidamente e coraggiosamente innovative. Ecco perché, nota giustamente Timpanaro, « non aveva del tutto torto Monaldo, dal suo punto di vista reazionario, di gridare contro il Giordani che gli aveva fatto uscire dalla retta via polirica e religiosa il figlio ». Ciò non toglie nulla all’iniziativa leopardiana, all’originalità di un'evoluzione intellettuale e culturale che, incoraggiata attraverso un’intelligente discretissima maieutica, procede presto speditamente per conto proprio; riscoprendo nella sua logica interna i punti di forza perché al nuovo modello — del « perfetto scrittore italiano », sostitutivo di quello familiare del « letterato cristiano » — corrisponda l’energia intimamente stimolante di una verità commisurata alle esperienze personali del giovane e alle sue più autentiche predilezioni. Quel nuovo modello Giordani glielo aveva fornito profilandolo a sua immagine e somiglianza (« fate, Giacomino mio adoratissimo, di tener vivo all’Italia il suo perfetto scrittore, ch’io vedo in voi e in voi solo »). Leopardi lo raccoglie potenziandolo nell’aspetto di una fede letteraria che, prepotente ed esclusiva (« Ella può esser certa che se io vivrò, vivrò alle Lettere, perché ad altro non voglio né potrei vivere »: Epistolario, 26), si appoggia su un patriottismo di diretta ascendenza classicista fermo sulle posizioni, largamente tradizionali, di un vibrato nazionalismo linguistico: mia patria è l’Italia per la quale ardo d’amore, ringraziando il cielo d’avermi fatto Italiano, perché alla fine la nostra letteratura, sia pur poco coltivata, è la sola figlia legittima delle due sole vere tra le antiche, né certo Ella vorrebbe che la fortuna l’avesse costretto a farsi grande col Francese o col Tedesco, e internandosi ne’ misteri della nostra lingua compatirà alle altre e agli scrittori a’ quali bisogna usarle; come spessissimo è avvenuto a me che tanto meno di lei conosco la mia lingua, la quale se mi si vietasse di adoperare con darmisi pieno possedimento di una straniera, io credo che porrei la speranza di divenir qualche cosa nella vera letteratura, e lascerei gli studi (ibidem);
un patriottismo convenzionale, in sé neutro, che non a caso aveva potuto esprimersi in termini pressoché identici già nel ’16, nella chiusa della lettera indirizzata alla « Biblioteca italiana » in risposta all’articolo della Staél e non pubbli-
cata (Tutte le opere cit., 1, p. 882). L'influenza di Giordani vale a fissarlo, per
$ 43.
Il «perfetto scrittore»; il primo amore e le canzoni civili
33
così dire, fra gli elementi costitutivi di un’ideologia orientata in senso politicamente progressivo, nella direzione delle prime canzoni. Ma all’interno, questo, di un sistema di idee linguistico- letterarie alla cui evoluzione relativamente autonoma, conviene ribadirlo, deve pur sempre riportarsi il modello del « perfetto scrittore » e l’uso che Leopardi ne fa fino al canto Ad Angelo Mai. Il primo incontro con la letteratura e con i problemi della lingua letteraria si offre a Leopardi, nella memoria, con i caratteri di una sconvolgente (e casuale) rivelazione: «Io da principio avea pieno il capo delle massime moderne, disprezzava, anzi calpestava, lo studio della lingua nostra, tutti i miei scrittacci originali erano traduzioni dal francese, disprezzava Omero Dante tutti i classici, non volea leggerli, mi diguazzava nella lettura che ora detesto: chi mi ha fatto mutar tuono? la grazia di Dio ma niun uomo certamente » (Epistolario, 32). L’allusione è a un passato troppo indeterminato, e irrigidito nella dichiarata ma improbabile univocità delle sue fisime francesizzanti, perché sia possibile procedere a un’identificazione meno sommaria di quella che, con riferimento agli anni fanciulleschi, ci risospinge verso un generico gusto compilativo disinvoltamente modernizzante. La questione del resto è secondaria ai fini qui del nostro discorso; così come in secondo piano non può non passare il tema cui si ricollega, l'assoluta casualità per Leopardi di un’esperienza tanto decisiva e tuttavia maturata in solitudine, vincendo il sonno
recanatese, senza alcuna solleci-
tazione da parte dell'ambiente. Ciò che conta ora per noi, di là dalle persuasioni autocritiche e polemiche della memoria leopardiana, è l’atteggiamento al presente del giovane scrittore: il suo attestarsi sulle posizioni di un neoclassicismo praticato con convinzione, puntigliosamente difeso dagli attacchi del romanticismo lombardo, e nondimeno critico e intimamente selettivo. L'orientamento di massima è indicato dai nomi che ricorrono nella lettera in risposta alla Staél e in quelle a Giordani. I nomi di Parini, Alfieri
e Monti; lateralmente, quelli di Me-
tastasio e di Botta: segnali, soprattutto i primi, di una cultura e di un gusto sensibili alla tradizione classicheggiante italiana in tutta la sua estensione, fino al recupero simultaneo — sul piano intanto di una preliminare designazione di autorità e di valori indiscutibili — dell’Ariosto e del Tasso. L’area è ampia ma non perciò suscettibile di crescite scriteriate. Sintomatica in questo senso la rapidità con cui Leopardi dopo un momento di accensione, in omaggio a Giordani e alla sua tesi sulle analogie che esisterebbero fra lo stile dei greci e l'italiano trecentesco, si dispone a liquidare il mito puristico del « buon secolo »; prendendo così le distanze da quell’amore per il Trecento che il piacentino, non senza qualche rischio di pedanteria, allegava all'immagine del « perfetto scrittore ». Il ripiegamento di Leopardi sulle certezze del classicismo è risoluto, nella prospettiva — si badi bene — di una totale rifondazione della nostra cultura; e sulla spinta, per nulla affatto marginale, di un’intatta volontà di rinnovamento civile: vi dirò solamente che quanto più leggoi latini e i greci, tanto più mi s ’impiccolisconoi nostri [classici] anche degli ottimi secoli, e vedo che non solamente la nostra eloquenza
34
Giacomo
Leopardi
ma la nostra filosofia, e in tutto e per tutto tanto il di fuori quanto il di dentro della nostra prosa, bisogna crearlo. Gran campo, dov’entreremo se non con molta forza, certamente con coraggio e amor di patria (ivi, 79).
All’interno del modello giordaniano, fermo restante l’ideale di una scrittura che si alimenti nell’humus di una spiritualità intera, una scrittura carica di intenzioni ideologico-morali non meno che artisticamente ineccepibile, la rifondazione auspicata da Leopardi per la nostra cultura letteraria — trascuriamo il riferimento alla filosofia, per ora non più che di principio — passa attraverso alcune significative prese di posizione. Il rifiuto dell’equazione stabilita da Giordani fra il diletto estetico e il « bello » ideale (ivi, 35); la difesa, ancora contro Giordani, di una vocazione che lo spinge a contravvenire al precetto puristico per il quale l’esercizio della prosa, nella fase dell’apprendistato letterario, dovrebbe precedere quello ritenuto più arduo della poesia (ivi, 32): corrispondono queste posizioni, fra le più notevoli nel carteggio per gli anni 1817-9, alle ragioni di fondo di un’elaborazione teorica che, aliena da ogni forma di classicismo accademico, normativo e staticamente retorico, si dispone piuttosto ad assecondare l’esperienza viva, attuale, dello scrittore; ricevendone l’incentivo per l’approfondimento di una tematica che dal piano generale, istituzionale, della cultura lette-
raria si porterà presto su quello di una poetica in via di formazione ma già definita almeno nelle linee principali. È quanto accade a proposito del problema della lingua. La cui soluzione, ricercata nell’equilibrio fra il fondo nativo schiettamente « popolare » dell’italiano e un uso letterario in grado di esaltarne la naturalezza contro una tradizione d’arte irrigidita nel canone puristico e toscaneg-
giante, si apre a questioni che investono la dinamica stessa dell’espressione. In questa prospettiva, aliena da ogni ribellismo di tipo illuministico, alla maniera del « Caffè », non meno critica nei confronti degli atteggiamenti tradizionalisti e più vietamente puristici, c'è spazio sia per il riconoscimento spassionato del merito storico degli scrittori toscani o di scuola toscana sia per una più mossa e originale disamina dei concetti su cui si fonda il dibattito linguistico sette-otto-
centesco. Sulla traccia di Monti e di Perticari, con significativi aggiustamenti resi possibili dall'influenza giordaniana e forse (vi insiste Tateo) dall’accoglimento di alcune intuizioni di Cesari, Leopardi si ripropone il problema nei suoi aspetti fondamentali. La revisione, condotta anche sul terreno terminologico, riguarda il rapporto fra lingua scritta e lingua parlata, la distinzione fra « precisione » e « proprietà » (una nozione, questa della « proprietà », destinata a durare nel pensiero leopardiano: ce lo testimonia come è noto anche De Sanctis, rievocando la memorabile visita del poeta alla scuola di Puoti), il tema dell’« eleganza » e del « pellegrino »: nella direzione di una teoria dell'espressione letteraria, segnatamente poetica, le cui conclusioni, collegate a concetti di derivazione sensistica (fondamentale quello che presiede alla distinzione fra.«termini» e « parole »),
$ 43.
Il «perfetto scrittore»; il primo amore e le canzoni civili
35
spiccheranno fra i dati costitutivi, nel vivo ormai delle maggiori esperienze leopardiane, di una raggiunta maturità linguistica e lirica. In questo quadro, di fermento ideologico e di più pacata riflessione letteraria, d’inquietudine e di accesi entusiasmi ricompòsti nella chiara cognizione di sé e delle proprie attese di intellettuale, il mondo privato dello scrittore, le tensioni psicologiche, i trasalimenti della giovinezza, si pongono come un elemento attivo e vitale. Quel mondo, autobiografico almeno in prima istanza, affiorato già nell’Appressamento della morte torna a proporsi — alla fine del 1817 — nel cosiddetto « Diario del primo amore » e nei versi di poco posteriori (Il primo amore, già Elegia I) che sullo stesso tema, legato al breve soggiorno a Recanati della cugina Gertrude Cassi, ne rappresentano lo svolgimento intenzionalmente letterario, in una trama assai fitta di reminiscenze petrarcheggianti organizzate nella struttura ternaria, in terzine dantesche, dell’elegia amorosa.
A differenza della cantica la materia autobiografica risulta in partenza, nella prosa del diario, energicamente dissociata dalla letteratura. L’avvertenza di Leo-
pardi, secondo la quale durante la stesura di quelle pagine egli si sarebbe astenuto dalla lettura degli scrittori amorosi e in particolare di Petrarca, rende esplicita una preoccupazione di autenticità sentimentale e di spontaneità‘ehe, proclamata conclusivamente contro ogni possibile sospetto di convenzionalità e di artificio, corre lungo la relazione analitica, puntualissima, di stati d’animo interrogati sul nascere e fermati in una sorta di lucido e serrato referto psicologico:
[FANTASIE D'AMORE] [...] Ogni sera, stando in letto e vegliando a lungo, con ogni possibile industria m’adopero di richiamarmi alla mente la cara sembianza!, la quale probabilmente per questo appunto ch’io con tanto studio la cerco, mi sfugge, ed io non arrivo a vederne altro che i contorni, e ci affatico tanto il cervello che alla fine mi addormento per forza colla testa annebbiata infocata e dolente. Così m’accadde ieri sera, ma questa mattina svegliatomi per tempissimo, in quel proprio punto di svegliarmi, tra il sonno e la veglia spontaneamente m’è passata innanzi alla fantasia la desiderata immagine vera e viva ?, onde io immediatamente riscosso e spalancati gli occhi, subito le son corso dietro colla I. Diario del primo amore; cit., I, pp. 356-7.
in Tutte
le opere
‘ 1. la cara sembianza: l’immagine della Cassi, già minuziosamente descritta: « di ventisei anni {...] alta
e membruta
quanto
nessuna
donna
ch’io m’abbia veduta mai, di volto però tutt’altro che grossolano, lineamenti tra il forte e il delicato, bel colore, occhi nerissimi, capelli castagni, maniere benigne, e, secondo me, graziose, lontanissime dalle affettate, molto meno lontane dalle primitive, tutte proprie delle Si-
) gnore di Romagna e particolarmente delle penag saresi, diversissime, ma per una certa qualità inesprimibile, dalle nostre marchegine » (p. 353). 2. la desiderata...viva: nei versi del Primo amore l’espressione, usata qui in un contesto di puntuale verità psicologica, si fissa nei moduli di un linguaggio più astratto e convenzionale, di marca petrarchista: «la dolce imago » (v. 26), «la illibata, la candida imago » (v. 88), «la bella imago» (v. 101).
Giacomo
36
Leopardi
mente, e se non sono in tutto riuscito a farla tornare indietro, pure in quella freschezza di mente mattutina, tanto ne ho veduto e osservato e dell’aria del volto, e dei moti e dei
gesti e del tratto e dei discorsi e della pronunzia, che non che m’abbia fatto maraviglia l’esserne stato una volta preso, ho anzi considerato che se io avessi quelle cose tuttora presenti alla fantasia, sarei ben più smanioso e torbido ®che io non sono. Ora appresso a poco io duro come ne’ giorni innanzi, parendomi che il solo mio vero passatempo sia lo scrivere queste righe; coll’animo voto o più tosto pieno di tedio (eccetto nel caldo di quel pensieri), perché non trovo cosa che mi paia degna d’occuparmi la mente né il corpo, e guardando come il solo veramente desiderabile e degno di me quel diletto che ho perduto, o almeno come maggiore di qualunque altro che io mi potrei procacciare, ogni cosa che a quello non mi conduce, mi par vana; e però lo studio (al quale pure di quando in quando ritorno svogliatissimamente e per poco) non m’adesca più, e non mi sa riempire il voto dell'animo, perché il fine di questa fatica, che è la gloria, non mi par più quella gran cosa che mi pareva una volta, o certo io ne veggo un’altra maggiore, e così la gloria divenuto un bene secondario non mi par da tanto ch’io ci abbia da spender dietro tutta la giornata, distogliendomi dal pensare a quest'altro bene: oltrech’ella per avventura mi pare una cosa più lontana, e questo in certa guisa più vicino, forse perché nell’atto di leggere e di studiare non s’acquista gloria, ma nell’atto di pensare a quest'altro bene s’acquista quel doloroso piacere 9, che pure il cuor mio giudica il più vero e sodo bene ch’io ora possa cercare.
La presenza femminile evocata nella solitudine notturna, pensiero dominante tra la veglia e il sonno, è l’elemento catalizzante in un processo di sfogo e insieme di accertamento interiore la cui realtà — qui come nel resto del diario — non conosce altra dimensione se non quella di un prolungato fantasticare. Un processo privo di un vero svolgimento, chiuso nella constatazione di un sentimento fondamentale, il « doloroso piacere », intorno al quale in un giuoco relativamente vario di aggregazioni diverse si stringono alcune elementari situazioni psicologiche: l’eccitazione e la malinconia, un senso indefinito di vuoto, l’inquietudine e la svogliatezza; reazioni di un animo che si scopre «tenero e sensitivo », portato all’amore sentimentale, attento agli affetti più intimi non meno che alle altre inclinazioni, altrettanto autentiche, che lo spingono a inseguire il mito giovanile della gloria. L’accantonamento di quest’ultimo per un «bene più vero e sodo », il piacere «attuale » del pensiero amoroso, non significa un abbandono definitivo. Né può significarlo se poco dopo, nella conclusione del diario, lo scrittore immagina di «essere divenuto qualche. cosa di grande nelle 3. torbido: alterato, confuso (cfr. Il primo amore,
vv. 29-31). 4. appresso a poco: all’incirca. 35. distogliendomi ...bene: a proposito dello studio e della gloria, trascurati per l’urgenza di un interesse rivelatosi più gradito, cfr. anche Il primo amore, vv. 73-8; e ancora nel diario, a conclusione di questa stessa pagina: « non so vedere come ripiglierò l’antico amore allo studio,
perché mi pare che anche passata questa infermità ‘di mente, sempre mi dovrà restare il pensiero che c’è una cosa più dilettosa che lo studio non è, e che io n’ho fatto una volta lo sperimento »,
6. doloroso pilicere: per il tema, ma svolto in forme del tutto stilizzate, cfr. anche J/ primo amore, vv. 7-12 e passim.
$ 43.
Il «perfetto scrittore» ; il primo amore e le canzoni civili
37
lettere » e d’incontrare nuovamente la donna del primo amore, ricevendone allora un'accoglienza premurosa e gratificante. Si tratta bensì d’inverarlo, quel mito, in una più ricca vita interiore; alla luce intanto di un'esperienza che, esaltando
il « piacere » sia pur « doloroso » di quelle fantasie, si afferma nel mondo morale del giovane protestando l'esigenza di un benessere inteso come pienezza e vitalità dei sentimenti, gusto di sentire: una condizione vissuta nella sfera dell’irriflesso,
del « cuore », affidata alla verità immediata c corposa (un bene « sodo » dice Leopardi) di un’acuta mobilissima sensitività. L'analisi leopardiana, diretta « a conoscere se medesimo e le passioni » attraverso un massimo di fedeltà introspettiva si svolge tutta nell’ambito dello psicologismo sensistico. È un dato, questo, da rilevare sia con riguardo a prossime applicazioni concettuali sia allo scopo di precisare un atteggiamento che sorprendiamo carico di un potenziale linguistico-espressivo, oltre che ideologico, rispetto
al quale la stilizzazione del Primo amore (ma il discorso va esteso alla successiva Elegia II, parzialmente rappresentata nel frammento xxxviti dei Canti) costituisce un
indubbio
arretramento.
La condizione
del diario, la sua inebriante
verità
psicologica e fantastica, si determina in uno strenuo recupero della fisicità. Si tratta di un’operazione della mente che, circoscritta in un luogo deputato, il letto, lo spazio fisico delle fantasie notturne e della drammatizzazione sentimentale, consiste nel reiterato tentativo di restituire a un’immagine in dissolvenza, la «cara sembianza », i tratti reali del viso, i suoi gesti, il suono stesso delle parole pronunciate, della loro cadenza. Che è poi il tentativo di riprodurre la situazione iniziale: il turbamento
di chi, come il poeta ormai maturo all’amore, divenuto
sensibile all’«impero della bellezza », scopre nelle proprie emozioni il segno di un’esperienza sublime e tuttavia concretissima, fatta di attrazione per la persona « alta e membruta » della donna, per il suo volto dai lineamenti intensi e insieme delicati, acceso dagli occhi « nerissimi » e dai capelli castani, per le sue maniere gradevoli ma non affettate; emozioni che in un ingorgo di sentimenti, pur nell’indeterminatezza di alcuni, fra una vaga inquietudine e un’inesplicabile voluttà, si materializzano nelle manifestazioni che alterano l’equilibrio psico-fisico del giovane: il sentir parlare di quella persona, mi scuote e tormenta come a chi si tastasse o palpeggiasse una parte del corpo addoloratissima e spesso mi fa rabbia e nausea; come veramente mi mette a soqquadro lo stomaco e mi fa disperare il sentir discorsi allegri, e in genere tacendo sempre, sfuggo quanto più posso il sentir parlare, massime negli accessi di quei pensieri. [. . .] E sono svogliatissimo al cibo, la qual cosa noto come non ordinaria in me né anche nelle maggiori angosce, e però indizio di vero turbamento
(Tutte le opere cit., 1, p. 354); emozioni che si ripetono nel corso dell’intero memoriale: nel circuito di un pensiero che resiste all’affievolirsi dell'immagine, al progressivo (e inevitabile) esaurimento dell’infatuazione; aderendo a un « desiderio [. . .] di sentire e di amare »
Giacomo
38
Leopardi
‘che nell’attrito.,degli affetti e delle ‘sensazioni ritrovate, fra gli smarrimenti e le smanie dell'animo dinanzi all'immagine riguadagnata, trapassa sul piano di una conoscenza speciale, del ricordoe dell’immaginazione più che della ragione; una conoscenza eminentemente percettiva, alla quale corrisponde nel diario una prosa sliricizzata, oggettiva al limite del prosaico, intraducibile senza sacrificio negli schemi petrarcheggianti del Primo amore o in quelli che nell’E/egia II, sulla scia del Werther e dell’Ortis, ci propongono la soluzione altrettanto esterna della concitazione e del pathos. Ma
si devono
attendere
altre «situazioni,
affezioni,
avventure
storiche »
perché la tensione psicologico-sensistica del « Diario », riproducendosi in contesti diversi, sulla traccia anzitutto di una più sicura e totale aspirazione conoscitiva, rifluisca in un linguaggio che attraverso la designazione degli oggetti ripetendone a suo modo la fisicità, si ponga esso stesso — con esiti allora di originalità assoluta — come un elemento attivo di provocazione, al livello sensoriale, della memoria e dell’immaginazione. Conviene piuttosto, per ora, ritornare su quell’esigenza di genuinità dell’analisi che nel « Diario », lo abbiamo segnalato, ci spiega la deliberata astensione dalla lettura di Petrarca e degli scrittori amorosi in genere. La ricerca di una piena autenticità, l’insofferenza per l’artificio non significano l’illusione in Leopardi di poter fermare la propria scrittura al grado di un'assoluta, astratta, verginità sentimentale. Il « Diario » presuppone fin troppo evidentemente il modello della Vita di Alfieri (per l’episodio, inizialmente, del « primo amoruccio »: epoca II, cap. x) perché quell’illusione, se mai coltivata, potesse resistere fondatamente. Ma la questione è un’altra. Va detto intanto che la rimozione della letteratura non comporta alcun pregiudizio antiletterario. Non a caso il « Diario » è anche il ragguaglio di un’attività poetica che, inframezzata alla compilazione memorialistica in prosa, procede indipendentemente
da questa come
effusione in versi, nel « caldo della malinconia », di un
« cuore » poetico oltre che « sensitivo » e « molle ». Che i versi ricordati nel « Diario » debbano identificarsi con // primo amore o che ne rappresentino (come sembra
più probabile) una primitiva stesura, è qui secondario. Ciò che conta è il dichiarato piacere del poeta alla loro lettura, proprio nel momento della maggiore «svogliatezza a ogni cosa e specialmente allo studio »; a dimostrazione che nell’orizzonte del primo amore -— già nel « Diario » — la letteratura, lungi dall’esserne esclusa, partecipa di quella vicenda non meno degli altri elementi d’ordine psicologico e affettivo che ne costituiscono la ragione essenziale. La prosa del « Diario » semmai si afferma come altro dalla letteratura, un prima o un dopo se si preferisce, e non contro di questa: come il luogo in cui anche la letteratura, quei versi cui contemporaneamente
l’autore si dedica, distanziata nell’analisi, possa
comprovare la sua necessità; rapportandosi a quel bisogno di « sfogo » del cuore
che, mentre ne ribadisce l'urgenza in chi come Leopardi non si nasconde la propria vocazione di scrittore (« Volendo pur dare qualche alleggiamento al mio cuore, e non sapendo né volendo farlo altrimenti che collo scrivere [.. .]»), vale a determinarla di fatto nella prospettiva di una ricerca più lunga e impegnativa. ee
$ 43.
Il «perfetto scrittore»; il primo amore e le canzoni civili
39
Gli esiti elegiaci del « Diario », fermi pressoché esclusivamente alla sua occasione erotica, rappresentano soltanto uno dei possibili svolgimenti della poesia leopardiana all’altezza ‘del primo amore; uno svolgimento certo non trascurabile, con riguardo a una vena inesausta, fra il lirico e il narrativo, le cui espres-
sioni maggiori — dalla « Cantica » al Sogno al Consalvo — segnano la carriera di Leopardi dello stigma di una letterarietà intensamente emotiva, vistosamente fuori misura. Ma insomma riduttivo, quello svolgimento, se lo commisuriamo oltre che al potenziale linguistico del « Diario », cui abbiamo accennato, agli elementi che in quella prosa trascendono lo « sfogo » strettamente amoroso, o piuttosto lo aprono a una dimensione autobiografica tendenzialmente integrale; sullo slancio di una curiosità introspettiva che, sottraendosi al riscontro con esperienze consimili, approda a una realtà scoperta candidamente, in un movimento di emozioni sorprese a caldo e perciò tanto più sollecitanti. Che la scoperta fosse relativa, trattandosi di una riscoperta o meglio di un accertamento a posteriori, sulla scorta di un modello letterario (la Vita alfieriana nella sua interezza oltre che per l'episodio del « primo amoruccio ») già tutto assimilato e in gran parte condizionante, toglie poco al candore dell’ipotesi leopardiana; e anche meno alla naturalezza con la quale Leopardi, consapevole della sua fondamentale vocazione di scrittore, si dispone a ritrovarla attiva nel giro dei suoi affetti più stringenti e veri. Ma resteremmo ai margini della maggiore problematica leopardiana se dimenticassimo che quella vocazione, nel quadro intero della storia del poeta. nel periodo del primo amore, ha pure un preciso punto di riferimento. L’inclinazione alla scrittura, ritrovata nel « Diario » come il momento di una più complessa realtà personale, tutta coinvolta in questa, non può non specchiarsi prima o poi nell’ideale del « perfetto scrittore ». Si tratterà allora di saldare l'impegno civile sotteso al modello giordaniano con le ragioni del « cuore », trasferendolo sul piano di una più intima persuasione autobiografica, in grado di garantire l'autenticità delle passioni, anche di quella politica; ma soprattutto in grado di avvalorare la fede letteraria già espressa a Giordani (« vivrò alle Lettere, perché ad altro non voglio né potrei vivere ») orientandola sulla linea del « Diario » nel senso di un impegno totale, di conoscenza e di « sfogo » interiore oltre che di militanza intellettuale. L'alternativa alla soluzione dell’elegia amorosa è in definitiva nel progetto di una poesia che, senza rinunciare all’ideale giordaniano, riassumendone le intenzioni civili e parenetiche, sappia innestarle in una situa-
zione sentimentale che ne esalti il carattere di verità, proiettandole sullo schermo di una coscienza integrale del proprio stato e delle proprie aspirazioni. Un progetto intravisto alla vigilia della canzone All’Italia, in un « argomento » d’elegia la cui stesura risale al giugno del ‘18:
Oggi finisco il ventesim’ anno. Misero me che ho fatto ? Ancora nessun fatto grande. Torpido giaccio tra le mura paterne. Ho amato te cwà« O mio core. ec. non ho sentito passione non mi sono agitato ec. fuorché per la morte che mi minacciava. ec. Oh che
Giacomo Leopardi
40
fai? Pur sei grande ec. ec. ec. Sento gli urti tuoi ec. Non so che vogli. che mi spingi a cantare a fare né so che, ec. Che aspetti? Passerà la gioventù e il bollore ec. Misero ec. E come riaxep® a te senza grandi fatti? ec. ec. ec. O patria o patria mia ec. che farò non posso spargere il sangue per te che non esisti più. ec. ec. ec. che faro di grande? come piacerò a te? in che opera per chi per qual patria spanderò i sudori i dolori il sangue mio? (Tutte le opere cit., 1, pp. 330-1).
Si tratta di un documento, come generalmente si riconosce, di grande significato. Nella prospettiva delle canzoni civili, di quella AllItalia e della seguente Sopra il monumento di Dante, varrà a chiarirci la complessità della loro genesi, l’intreccio dei motivi psicologici che presiedono al loro stesso concepimento, collegandolo alla matrice lirica del « Diario » e delle elegie amorose. Ma varrà
soprattutto, nel confronto testuale con le canzoni del ’18, a dimostrare la difficoltà pratica in sede di esecuzione, o piuttosto l’intempestività, del progetto leopardiano. Rispetto a quest’ultimo, a quell’esigenza così chiara nel nostro « argomento » di una poesia che lasci rifluire il risentimento etico-politico nelle emozioni private e negli slanci più personali e intimi dell’uomo, non resta che registrare una sostanziale divaricazione. Certe persistenze, d’intonazione soprattutto, non bastano a ridurre il divario esistente già fra quel primo disegno e il successivo più ampio e articolato « argomento di una canzone sullo stato presente dell’Italia » (Tutte le opere cit., 1, pp. 331-2), a ridosso ormai del prodotto finito. L’esclusione dei dati più concreti e personali — dell’elemento amoroso e degli altri che precisano l’identità autobiografica del ventenne — è il segno di una risoluta correzione del tiro nel senso di una poesia di puro impegno civile:
IL ALL'ITALIA
5
O patria mia, vedo le mura e gli archi e le colonne e i simulacri e l’erme torri degli avi nostri, ma la gloria non vedo, non vedo il lauro e il ferro ond’eran carchi i nostri padri antichi. Or fatta inerme, nuda la fronte e nudo il petto mostri. Oimè quante ferite,
II. All’Italia; in Tutte le opere cit., 1, pp. 3-4. 2. simulacri: statue. — erme: solitarie. 5. il lauro; l’alloro, con il quale s’incoronavano nell’antichità gli eroi e ipoeti. — ond’ . . . carchi:
di cui erano carichi, ricchi.
6. fatta inerme: disarmata. priva delle auree bende (v. 33). — nudo: spogliato del manto (ivi). 7. nuda:
Il « perfetto scrittore » ; il primo amore
e le canzoni civili
41
che lividor, che sangue! oh qual ti veggio, formosissima donna! Io chiedo al cielo e al mondo:
dite dite;
chi la ridusse a tale ?E questo è peggio, che di catene ha carche ambe le braccia;
sì che sparte le chiome e senza velo siede in terra negletta e sconsolata, nascondendo la faccia tra le ginocchia, e piange. Piangi, che ben hai donde,
Italia mia,
le genti a vincer nata e nella fausta sorte e nella ria. Se fosser gli occhi tuoi due fonti vive, mai non potrebbe il pianto adeguarsi al tuo danno ed allo scorno; che fosti donna, or sei povera ancella. Chi di te parla o scrive, che, rimembrando il tuo passato vanto, non dica: già fu grande, or non è quella? Perché, perché ? dov'è la forza antica, dove l’armi e il valore e la costanza? chi ti discinse il brando? chi ti tradì ? qual arte o qual fatica o qual tanta possanza valse a spogliarti il manto e l’auree bende? come cadesti o quando da tanta altezza in così basso loco? nessun pugna per te? non ti difende nessun de’ tuoi? L’armi, qua l’armi: io solo combatterò, procomberò sol io.
20
30
35
Dammi, o ciel, che sia foco
agl’italici petti il sangue mio. Dove sono i tuoi figli ? Odo suon d’armi
9. qual: in quale stato. 12. a tale: in tali condizioni 14. sparte le chiome: con i capelli sparsi. — senza velo: privata d’ogni distinzione regale, come una schiava (v. 24). 18. ben hai donde: ne hai ben motivo 19-20. Ze genti... ria: Interpretazione dubbia.
Può intendersi: nata a dominare i popoli sia nei momenti felici (con le armi) sia in quelli avversi (con la forza del tuo prestigio); oppure: nata a superare le genti sia nel grado della raggiunta felicità sia in quello della miseria. 21. vive: perenni. Per l’espressione cfr. Canz. 164, 9; 231, 12. 24. donna: signora, dominatrice. 25-7. Chi...dica: chi fra quelli che parlano
40
o scrivono di te, ricordando la tua gloria (vanto)
passata, potrebbe non dire ...? 31. arte...fatica: astuzia, sforzo. 37. L’armi, qua l’armi: cfr. Aen. 11, 668: « Arma, viri, ferte arma». Già nella sua traduzione Leopardi: « Armi, qua l’armi ».
38. procomberò: (lat.) morirò cadendo in avanti contro il nemico. 39. sia foco: sia distimolo, incendiando gli animi degli italiani. 41. Dove...figli: «Per un’ode lamentevole sull’Italia può servire quel pensiero di Foscolo nell’Ortis lett[era] 19 e 20 febbraio 1799 [. . .]» (Zibaldone, 58). Questo il pensiero di Foscolo: «I tuoi confini, o Italia, son questi! ma sono tutto dì sormontati d’ogni parte dalla pertinace
Giacomo
42
Leopardi
e di carri e di voci e di timballi: in estranie contrade
pugnano i tuoi figliuoli. 45
50
55
Attendi, Italia, attendi. Io veggio, o parmi, un fluttuar di fanti e di cavalli,
e fumo e polve, e luccicar di spade come tra nebbia lampi. Né ti conforti? e i tremebondi lumi piegar non soffri al dubitoso evento? a che pugna in quei campi l’itala gioventude? O numi, o numi; pugnan per altra terra itali acciari. Oh misero colui che in guerra è spento, non per li patrii lidi e per la pia consorte e i figli cari, ma da nemici altrui
per altra gente, e non può dir morendo: alma terra natia,
60
la vita che mi desti ecco ti rendo. Oh venturose e care e benedette l’antiche età, che a morte
per la patria correan le genti a squadre; e voi sempre onorate e gloriose, 65
o tessaliche
strette,
dove la Persia e il fato assai men forte fu di poch’alme franche e generose! Io credo che le piante e i sassi e l’onda e le montagne
70
75
con
vostre
al passeggere
indistinta voce
narrin siccome tutta quella sponda coprìr le invitte schiere de’ corpi ch’alla Grecia eran devoti. Allor, vile e feroce, Serse per l’Ellesponto si fuggia, fatto ludibrio agli ultimi nepoti;
avarizia delle nazioni. Ove sono dunque i tuoi figli? Nulla ti manca se non la forza della concordia [...]» (ed. crit. a c. di G. Gambarin, Firenze 1955, p. 434). 42. timballi: tamburi. 43. estranie contrade: con Napoleone in Russia: il tema sarà ripreso nella canzone Sopra il monumento di Dante (vv. 139 sgg.). 45. Attendi: fa’ attenzione. — farmi: mi pare di vedere.
53. per altra terra: per la Francia. — spade. 61. venturose: fortunate. 62. che: nelle quali.
47. fumo: dei fucili e dei cannoni. 49. lumi: occhi. 50. piegar ...evento: non sostieni di volgere (piegar) all’esito incerto di quella battaglia?
70. indistinta:
acciari:
65. tessaliche strette: delle Termopili, che univano la Tessaglia ad Atene: teatro della celebre difesa opposta dai trecento spartani, guidati
dal
re
Leonida,
ai persiani
di
Serse
(480 a. C.). 67. franche: risolute. in coro,
all’unisono.
72. invitte schiere: sogg. di coprìr: rono. 73. de’: con i. — devoti: consacrati.
ricopri-
Il « perfetto scrittore » }; il primo amore
e le canzoni civili
e sul colle d’Antela, ove morendo si sottrasse da morte il santo stuolo, Simonide salia,
guardando l’etra e la marina e il suolo. E di lacrime sparso ambe le guance, e il petto ansante, e vacillante il piede, toglieasi in man la lira: Beatissimi voi, ch’offriste il petto alle nemiche lance per amor di costei ch’al Sol vi diede; voi che la Grecia cole, e il mondo
80
85
ammira.
Nell’armi e ne’ perigli qual tanto amor le giovanette menti, qual nell’acerbo fato amor vi trasse? Come sì lieta, o figli,
l’ora estrema vi parve, onde ridenti correste al passo lacrimoso e duro? Parea ch’a danza e non a morte andasse ciascun de’ vostri, o a splendido convito:
95
ma v’attendea lo scuro Tartaro, e l’onda morta;
né le spose vi foro o i figli accanto quando su l’aspro lito senza baci moriste e senza pianto. Ma non senza de’ persi orrida pena ed immortale angoscia. Come lion di tori entro una mandra or salta a quello in tergo e sì gli scava con le zanne la schiena. Or questo fianco addenta or quella coscia; tal fra le perse torme infuriava
100
105
tandolo come esempio di amore 80. etra: cielo. 86. di costei: della patria. 87. cole: venera (lat. « colere »).
della gloria,
che cantò le maggiori imprese dei greci: Ma-
90. qual... trasse: quale amore
vi spinse ad
ratona,
una morte prematura (acerbo fato)? 93. al passo: della morte. 97. Tartaro: gli Inferi, il regno dei defunti. — onda morta: i fiumi infernali (ricorda il dantesco «la morte gora », Inf. vini, 31). 98. foro: furono. 99. aspro lito: il luogo montuoso della battaglia. Ma aspro evoca anche la durezza dello scontro.
76. fatto... nepoti: divenuto oggetto di vergogna presso i discendenti. 78. si...morte: s’immortalò. 79. Simonide:
di Ceo (556-468 a. C.), il poeta
Artemisio,
frammento
Salamina,
Platea.
Un
per i caduti delle Termopili
stato tramandato
suo
ci è
da Diodoro Siculo. Questa la
traduzione che ne fece Giordani: « De’ morti alle Termopili gloriosa è la fortuna, bello il fine, altare la tomba, lode la sventura. La funeral veste di que’ valorosi non sarà consumata né discolorata mai dal tempo che vince ogni cosa. La loro sepoltura contiene la gloria degli abitanti di Grecia. N’è testimonio Leonida, re di Sparta, che lasciò gran bellezza di virtù e fama perenne ». Nello Zibaldone (44-5; 67-8) Leopardi ricorda l’episodio delle Termopili por-
102. immortale: infinita. 103-106. Come lion...coscia: corrente
nei classici:
cfr.
similitudine ri-
Omero
(Iliade,
v,
161-2; x11, 299-306). Ma anche in Canz.. 28, 100-1.
44
110
115
120
Giacomo
l’ira de’ greci petti e la virtute. Ve’ cavalli supini e cavalieri; vedi intralciare ai vinti la fuga i carri e le tende cadute, e correr fra’ primieri pallido e scapigliato esso tiranno; ve’ come infusi e tinti del barbarico sangue i greci eroi, cagione ai persi d’infinito affanno, a poco a poco vinti dalle piaghe, l’un sopra l’altro cade. Oh viva, oh viva: beatissimi voi mentre nel mondo si favelli o scriva. Prima
125
Leopardi
divelte,
spente nell’imo che la memoria amor trascorra La vostra tomba verran le madri orme del vostro
in mar
precipitando,
strideran le stelle, e il vostro o scemi, è un’ara; e qua mostrando ai parvoli le belle sangue. Ecco io mi prostro,
o benedetti, al suolo, e bacio questi sassi e queste zolle, 130
che fien lodate e chiare eternamente dall’uno all’altro polo. Deh foss’io pur con voi qui sotto, e molle fosse del sangue mio quest’alma terra.
135
ch'io per la Grecia i moribondi lumi chiuda prostrato in guerra, così la vereconda fama del vostro vate appo i futuri
140
tanto durar quanto
che se il fato è diverso, e non consente
possa, volendo i numi,
la vostra duri.
La trasposizione di un proprio indeterminato eppure sofferto bisogno d’azione dal piano lirico-elegiaco (« Misero me che ho fatto? Ancora nessun fatto grande. [. . .] Che aspetti? Passerà la gioventù e il bollore ») a quello pare108. ira... virtute: passione, valore; cfr. Foscolo, Sepolcri, v, 201.
109. Ve’: vedi. 113. esso: lo stesso. 114. infusi: «qui vale aspersi o bagnati »: così Leopardi nelle sue Annotazioni. 117. vinti dalle piaghe: prostrati dalle ferite, dissanguati. 120. mentre: finché.
122. nell’imo: nel profondo del mare.
123-4. vostro amor: l’amore per voi. — trascorra 0 scemi: si dilegui o si riduca. 137. vereconda: umile, modesta rispetto a quella degli eroi greci. 138. appo i futuri: presso i posteri.
Metro Strofe dispari: ABcd ABCe FGe FHG} AlMiM; strofe pari: ABCD aBdEFg EfHgI HLMiM.
$ 43.
Il « perfetto scrittore » ; il primo amore e le canzoni civili
45
netico ed eloquente (« L’armi, qua l’armi: io solo / combatterò, procomberò sol io. / Dammi, o ciel, che sia foco / agl’italici petti il sangue mio ») è il dato su cui insistere per intendere l’orientamento fondamentale del canto civile di Leopardi. La cui presenza nella struttura compositiva delle canzoni, di questa All’Italia come della gemella Sopra il monumento di Dante, mentre vale a segnarle | di una nota soggettiva, spiccatamente individualistica, negli accenti di una personalità risentita e generosamente impaziente; si commuta in quella di un iovate consapevole del declino etico-politico della patria e nondimeno fermo in un «supremo atto di fede: nella fiducia che l’intellettuale possa (e debba) assolvere una funzione positiva, di rinfrancamento e di rigenerazione ideale. La rappresentazione della crisi italiana e il ricordo di un passato glorioso mortificato nella miseria del presente, per l’inerzia di un « guasto legnaggio » dimentico dei propri doveri civili, costituiscono l’asse tematico di un discorso intorno al cui obiettivo, di ammonizione e insieme di persuasione, di pungolo morale, si stringono gli elementi materiali — storici e di pensiero — del canto leopardiano. Elementi polemici impliciti o appena accennati nella prima canzone, dichiarati e ampiamente svolti nella seconda: il rifiuto della « pace » reazionaria della Restaurazione, la denuncia della rapace dominazione francese e dell’innaturale partecipazione italiana alla campagna napoleonica in Russia; elementi riassunti in un’attestazione più generale, relativa al torpore spirituale degli italiani, al loro stato di forzata ma anche colpevcle insensibilità; e perciò distaccati da una valutazione politica in senso stretto, assimilati piuttosto in una logica argomentativa che, rapportandoli a quella condizione di oggettivo cedimento della coscienza civile, ne esalta il significato di prove dolorose, esempi di un’irrimediabile infelicità. Che per quest’ultimo aspetto in particolare il discorso leopardiano rifletta, come sostiene Blasucci, un’esperienza più ampia di quella specificamente etico-politica è senza dubbio vero. Al fondo delle constatazioni di Leopardi — nell’episodio soprattutto dei caduti in Russia e anche altrove, diffusamente, in entrambi le canzoni —
si riconoscono i segni capacità di aderire alle l'umanità proiettandovi sentimento che, serrato
di un’intensa consuetudine con il dolore: una speciale pene degli uomini e in gener= alle vicende dolorose delil sentimento di una miseria fatale e sperimentata; un nei termini di una superiore certezza morale, può risol-
versi in una verità liberatoria ed eroica, di rasserenamento
tutto intellettuale:
«e questo vi conforti / che conforto nessuno / avrete in questa o nell’età futura » (Sopra il monumento di Dante, vv. 164-6); un sentimento altrimenti immediato, carico delle personali inquietudini del poeta ventenne, e perciò disposto a tradursi nelle movenze più intenerite, patetiche ed elegiache, del canto leopardiano. Ma non converrà sottovalutare gli altri dati che nel discorso di Leopardi
ne esaltano le intenzioni più schiettamente politiche e parenetiche. Se è vero infatti (e ha ragione Blasucci a insistervi) che al centro della canzone All’Italia è
«lo stesso personaggio eroico-elegiaco del poeta, con le sue interrogazioni in-
calzanti e le sue esclamazioni desolate »; si deve pure precisare che quel « soggetto lirico » insiste sull’io civile dell’intellettuale, Il cui intervento nel senso della per-
46
Giacomo
Leopardi
suasione etico-politica non si limita ai momenti dell’apostrofe e dell’esortazione diretta; estendendosi bensì a una realtà soggettiva che, fermata in un gesto paradigmatico (« L’armi, qua l’armi [...]»), brucia in esso, nella sua esemplarità ed emblematicità morale, ogni residuo propriamente lirico e autobiografico; predisponendosi così, in nome di un’elementare passione patriottica, alla serie dei successivi confronti —
con
Simonide,
nella canzone
A/l’Italia; e poi, nel-
l’altra, con gli artefici del monumento e con Dante stesso — le cui ragioni investono di nuovo l’alta responsabilità affidata all'uomo di cultura. Il confronto, nell'impianto pindarico o piuttosto chiabreriano (del Chiabrera migliore: su cui cfr. Zibaldone, 24-6) dei due componimenti, può spingersi alla completa identificazione, come nel collegamento istituito fra il « canto » del poeta e l’« opra » degli artisti che attendono al monumento dantesco (Sopra il monumento di Dante, vv. 69-73); o limitarsi alla designazione di un destinatario ideale, Dante, fatto
rivivere a testimoniare un naturale consentimento (« Padre, se non ti sdegni, | mutato sei da quel che fosti in terra »; ivi, vv. 137-8); oppure risolversi nel repentino mutamento di prospettiva che consente il trapasso — e l’identificazione, su un diverso piano concettuale — dallo sfogo del poeta moderno alla testimonianza dell’antico, nel canto di Simonide. Ma ciò che lo sostiene unitariamente, e lo avvalora nell’ambito di un’esperienza militante, di milizia letteraria, è il
proposito dello scrittore di rapportare il proprio messaggio, di protesta e d’ammonizione,
nonché
gli slanci personali,
a una
lezione assoluta,
di patriottismo e
d’impegno intellettuale, viva oltre i tempi e le circostanze diverse nei raccordi di un’esaltante (e persino peregrina) memoria culturale. Un proposito che conferma le prime intenzioni del canto leopardiano, di edificazione civile, contemperandole con quelle che -- da un’angolazione sensibilmente diversa — ci rimandano a una seconda dimensione delle canzoni del ’18, al loro carattere,
lo di-
remmo, di manifesto politico-culturale. Un aspetto, quest’ultimo, avvicinabile alla dichiarazione di principio che si legge nella dedicatoria a Monti riguardo all’« ultima gloria » degli italiani: quella che « deriva loro » — come scrive Leopardi — « dagli studi e singolarmente dalle lettere e dalle arti belle; tanto che per anche non si potrà dire che l’Italia sia morta » (Tutte /e opere cit., 1, p. 55); una dichiarazione che nella dedica montiana risuona come un appello a un credo comune, in funzione del legame che il poeta istituisce di fatto tra sé e i « pochissimi » preoccupati di salvaguardare quell’ultima dignità (ivi, p. 54); ma che,
proiettata sul testo, ne evidenzia la segreta ambizione di rappresentare esso stesso, in virtù del suo spessore ideale, per l’ardimentosa sostenutezza e perplessità del suo ductus stilistico, un punto fermo nelle attese e nei progetti di rinnovamento
di un’intera élite intellettuale. Vi sono tutte le condizioni perché le canzoni civili rivestano il significato al momento della loro pubblicazione e diffusione di un’aperta scelta di campo. ‘ Una scelta politica, in senso antilegittimista, valida ben oltre le preoccupazioni di cui si farà portavoce Brighenti accennando al malumore dei liberali bolognesi, contrariati per le puntate antifrancesi e antinapoleoniche in particolare
$ 43.
Il «perfetto scrittore» ; il primo amore e le canzoni civili
47
della seconda canzone: preoccupazioni alle quali Leopardi opporrà la necessità d’ingannare la censura mascherando attraverso controfigure i principali obiettivi della sua polemica, gli austriaci e le tirannie italiane; ma senza sminuire d’altra parte il diritto « del puro e semplice vero » contro le «vane parzialità e prevenzioni » (Epistolario, 148). Che è precisazione di fondamentale importanza, e non solo come espressione di una generale intransigenza morale; quanto nella prospettiva di un impegno ideologico che, superata ogni nozione riduttiva della politica, meramente contingente, ferma restante la capacità di distinguere nella realtà italiana le istanze in ogni caso e comunque progressive da quelle volte al passato, di conservazione e di regresso, guarderà proprio al « vero » come alla condizione di un integrale affrancamento; in senso anche e propriamente sociale, alla luce di persuasioni che, latenti per un periodo non breve, s’imporranno soprattutto negli ultimi anni contro lo spiritualismo e il moderatismo dei cattolico-liberali. Ma la via al «vero », in un’accezione ben più impegnativa di quella usata nella risposta a Brighenti, passa (lo vedremo presto) attraverso la crisi del 1819: la crisi in particolare del modello intellettuale che, applicato nelle canzoni politiche, e consacrato nella chiusa del Discorso di un italiano, si rivelerà inadeguato a riflettere compiutamente il mondo del poeta. Al cui interno la passione civile del « perfetto scrittore », lo slancio generoso dell’intellettuale, la risolutezza alfieriana dei propositi conoscono presto il turbamento di una situazione psicologica, di sconforto e di prostrazione, altrettanto acuta. È il segno sul piano personale di una problematica nuova e ormai urgente. La sua traduzione concettuale, nel pessimismo dello Zibaldone, presuppone lo scarto che abbiamo notato fra le lettere al padre e al fratello: l'insorgere accanto a un prepotente bisogno di libertà, fuori di Recanati e lontano dalla famiglia, di un penoso sentimento di sconfitta. Le cui tracce si riconoscono già in alcune lettere a Giordani: [...] sono due mesi ch’io non istudio, né leggo più niente, per malattia d’occhi, e la mia vita si consuma sedendo colle braccia in croce, o passeggiando per le stanze (Epistolario, 116).
Non ho più pace, né mi curo d’averne. Farò mai niente di grande? né anche adesso che mi vo sbattendo per questa gabbia come un orso? In questo paese di frati, dico proprio questo particolarmente, e in questa maledetta casa, dove pagherebbero un tesoro perché mi facessi frate ancor io [...] (ivi, 117).
Nell’età che le complessioni ordinariamene si rassodano, io vo scemando ogni giorno di vigore, e le facoltà corporali mi abbandonano a una a una. Questo mi consola, perché m’ha fatto disperare di me stesso, e conoscere che la mia vita non valendo
più nulla, posso gittarla, come farò in breve, perché non potendo vivere se non in questa
condizione e con questa salute, non voglio vivere, e potendo vivere altrimenti, bisogna
tentare. E il tentare così com’io posso, cioè disperatamente e alla cieca, non mi costa
più niente, ora che le antiche illusioni sul mio valore, e sulle speranze della vita futura,
48
Giacomo
Leopardi
e sul bene ch’io potea fare, e le imprese da togliere, e la gloria da conseguire, mi sono sparite dagli occhi, e non mi stimo più nulla, e mi conosco assai da meno di tanti miei cittadini, ch'io disprezzava così profondamente (ivi, 118).
Momenti, poco prima del fallito tentativo di fuga, di struggente disperazione; e sintomi al.tempo stesso di un’ottica in sensibile trasformazione, orientata ora a rapportare le aspirazioni più vive dell’intellettuale e dell’uomo di cultura alla malattia che categoricamente le nega, dichiarandone l’illusorietà sul piano di una verità personale ineludibile perché fisica e concretissima, non teorica, tutta penosamente sofferta. La crisi del « perfetto scrittore », non tanto dell’ideologia che lo ispira quanto della possibilità per Leopardi — in una mutata condizione psicologica e di pensiero — di continuare ad assumerne la parte, corrisponde a un processo mentale lento e sinuoso, esposto a ritorni di fiamma dopo la diffusione delle canzoni politiche e gli incoraggiamenti a persistere che il poeta ne ricevette; e non dissociabile dal processo di sperimentazione linguistica che, attestatoci nei disegni e negli abbozzi del 1819-20, ci rinvia alla dimensione specificamente letteraria della nuova « conversione » leopardiana. Per quest’aspetto, se di mutamento si può (e si deve) parlare, esso risulta certo meno evidente delle innovazioni tematiche flagranti negli « idilli » e soprattutto nelle canzoni filosofiche. Il fatto è che la crisi dell’intellettuale resterà pur sempre all’interno di una cultura letteraria sostanzialmente fedele ai princìpi di un classicismo che, già individuato al tempo delle ultime traduzioni e nella lettera a M.me de Staél, riceve la sua codificazione nel Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica (1818), alla vigilia dell’incontro diretto con Giordani a Recanati e qualche mese prima delle canzoni civili: sulla scorta di un’ideologia letteraria che, fatto proprio (e per sempre) il mito
dell’impareggiabile felicità immaginativa degli antichi, ne desume — in polemica con Di Breme — i princìpi categoriali della poesia; e con questi l’irragionevolezza di chi, come i romantici, ritiene di poterla allontanare « dal commercio coi
sensi, per li quali è nata e vivrà » (Tutte le opere cit., 1, p. 915); stornandola così dall’imitazione della natura e dal suo fine vero, il diletto. Un fine conseguibile attualmente a patto che il poeta moderno, ritrovando la condizione primitiva, e cedendo allora a un richiamo primigenio, soprattutto efficace nell’età dell’infanzia,
sappia neutralizzare gli effetti dell’incivilimento; recuperando un’intatta capacità fantastica e insieme la facoltà, negata ai romantici, di « trasportarci in quei
primi tempi » restituendoci a « quella natura che ci è sparita dagli occhi », e anzi svelandocela « ancora presente e bella come in principio », in grado infine di for-
nirci « quei diletti soprumani di cui pressoché tutto, salvo il desiderio, perduto » (ivi, p. 922). Questo il nucleo essenziale del Discorso di un Intorno al quale si collocano le fitte osservazioni polemiche, non sempre mente a fuoco, contro la moderna scuola letteraria e i suoi seguaci; e
abbiamo italiano. precisaal quale
ci riferiremo presto per segnalare, al culmine della crisi del ’19, lo slittamento
$ 43.
Il « perfetto scrittore»; il primo amore e le canzoni civili
49
concettuale in senso pessimistico determinatosi sul tema del rapporto con la natura e la nativa felicità degli antichi. Ma la successiva correzione, se vale evidentemente a circoscrivere la portata del Discorso al tempo che precede la «conversione » filosofica, non altera le linee direttrici di una poetica le cui predilezioni stilistiche resteranno tendenzialmente quelle affermate contro Di Breme e implicite nel rifiuto d’ogni affettazione intellettualistica, a vantaggio della parola sensistica, concreta ed evocativa, in grado di sollecitare la fantasia del lettore. A ragioni polemiche più immediate, ma non perciò indifferenti nella prospettiva del Leopardi maturo, rispondono altri temi del Discorso: l'esigenza di reintegrare il buon gusto corrotto da una diffusa insensibilità estetica, dalla prevalente sordità al richiamo della natura e dall’attrazione per tutto ciò che appaia inconsueto e singolare; e l’insistenza sulla necessità di uno «studio lungo e profondo de’ poeti antichi » (ivi, p. 931): secondo una logica che, assegnata ai classici greco-latini la parte di sicuri mediatori fra i moderni e la realtà primitiva, sconsiglia pure l’uso eccessivo della mitologia e in genere l’asservimento alle regole e alla precettistica degli antichi. Il
principio è che il poeta non deve imitare « altri poeti, ma la natura » né si vuole che egli « vada accattando e cucendo insieme ritagli di roba altrui; non vogliamo che il poeta non sia poeta; vogliamo che pensi e immagini e trovi, vogliamo ch’avvampi, ch’abbia mente divina, che abbia impeto e forza e grandezza di affetti e di pensieri » (ivi, p. 932). La stessa categoria del « patetico » e del « sentimentale » che i romantici si arrogano come propria non può non rimandarci per Leopardi, se bene intesa, alla lezione dei classici. I quali seppero ritrovarla, nel contatto diretto con la natura, interamente calata nelle cose; e perciò immune dai pregiudizi che la snaturano presso i romantici, identificabile e godibile da una sensibilità «intima e spontanea, modestissima anzi ritrosa, pura dolcissima sublimissima,
soprumana
e fanciullesca,
madre
di gran diletti e di
grandi affanni, cara e dolorosa come l’amore, ineffabile inesplicabile, donata dalla natura a pochi» (ivi, p. 934). Che nel Discorso prema una materia non proprio riducibile alle posizioni dei classicisti nella querelle coi romantici è fuori discussione; quanto duttile (e antiaccademico) sappia essere l’atteggiamento del poeta sui problemi della cultura letteraria, lo dimostrerà presto la lettera a Montani e soprattutto l’abbozzo di un trattato Della condizione presente delle lettere italiane. Basterebbe del resto in questo stesso periodo il famoso giudizio espresso su Monti, «poeta veramente dell’orecchio e dell’immaginazione, del cuore in nessun modo » (Zibaldone, 36), per misurare la distanza che separa Leopardi dai compagni di strada, anche dai più rappresentativi. La possibilità tuttavia d’intravedere nel Discorso (e negli altri scritti coevi) i segni di un romanticismo preterintenzionale, per così dire, insidiato dalle approssimazioni polemiche e dai difetti d’informazione e pure prorompente, non deve indurci a trascurare come al centro dell’operetta e del pensiero estetico-letterario di questi anni permanga il classicismo di
Leopardi: la visione « più mitica che storica » (Figurelli) di un mondo paradig-
Giacomo
50
Leopardi
matico, di intensa vitalità morale oltre che artistica. Da cui discendono i principi di una poetica risolutamente antiformalistica, profondamente coinvolta nei processi di trasformazione ideologica dello scrittore; e quindi in movimento: sulle tracce di un’elaborazione ideale che approderà naturalmente al canone romantico della poesia moderna e « sentimentale » senza perciò rinunciare, non che alle principali indicazioni tracciate nel risvolto della polemica antiromantica del ’16 e del ’18, al senso più profondo di quel classicismo. La cui necessità spirituale e culturale, ben lungi dall’attenuarsi dopo la « conversione » filosofica, ne risulterà incrementata: man mano che, consolidate le ragioni del proprio pessimismo, Leopardi sentirà sempre più problematico il recupero dell’antico; commutando allora il significato stesso della letteratura e della poesia nella direzione non più del « dilettevole » ma in quella della « consolazione ». Che sarà il modo, lo constateremo presto, non certo di sfuggire all'amara negatività del presente, quanto di riassumerla in un quadro più ampio di verità e responsabilità intellettuali. Nel cui ambito la piacevolezza propria della poesia, il diletto della tradizione classica, bruciato ogni residuo estetizzante, saprà riabilitarsi corrispondendo a una vitale aspirazione edonistica.
$ 44.
La crisi del ’19; antico e moderno
Un improvviso ripiegamento sulla propria condizione, «Io son distrutto / né schermo alcuno ho dal dolor, che scuro / m'è l’avvenire, e tutto quanto io
scerno / è tal che sogno e fola / fa parer la speranza », ci segnala la distanza che divide il Leopardi dell’ Angelo Mai (1820) da quello delle canzoni civili. Nella prospettiva ancora aperta della lirica eloquente il dato soggettivo proclama l’impossibilità di riprodurre quell'immagine d’intellettuale già realizzata nell’io-vate di All’Italia e di Sopra il monumento di Dante. Leopardi non mette in discus-
sione i princìpi che informano il modello del « perfetto scrittore »: la nozione che la salvezza dell’Italia consiste nella capacità di ripetere la lezione morale del passato confrontandola con lo stato del « secol di fango», inetto e mediocre, è ancora nell’ Angelo Mai fra le ipotesi di un’ideologia etico-politica che, presto assimilata in un più vasto organismo di pensiero, continua a insistere sul ruolo sociale del letterato come sulla condizione di un autentico rinnovamento civile. Lo scarto
lirico ai vv. 34-8 dichiara l’inadeguatezza del poeta, la sua forzata astensione dinanzi a un’impresa carica di futuro c tuttavia estranea, dolorosamente, al sentimento di una personale irrimediabile delusione. Per le sue implicazioni biografiche e psicologiche questo stato d’animo ci rimanda agli avvenimenti del 1819: alla malattia degli occhi che a partire dal marzo di quell’anno, con fasi alterne, perseguiterà Leopardi per il resto della vita; al fallimento del suo tentativo di fuga da Recanati. Avvenimenti di cui
abbiamo già rilevata l'incidenza nella storia leopardiana, in rapporto a un atteggiamento che nel rifiuto di un’esistenza mediocre, d’isolamento provinciale e di
$ 44.
La crisi del *19; antico e moderno
51
conformismo, rifletteva un’eccitante aspirazione intellettuale; e insieme, su un piano diverso ma con esiti affini, di straordinaria lucidità e determinazione mo-
rale, il senso di una sofferenza predestinata, attribuibile a « quasi ogni uomo di gran genio » e tuttavia vissuta in perfetta buona fede, autenticamente, di qua da quella spiegazione per altri versi confortante, come una pena singolare, un impulso autodistruttivo nella lettera a Carlo della fine di luglio, di fuga disperata e di violenta negazione di sé. Avvenimenti sui quali converrà ora ritornare, e in particolare sul primo, da un altro punto di vista. Con riguardo alla loro parte nella conversione leopardiana dal « bello » alla « filosofia »: un momento decisivo nella carriera del poeta, da ascriversi al '19 secondo la sua stessa testimonianza,
in stretta connessione con quella malattia degli occhi che, privandolo « della continua distrazione della lettura », lo avrebbe
indotto «a sentire la sua infelicità
in un modo assai più tenebroso, [...] ad abbandonar la speranza, a riflettere profondamente sopra le cose [...], a divenir filosofo di professione (di poeta ch'egli era), a sentire l’infelicità certa del mondo, in luogo di conoscerla » (Zibaldone, 144). Il nesso così puntualmente stabilito fra la vicenda biografica e l’evoluzione in senso filosofico dei propri interessi mentali ci mette in guardia contro il pericolo di un’interpretazione riduttiva dei luoghi in cui il poeta, già nell’ Angelo Mai, quindi nella sua restante produzione, fino agli ultimi canti, restringe il campo d’osservazione fra i termini di un’esperienza all'apparenza soltanto privata. Quei luoghi varranno ormai, strutturalmente, nell’organizzazione profonda del canto leopardiano, come altrettanti segni di una verità sui generis: quella raggiunta attraverso un’elaborazione concettuale tanto più convincente per quanto sollecitata (e insieme garantita) dagli accadimenti personali: della persona, propriamente, nella sua concreta realtà soggettiva. Una verità che, sulla linea discriminante fra il sentire e il conoscere (« cominciai [...] a sentire l’infelicità certa del mondo, in luogo di conoscerla »), protesta un grado di validità più alto di quello assegnabile ai processi di un’intelligenza meramente teorica; esaltando in tal modo le esperienze che nell’ambito dell’esistenza empirica sanno offrirsi come occasioni di un perentorio sensibilissimo accertamento di portata generale. Nel caso che ora ci interessa, rifacendo un itinerario conoscitivo e lirico diffi-
cilmente schematizzabile, non dovrà sfuggirci come quell’impossibilità di sperare dichiarata nell’Angelo Mai, mentre conserva tutto il suo valore, anche formale,
di confidenza chiusa in se stessa, riferibile
a un improvviso trasalimento indivi-
duale, quasi un moto di sfiducia dimessamente fra parentesi nel costrutto eroico-
celebrativo del canto; si protende oltre i termini che la contengono, calamitando
il materiale che nella prima parte della canzone, fermato in una serie di potenti espressioni metaforiche (« secol morto », « nebbia di tedio », « virtude rugginosa »),
accennava al presente come a una realtà di « disperato obblio », di rinuncia e di morte; una realtà che, lasciata finora sullo sfondo del componimento,
in fun-
zione di un prolungato controcanto doloroso, riceve qui una nuova inclinazione verso soluzioni assai più inquietanti. Nella confidenza del poeta la decadenza
Giacomo Leopardi
Sa
del presente, rifrangendosi sullo schermo di un’esperienza interiore che la comprova, rivivendola in se stessa, può confermarsi come l’oggetto polemico del discorso leopardiano; e porsi insieme come il suo angolo visuale, il punto d’osservazione
di un’analisi
del
reale
assolutamente
coinvolta,
condizionata,
nella
crisi che denuncia; e perciò drammaticamente inabile a fornire un rimedio positivo. Si ritorna a una situazione idealmente preliminare: all’impossibilità per Leopardi di ripetere lo schema che nelle canzoni civili contrapponeva allo « stato presente » la fiducia tutta umanistica (e illuministica) nella forza intrinsecamente edificante del. messaggio intellettuale. Questo non può ormai non riflettere la persuasione di una sconfitta che, adeguando la condizione personale del poeta a quella di un’età intera, lo costringe tragicamente dalla parte dei vinti. La fiducia di un tempo nell’azione intellettuale emblematizzata nella scoperta filologica di Angelo Mai, l'« Italo ardito », conserverà intatto il suo carattere agonistico ed eroico; ma ormai come distanziata dal poeta, più osservata e celebrata che condivisa, in una prospettiva che tende a trasmutarla sul piano di una grande illusione. La posizione leopardiana, di là dal suo esito nella canzone a Mai, rivista nella storia dello scrittore, si colloca in un periodo — fra il ’19 e il ’20 — d’intensa progettazione letteraria documentataci da un materiale cospicuo, di disegni e abbozzi, di frammenti di varia lunghezza, realizzato solo in minima parte: a distanza di qualche tempo, con sensibili modifiche rispetto all’idea originaria, come nel caso dell’abbozzo Dell’educare la gioventù italiana da cui discende la canzone Nelle nozze della sorella Paolina (1821) o in quello degli Inni cristiani, un disegno più articolato al quale risale il primo spunto dell’Inno ai patriarchi (1822). Un materiale solo parzialmente rispecchiato nei temi cui pure Leopardi indulge in questo stesso periodo: i temi a forti tinte patetiche delle canzoni in seguito rifiutate (ma allora care al poeta che le avrebbe pubblicate, se Monaldo non l’avesse impedito, insieme con l’Angelo Mai), entrambi del marzo-aprile 1819, Per una donna inferma di malattia lunga e mortale e Nella morte di una donna fatta trucidare col suo portato dal corruttore per mano ed arte di un chirurgo; temi legati a episodi di cronaca o a vicende pervenute casualmente all’orecchio dello scrittore, rintracciati in vista di uno svolgimento che vorrebbe essere intensamente sentimentale ed eloquente: Leopardi li accoglie, oltre che nelle due canzoni e nei relativi abbozzi, nel disegno di una poesia su una fanciulla violentata (I! primo delitto o la vergine guasta) e in quello ispirato al suicidio di una « povera monaca nativa di Osimo ». Temi e disegni trascurabili a conti fatti, se non per la tendenza che ci dimostrano da parte del poeta a ricercare all’esterno, fuori di sé, le prove di una crudeltà fatale cui rapportarsi simpateticamente, sciogliendo nella tenerezza e nel compatimento ogni riserva d’ordine moralistico, per riversare su quegli esempi di donne fragili e sventurate non tanto una per-
sonale situazione dolorosa, di debolezza indifesa, quanto un’acuta preliminare esigenza di solidarietà e di espansione affettiva. Che è poi un modo di guardarsi attorno ritraducendo negli accenti di una più dimessa e sconsolata parteci-
$ 44.
La crisi del ’19; antico e moderno
53
pazione gli impulsi generosi che, già espressi nelle canzoni civili, sulla scia di queste continuano a premere su Leopardi — ce lo attestano gli appunti per una Canzone sulla Grecia e il progetto di un «Elogio o Vita» del patriota polacco Kosciuszko — incoraggiandolo a ripetere l’esperienza di una letteratura altamente retorica, d’incitamento ma ora anzitutto di nobile consolazione per le sven ture che accomunano popoli e nazioni diverse. Ma la ricerca leopardiana tende anche ad altre soluzioni. E intanto a una singolare ricognizione autobiografica nella prospettiva di un romanzo di tipo goethiano e foscoliano — fra il Werther e l’Ortis — alla cui progettazione lo scrittore attende in tempi successivi, lasciandocene traccia negli abbozzi che promettono di volta in volta la Vita di un Silvio Sarno o di un Ruggiero o Ranuccio, di un Vanni da Belcolle o di un Poggio; e a distanza di qualche anno, forse nel 1825, la Storia di un'anima assegnata a un Giulio Rivalta. Che quel romanzo sia rimasto fra i progetti irrealizzati, malgrado i ricorrenti ritorni di fiamma, è il segno della difficoltà per Leopardi di correggere un’ottica sostanzialmente lirica che, dominante negli appunti preparatori, i cosiddetti Ricordi d’infanzia e di adolescenza, ne pregiudica lo svolgimento narrativo negandoli ad un uso che voglia riproporli in chiave di oggettività e di distacco. Leopardi può prevedere nel suo disegno la narrazione della propria morte: « morì senza lagnarsi né rallegrarsi ma sospirando com'era vissuto » (Tutte le opere cit., 1, p. 361); ciò che non può evitare, o almeno non gli riesce di ristrutturare, è il sistema di una memoria che rifugge dall’organizzare i propri contenuti: lasciando che questi si affaccino l’uno sull’altro, in un aggregato di ricordi la cui giustificazione (e ragione evocativa) è tutta nella loro forza di riaccendere sensazioni e fantasie personalissime, valide presentemente, e perciò sottratte alla relativa oggettività di un tempo in sé concluso, il passato; e riportate alla logica prepotentemente soggettiva che presiede alla loro libera registrazione sulla carta. Notazioni psicologiche e di carattere, spunti aneddotici, impressioni infantili, osservazioni morali, citazioni di letture fatte s’inseguono sulla pagina richiamandoci non tanto alla loro precipua incidenza biografica, spesso
evidentemente minima anche a tener conto del proposito dello scrittore di esemplare comunque la vita di un uomo comune, quanto alla loro capacità in sé, un’intima segreta prerogativa, di forzare il movimento affatto imprevisto della memoria sollecitandolo nel senso di una réverie prolungata, potenzialmente inesauribile:
giardino presso alla casa del guardiano, io era malinconichiss[imo] e mi posi a una finestra che metteva sulla piazzetta ec. due giovanotti sulla gradinata della chiesa abbandonata ec. erbosa. ec. sedevano scherzando: sotto al lanternone ec. si sballottavano
ec. comparisce: la. prima: lucciola ch'io: vedessi’ ii quell’anno ec. uno dei due s'alza
gli va addosso ec: io domandava: fra’ me' misericordia: alla poverella l’esortava ad alzarsi ec. ma la colpì e gittò a terra'e tornò all’altro ec. intanto la figlia del cocchiere ec. allà finestra per lavare un piattello nel tornare dice a alzandosi da cena e affacciatasi vero. Se vedeste che tempo. Nero come un cappello # dà piove stanotte — quei dentro era risorta ec. avrei finestra ec. intanto la lucciola di.quella lume il sparisce e poco dopo
Giacomo
54
Leopardi
voluto ec. ma quegli se n’accorse tornò — porca buzzarona — un’altra botta la fa cadere già debole com'era ed egli col piede ne fa una striscia lucida fra la polvere ec. e poi ec. finché la cancella. Veniva un terzo giovanotto da una stradella in faccia alla chiesa prendendo a calci i sassi e borbottando ec. l’uccisore gli corre a dosso e ridendo lo caccia a terra e poi lo porta ec. s’accresce il giuoco ma con voce piana come pur prima ec. ma risi un po’ alti ec. sento una dolce voce di donna che non conoscea né vedea ec. Natalino andiamo ch’è tardi. Per Amor di Dio che adesso adesso non faccia giorno risponde quegli ec. sentivo un bambino che certo dovea essere in fasce e in braccio alla donna e suo figlio ciangottare con una voce di latte suoni inarticolati e ridenti e tutto di tratto in tratto e da se senza prender parte ec. cresce la baldoria ec. C'è più vino da Girolamo? passava uno a cui ne domandarono ec. non c’era ec. la donna venia ridendo dolcemente con qualche paroletta ec. oh che matti! ec. (e pure quel vino non era per lei e quel danaro sarebbe stato tolto alla famiglia dal marito) e di quando in quando ripetea pazientemente e ridendo l’invito d’andarsene e invano ec. finalmente una voce di loro oh ecco che piove era una leggera pioggetta di primavera ec. e tutti si ritirarono e s’udiva il suono delle porte e i catenacci ec. e questa scena mi rallegrò [...] (ivi, pp. 363-4).
Allo materiale scomporsi interiore,
stato dei fatti la soluzione narrativa risulta obiettivamente lontana. Il così raccolto, non che disporsi lungo una linea di racconto, tende a in frammenti la cui estensione coincide con il tempo, assolutamente di un recupero di sensazioni ed emozioni che, distaccandosi dal dato
autobiografico, di là dalla storia chiusa del passato da cui emergono, si direbbero rivivere in funzione soltanto di una rinnovata, tutta attuale, concentrazione
fantastica. L’ottica dei Ricordi è la stessa progetti leopardiani, gli Argomenti di idilli, morialistica, pur nel gioco così suggestivo sente, procede a fermare gli spunti di una
di quella che in un’altra sezione dei senza più alcuna preoccupazione medei tempi, diviso fra passato e prepossibile rielaborazione della fantasia:
Ombra delle tettoie. Pioggia mattutina del disegno di mio padre. Iride alla levata del sole. Luna caduta secondo il mio sogno. Luna che secondo i villani fa nere le carni, onde io sentii una donna che consigliava per riso alla compagna sedente alla luna di porsi le braccia sotto il zendale. Bachi da seta de’ quali due donne discorrevano fra loro e l’una diceva, chi sa quanto ti frutteranno, e l’altra, in tuono flebiliss[imo] oh taci
che ci ho speso tanto, e Dio voglia ec. ... Galline che tornano spontaneamente la sera alla loro stanza al coperto. Passero solitario. Campagna in gran declivio veduta alquanti passi in lontano, e villani che scendendo per essa si perdono tosto di vista, altra immagine dell’infinito (ivi, p. 336).
Converrà non dimenticare questi appunti. E non solo perché Leopardi ne deriverà alcuni suggerimenti precisi: i più vistosi nel Frammento XXXVII e nel Passero solitario; quanto perché proprio queste annotazioni, come del resto la gran parte dei Ricordi d’infanzia e di adolescenza, fonte abbondante a loro
$ 44.
La crisi del ’19; antico e moderno
55
volta di successivi svolgimenti tematici, ci aiutano a definire il linguaggio dell'e idillio » leopardiano; riportandoci intanto al momento originario di quell’espe-
rienza: a una fase di sperimentazione, oscillante fra la tentazione autobiografica
— nel senso di un approccio alla realtà in chiave qui espressamente lirica — e il consolidato amore, dalla traduzione di Mosco in poi, per la poesia pastorale. Un amore che, sulla traccia dei maggiori esemplari cinquecenteschi (Tasso, Guarini), s’indirizza ora ai tentativi dell’Erminia e soprattutto a quello, ricavato da Alamanni e compiuto per metà, della Telesilla: un dramma pastorale, ma a conclusione tragica, il cui interesse va certamente oltre i risultati artistici, complessivamente modesti, dell’ampio frammento versificato che doveva costituirne la prima parte e l’inizio appena della seconda. Inteso a un’integrale rifondazione drammatica, in polemica con il classicismo francese per l’esigenza di un diretto recupero dell’arte classica, il tentativo leopardiano vale principalmente per le preoccupazioni di carattere teorico che lo ispirano; e attraverso queste per le indicazioni che ne ricaviamo — si legga l’Avvertenza che accompagna il frammento della Telesilla — in merito a una posizione letteraria non disposta a lasciarsi chiudere nei termini della controversia classico-romantica, volta piuttosto alla definizione di concetti (la semplicità dell’azione, la forza e « verità moderna » delle passioni rappresentate, il rispetto delle « regole naturali non arbitrarie ») la cui portata, pur nella sommarietà dell’abbozzo che ce li illustra, travalica i confini del genere tragico investendo il disegno più ambizioso di una generale riforma della cultura letteraria. Si tratta del disegno che intravediamo anche nel progetto di un trattato Della condizione presente delle lettere italiane (cfr. Tutte le opere cit., I, pp. 368-9). Dal confronto fra la nostra e le altre letterature moderne emergerebbe, secondo Leopardi, la « necessità di libri italiani dilettevoli ed utili per tutta la nazione »; affermandosi nel contempo l’urgenza di generi nuovi o da rinnovare sostanzialmente, come l’eloquenza e la lirica, l’epica in prosa, la commedia oltre alla tragedia; nella prospettiva di un gusto che preso atto, per quanto attiene in particolare alla poesia, della raffinatezza virgiliana e latina conferitale da un Alfieri e da un Parini, da Monti e da Foscolo e poi ancora da Arici e da Pindemonte, sappia riconoscere l’assenza in essa d’una vera originalità e arditezza espressiva; constatando così il decadimento di una civiltà letteraria che, nell’impossibilità ormai di riprodurre certa nativa energia del classicismo greco, « quel primitivo che ne’ greci anima e divinizza il tutto », non può non disporsi alla ricerca di valori formali di matrice colta, anche nel campo della prosa, che Leopardi vorrebbe «inaffettata, fluida, armoniosa, propria, ricca, efficace, evidente, pura, da cavarsi da’ trecentisti, dagli altri scrittori italiani, da’
greci quanto a moltissime forme, da’ latini quanto a moltissime così forme come parole, che si possono ancora derivare in grandissino numero nella nostra lingua, e adattarvele mollissimamente,
arricchendola oltremodo ».
Il progetto, destinato a rimanere sulla carta come la stragrande maggioranza dei disegni e degli abbozzi di questo periodo, sembra riflettere l'entusiasmo
ancora del primo incontro con Giordani e con il modello politico-culturale del
56
Giacomo Leopardi
« perfetto scrittore »; un entusiasmo ravvivato dalla visita dell'amico a Recanati e dalle conversazioni che ne seguirono, e ulteriormente accesosi dopo la pubblicazione delle canzoni civili. I punti di contatto fra l’abbozzo del trattato e la lettera a Montani, già ricordata, del 21 maggio del ’19, ci dimostrano come il consenso ottenuto potesse incoraggiare il poeta a persistere sulla via di un impegno intellettuale avanzato, sempre più sensibile ai compiti di rinnovamento assegnati alla letteratura. C'è da chiedersi tuttavia, da una visuale convenientemente allargata, se questo atteggiamento non corrisponda in realtà se non ad un aspetto di un’esperienza nell’insieme assai più problematica. La passione culturale è fuori discussione così come fuori discussione sono l’acutezza e la tempestività di molte delle osservazioni leopardiane: sull’opportunità ad esempio di stabilire un contatto in qualche modo fra il linguaggio letterario e quello della scienza; o in merito alla necessità di rivolgersi alle letterature straniere « per mostrare quali grandi opere abbiano fornite in questi ultimi tempi, quale vi sia l’amore dello studio, quali gli effetti della letteratura, quali le strade che si sono aperte, e dove noi dobbiamo imitarli »; oppure sull’urgenza di una letteratura in sintonia coi tempi, adattata al « gusto corrente », aperta al diffuso «spirito filosofico », e soprattutto in grado di aderire alla realtà della nazione intera: una letteratura « popolare » disponibile all’esigenza di una larga divulgazione, e perciò anche utile e istruttiva. Osservazioni da valutare per ciò che sono: ipotesi di studio, prime definizioni in una ricerca appena avviata. E però sicure in una linea di tendenza che, superando di slancio le difficoltà e l’inevitabile provvisorietà del discorso, ne csalta i dati di fondo: la spregiudicatezza con cui Leopardi, mentre ribadisce il proprio classicismo, non esita ad accogliere posizioni notoriamente romantiche; e la risolutezza con la quale dal piano tecnico, della letteratura e delle sue prerogative linguistiche e di genere, egli sa portarsi su quello riguardante responsabilità più generali: le responsabilità sociali e politiche dello scrittore e della scrittura, ancora una volta, privilegiate su ogni altra preoccupazione, compresa quella d’un più rigido rispetto del confine che divide — nell’inclinazione di massima, almeno, delle rispettive tematiche — la parte neoclassica dell’avversa.. Ma da una prospettiva più larga resta la sensazione che l'entusiasmo e la passione innovativa di Leopardi, il suo impegno nella direzione
del modello giordaniano, costituiscano soltanto uno ormai dei poli d’attrazione all’interno di una realtà intellettuale divenuta più inquieta. I C'è da fare i conti anzitutto con il senso d’impotenza che sorprende il poeta rivelandogli la precarietà dei suoi progetti letterari, di quest’ultimo come degli altri dello stesso periodo. « Mi domandi — così a Giordani in una lettera del 20 marzo 1820 — che cosa io pensi e che scriva. Ma io da gran tempo non penso né scrivo né leggo cosa veruna, per l’ostinata imbecillità de’ nervi degli occhi e della testa: e forse non lascerò altro che gli schizzi delle opere ch’io vo meditando,
e ne’ quali sono andato esercitando alla meglio la facoltà dell'invenzione che ora è spenta negl’ingegni italiani» (Epistolario, 146; ma cfr. anche 117). Un sentimento d’impotenza che si fa tanto più doloroso al pensiero del numero e
$ 44.
La crisi del *19; antico e moderno
57
della gravità dei problemi culturali che sarebbero da affrontare; e al pensiero dell'occasione
cui
lo scrittore
si sente
costretto
a rinunciare,
dimettendo
speranza di poter incidere con la propria opera nella realtà italiana:
così
ogni
Tante cose restano da creare in Italia, ch'io sospiro in vedermi così stretto e incatenato dalla cattiva fortuna, che le mie poche forze non si possano adoperare in nessuna cosa. Ma quanto ai disegni chi può contarli ?La lirica da creare (e questa presso tutte le nazioni, perché anche i francesi dicono che l’ode è la sonata della letteratura), tanti
generi della tragedia, perché dall’Alfieri n'abbiamo uno solo; l’eloquenza poetica, letteraria, e politica, la filosofia propria del tempo, la satira, la poesia d’ogni genere accomodata all’età nostra; fino a una lingua e a uno stile ch’essendo classico e antico,
paia moderno e sia facile a intendere e dilettevole così al volgo come ai letterati. In somma la stadio da correre è infinito; e io che forse dalla natura avea ricevuto qualche poco di lena per mettermi nella carriera, e giungere a un certo termine, sono sempre rattenuto nelle carceri della fortuna, e oramai privo della speranza di mostrare all'Italia qualche cosa ch’ella presentemente non si sappia neanche sognare (ivi).
Sono i medesimi
temi, come
si vede, annotati in vista del trattato Della
condizione presente delle lettere italiane. Prospettati obliquamente, alla luce ora di una coscienza indotta a rimuoverli dal proprio orizzonte operativo, ci dimostrano — per la loro urgenza culturale, così drammaticamente esaltata — il costo della rinuncia e insieme la profondità della crisi leopardiana. Che è crisi precisamente dell’intellettuale: constatazione dell’impossibilità di esprimere fattivamente, creativamente, la propria ansia rinnovatrice. Comprensibile allora il ripiegamento del poeta su una tematica più dimessa, insistentemente commiserativa e patetica, quella affiorata in margine alle canzoni Per una donna inferma e Nella morte di una donna. E soprattutto la sua disponibilità verso una materia che nel disegno degli Inni cristiani, sulle tracce del Génie du christianisme, accenna a un’in-
calzante tentazione spiritualistica: innegabile per quanto immune dal fideismo reazionario di uno Chateaubriand, indirizzata ad esaltare nel messaggio cristiano il momento
della diretta testimonianza dell’infelicità dell’uomo; e insieme, per
altri versi, sensibile a motivi che forzano la richiesta religiosa vera e propria, o piuttosto la allentano giustapponendole una forte attrazione, tutta letteraria, per la naturalità e primitività dei miti biblici: nella direzione dell’Inno ai patriarchi, e alla luce intanto di una singolare (e sintomatica) commistione di elementi classici e cristiani. Ma comprensibile in particolare, se dal piano della progettazione letteraria risaliamo a quello delle attestazioni schiettamente e compiutamente documentarie, l’attenzione con cui Leopardi segue i propri processi mentali portandoci al centro della sua crisi d’intellettuale; dandoci il modo di sorprendere le ragioni di un atteggiamento che, orientabile variamente a giudicare dai disegni e dagli abbozzi del 1819-20, insiste in realtà su un nucleo unitario di problemi esistenziali e morali; il cui svolgimento coincide con l’acquisto della nuova dimensione filosofica, e attraverso questa con l’aprirsi del discorso
Giacomo Leopardi
58
leopardiano a soluzioni che, ferma l'impossibilità di ripetere l’immagine civile e politica del vate di A/l’Italia e di Sopra il monumento di Dante, non che quella che ne deriva, di sensibile riformatore culturale (nel trattato Della condizione presente delle lettere italiane), la trasmutano nella poeta-filosofo della canzone Ad Angelo Mai e dei canti Il punto di partenza è rappresentato dallo stato della fuga da Recanati e l’insorgere del male della nella lettera del 19 novembre del 1819:
più complessa composti negli d'animo, dopo vista, espresso
identità del anni 1821-2. il fallimento a Giordani
Se in questo momento impazzissi, io credo che la mia pazzia sarebbe di seder sempre cogli occhi attoniti, colla bocca aperta, colle mani tra Je ginocchia, senza né ridere né piangere, né muovermi altro che per forza dal luogo dove mi trovassi. Non ho più lena di concepire nessun desiderio, né anche della morte, non perch’io la tema in nessun conto, ma non vedo più divario tra Ja morte e questa mia vita, dove non viene più a consolarmi neppure il dolore. Questa è la prima volta che la noia non solamente mi opprime e stanca, ma mi affanna e lacera come un dolor gravissimo; e sono così spaventato della vanità di tutte le cose, e della condizione degli uomini, morte tutte le passioni, come sono spente nell’animo mio, che ne vo fuori di me, considerando
ch’è un niente anche la mia disperazione. Gli studi che tu mi solleciti amorosamente
a continuare,
non
so da otto mesi
in poi che cosa sieno, trovandomi i nervi degli occhi e della testa indeboliti in maniera, che non posso non solamente leggere né prestare attenzione a chi mi legga checché si voglia, ma fissar la mente in nessun pensiero di molto o poco rilievo (Epistolario, 133).
Uno
stato
d’animo
non
del tutto
inedito,
certamente,
se pensiamo
alle
espressioni di sconforto che ricorrono nell’epistolario leopardiano prima ancora di questa data, già nelle lettere a Giordani e in quella a Carlo precedente il tentativo di fuga; ma divenuto più acuto qui ed esclusivo, quello stato d’animo, esacerbato eppure lucidissimo, dominato, e perciò tanto più penoso rispetto alle esperienze consimili che, nel passato, avevano conosciuto lo sfogo almeno di un più acceso risentimento e della protesta concitata. Una vita «senza illusioni e affetti vivi [.. .] senza immaginazione ed entusiasmo » è quella che incombe ora sullo scrittore, «stecchito e inaridito come una canna secca » (ivi, 143). A darle un senso varranno non tanto le parole affettuose e pie, intelligentemente discrete, della zia Ferdinanda Melchiorri sua confidente di questo periodo; quanto alcuni momenti di abbandono all’amicizia di Giordani: « Bisogna pure che il mondo sia qualche cosa, e ch’io non sia del tutto morto, poiché mi sento infervorato
d'affetto verso cotesto bel cuore. Dimmi, dove troverò uno che ti somigli ? dimmi, dove troverò un altro ch’io possa amare a par di te?» (ivi, 135); e soprattutto le risorse di una mente che si esercita, evitando facili slittamenti e camuf-
famenti metafisici, a collegare il proprio sentire a persuasioni più generali relative in generale alla condizione umana. Persuasioni che riflettono la materia divenuta
$ 44.
La crisi del ‘19; antico e moderno
59
cospicua, nel frattempo, dello Zibaldone; e che ritroviamo all'atto di una formu-
lazione che ne scopre i caratteri di verità urgente dichiarandone le essenziali implicazioni autobiografiche. Così nella splendida lettera ancora a Giordani del 6 marzo del 1820:
Sto anch'io sospirando caldamente la bella primavera come l’unica speranza di medicina che rimanga allo sfinimento dell’animo mio; e poche sere addietro, prima di coricarmi, aperta la finestra della mia stanza, e vedendo un cielo puro e un bel raggio di luna, e sentendo un’aria tepida e certi cani che abbaiavano da lontano, mi si svegliarono alcune immagini antiche, e mi parve di sentire un moto nel cuore, onde mi
posi a gridare come un forsennato, domandando misericordia alla natura, la cui voce mi pareva di udire dopo tanto tempo. E in quel momento dando uno sguardo alla mia condizione passata, alla quale ero certo di ritornare subito dopo, com’è seguìto, m’agghiacciai dallo spavento, non arrivando a comprendere come si possa tollerare la vita senza illusioni e affetti vivi, e senza immaginazione ed entusiasmo, delle quali cose un anno ‘addietro si componeva tutto il mio tempo, e mi faceano così beato non ostante i miei travagli. Ora sono stecchito e inaridito come una canna secca, e nessuna passione trova più l’entrata di questa povera anima, e la stessa onnipotenza eterna e sovrana dell'amore è annullata a rispetto mio nell’età in cui mi trovo. Intanto io ti fo questi racconti che non farei a verun altro, in quanto mi rendo certo che non gli avrai per romanzeschi, sapendo com’io detesti sopra ogni cosa la maledetta affettazione corruttrice di tutto il bello di questo mondo, e che tu sei la sola persona che mi possa intendere, e perciò, non potendo con altri, discorro con te di questi miei sentimenti, che per la prima volta non chiamo vani. Perché questa è la miserabile condizione dell’uomo, e il barbaro insegnamento della ragione, che i piaceri e i dolori umani essendo meri inganni, quel travaglio che deriva dalla certezza della nullità delle cose, sia sempre e solamente giusto e vero (ivi, 143).
La differenza fra i «travagli » passati e il sentimento presente, di afflitta delusione e d’inaridimento,
corrisponde all’esaurirsi di una tensione etica che,
un tempo viva e sofferta, intimamente positiva, non può non cedere ora alle conclusioni cui porta la nozione di un’assoluta vanità: Era un tempo che la malvagità umana e le sciagure della virtù mi movevano a sdegno, e il mio dolore nasceva dalla considerazione della scelleraggine. Ma ora io piango l’infelicità degli schiavi e de’ tiranni, degli oppressi e degli oppressori, de’ buoni e de” cattivi, e nella mia tristezza non è più scintilla d’ira, e questa vita non mi par più degna d’esser contesa (ivi, 135).
Conclusioni che resistono tuttavia a ogni ipotesi di resa senza condizioni, di fuga nell’autocompatimento o nella rassegnazione religiosa. Siamo lontani dal modello civile rinnovato, fra gli abbozzi del 19-20, nei disegni che ripropongono l’idea di una letteratura parenetica, eloquente e nobilmente politica; ma non
Giacomo Leopardi
60
meno lontani dalle canzoni poi rifiutate del ’19, dagli analoghi progetti riduttivamente sentimentali, dal progetto lirico-religioso infine degli Inni cristiani. Vicini semmai a certi atteggiamenti o anche soltanto accenni sparsi che in quel materiale sembrano correggerlo nel senso di un’esecuzione potenzialmente più persuasiva. A_preservarle comunque, quelle conclusioni, dal pericolo di cedimenti irrazionali vale del resto la ferma coerenza con la quale Leopardi sa rapportare la propria crisi al processo, largamente avviato nello Zibal/done, di un'ardimentosa
elaborazione
concettuale.
Le nozioni
della «noia»
e del «nulla »,
il sentimento di una precoce vecchiezza e aridità spirituale, tanto più amaro se confrontato con la vitale reattività di un tempo e con la certezza che, finita la fanciullezza, possa dirsi « finito il mondo e la vita [. . .] per tutti quelli che pensano e sentono » (ibidem), ci ripropongono in effetti alcuni dei temi sui quali si esercita con maggiore impegno il pensiero leopardiano negli anni di cui ci occupiamo. Temi affermati polemicamente, in aperta opposizione contro i « poveri filosofastri che si consolano dello smisurato accrescimento dalla ragione, e pensano che la felicità umana sia riposta nella cognizione del vero, quando non c’è altro vero che il nulla » (ivi, 143). La loro presenza nello Zibaldone, sulla spinta di alcune influenze determinanti (Rousseau, ma soprattutto M.me de Staél), si affida alla serie delle antitesi — natura-ragione, bello-vero, immaginazione-sentimento, poesia-filosofia — che informano il « sistema » delle idee di Leopardi a partire dal 1818-9. «La ragione è nemica d’ogni grandezza: la ragione è nemica della natura: la natura è grande, la ragione è piccola » (Zibaldone, 14). È la « gran verità » da cui prende le mosse il pensiero filosofico-morale di Leopardi. L’ipotesi che la sostiene, il primato della natura, si collega a posizioni precedenti d’ordine estetico e letterario; posizioni d’ascendenza puristica e neoclassica maturate fra il ’16 e il °17, messe a punto nel vivo della polemica con Di Breme, nel Discorso di un italiano, e contemporaneamente indirizzate in una prospettiva che dal piano originario, l’invidiabile felice « naturalezza » degli scrittori antichi, le proietta su quello della generale condizione umana. È su questo piano che la storia di Leopardi subisce una prima svolta in senso propriamente pessimistico. Negli
anni 1817-8 la protesta etico-politica aveva implicato la coscienza dell’irrimediabile, la nozione di una realtà disperatamente compromessa per la crisi oggettiva, storica, delle virtù civili degli italiani; ma soltanto ora lo sconforto e la passione intellettuale, ricomposti un tempo nel modello positivo del « perfetto scrittore », e quindi risolti nell'atto di fede — umanistico e illuministico — di un alto messaggio educativo, si direbbero precipitare in un sistema di negazioni metodiche e assolute. Da questo punto di vista, se ci disponiamo al pensiero leopardiano rispettandone l’identità essenziale, il suo carattere nel complesso di poderosa indagine pessimistica, non tardiamo ad accorgerci che la « gran verità » proclamata nelle prime pagine dello Zibal/done segna veramente l’inizio di una stagione nuova. AI cui centro è non tanto la nostalgia dello scrittore per ciò che l’uomo ha perduto, lo stato naturale e con questo la facoltà delle « illusioni » che, sole, pote-
ef
$ 44.
Le crisi del ’19; antico è moderno
61
vano indurlo a grandi imprese; quanto la constatazione del dominio della ragione, «noi siamo nel secolo della ragione», e delle sue ineluttabili conseguenze, Che procedono per l’uomo moderno da una condizione senile, di esperienza freddamente calcolatrice, arida ed egoista, convertendosi nella « barbarie » dell’età incivilita: «la ragione, facendo naturalmente amici dell’utile proprio e togliendo le illusioni che ci legano gli uni agli altri, scioglie assolutamente la società, e inferocisce le persone » (ivi, 23). In questo quadro il confronto col passato, sulla linea del Discorso di un italiano e in anticipo rispetto a soluzioni venture, nella canzone Alla primavera, può farsi clegia e insieme fervida ricreazione dei miti classici: Che bel tempo era quello nel quale ogni cosa era viva secondo l’immaginazione umana e viva umanamente cioè abitata o formata di esseri uguali a noi, quando nei boschi desertissimi si giudicava per certo che abitassero le belle Amadriadi e i fauni e i silvani e Pane ec. ed entrandoci e vedendoci tutto solitudine pur credevi tutto abitato e così de’ fonti abitati dalle Naiadi ec. e stringendoti un albero al seno te lo sentivi quasi palpitare fra le mani credendolo un uomo o donna come Ciparisso ec. e così dei fiori ec. come appunto i fanciulli (ivi, 63-4).
Ma più urgentemente si tratta per Leopardi, attraverso quel confronto, di stabilire una discriminante storico-concettuale: il confine che divide periodi diversi, l’antichità classica dall’età moderna, confermando la differenza che corre fra il primitivo e il barbarico (« Altro è primitivo altro è barbaro. Il barbaro è già guasto,
il primitivo
ancora
non
è maturo»;
ivi,
118);
in una
prospettiva
che, riassumendo in termini storici la tragedia del presente, dichiara la grande occasione perduta dall’umanità dopo la « barbarie de’ tempi bassi », il Medioevo, di far coincidere il proprio incivilimento col recupero integrale dell’antico: dei suoi valori sociali oltre che largamente esistenziali; sociali e precisamente di organizzazione civile e politica, a tener conto delle posizioni più avanzate del pen-
siero illuministico: [...] osservate che l’incivilimento ha conservato in grandissima parte il cattivo dei tempi bassi, ch’essendo proprio loro, era più moderno, e tolto tutto quello che restava loro di buono dall’antico per la maggior vicinanza (del quale antico in tutto e e per tutto abbiam fatto strage), come l’esistenza e un certo vigor del popolo, e dell’in| dividuo, uno spirito nazionale, gli esercizi del corpo, un’originalità e varietà di caratteri costumi usanze,
ec. L’incivilimento
ha mitigato la tirannide de’ bassi tempi,
ma l’ha resa eterna, laddove allora non durava, tanto a cagione dell’eccesso, quanto per li motivi detti qui sopra. Spegnendo le commozioni e le turbolenze civili, in luogo di frenarle com’era scopo degli antichi (Montesquieu ripete sempre che le divisioni sono necessarie alla conservazione delle repubbliche, e ad impedire lo squilibrio dei poteri, ec. e nelle repubbliche ben ordinate non sono contrarie all'ordine, perché questo risulta dall’armonia e non dalla quiete e immobilità delle parti, né dalla gravitazione smoderata e oppressiva delle une sulle altre, e che per regola generale, dove tutto è tranquillo non c’è libertà), non ha assicurato l’ordine ma la perpetuità tranquillità e
immutabilità del disordine, e la: mullità della’ vita umana (ivi, 162-3).
62
Giacomo
Leopardi
Alla definizione storico-concettuale dell’età moderna si accompagna l’indagine su ciò che, con una formula ricorrente in Leopardi, diremmo lo « stato presente » dell’uomo,
la condizione
dell’incivilito.
Il sentimento
della noia e della
vanità delle cose, il rapporto fra l’istinto di conservazione e il rifiuto dell’esistenza, la tentazione del suicidio: questi alcuni dei temi dell’indagine leopardiana. Il cui postulato, la certezza « della impossibilità di esser felice a questo mondo » (ivi, 140), mentre ribadisce l'orientamento fermamente pessimistico del pensiero di Leopardi, vale a precisare ciò che presto s'impone come suo specifico oggetto: la questione della felicità. La crisi storico-sociale determinata dall’avvento della ragione e dallo spegnersi delle illusioni antiche corrisponde infatti, sul piano individuale, allo smarrimento di uno stato originariamente felice, o almeno più felice di quello presente, uno stato d’inconsapevolezza e d’inesperienza dovuto
alla materna
sollecitudine
della natura.
Quest'ultima,
nascondendo
il
vero «sotto un profondissimo arcano » (ivi, 125), avrebbe consentito all'uomo di abbandonarsi con fiducia alla vita dell’immaginazione, dandogli il modo di un'esistenza in perfetta sintonia con la sua legge e con l’ordine universale cui spontaneamente si sarebbero commisurati ogni impulso e ogni nostra elementare esigenza. È l’ipotesi che informa anche il Discorso di un italiano. Là dove in particolare il confronto fra la poesia antica e quella moderna, collegato alla necessità per noi di ritrovare un rapporto più schietto con la natura, al fine di derivarne quel « diletto puro e sostanziale » che la poesia produce facendo leva su una nostra invincibile inclinazione, si apre al ricordo di un’eccitante esperienza infantile:
[FANCIULLEZZA E IMMAGINAZIONE] [...] Imperocché quello che furono gli antichi, siamo stati noi tutti, e quello che fu il mondo per qualche secolo, siamo stati noi per qualche anno, dico fanciulli e partecipi di quella ignoranza e di quei timori e di quei diletti e di quelle credenze e di quella sterminata operazione della fantasia; quando il tuono e il vento e il sole e gli astri e gli animali e le piante e le mura de’ nostri alberghi ?, ogni cosa ci appariva o amica o nemica nostra, indifferente nessuna, insensata 3nessuna; quando ciascun og-
getto che vedevamo ci pareva che in certo modo accennando 4, quasi mostrasse di volerci favellare; quando in nessun luogo soli, interrogavamo le immagini e le pareti e gli alberi e i fiori e le nuvole, e abbracciavamo sassi e legni, e quasi ingiuriati malmenavamo e quasi beneficati carezzavamo cose incapaci d’ingiuria e di benefizio; quando la maraviglia tanto grata a noi che spessissimo desideriamo di poter credere per poI. Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica; in Tutte le opere cit., 1, pp. 919-20. 1. gli antichi: i primitivi, già sopra definiti « nostri primi padri ».
2. alberghi: dimore; anche oltre: albergo non d’uomini ma d’immortali. 3. insensata: priva di sensi, inanimata. 4. in... accennando: esprimendosi a cenni,
$ 44.
La crisi del ’19; antico e moderno
63
terci maravigliare, continuamente ci possedeva; quando i colori delle cose quando la luce quando le stelle quando il fuoco quando il volo degl’insetti quanto il canto degli uccelli quando la chiarezza dei fonti tutto ci era nuovo o disusato, né trascuravamo nessun accidente come ordinario 5, né sapevamo il perché di nessuna cosa, e ce lo fingevamo a talento nostro, e a talento nostro l’abbellivamo; quando le lagrime erano giornaliere, e le passioni indomite e svegliatissime, né si reprimevano forzatamente e prorompevano arditamente. Ma qual era in quel tempo la fantasia nostra, come spesso e facilmente s’infiammava, come libera e senza freno, impetuosa e istancabile spaziava, come ingrandiva le cose piccole, e ornava le disadorne, e illuminava le oscure, che simulacri vivi e spiranti che sogni beati che vaneggiamenti ineffabili che magie che portenti che paesi ameni che trovati romanzeschi, quanta materia di poesia, quanta ricchezza quanto vigore quant’efficacia quanta commozione quanto diletto. Io stesso mi ricordo di avere nella fanciullezza appreso coll’immaginativa 6 la sensazione d’un suono così dolce che tale non s’ode in questo mondo; io mi ricordo d’essermi figurate nella fantasia, guardando alcuni pastori e pecorelle dipinte sul cielo d’una mia stanza”, tali bellezze di vita pastorale che se fosse conceduta a noi così fatta vita, questa già non sarebbe terra ma paradiso, e albergo non d’uomini ma d’immortali; io senza fallo (non m’imputate a superbia, o lettori, quello che sto per dire) mi crederei divino poeta se quelle immagini che vidi e quei moti che sentii nella fanciullezza, sapessi e ritrargli al vivo nelle scritture e suscitarli tali e quali in altrui. Ora che la memoria della fanciullezza e dei pensieri e delle immaginazioni di quell’età ci sia straordinariamente cara e dilettevole nel progresso della vita nostra, non voglio né dimostrarlo né avvertirlo: non è uomo vivo che non lo sappia e non lo provi alla giornata 8, e non solamente lo provi, ma se ne sia formalmente accorto, e purch’abbia filo d’ingegno e di studio, se ne sia maravigliato. Ecco dunque manifesta e palpabile in noi, e manifesta e palpabile a chicchessia la prepotente inclinazione al primitivo, dico in noi stessi, cioè negli uomini di questo tempo, in quei medesimi ai quali i romantici proccurano di persuadere che la maniera antica e primitiva di poesia non faccia per loro. Imperocché dal genio ® che tutti abbiamo alle memorie della puerizia si deve stimare quanto sia quello che tutti abbiamo alla natura invariata e primitiva 19, la quale è né più né meno quella natura che si palesa e regna ne’ putti, e le immagini fanciullesche e la fantasia che dicevamo, sono appunto le immagini e la fantasia degli antichi, e le ricordanze della prima età e le idee prime nostre che noi siamo così gagliardamente tratti ad amare e desiderare, sono appunto quelle che
5. né trascuravamo . .. ordinario: nulla trascuravamo di ciò che ci accadeva perché nulla era per noi consueto. 6. immaginativa: la facoltà dell’immaginazio-
ne. 7. alcuni...stanza: cfr. Le ricordanze, vv. 623; e ancora fra i Ricordi d’infanzia e di adolescenza: « Canto dopo le feste, agnelli sul cielo della stanza [...]» (in Tutte le opere cit., p. 360).
8. alla giornata: quotidianamente. 9. genio: attitudine, attrazione. 10. alla natura... primitiva: riprende uno dei temi principali del Discorso, già svolto da un altro punto di vista: « nessuna mutazione degli uomini indusse mai cambiamento nella natura,
la quale vincitrice dell'esperienza e dello studio e dell’arte e d’ogni cosa umana mantenendosi eternamente quella, a volerne conseguire quel diritto puro e sostanziale ch’è il fine proprio della poesia [. . .], ma che insieme è confermato alla condizione primitiva degli uomini, è necessario che, non la natura a noi, ma noi ci adattiamo alla natura, e però la poesia non si venga mutando, come vogliono i moderni, ma ne’ suoi caratteri principali, sia, come la natura, immutabile. E questo adattarsi degli uomini alla natura, consiste in rimetterci coll’immaginazione come meglio possiamo nello stato primitivo de’ nostri maggiori, la qual cosa ci fa fare senza nostra fatica il poeta padrone delle fantasie » (ivi, p. 918).
64
Giacomo
Leopardi
ci ridesta l'imitazione della natura schietta e inviolata, quelle che ci può e secondo noi ci deve ridestare il poeta, quelle che ci ridestano divinamente gli antichi, quelle che i romantici bestemmiano e rigettano e sbandiscono dalla poesia, gridando che non siamo più fanciulli: e pur troppo non siamo; ma il poeta deve illudere, e illudendo imitar la natura, e imitando la natura dilettare. [. . .]
La possibilità di recuperare la condizione dell’infanzia riattivando le facoltà immaginative proprie dei primitivi, la loro candida disposizione agli inganni della natura e della poesia, sua imitatrice, è fra i presupposti della polemica antiromantica di Leopardi. Un presupposto ottimistico (Biral) nel quale si riflette la. convinzione che i classici greco-latini, interpreti diretti dalla natura, siano sostanzialmente riproducibili e perciò tali da permettere al poeta moderno che li assuma come modelli di rinnovare la vitalità fantastica degli antichi: «a’ tempi nostri per imitare poetando la natura vergine e primitiva, a parlare il linguaggio della natura (lo dirò con dolore della condizione nostra, con disprezzo delle risa dei romantici) è pressoché necessario lo studio lungo e profondo de’ poeti antichi » (Tutte le opere cit., 1, pp. 930-1). A questo patto il risultato è immancabile. Ed è qui l’ottimismo leopardiano: nella prerogativa concessa al poeta che sappia farsi antico assimilando la lezione dei classici di neutralizzare gli effetti dell’incivilimento, restituendoci alla libera vita dell’immaginazione: «a volere che l’immaginazione faccia presentemente in noi quegli effetti che facea negli antichi, e fece un tempo in noi stessi, bisogna sottrarla dall’oppressione dell’intelletto, bisogna sferrarla e scarcerarla [. . .]: questo può fare il poeta, questo deve » (ivi, p. 921). Non ci sorprenderemo se in un diverso contesto, trattandosi non più del diletto estetico ma tout court della felicità, nelle pagine dello Ziba/done il discorso di Leopardi si attesti su posizioni di più amara negatività. Cambia il contesto: l’attenzione si porta sui problemi generali della realtà umana; ma soprattutto viene meno, imboccato il fatidico 1819, la pretesa che le questioni vitali dell’uomo siano rapportabili immediatamente a un progetto culturale, di battaglia e di rinnovamento letterario: quel progetto che attraverso la polemica antiromantica in difesa della tradizione si era espresso nella chiusa del Discorso di un
italiano affermandosi come la condizione di una più ambiziosa conquista ideale. La visuale insomma si allarga e insieme si sposta il punto di vista. Questo mutamento nel passaggio dal Discorso di un italiano ai pensieri dello Zibaldone può esemplificarsi attraverso un'importante annotazione del gennaio del ’20: Ci sono tre maniere di veder le cose. L’una e la più beata, di quelli per li quali esse hanno anche più spirito che corpo, e voglio dire degli uomini di genio e sensibili, ai quali non c'è cosa che non parli all’immaginazione o al cuore, e che trovano da per tutto materia di sublimarsi e di sentire e di vivere, e un rapporto continuo delle cose coll’infinito e coll’uomo, e una vita indefinibile e vaga, in somma di quelli che considerano il tutto un aspetto infinito e in relazione cogli slanci dell’animo loro, L'altra
PI
$ 44.
La crisi del ’19; antico e moderno
65
e la più comune, di quelli per cui le cose hanno corpo senza aver molto spirito, e voglio dire degli uomini volgari (volgari sotto il rapporto dell’immaginazione e del sentimento, e non riguardo a tutto il resto, per esempio alla scienza, alla politica ec. ec.) che senza essere sublimati da nessuna cosa, trovano però in tutte una realtà, e le considerano quali elle appariscono, e sono stimate comunemente e in natura, e secondo questo si regolano. Questa è la maniera naturale, e la più durevolmente felice, che senza condurre
a nessuna grandezza, e senza dar gran risalto al sentimento dell’esistenza, riempie però la vita di una pienezza non sentita, ma sempre uguale e uniforme, e conduce per una strada piana e in relazione colle circostanze della nascita al sepolcro. La terza e la sola funesta e miserabile, e tuttavia la sola vera, di quelli per cui le cose non hanno né spirito né corpo, ma son tutte vane e senza sostanza, e voglio dire dei filosofi e degli uomini per lo più di sentimento che dopo l’esperienza e la lugubre cognizione delle cose, dalla prima maniera passano di salto a quest’ultima senza toccare la seconda, e trovano e sentono da per tutto il nulla e il vuoto, e la vanità delle cure umane e dei desideri e delle speranze e di tutte le illusioni inerenti alla vita per modo che senza esse non è vita
(Zibaldone, 102-3).
L’ottica di Leopardi corrisponde evidentemente alla terza maniera, « la sola funesta e miserabile, e tuttavia la sola vera »; la prima, «la più beata », appartiene per lui al passato, a una fase superata, e bruscamente, senza soluzione intermedie. Una testimonianza da integrare con l’altra, di poco successiva, relativa alla
«carriera»
del poeta e alla sua
«mutazione»
dallo stato antico al moderno:
Nella carriera poetica il mio spirito ha percorso lo stesso stadio che lo spirito umano in generale. Da principio il mio forte era la fantasia, e i miei versi erano pieni d’immagini, e delle mie letture poetiche io cercava sempre di profittare riguardo alla immaginazione. Io era bensì sensibilissimo anche agli affetti, ma esprimerli in poesia non sapeva. Non aveva ancora meditato intorno alle cose, e della filosofia non avea che un barlume, e questo in grande, e con quella solita illusione che noi ci facciamo, cioè che nel mondo e nella vita ci debba esser sempre un'eccezione a favor nostro. Sono stato sempre sventurato, ma le mie sventure d’allora erano piene di vita, e mi disperavano perché mi pareva (non veramente alla ragione, ma ad una saldissima immaginazione) che m’impedissero la felicità, della quale gli altri credea che godessero. In somma il mio stato era allora in tutto e per tutto come quello degli antichi. [. . .] La mutazione totale in me, e il passaggio dallo stato antico al moderno, seguì si può dire dentro un anno, cioè nel 1819 dove privato dell’uso della vista, e della continua distrazione della lettura, cominciai a sentire la mia infelicità in un modo assai più tenebroso, cominciai ad abbandonar la speranza, a riflettere profondamente sopra le cose [. . .], a divenir filosofo di professione (di poeta ch'io era), a sentire l’infelicità certa del mondo, in luogo di conoscerla, e questo anche per uno stato di languore corporale, che tanto più mi allontanava dagli antichi e mi avvicinava ai moderni. Allora l’immaginazione in me fu sommamente infiacchita, e quantunque la facoltà dell'invenzione allora appunto crescesse in me grandemente, anzi quasi cominciasse, verteva però principalmente, o sopra affari di prosa, o sopra poesie sentimentali. È s'io mi metteva a far versi, le immagini mi venivano a sommo stento, anzi la fantasia era quasi dissec-
Giacomo
66
Leopardi
cata [. . .]; bensi quei versi traboccavano di sentimento (1° luglio 1820). Così si può ben dire che in rigor di termini, poeti non erano se non gli antichi, e non sono ora se non i fanciulli, 6 giovanetti,
e i moderni che hanno questo nome, non sono altro che
filosofi. Ed io irifatti non divenni sentimentale, se non quando perduta la fantasia divenni insensibilé alla natura, e tutto dedito alla ragione e al vero, in somma
filosofo
(ivi, 143-4).
La preoccupazione qui di rapportare la propria vicenda ad uno schema rigidamente oppositivo — antico-moderno — ci spiega certa secchezza della testimonianza di Leopardi, per quanto attiene in particolare alla storia della sua esperienza letteraria che sappiamo ben più complessa. Ma il documento resta di fondamentale importanza per stabilire il divario che separa il momento dello Zibaldone da quello del Discorso di un italiano. Un divario che si apre per effetto i una certezza definitiva: la condizione dei primitivi, la loro felicità naturale, è realtà irrecuperabile. La testimonianza autobiografica ne è il riconoscimento penosamente sofferto; ed è insieme l’espressione di un modo
nuovo
di porre il
problema nella sua interezza. Non più subordinandolo ad una fede letteraria ma riguardandolo, indipendentemente da ogni fede, in sé e per sé. Di qui un vero e proprio capovolgimento di posizioni. La letteratura non è più chiamata a sanare i guasti della ragioné e dell’incivilimento; sono questi ultimi bensì che, insana-
bili, la costringono a rispecchiare il dramma della delusione moderna, la sconfitta dell’immaginazione e della poesia. La storia personale dello scrittore ha in questo senso uri valote esemplare. La sua metamorfosi, riproducendo la generale trasformazione umanà, si propone implicitamente come un’esperienza in qualche modo tipica: dell’uomo prima che del poeta, o piuttosto del poeta che si considera nella totalità della sua persona, rintracciando nella propria vicenda letteraria i segni —- biologici, psicologici — della vicenda che accomuna al suo il destino dei contemporanei. Un destino di aridità e di tetra alienazione nel vero. È il contrassegno della poesia dei moderni, sentimentale o filosofica; ma è prima di tutto una condizione conoscitiva vissuta come una condanna, lo stato tragico del disinganno e della consapevolezza. Ne deriva quella maniera di « veder le cose » che, propria degli uomini « di sentimento », non può non tradursi per costoro nella constatazione del nulla, del vuoto che si esalta in una spirale di negazioni fino a imporre la misura di un suo paradossale spessore: Tutto è nulla al mondo, anche la mia disperazione, della quale ogni uomo anche savio, ma più tranquillo, ed io stesso certamente in un’ora più quieta conoscerò la vanità e l’irragionevolezza e l'immaginario. Misero me, è vano, è un nulla anche questo mio dolore, che in un certo tempo passerà e s’annullerà, lasciandomi in un voto universale e in un’indolenza terribile che mi farà incapace anche di dolermi (ivi, 72).
Io era spaventato nel trovarmi in mezzo al nulla, un nulla io medesimo. Io mi sentiva come soffocare; considerando e sentendo che tutto è nulla, solido nulla (ivi, 85).
$ 44.
La crisi del 19; antico e moderno
67
La crisi dell’uomo e dell’intellettuale, nell’attrito fra biografia e impegno
etico-culturale e politico, si riflette così in un sistema di pensiero che la convalida nei termini di una verità più generale, desumendone al tempo stesso le ragioni del proprio fondamentale orientamento pessimistico. Rimarremmo tuttavia di qua dallo Zibaldone se per cercarne i collegamenti con la storia del poeta e con ì documenti che ce l’attestano fuori delle pagine del grande diario, ne trascurassimo lo specifico apporto: il contributo ch’esso dà a problemi che si costituiscono in un organismo concettuale tendenzialmente autonomo dalle ragioni che pure, in ultima istanza, lo rimandano ai processi di massima della personalità leopardiana. Non si tratta di riproporre la questione, ormai passata in giudicato dopo il risolutivo chiarimento di Cesare Luporini, della fisionomia propria del pensiero di Leopardi. Nessun dubbio sull’identità del « grande moralista » la cui testimonianza dovrà pur sempre valutarsi sul terreno che direttamente e meglio la esprime, quello storico e ideologico, delle persuasioni concrete, d’ordine umano e pratico più che astrattamento speculativo. Resta la tensione teoretica, l’attenzione con cui il poeta segue fino in fondo lo svolgimento delle
proprie idee, correlandone le conclusioni alla luce di una logica strenuamente sistematica. Un elemento, questo, da tener presente per intendere come il pessimismo e l’eudemonismo,
il tema della felicità e del piacere, componenti essen-
ziali l’uno e l’altro della meditazione leopardiana, possano assolvere una funzione attiva, d’incremento problematico, e non di puro rispecchiamento di un’esperienza storico-intellettuale già conclusa. La questione, dal nostro punto di vista, implica l’atteggiamento di Leopardi verso la cultura filosofica contemporanea e in genere verso la filosofia. Un atteggiamento fortemente segnato dalla matrice. settecentesca del suo pensiero e insieme altrettanto selettivo. L’accenno in una lettera a Giordani del ’18 in me| rito all’urgenza di creare una « nostra filosofia » non ci autorizza evidentemente a pensare che col suo « sistema » Leopardi intendesse mai riempire il vuoto allora denunciato. Il suo rapporto con la filosofia europea del tempo non può dirsi comunque di pacifica subordinazione. Certe posizioni riecheggiano nello Zibaldone a smentita di un’intera civiltà filosofica. La polemica contro la ragione, la raison illuministica, la costante negazione del progresso e della perfettibilità umana (ivi, 222-3; 371-3) sono fra i motivi di fondo di un pensiero che, nutrito di Settecento, non esita a prenderne le distanze su temi anche caratterizzanti e di portata decisiva. L'indifferenza verso ogni possibile svolgimento del concetto di « natura » in senso contrattualistico —
nella direzione, intendiamo,
del Contrat social — ci dimostra d’altra parte come lo stesso naturalismo degli anni di cui parliamo, impensabile fuori della lezione di Rousseau, presupponga in realtà un margine non trascurabile di autonomia nei confronti del suo precedente maggiore. Estraneo a tutto ciò che preme sul pensiero filosofico avviandolo all’idealismo e allo storicismo, Leopardi è soprattutto interessato alla organizzazione concettuale del proprio pessimismo e della propria morale eudemonistica. L’uno e l’altra, indissociabili, agiscono peraltro come un filtro ideologico: esclu-
Giacomo
68
Leopardi
dendo dal « sistema » quegli elementi della cultura settecentesca che ne comprometterebbero, se accolti, l'inclinazione irrinunciabilmente negatrice. Di qui il carattere selettivo dell’atteggiamento leopardiano. La cui singolarità e relativa originalità, riscontrabili nella coerenza dell’insieme più ancora che nel confronto (non sempre certo) con singole posizioni del tempo, meno evidenti sul terreno strettamente gnoseologico, si riconoscono con chiarezza su quello che nello Zibaldone concerne le esperienze dell'animo umano per dichiararne la categorica vocazione alla felicità. Se la gnoseologia leopardiana, infatti, con le sue sintomatiche predilezioni (critica dell’innatismo, concetto di «assuefazione » da cui procede quello successivo della « conformabilità ») resta nell’ambito della tradizione empiristica e sensistica senza scarti di rilievo, lungo l’asse di un pensiero risalente in linea di massima a Locke e agli Ideologi, a Cabanis e a Destutt de Tracy in primo luogo, eredi della dottrina condillachiana; la «scienza dell’animo » che Leopardi pratica in vista e a ridosso della sua « teoria del piacere », pur iscrivendosi in un’area di pensiero tipicamente settecentesca, legata a quella medesima tradizione, ne riesce con caratteri d’indubbia originalità. Caratteri riferibili ancora una volta all’azione filtrante del pessimismo; e tali da segnare una sostanziale differenza fra le conclusioni del poeta, non isolabili dal sistema generale delle sue idee, e quelle cui approdano generalmente i teorici dell’edonismo settecentesco italiano, economisti e riformatori (da Ortes a Genovesi, a Verri, a Beccaria), interessati più al rapporto fra felicità privata e beni sociali e quindi alla definizione di un comportamento individuale in grado di ridurne l'attrito, che non al carattere di una tensione psicologica che nella realtà dell’individuo si afferma per Leopardi come una richiesta primaria e assoluta, di qua da ogni calcolo economico-sociale (cfr. per questo aspetto il saggio di Derla). Il rimprovero ai « moderni psicologi » di fermarsi assai prima di avere individuato le cause originarie dei fenomeni descritti, rinunciando così ad una spiegazione che dimostri la stretta corrispondenza esistente fra le manifestazioni dell'animo umano e il «resto del sistema di nostra natura » (ivi, 53), mentre ci attesta esplicitamente l’insofferenza di Leopardi per le mistificazioni spiritualeggianti di un Saint-Pierre o di uno Chateaubriand, troppo preoccupati (in « mala fede ») di comunicare la suggestione del mistero per procedere ad una chiarificazione risolutiva dei sentimenti dell’uomo; vale ad accertarci, al positivo, di una prospettiva evidentemente volta a saldare la «scienza dell’animo umano » (ibî-
dem) così come il poeta mostra di concepirla, immune dall’irrazionalismo e non meno aliena dall’esaurirsi nell’ambito di un’inerte fenomenologia, con le risultanze di un pensiero che su un piano diverso, filosofico-morale, ha riconosciuto definitivamente
i caratteri essenziali
del vivere moderno; stabilendo
nel con-
tempo i princìpi più adatti per un’indagine indirizzata ai meccanismi che regolano la vita interiore dell’incivilito. In questa prospettiva si riabilita l’antico interesse
di Leopardi per l’analisi dei sentimenti. Un interesse proclamato nel « Diario del primo amore »; discusso in polemica coi romantici, come una componente esteticamente improduttiva del gusto moderno; e rilanciato ora in una trama di
4

![Leopardi [First ed.]](https://ebin.pub/img/200x200/leopardi-firstnbsped.jpg)



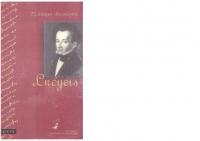


![Giacomo Leopardi [First ed.]](https://ebin.pub/img/200x200/giacomo-leopardi-firstnbsped.jpg)
![Leopardi. Scritti 1934-1963 [First ed.]](https://ebin.pub/img/200x200/leopardi-scritti-1934-1963-firstnbsped.jpg)